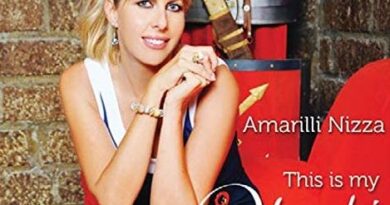Spettacoli 2016
LULU [Lukas Franceschini] Bolzano, 15 gennaio 2016.
Encomiabile e coraggiosa la decisione del Teatro Comunale di Bolzano, nell’ambito della Stagione d’Opera Regionale della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, di proporre l’opera Lulu di Alban Berg, titolo fondamentale del repertorio novecentesco. Il direttore artistico Matthias Lošek ha ideato una programmazione che da risalto all’espressività contemporanea in lavori di compositori del XX e XXI secolo senza tuttavia dimenticare il repertorio classico operistico. Ecco pertanto l’intestazione “OPER.A 20.21.” che contrassegna la stagione 2015-16, la quale ha come sottotitolo “The irony of life”. Dopo Wozzeck ci vollero un paio d’anni prima che Berg decidesse di comporre una nuova opera. Fallite le trattive per i diritti di “Und Pippa tanzt” di Gerhart Hauptmann, la scelta cadde su un soggetto che comprendeva due drammi: Ergeist (Spirito della terra) e Die Buchse der Pandora (Il vaso di Pandora) entrambi di Frank Wedekind. Realizzata la stesura del libretto, Berg lavorò alla partitura dal 1928 fino alla sua morte nel 1935, con due interruzioni per dedicarsi ad altre composizioni. Nei primi mesi del 1934 la composizione era quasi ultimata, pertanto il compositore estrasse dall’opera alcuni pezzi che andranno a far parte della Symphonische Stucke aus der Oper “Lulu” per l’esecuzione data a Berlino il 30 novembre 1934 diretta da Erich Kleiber. Berg lavorò fino alla sua morte all’orchestrazione ma il terzo atto restò incompiuto ad eccezione di alcuni pezzi. Il regime nazista impedì che l’opera fosse rappresentata in Germania, così la prima si ebbe a Zurigo il 2 giugno 1937, andarono in scena i primi due atti e i frammenti sinfonici del terzo. Fu in questa forma ridotta che l’opera conobbe diffusione internazionale cui seguirono anche incisioni discografiche. La vedova Berg aveva inizialmente pensato all’ipotesi che il terzo atto potesse essere completato da un altro compositore ma dopo il rifiuto di Schoenberg e Weber, lei si oppose risolutamene al progetto fino alla sua morte nel 1976. Tuttavia, già dal 1962 Friedrich Cerha aveva incominciato a studiare quanto lasciato incompiuto da Berg per completarne la partitura, portando a termine il suo lavoro solo dopo la scomparsa della vedova dell’autore. La prima rappresentazione nella versione Cerha del terzo atto fu all’Opéra di Parigi il 24 febbraio 1979 sotto la bacchetta di Pierre Boulez e la regia di Patrice Chéreau, cui seguirono altre repliche in teatri tra cui La Scala e un’edizione discografica, che segnarono una rinnovata fortuna dell’opera. Musicalmente lo spartito ha un taglio di forme operistiche e il linguaggio adotta seppure in modo personale il metodo dodecafonico di Schoenberg. E’ da rilevare che nella struttura musicale di Lulu il rapporto dialettico con la storia è molto importante e reso evidente dalla ricchezza delle forme e delle tecniche compositive che si rifanno a strutture classiche: il rondò, la forma sonata, il recitativo, l’arioso, la canzonetta, l’arietta, il duettino, il quartetto, il sestetto. Inoltre l’opera dispiega una vasta gamma di modi espressivi che vanno dalla comune recitazione fino all’estremo virtuosismo vocale. A Bolzano abbiamo assistito alla prima esecuzione nazionale della nuova versione di Eberhard Kloke del 2010. Kloke, compositore e direttore, ha voluto ridisegnare la distanza musicale che separa i primi due atti con il terzo e basandosi sulla propria formazione musicale ha voluto realizzare una versione cameristica e modulare. Il lavoro di Eberhard Koke, che ridimensiona l’orchestra a una cinquantina di elementi con l’aggiunta della fisarmonica, pone l’accento su una strumentazione più trasparente e si avvicina all’innovazione bergiana che si rifà al concerto per violino e orchestra rendendo il testo molto più comprensibile. Se la versione originale tende al recupero delle forme tradizionali, questo nuovo completamento imprime un linguaggio musicale più moderno senza alterare la ricchezza espressiva e timbrica. Un vero piacere questo nuovo ascolto che non vorrei si considerasse migliore o peggiore al lavoro di Cerha, piuttosto alternativo sempre nel segno e nello sviluppo concettivo dell’autore. Eccellente la prova dell’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, la quale in questa versione cameristica traccia un suono preciso e compatto di assoluta precisione tecnica. Merito anche della collaudata bacchetta di Anthony Negus che si adopera in una lettura molto elegante puntando soprattutto sul particolare suono rifinito analizzando, fondamentalmente, la partitura su un omogeneo colore di ricercata raffinatezza dei pezzi chiusi senza abusare in squarci di elettrizzante musicalità dal timbro esasperato. Della lunga lista degli interpreti emerge innanzitutto l’ottima qualità generale, la quale ha determinato la prestigiosa riuscita dell’operazione. La protagonista Marie Arnet era una convincente Lulu sia sotto l’aspetto scenico sia, soprattutto, come cantante rifinita. Padrona del fraseggio e del colore vocale, intensa nel canto fiorito di non facile esecuzione. Paul Cary Jones era un Dr. Schon di beffarda irriverenza abbinata a un’elegante performance vocale, messa ancora più in risalto quando nel finale interpreta anche Jack lo Squartatore in maniera sadica e glaciale. Johnny van Hal era un Alwa di bella tensione e smarrimento sociale, Mark Le Brocq, un pittore e un domatore di elettrizzante teatralità. Jurgita Adamonyte corretto studente fin troppo scemo, straordinaria la resa vocale e scenica di Natascha Petrinsky, una contessa sensuale e ieratica di forte impatto. Per correttezza elenchiamo tutto il cast del quale dobbiamo registrare un elevato stile vocale e interpretativo: Duccio Del Monte (direttore del teatro/banchiere), Alan Oke (principe/domestico/marchese), Steven Scheschareg (atleta), Roland Selva (primario), Keith Harris (giornalista), Johannes Held (domestico), Rebecca Afonwy-Jones (arredatrice), Anna Lucia Nardi (madre), Mary-Jean O’Doherty (una quindicenne), Carlo Emanuele Esposito (commissario), David Thaler (clown), Andrea Deanesi (macchinista), Stefano Ferrario (violinista), Benjamin McQuade (pianista). La produzione emozionante e ben riuscita, con regia di David Pountney, scene di Johan Engels e costumi di Marie-Jeanne Lecca, è stato creato alla Welsh National Opera nel 2013. Un’imponente torre di ferro rosso di Engel domina nei tre atti fungendo alle molteplici scene, in particolare si ammira il simbolismo dei corpi dei mariti di Lulu appesi come una sorta di testimone simbolo della macabra vicenda. Variegati e molto eleganti i costumi di Marie-Jeanne Lecca, ora sobri da moda anni ’20, ora circensi o da avanspettacolo. Poutney sviluppa la sua lettura in una sorta di labirinto gabbia ove la figura della protagonista gioca in modo estremo con tutti i personaggi, tutti sono prigionieri di un destino intrinseco e inconscio degli eventi, la stessa Lulu, un’anima ribelle, anticonformista e forte, regge e supera ogni fase della discesa sociale distruttiva per perire al termine in modo “banale” da parte di stupratore-squartatore. Un vortice drammatico di elevata espressione teatrale e sottolineato da scelte coraggiose e cruenti come i nudi della protagonista, e l’agghiacciante morte impressa su un vetro semi-trasparente con il sangue che scivola sul corpo spoglio e sul vetro. Operazione riuscita con lode, cui il numeroso pubblico (rara tanta presenza per un titolo novecentesco) ha giustamente salutato con prolungati applausi al termine.
NOZZE DI FIGARO [William Fratti] Parma, 15 gennaio 2015.
Dopo qualche anno di assenza, finalmente Mozart ritorna sulle scene del Teatro Regio di Parma con Le nozze di Figaro, nello spettacolo creato per il Teatro di San Carlo di Napoli da Mario Martone, con scene di Sergio Tramonti, costumi di Ursula Paztek e luci di Pasquale Mari. Simon Orfila, che non ha sempre convinto appieno in altri ruoli a dispetto della sua strabiliante carriera internazionale, nei panni di Figaro mostra delle qualità vocali e doti interpretative di pura eccellenza. La sua tecnica si sposa alla perfezione col canto e lo stile mozartiano, sempre omogeneo e ben curato, brillantissimo, coi suoni ben in punta, supportato da una presenza scenica elegante e una recitazione puntuale e misurata. Ma chi davvero sorprende più di tutti è Laura Giordano nel ruolo di Susanna, limpida e cristallina, dotata di una voce leggera, ben timbrata e che corre, con una linea di canto morbida, compatta e molto musicale. Il suo personaggio è raffinato e rende ancora più piacevole l’ascolto. Eva Mei è un tripudio di classe, di gusto, di stile invidiabili, tecnicamente perfetta e in grado di rendere scenicamente una Contessa di elevatissima statura. La sua voce non è mai stata particolarmente stentorea, ma in questi ruoli, dove ciò che davvero è importante è il saper fare belcanto, è indubbiamente artista e professionista di riferimento. Da ricordare e riascoltare: “Dove sono” e il duetto con Giordano: “Sull’aria…Che soave zefiretto”. Roberto De Candia dipinge un personaggio mastodontico, autorevole ma non autoritario, nobile di portamento ma non snob, umano d’animo ma giustamente un poco distaccato. Il suo Conte è il ritratto perfetto del volere mozartiano, dove le sfaccettature più basilari e naturali del suo carattere e dei suoi istinti, al di là del ceto a cui appartiene, si devono cogliere senza cadere nel buffo. Il canto centra appieno lo stile con altrettanta efficacia ed eleganza. Un po’ meno adeguata è l’interpretazione di Laura Polverelli, che rende un Cherubino rifinito scenicamente ma la voce non ha più la freschezza necessaria al ruolo del ragazzino. Buona la prova di Marigona Qerkezinei panni di Marcellina, anche se qualche agilità risulta un poco pasticciata e certi acuti un po’ striduli. La accompagna Francesco Milanese nelle vesta di un discreto Don Bartolo. Sa farsi sentire anche Ugo Tarquini nel ruolo di Don Basilio, ma non è certo da considerarsi un tenore di grazia di stampo mozartiano. Più che soddisfacente è il Don Curzio di Matteo Macchioni. Infine efficaci la Barbarina di Giulia Bolcato, anche se un po’ acidula in acuto e il padre Antonio di Carlo Checchi.Altra grande sorpresa della produzione è Matteo Beltrami alla guida della brava Orchestra Filarmonica Italiana che, se non è parso particolarmente brillante in altri repertori, con questo Mozart sa tirar fuori le grinfie e dirigere con buona dosa d’accento. Ottima la prova del Coro del Teatro Regio di parma preparato da Martino Faggiani. Ciò che funziona solo parzialmente è la regia di Mario Martone, efficacissima nella caratterizzazione dei personaggi, negli sguardi, nei gesti, negli approcci, ma per oltre metà dello spettacolo gli artisti cantano e recitano sulle pedane costruite accanto all’orchestra, rapendo forse la platea e le prime file di palchi e loggione, ma costringendo seconde e terze file ad assistere solo in piedi oppure, non potendo, al mero ascolto, pur avendo pagato il prezzo intero.
RIGOLETTO [Lukas Franceschini] Milano, 17 gennaio 2016.
Il 2016 del Teatro alla Scala parte alla grande con la ripresa dell’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi che ha riservato soprese e un bis non consueto nel teatro meneghino. L’allestimento era quello di Gilbert Delfo creato nel 1994 per il ritorno dell’opera alla Scala dopo incomprensibili decenni d’assenza. Uno spettacolo tradizionale nel vero senso della parola, che oggi potrebbe suonare come banale routine, invece siamo di fronte a uno spettacolo di prim’ordine realizzato con scene ricche e imponenti di Ezio Frigerio e costumi di finissima ed elegante sartoria di Franca Squarciapino, i quali confermano la loro fama in una carriera imperante. Il regista si attiene letteralmente al libretto e alla drammaturgia focalizzando in particolare i tre protagonisti nel ruolo che loro competono regalandoci una lettura attenta, nitida e di piacevole visione. Chi scrive non condivide l’idea che questo spettacolo è “vecchio”, piuttosto apprezza ancora una volta una delle migliori realizzazioni degli anni ’90 che ancor oggi può essere proposta. La principale novità e gradita sorpresa era rappresentata dal giovane soprano Nadine Sierra, molti l’avranno vista e ascoltata nel recente Concerto di Capodanno alla Fenice, la quale ha interpretato il ruolo di Gilda in maniera egregia. Molto espressiva nel fraseggio e in un registro acuto preciso ha cantato il ruolo con la necessaria dovizia, magari mancava leggermente di partecipazione (finale atto II) ma le qualità ci sono e avrà modo di rodare il ruolo in occasioni future, intanto non possiamo che registrare questa positiva performance. Vittorio Grigolo tornava a cantare il duca di Mantova alla Scala e in quest’occasione non è possibile non segnalare un ridimensionamento della sua proverbiale esuberanza con accenti e fraseggio più raffinati e contenuti. La voce, sempre di notevole volume e proiezione, è meno squillante di tempo addietro ed egli evita, volutamente o no, le puntature tradizionali, e quando abbozza una mezzavoce questa è sempre sgranata e gutturale con l’aggiunta di qualche arbitraria e personale scelta dei tempi. È lecito domandarsi il perché considerato che il cantante è attento e preciso al repertorio finora eseguito e tuttavia resti oggi una delle carte migliori spendibili in tale ruolo, anche se era auspicabile attendersi maggiore scioltezza e perizia tecnica. Salvo errori Carlo Colombara debuttava nel ruolo di Sparafucile, al quale dava una bella precisa e compiuta caratterizzazione scenica, meno vocalmente per una certa ruvidità nel canto che lo contraddistingue. Buona la Maddalena di Annalisa Stroppa ma onestamente la preferisco in altro repertorio perché il timbro è parso debole in una sala grande come il teatro alla Scala. Giovanni Furlanetto era un Monterone molto sfocato, precisi invece il Marullo di Davide Pelissiero e la Giovanna di Chaira Isotton. Corretta e puntuale la partecipazione degli allievi dell’accademia nei ruoli minori: Azer Rza-Zada (Borsa), Gianluca Breda (Ceprano), Federica Lombardi (contessa), Oliver Purckhauer (usciere), Kristin Sveinsdottir (paggio). Coro in forma smagliante istruito sempre da Bruno Casoni. Molto bella la direzione di Nicola Luisotti, il quale subentrava al previsto Mikko Frank. Il direttore toscano ha tenuto le redini della partitura con sapiente mano e ferma interpretazione verdiana. Abbiamo avuto una lettura incalzate e molto drammatica di alto valore interpretativo cui si sono ben amalgamati i solisti (Grigolo forse un po’ meno). I tempi erano serrati e incisivi e l’equilibrio orchestrale di assoluto rilievo. Per ultimo, Leo Nucci, un baritono ormai leggenda. Era l’ennesimo Rigoletto con protagonista il grande Nucci da me ascoltato e ancora una volta e in maniera diversa il cantante ha saputo emozionarmi. Sgombriamo subito il fatto che l’eccezionalità di Nucci consiste nel saper reggere ancora il ruolo con una voce certamente non fresca ma ancora duttile e il baritono ha come punto di forza l’espressione e il fraseggio. Certo non tutti i momenti sono perfetti e sovente il suono risulta nasale ma basta ascolarlo (e vederlo) nelle prime battute “In testa che avete” e già abbiamo Rigoletto in tutte le sue declinazioni. In questo momento Nucci gode inoltre di una particolare buona salute che gli permette ancora di salire con facilità nel registro acuto e accenta ogni frase da sapiente cesellatore e con innata espressività. Un grande artista, cha ha avuto l’onore di poter bissare il “Si vendetta” con la signora Sierra a sipario chiuso ricevendo un’ovazione interminabile e meritatissima. Un bis che alla Scala rappresenta l’eccezione da quando Toscanini ne vietò la prassi, solo in altre tre occasioni fu violato il dettato. Alla recita che ho assistito il teatro registrava il tutto esaurito, il pubblico festante ha applaudito con interminabili chiamate tutto il cast ma particolarmente caloroso con il protagonista.
LA PICCOLA VOLPE ASTUTA [William Fratti] Torino, 23 gennaio 2016.
Con la messinscena di Příhody lišky Bystroušky di Leóš Janáček nello spettacolo di Robert Carsen originariamente creato per il palcoscenico di Strasburgo nel 2013, il Teatro Regio di Torino vince un’altra sfida in termini di qualità culturale. La scelta artistica è ambiziosa, poiché l’opera apre il ciclo che porterà all’esecuzione di tutti i lavori teatrali del compositore ceco, autore sopraffino, geniale, illuminato, ma ancora poco rappresentato in Italia. L’allestimento di Carsen, con le suggestive scene di Gideon Davey – che firma anche gli efficacissimi costumi – e le magnifiche, nonché affascinanti luci dello stesso Carsen e di Peter Van Praet, porta direttamente lo spettatore nel mondo dei sentimenti e la fiaba resta solo una scusante per poter mettere a nudo le emozioni umane. Ed è così che il cuore del pubblico è toccato fino alle lacrime quando la mamma di Bystrouška la cerca nel bosco, ma invano, poiché il guardiacaccia l’ha portata via. Per poi sorridere amaramente quando la volpe arringa astutamente le galline per distrarle e poterle scannare. E di nuovo si commuove al disgelo, all’uccisione di Bystrouška, che avviene quasi in sordina, poiché il geniale Janáček vuole trasmettere chiaramente il concetto del ciclo della vita, che non si interrompe mai. La direzione musicale di Jan Latham-Koenig è pressoché perfetta nei bellissimi suoni onomatopeici, su cui è particolarmente concentrata, forse un poco a discapito delle prime melodie, ma ciò è presumibilmente il risultato di una ricerca e una lettura personale che in ogni caso colpisce nel segno, poiché diverte e commuove, arrivando immediatamente al cuore. Come sempre eccellente l’Orchestra del Teatro Regio. Altrettanto superlativa è la prova dei protagonisti, dei quali è difficile fare un distinguo, se non per Lucie Silkenová, che risulta essere particolarmente in parte nei panni della piccola volpe astuta; Svatopluk Sem, un guardiacaccia che primeggia per un fraseggio molto eloquente; Ladislav Mlejnek nel doppio ruolo del parroco e del tasso, che sa esprimere tutta la malinconia della partitura. Altrettanto bravi gli altri numerosi personaggi: la volpe maschio di Michaela Kapustová, Harašta di Jakub Kettner, Lapák di Carlotta Vichi, il gallo di Diana Mian, la moglie del guardiacaccia di Eliška Weissová, il maestro di scuola di Jaroslav Březina, Pásková di Lenka Šmídová, Pásek di Roberto Guenno, Pepík di Martina Pelusi, Frantík di Martina Baroni, Chocholka di Kate Fruchterman, Bystrouška cucciolo di Anita Maiocco e gli altri animali di Flavio Allegretti, Alessandro Ferraris, Giorgio Fidelio. Preparatissime le voci bianche ad opera di Claudio Fenoglio, maestro del bravo Coro del Teatro Regio.
LA CENERENTOLA [Simone Ricci] Roma, 23 gennaio 2016.
A quasi duecento anni dalla prima rappresentazione, Roma accoglie nuovamente il dramma giocoso di Rossini con una lettura fiabesca, ma non troppo sdolcinata. Il bicentenario delle musiche di Rossini a Roma, i 199 anni dalla prima rappresentazione al Teatro Valle e il ritorno del titolo dopo più di tre lustri. Erano diversi gli spunti interessanti per assistere a “La Cenerentola”, prima opera in cartellone del 2016 per il Teatro Costanzi: la regia di Emma Dante ha conferito al dramma giocoso in due atti (la cui prèmiere risale appunto al 25 gennaio 1817) un tono a metà tra il fiabesco e l’inquieto. La Dante era al debutto assoluto al Teatro dell’Opera di Roma e le sue scelte, seppure rispettose del libretto, hanno introdotto simboli e metafore. L’elemento dominante è stato quello dei “cloni” giocattolo di Angelina e Don Ramiro, i quali seguivano continuamente i due protagonisti dopo essere stati caricati da una chiave sulla schiena e in tutto e per tutto simili nell’aspetto. Questa recensione si riferisce alla seconda recita in programma. I momenti buffi e divertenti non sono mancati, ma la regia non ha dimenticato le riflessioni, in particolare la condizione difficile di Angelina-Cenerentola, con una famiglia nemica che la maltratta e la fa sentire a disagio. Le pistole e i fucili che le altre pretendenti alla mano di Don Ramiro nascondevano dietro la schiena e che sono state usate per una sorta di “suicidio di massa” erano la testimonianza di una lettura particolare e sinistra, nonostante la scena abbia provocato più di un sorriso. La trasformazione finale di Don Magnico, Tisbe e Clorinda in altri giocattoli a molla, isolati dalla felicità di Cenerentola è stata invece la soluzione per far chiudere il sipario con altre simbologie. A dominare erano soprattutto due colori, il turchese e il blu, senza disorientare troppo gli spettatori. Don Ramiro era Giorgio Misseri, principesco nel suo aplomb scenico, magari un po’ timido quando si trattava di rendere i trasalimenti dell’anima e gli abbandoni lirici: il suo registro acuto è stato spesso coperto dall’orchestra, l’interpretazione complessiva è stata tutto sommato “tranquilla”. Josè Maria Lo Monaco ha disegnato una Angelina-Cenerentola convincente e appassionata. L’aria finale e il rondò sono stati affrontati con coraggio e la consapevolezza della tecnica della coloratura, grazie ad acuti carezzevoli e vellutati; il lato patetico del suo personaggio, inoltre, era caratterizzato da intima commozione e malinconia sognante (Una volta c’era un re). Il Don Magnifico di Carlo Lepore era divertente e gustoso, una performance scenica sottolineata più volte dal pubblico: il basso napoletano ha dimostrato il carisma giusto per mettere in mostra il mattatore della storia. Non è stato da meno Giorgio Caoduro, un Dandini misurato ed elegante nella sua comicità, strapazzato a dovere dalle due sorellastre e in grado di garantire un interessante spolvero vocale. Il ruolo di Alidoro è stato ricoperto da Marko Mimica, lo stesso interprete della prima recita in programma, nonostante fosse previsto un avvicendamento con Ugo Guagliardo. Mimica ha ricevuto un tributo convincente soprattutto dal loggione al momento degli applausi finali, grazie a una interpretazione corretta e mai sopra le righe. Damiana Mizzi (Clorinda) e Annunziata Vestri (Tisbe) sono apparse più che affiatate e capaci di rendere molto bene, anche vocalmente, l’idea della rabbiosa concorrenzialità e della delusione finale. I loro goffi tentativi di seduzione e i continui svenimenti, poi, hanno strappato più di una risata come dovrebbe essere sempre con dei personaggi così strampalati. La direzione d’orchestra di Alejo Pérez è iniziata in punta di piedi: la splendida sinfonia de “La Cenerentola” avrebbe forse necessitato di maggiore mordente, in alcune occasioni si è perso il senso dei buffi giochi di parole del libretto di Ferretti, ma c’è stato l’apprezzabile tentativo di dar vita a una lettura morbida, elegante e vaporosa, in cui far emergere l’incanto della fiaba. Inappuntabile come sempre il coro maschile del Teatro dell’Opera di Roma, preparato a dovere da Roberto Gabbiani, sontuoso soprattutto nel celebre O figlie amabili di Don Magnifico. Il pubblico romano è rimasto sostanzialmente soddisfatto dalla seconda recita di questo dramma giocoso: il lieto fine è stato rispettato come prevede ovviamente il libretto, non è sfuggito però quel sapore agrodolce che ha voluto trasmettere la regia di Emma Dante, con una denuncia sociale abilmente mascherata ma comunque presente. Il leggero sipario trasparente che ha diviso tutti gli interpreti da Don Magnifico e le sorellastre è la chiara testimonianza che il perdono può essere concesso anche a chi si comporta in maniera malvagia, ma è un qualcosa che si deve conquistare in modo faticoso e con pieno merito.
STIFFELIO [Lukas Franceschini] Venezia, 24 gennaio 2016.
Il Teatro La Fenice sta sviluppando una programmazione atta alla riproposta del repertorio operistico denominato “Primo-Verdi”, con composizioni del periodo 1839-1850. Nell’attuale stagione è stata allestita una nuova produzione di Stiffelio. Dopo Luisia Miller, eseguita a Napoli, Verdi cominciò a cercare nuovi soggetti per le future opere. L’attenzione si pose sui drammi che poi divennero Rigoletto e Il Trovatore, contemporaneamente chiese suggerimento a Francesco Maria Piave per un nuovo soggetto e questi consigliò Le Pasteur di Emile Souvestre e di Eugène Bourgeois, cui seguì l’entusiasmo del compositore anche in vista del contratto con il Teatro di Trieste dove sarà rappresentata nel novembre 1950 con il titolo di Stiffelio. La trama è sicuramente moderna, forse troppo per l’Ottocento, un prete coniugato che ritiene cristiano il perdono dell’infedeltà coniugale. Non fu facilmente compreso e accettato tale soggetto dai pubblici italiani oltre alle scontate difficoltà con la censura. La scena finale ove il prete cita il vangelo fu considerata blasfema, e non si accordò permesso alla moglie di confessare il peccato al proprio marito. Significativo il commento di un critico che definì la partitura “un lavoro filosofico e insieme religioso nel quale i canti dolci e affettuosi si adattano alla vicenda sena far uso di bande, cori e sforzi sovrumani di polmoni”. Verdi stava trovando la sua strada poetica, la quale si può affermare che inizia con Luisa Miller e troverà affermazione con la successiva trilogia romantica. Stiffelio è una via di messo ma segna un’incisiva maturazione, il compositore fu particolarmente legato all’opera, anche perché fu spesso rappresentata mutilata per ordine della censura perdendo il suo spessore, e in seguito elaborò un rifacimento che avrà per titolo Aroldo (1857). Tuttavia, Stiffelio, seppur non perfetto, con la singolare drammaturgia e lo scavo psicologico dei personaggi, penso non abbia meritato l’oblio cui fu sottoposto per molti lustri. È con plauso che oggi, seppur limitatamente, sia rientrato nel novero delle composizioni che suscitano interesse sia nel pubblico sia nelle programmazioni teatrali. Delude lo spettacolo di Johannes Weigand, con scene e luci di Guido Petzold e costumi di Judith Fischer, senza però creare danni enormi. La regia era enigmatica e probabilmente andava ricercata in concetti psicologici che a chi scrive non sono giunti. L’adattamento spoglio e poco intimistico non contribuiva al meglio, esagerato il funereo e tetro clima adottato, cui mancava una gestualità espressiva drammaturgica. In scena dominava una parete-murale, o forse una cancellata, la quale non individuava il clima intimo e forse borghese nel cui ambiente si sviluppa la vicenda, oltre alla confusa presenza di una specie di torre-pulpito con faro accecante nel centro del palcoscenico. Apprezzabili i costumi storicamente appropriati. Sul podio c’era Daniele Rustioni che dopo I Masnadieri coglie un personale successo in queste partiture del primo Verdi. Il direttore è ben conscio delle imperfezioni dell’opera ma con mano esperta risolve la difficile prova scavando nei colori orchestrali, mettendo in luce le pagine più riuscite con ritmo incalzante e un ammirevole parallelo tra orchestra e palcoscenico. Rustioni da forza e convincimento allo spartito e magistralmente riesce a sopperire anche alle lacune di una parte del cast per personale impeto e narrazione drammaturgica soprattutto nel II e III atto. Stefano Secco, il protagonista, riesce a ritagliarsi un particolare successo in un ruolo molto sfaccettato nel quale l’uso del fraseggio la fa da padrone. Sicuro in un canto non sempre perfetto, è tuttavia capace di trasmettere i sentimenti del personaggio attraverso una vocalità controllata, ma non sempre, e in un accento credibile. Juliana Di Giacomo ha una voce bellissima e di robusto corpo tipicamente drammatica e adatta al ruolo, peccato che l’imperizia tecnica non le permette di esprimersi come dovrebbe, e con tali mezzi! L’intonazione è sovente precaria e il registro acuto generalmente fisso sfocia sempre in un grido malfermo. Dimitri Platanias non possiede le caratteristiche del nobile baritono verdiano e spreca la sua parte in un canto rude e sopra le righe. Più azzeccato il Raffaello di Francesco Marsiglia tenore di buona impostazione cui si può sommare anche Simon Lim che disegna un credibile Jorg ma povero di colori. Ottime le parti di fianco che erano interpretate da Cristiano Olivieri, Federico, e Sofia Koberidze, Dorotea. Teatro pieno in ogni ordine di posto, buon successo al termine per tutta la compagnia.
ATTILA [Lukas Franceschini] Bologna, 26 gennaio 2016.
Il Teatro Comunale di Bologna inaugura la Stagione 2016 con un’eccellente nuova produzione di Attila, una delle opere più belle degli anni di galera del giovane Verdi. Anche il Teatro Comunale di Bologna per l’inaugurazione della stagione sceglie un titolo verdiano dei cosiddetti “anni di galera”: Attila. Ottavo titolo operistico del catalogo ebbe il suo battesimo alla Fenice di Venezia il 17 marzo 1847, non possiamo considerarla tra i lavori più riusciti, tuttavia sempre gradita al pubblico. Nonostante l’entusiasmo del compositore per il libretto e la presenza in partitura di alcune ottime pagine e melodie efficaci possiamo ritenerlo un altro passo nella formazione compositiva che maturerà di lì a poco. L’opera si articola notevolmente al racconto teatrale ed emerge l’uso fantasioso dell’utilizzo dell’orchestra. Tra i personaggi solo il protagonista e Odabella trovano una dimensione precisa drammaturgica anche se non sempre omogenea. Ezio e Foresto sono personaggi insipidi, pur avendo a disposizione arie rilevanti, il finale dell’opera è poi deludente ma preceduto da un grande terzetto che vale tutta l’opera: “Te sol quest’anima”. L’opera mancava dal palcoscenico bolognese da ben diciassette anni e per quest’occasione abbiamo avuto un nuovo allestimento, affidato al duo Daniele Abbado-Gianni Carluccio, in coproduzione con Venezia e Palermo. Non possiamo affermare che questa produzione ci abbia entusiasmato ma non ha neppure sconfinato nell’assurdo, si è limitata a una banale narrazione senza nervo. In scena poco movimento e personaggi non particolarmente calibrati, soprattutto Attila che avrebbe meritato più spessore. Affiancare tableau d’arte contemporanea in questa vicenda non mi è parsa né idea molto originale né pertinente, oltre a svariate citazioni di stili registici del passato, e il protagonista legato con funi calate dall’alto nel finale è completamente assurda. Insomma tutto scorre velocemente senza lasciare traccia indicativa cui contribuisce la scena spoglia e troppo grigia di Gianni Carlucci, i costumi senza uno stile ben preciso di Daniela Cernigliaro si ascrivono ai commenti precedenti, talvolta anche bruttini e senza stile con miscela di modernità in mimetica e giacche ottocentesche per Ezio. La parte migliore è solo musicale. Michele Mariotti conferma le sue ottime capacità equilibrando un’orchestra ruspante e focalizzando un ritmo battagliero di grande enfasi e felice intuizione. Non mancano, a fianco dei tempi sostenuti, i raffinati momenti elegiaci ammirevolmente eseguiti con dolcezza e grande respiro orchestrale. Magari non sempre abbiamo trovato unità d’intenti ed equilibrio bilanciato ma sicuramente la prova è più che positiva. Ildebrando D’Arcangelo, che debuttava nel ruolo, non poteva offrici un personaggio guerriero e truce considerate le sue origini belcantistiche, anzi forse è il limite odierno cui possa affrontare un personaggio verdiano. Ma il cantante è un raffinato fraseggiatore e dal nobile d’accento, sviluppa la sua lettura scavando più sul lato umano del ruolo che su quello guerriero. Anche se a tratti monocorde colpisce la linea di canto uniforme e la sapiente capacità espressiva della parola. Maria José Siri è cantante di grande temperamento e questo è il suo punto di forza nell’affrontare un’Odabella di forte temperamento che mai si trova in difficoltà. Guerriera piuttosto che donna, ha le sue ammende nel settore grave non sempre uniforme e in un acuto sovente tirato, ma conosce e sa cantare questo Verdi ruvido e particolarmente verace con un mordente interpretativo di spessore. Fabio Sartori conferma le sue ottime professionalità canore affrontando il ruolo di Foresto con un piglio espressivo molto maggiore rispetto a sue recenti esibizioni. Il tenore è assolutamente sicuro in ogni registro si conquista un personale successo meritatissimo. Ottima la prova del giovane basso Antonio Di Matteo, un Leone di possente voce caratterizzata da una pastosità di prezioso smalto, non possiamo non pensare che tra qualche anno passerà al ruolo protagonista. Sui generis l’Uldino di Gianluca Floris. Molto bene la performance del coro preparato da Andra Faidutti. Ho lasciato per ultimo Simone Piazzola, il quale purtroppo si fatto annunciare indisposto all’inizio dello spettacolo e dopo la sua grande aria del II atto ha dovuto abbandonare la produzione per un aggravarsi della patologia (sbalzo di pressione) e lo spettacolo è stato terminato senza la presenza di altro artista. Auguriamo al giovane baritono una veloce e felice guarigione e ci esentiamo, doverosamente, dalla valutazione. Resta indubbio che egli, come già scritto in altre occasioni sia una delle giovani voci più attendibili del momento e pertanto lo aspettiamo in spettacoli futuri. Non posso tuttavia non evidenziare che è assurdo che non si potesse convocare in teatro il previsto secondo baritono considerate le non felici condizioni di Piazzola sin dall’inizio dello spettacolo. Non conosco il motivo per tale lacuna. Al termine un trionfale successo per tutta la compagnia.
ATTILA [William Fratti] Bologna, 28 gennaio 2016.
La parte del leone la fa il direttore musicale Michele Mariotti alla guida della sua bravissima orchestra. Il suo modo, il suo stile nel dirigere il primo Verdi è sinceramente entusiasmante, intriso di colori belcantistici, accenti drammatici, sfumature che bilanciano perfettamente musica e teatro, sempre a favore degli interpreti sul palcoscenico. Ed è così, anche grazie alla diligenza dell’ottimo coro preparato da Andrea Faidutti, che pagine semplici come l’apertura del dramma “Urli, rapine, gemiti” diventano momenti galvanizzanti ed eccitanti. Ma la pagina corale dove è impossibile restare impassibili è la scena dei profughi, toccante e commovente, altro momento in cui il Coro del Teatro Comunale di Bologna non perde occasione per primeggiare. Ildebrando D’Arcangelo, al suo debutto nel ruolo, è un Attila mastodontico, autorevole, regale, così elegante che i barbari sembrano i romani, non gli unni. La provenienza dal repertorio belcantistico favorisce l’esecuzione vocale in termini tecnici, cui si aggiungono una presenza scenica da gigante del palcoscenico, un fraseggio particolarmente espressivo e un’indubbia capacità d’accento. La gran scena e finale di primo atto hanno uno spessore davvero enorme; addirittura la cabaletta mostra facilità e morbidezza nell’arrivo al fa acuto, con agilità sgranate naturalmente, che la platea si infiamma e richiede il bis, fortunatamente concesso. Altra debuttante è Maria José Siri nei panni della guerriera Odabella. Come già notato in precedenti occasioni, il soprano ha tutte le carte in regola per primeggiare – del resto i calorosi consensi del pubblico dimostrano che piace – ma non convince mai fino in fondo, come se smettesse di studiare una parte una volta arrivata al novanta percento, senza scavare ancora più a fondo cercando quel fraseggio, quel colore, quell’accento, quella sfumatura, quel suono che potrebbero fare la differenza. Foresto è l’indiscutibile tenore verdiano per eccellenza del momento. Fabio Sartori, come di sua consuetudine, si presenta con una valanga di voce squillante che in questa occasione, più che mai, si diletta nello smorzare, nell’esplorare cromatismi e nel dipingere tinte più variegate, chiudendo addirittura la bellissima aria alla maniera di Bergonzi in pianissimo. L’indisposto Simone Piazzola è sostituito da Gezim Myshketa, altro bravo cantante, ma che in questo tipo di ruoli, come già rilevato, palesa alcuni problemi. Talvolta è lo scurire, talvolta l’eccessivo accentare, talaltra il passaggio in acuto. In questa occasione nessuno di questi è riscontrato, ma ciò che più si coglie è una certa difficoltà nel legato, che rende il canto discontinuo e disomogeneo. Il materiale vocale resta comunque degno di nota e tutte queste “prove” lo renderanno certamente migliore in futuro. Il giovane Antonio Di Matteo ha compiuto passi da gigante rispetto a un anno fa, quando si notavano le buone doti, ma con qualche incertezza. Oggi, nei panni del grave Leone, convince pienamente. Efficace l’Uldino di Gianluca Floris. Quanto allo spettacolo di Daniele Abbado, con scene e luci di Gianni Carluccio e costumi dello stesso Carluccio e di Daniela Cernigliaro, se inizialmente sembra senza infamia e senza lode, un poco scopiazzato da Pelléas et Mélisande, col procedere della vicenda prende corpo, anzi, stimola pensieri e riflessioni. Se lo spazio dell’opera di Debussy aveva un senso molto logico, direttamente connesso sia al dramma teatrale sia al dramma musicale, lo spazio di Attila, inizialmente vuoto, tende a riempirsi di concetti che vanno ben oltre l’episodio storico e le trasposizioni risorgimentali. Dunque il re degli unni può diventare un qualunque dissidente militante, mentre Ezio un generale disertore ed in questo modo l’attualizzazione è fatta: ancora una volta Giuseppe Verdi, con l’aiuto di un valido regista, regala al suo pubblico musica, teatro e ideali, quegli ideali che hanno reso libera l’Italia dal giogo straniero, quegli ideali che ancora oggi infiammano il cuore di molti popoli imprigionati nella loro terra.
L’ITALIANA IN ALGERI [Lukas Franceschini] Treviso, 27 gennaio 2016
Felice conclusione della Stagione Lirica al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” con la nuova produzione dell’opera di Gioachino Rossini L’italiana in Algeri, in coproduzione con il Teatro Comunale di Ferrara. Dopo le farse nei teatri minori veneziani, Rossini fece il “gran passo” proprio con L’italiana in Algeri al Teatro La Fenice nel 1813 ove colse un trionfo, forse ineguagliato rispetto altri spartiti, nel più importante teatro dell’Italia settentrionale. La sua it 2fama prese un balzo rilevante sia nel genere buffo sia nel serio, i cui lavori furono quasi tutti composti per il Teatro San Carlo di Napoli nel giro di pochi anni. L’allestimento proposto a Treviso era curato da Giuseppe Emiliani alla regia con elementi scenici di Emanuele Luzzati, costumi di Stefano Nicolao e proiezioni di Marco Godeas. Spettacolo senza ombra di dubbio piacevole, delineato da una scena che seppur con pochi elementi immerge lo spettatore in un mondo immaginario e favolistico. Infatti, la trama dell’opera è così particolarmente buffa ma irreale che questa drammaturgia le calza a pennello. Credo, ma non ne sono certo, che le scene a fondale siano state realizzate da Luzzati qualche decennio addietro per La Fenice, e ancor oggi funzionano a meraviglia per opera di Federico Cautero. Molto belle le proiezioni che già nell’overture raccontano con cartone animato la vicenda iniziale dell’opera strappando un simpatico sorriso ironico. Giuseppe Emiliani cura una regia molto tradizionale, questo non deve apparire come un difetto anzi oggigiorno è un pregio, non it 3cercando letture di elevato spessore psicologico ma attenendosi doviziosamente al libretto e visualizzando i personaggi nelle loro distinte sfaccettature ben ragionate e molto divertenti. Unica pecca che mi permetto di rilevare è che sovente si sono viste situazioni che erano in parte ispirate ad altre regie di un collega purtroppo scomparso che con tali spettacoli creò un punto di riferimento nel teatro rossiniano buffo. Molto belli e di grande fattura sartoriale i costumi di Stefano Nicolao, cromatici e fantasiosi anche se alcuni parevano un po’ fuori stile ma nel teatro comico ci può anche stare. Principale artefice di questo spettacolo è stato il maestro concertatore Francesco Ommassini che da sapiente conoscitore dello spartito trova e coniuga tutti gli aspetti buffi e patetici con somma capacità. Lo sviluppo serrato dei tempi e la brillantezza d’impianto generale producono un ottimo ascolto e una piacevole esecuzione sonora ben timbrata e molto omogenea con il it 4palcoscenico. Possiamo affermare, dopo le recenti provi in Il turco in Italia e La scala di seta, che Rossini è autore eletto per Ommassini, anche se l’Orchestra Città di Ferrara non mi è parsa così precisa e rifinita com’era logico aspettarsi, ma il risultato è più che soddisfacente. Le lacune si devono registrare, purtroppo, anche nel Coro Iris Ensemble, il quale abbisognerebbe di maggiore preparazione soprattutto tecnica. Forse si è trattato di un incidente “di percorso” poiché in altre occasioni la professionalità espressa era molto buona. Il cast denotava un’omogeneità molto apprezzabile. La protagonista Alisa Kolosova è un mezzosoprano con buone qualità, alcune magari da rifinire, ma la brillantezza dell’interpretazione e le precise agilità rendono appieno il personaggio. Nicola Ulivieri è un Mustafà spassoso e di grande ironia, capace di rendere il buffo ruolo con precisi colori e accenti molto raffinati, raccogliendo un personale successo in una delle migliori prove degli ultimi anni. Lorenzo Regazzo invece cambia ruolo interpretando in quest’occasione un simpatico Taddeo. Solitamente lo abbiamo it 5ascoltato in Mustafà, ma anche il personaggio buffo e in parte ingenuo gli calza a pennello. Regazzo ha la capacità interpretativa di non fare il verso macchiettistico ma trova un’eleganza magari allampanata per disegnare un Taddeo di estremo gusto teatrale, con l’aggiunta di una vocalità morbida, precisa, raffinata e molto stilizzata. Molto interessante il Lindoro di Francisco Brito, tenore di ottime qualità interpretative e dotato di voce squillante e rifinita tecnicamente. Tuttavia dovrebbe perfezionare i colori e gli accenti, ma col tempo credo che colmerà questi piccoli difetti. Molto bravo Giulio Mastrototaro che eleva il ruolo di Haly a un elegante e spassoso capo delle guardie, ritagliandosi un successo personale nell’esecuzione dell’aria “Le femmine d’Italia” eseguita con precisa vocalità e brillante eleganza. Brave professioniste sono state anche Daniela Cappiello, Elvira, e Valeria Girardello, Zulma, in piena sintonia con il cast e it 6molto valide scenicamente. Al termine un vibrante convinto successo, peccato che il teatro alla prima fosse occupato solo per la metà dei posti disponibili, forse la recita infrasettimanale? Non saprei, certo che per un titolo come Italiana il teatro dovrebbe essere sold-out, semmai suggerirei di anticipare l’inizio dello spettacolo poiché le 20.45 mi pare troppo tardi.
IL TURCO IN ITALIA [William Fratti] Piacenza, 29 gennaio 2016.
Con la messinscena de Il Turco in Italia di Gioachino Rossini il Teatro Municipale di Piacenza mette a segno un altro punto in termini di programmazione e qualità artistica. L’opera fa parte del grande repertorio, ma così come nella stagione precedente con Les contes d’Hoffmann, si tratta di un titolo poco rappresentato a Piacenza ed è il modo migliore per offrire novità culturali alla città, ma al contempo garantirsi il teatro pieno. Lo spettacolo, originariamente creato lo scorso anno a Treviso, oggetto di una coproduzione internazionale che vede coinvolti anche Ferrara, Ravenna e Metz, è firmato dal bravo Federico Bertolani che nel corso degli ultimi anni è cresciuto da direttore di palcoscenico e assistente alla regia. Il pregio del suo lavoro è quello di essersi concentrato sulla caratterizzazione dei singoli personaggi, arricchendola di gestualità elegante e divertente, mai ridicola, nonché di una buona dose di movimento tra controscene, spostamenti di attrezzeria ed elementi scenografici, col conseguente rapimento dell’attenzione degli spettatori. Un solo appunto può essergli rivolto nell’aver fatto interpretare in platea la bella aria di secondo atto di Don Geronio. Indubbiamente si tratta del proseguimento ideale della bellissima operazione di flash mob che nei giorni precedenti l’opera ha coinvolto e interessato tutta la città. Si è anche vista Donna Fiorilla civettare col pubblico durante la pausa tra i due atti, mentre il marito la cercava disperatamente. Ma un conto è eseguire in sala un coro o un recitativo, un conto è un’aria, poiché la platea gode di un’acustica molto differente, inoltre si impedisce una buona visione – oltre all’ascolto – di seconde e terze file di palchi, gallerie e loggione e ciò non è corretto nei confronti del pubblico pagante. A parte ciò il lavoro è fatto bene e lo spettacolo è filologico e divertente, con le scene efficacissime di Giulia Zucchetta e i bei costumi di Federica Miani, cui va riconosciuto il merito di aver fatto abbinamenti cromatici di buon gusto, oltre al pregio di una certa classe, seppur prêt-à-porter. Ottimo il disegno luci di Claudio Schmid. Quanto alla parte musicale, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini non è certamente in forma come di sua consuetudine, soprattutto tromba e corno che fanno qualche bel capitombolo. Migliori gli archi e le percussioni. Alla sua guida è Giovanni Di Stefano, che non è da considerarsi un direttore rossiniano di riferimento, ma ha il pregio di tenere tempi saldi e soprattutto di accentare laddove la scrittura del pesarese lo richiede. Riesce inoltre a reggere buoni equilibri nei pezzi d’assieme, creando un buon amalgama pur tenendo ben distinte le singole parti: orchestra, coro e ciascuno dei solisti. Ottima la prova di Gianluca Ascheri al fortepiano; pure eccellente il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Simone Alberghini è un Selim dalla statuaria presenza scenica, sempre disinvolto eppur misurato, mai votato ad alcun tipo di eccesso. Inizialmente è purtroppo poco elastico e povero di fraseggio, ma nella seconda parte fortunatamente riprende tutte le forze e l’intero sapere rossiniano di cui è depositario. Lo affianca la giovane Leonor Bonilla nei panni di una Donna Fiorilla riuscitissima nel personaggio, soprattutto perché compie i suoi gesti antipatici senza mai risultare tale. Il materiale vocale di cui è dotata la cantante è indubbiamente di ottimo livello, anche se c’è spazio per migliorare ed imbellire il suono di certe note in acuto, anche nei picchettati. Inoltre agilità e variazioni, pur essendo ben eseguite, si rifanno di più allo stile romantico che non a quello rossiniano, per cui sarebbe necessario uno studio specifico, già facilitato dalla buonissima base di partenza. Rossiniano DOC è Marco Filippo Romano, un Don Geronio riuscitissimo sotto ciascun profilo, dalla recitazione ad ogni singolo passaggio musicale, attraverso un fraseggio così eloquente che se ne percepiscono gesti e sguardi anche ascoltandolo ad occhi chiusi. Boyd Owen è un Don Narciso soddisfacente anche se non entusiasmante, dotato di bella voce leggera, ma talvolta aspra e si lascia scappare qualche nota calante. È invece azzeccatissimo il Prosdocimo di Andrea Vincenzo Bonsignore, buffo rossiniano ben riuscito nello stile di canto come nell’interpretazione divertente ed efficace. Anche la Zaida di Loriana Castellano si fa notare per il suo canto ben eseguito nell’intenzione del compositore. Simpatica l’interpretazione dell’Albazar di Manuel Amati. Peccato per qualche taglio qua e là nella partitura. Applausi entusiastici per tutti, nonostante il solito pubblico disturbante che cerca di correre al guardaroba non appena si spengono le luci.
LO SCHIACCIANOCI [Mirko Gragnato] Vicenza, 30 gennaio 2016
Il Ballet du Theatre de Genéve rilegge lo Schiaccianoci di Tchajkovsky con le coreografie di Jeroen Verbruggen, tra abiti di Lady Gaga e viaggi onirici: attraverso specchi e grandi armadi. La musica di Tchajkovsky già risuona nella sala, sipario calato, luci accese e mormorii tra il pubblico. Il balletto è senza orchestra, manca il rito dell’oboe che dà il La, dell’ingresso del direttore e di quel silenzio che viene ripopolato dall’attacco di una bacchetta. La musica che esce dalle casse rende il tutto artificioso, come la musica che condisce le corsie dei supermercati o dei grandi negozi di firma. Luci spente, Il sipario si alza e in questa sensazione di smarrimento siamo condotti in questa favola antica ma nuova, reinterpretata, riletta con gli occhi di un adolescente e delle complessità che il non essere più bambini ma non ancora adulti comporta in quel confuso intreccio di emozioni e sensazioni. IL DNA natalizio di questa storia viene stravolto e anziché far tornare tutti bambini, cosa che ispirano favole e sogni, ci fa scontrare con quella che è la dura realtà, il mondo degli adulti nel quale bisogna crescere e diventare grandi. Il Re dei topi e la sua genia si presentano con mascheroni col viso travisato tra un misto di uomo nero e componenti del famoso gruppo dei Kiss.Il tutto in un allestimento di ampi lampadari, abiti svolazzanti con un tocco di eccesso, vicino al rococò. La danza contemporanea, di cui il Ballet du Theathre de Geneve è forse una delle punte di diamante, con un approccio di maggiore libertà si presta ad uscire dalle rigide regole della danza classica, così come l’adolescente si sente smarrito in quel corpo che cambia, in una società quella della famiglia in cui si sente stretto. Questa la lettura che appare dai passi della coreografia di Jeroen Verbruggen. La partitura di Tchaykosky viene smontata e rimontata come un abito che viene riadattato alle situazioni e ai tempi, così sentiamo una danza russa che shifta da un atto all’altro e il tema di Drossemeier che viene riproposto per ben tre volte. La festa in casa Stahlbaum viene esposta come un party dove i bambini sono più adolescenti presi dall’interesse di far colpo sulle ragazze. Dove i passi perdono uniformità e diventano espressione di vigore e giochi d’intesa, dove l’importante è apparire e allo stesso tempo far parte del gruppo.schiaccinaoci0116La giovane Marie, interpretata da Yumi Aizawa, diventa la bambina-adolescente che attira l’attenzione degli adulti nel modo sbagliato: movimenti nervosi e instabili che vengono accompagnati dagli staccati ribattuti di archi e legni, mostrandone l’esclusione da un mondo che non permette più di essere bambini, ma che smonta e riveste la giovane Marie con l’uniformità degli altri corifei nelle musiche della festa. Se nella storia di Hoffmann, che quest’anno celebra il 200°compleanno, il mondo si trasforma durante una notte di sogno, qui la fuga dalla realtà avviene attraverso i nebbiosi anfratti di un grande armadio, che diventa portale per nuovi mondi, racchiudendo le tante maschere della nostra quotidianità, una seconda pelle pronta per ogni avversità che la vita ci pone. Dalle sue porte infatti, come se fosse un moltiplicatore delle nostre paure e delle nostre fragilità, come un esercito di cloni escono tante Marie a cui segue la danza dei fiocchi di neve, nella quale grandi specchi a Psiche danzano spinti tra salti e volteggi delle tante “Sè stessa” che Marie deve affrontare vis a vis, andando, come l’Alice di Carrol, oltre lo specchio, fino alla fuga finale in un mondo nuovo al di là della coltre di nebbia che il grosso armadio racchiude. Quello che si apre nel secondo atto sembra un salotto progettato dallo studio65 dove il pavimento non è altro che un cielo azzurro sopra il quale scendono le luci della notte. Tra le stelle si apre una porta che con una scala fa scendere Marie su un parterre, in cui si avvolgono cielo e nuvole, dove l’intero corpo di ballo in abito marziale, con la bocca imbavagliata da un fazzoletto a motivi floreali, muove i passi del famoso Waltzer dei fiori e con Giochi di incastri e movimenti sinuosi si riadatta il famoso balletto. Segue poi la danza spagnola che resta un alto esempio della tecnica e dello stile di questo corpo di ballo, il quale maestralmente fonde le acrobazie alla tecnica del classico. Ai passi si affiancano gli strabilianti abiti della maison francese On Aura Tout Vu, firmati da Livia Stoianova e Yassen Samouilov consacrati al successo per la collaborazione con l’estrosa popstar Lady Gaga. Il sentimento amoroso, che lega Marie e il principe schiaccianoci, si muove in questo balletto tra sfuggenti passi a due dove il volto del principe, interpretato da Zachary Clark, appare travisato con una palla avvolta da tanti aculei, il dramma del corpo che cambia e che bisogna nascondere. Le punte dei difetti personali che tanto affollano i pensieri degli adolescenti sino a far trasudare la morbosa attenzione al corpo in uno schiaccianoci che si mostra scorticato, strappato di ogni lembo di pelle, mostrando i muscoli a vivo. Sino a quando il sentimento come una ritrovata tenerezza e ingenuità si armerà non delle acuminate frecce di amore, ma di un semplice tocco di dita. Una ritrovata ingenuità e tenerezza farà comprendere l’altro, e la fisicità diventerà una scoperta, sino al momento topico quando l’indice di Marie, ormai vincitrice delle paure sfiora il petto del principe, e con il tocco di un polpastrello apre il cuore ai sentimenti vincendo ogni titubanza.
LA CENERENTOLA [Mirko Gragnato] Verona, 4 Febbario 2016
Opera Futura allestisce La Cenerentola dai colori rosati e dalle luci tenui, che con la regia di Paolo Panizza e la direzione di Sebastiano Rolli intreccia con passi di danza le voci dell’Accademia del Teatro La Scala. La direzione di Sebastiano Rolli sin dall’ouverture si mostra misurata, quasi trattenuta, mancando spesso il vero crescendo rossiniano e la variopinta tavolozza di colori che vanno dal pianissimo sino alle vette del fortissimo. Si apre il sipario: scale oblunghe, finestre oblique e un grande camino, che troneggia sul palco, pensato come la bocca di un grande mascherone; un focolare come si possono trovare nella splendida Villa della Torre che abita i pendii del valpolicella. Le scene nelle loro linee di instabilità ricordano qualche quadro di Escher o una casa tratta dall’illustrazione del mondo alicesco di Carrol. Fin da subito le dispotiche Clorinda e Tisbe, interpretate da Cecile Lee e Chiara Tirotta, acconciate con grandi chiome e abbigliate da svolazzanti tessuti sostenuti da crinolina, mostrano una buona intesa vocale e scenica anche se manca ancora quella matura consapevolezza del ruolo sul palcoscenico, che solo l’esperienza potrà dare. Della Cenerentola di Aya Wakizono con un timbro leggero, seppur con maggior consapevolezza nel ruolo, sembra un po’ in difficoltà sulle note gravi che la partitura richiede cercando di ovviare con un vibrato che le viene naturale ma che svanisce sulle note più acute, dove mostra chiarezza e limpidezza vocali. Le due sorellastra fan ben intendere alla povera cenerentola che è bene finirla ” con la solita canzone” armandosi di mattarelli minacciando di suonargliele di santa ragione. L’arrivo di un mendicante, che in realtà è il buon Alidoro maestro del Principe, travisato per meglio cogliere le virtù delle fanciulle che abitano la casa di Don Magnifico vedrà ben schierate le egoiste figlie del barone contro la tenerezza di cuore della povera Cenerentola. Segue il coro in tenuta di gala, in abiti da ufficiali, recando l’invito al ballo per le ” figlie amabili di don Magnifico” destando tutta l’attenzione di Clorinda e Tisbe. Qui la geniale invettiva del regista Paola Panizza che in ” Cenerentola vien qua… va là… va su… va giù” in un deliro di richieste e capricci grazie all’intervento di tre ballerine fa realmente in quattro la povera Cenerentola. L’arrivo di Don Magnifico che “col cicì ciùciù di botto” viene svegliato è interpretato da Giovanni Romeo. Nell’aria “Miei rampolli femminini” sarà per i tempi un po’ più trattenuti del maestro Rolli ma il Romeo ne esce un po’ affaticato, mentre invece nell’azione scenica riesce ottimamente nella macchietta del aristocratico decaduto imbacuccato nella lunga camicia da notte. Il giovine Don Ramiro di Pietro Adaini fa la sua apparizione negli abiti del cameriere, trovandosi sulla scena deserta, ed è forse colui che ha il timbro più bello e che con leggerezza sfiora le note più acute della parte tenorile, anche se punta a non osare troppo già nel primo atto risparmiando più le energie per il secondo. Resta da dire che in “un soave non so che” mostra tecnica capace nelle leggere e agili scalette e brevi trilli, producendo un pregevole binomio tra tecnica e timbro. Ma la vera sorpresa di questa Cenerentola è il baritono Modestas Sedlevicius, un Dandini sicuro nella parte vocale quanto nel ruolo sulla scena, così convincente nel travisato principe damerino tutto cipria, giacchetta, e ovviamente, per fare un po’ il verso ai fighetti del nostro tempo, con un ciuffo ben costruito dal coiffeur. Sedlevicius con amiccamenti e movenze interpreta appieno quel “Io recito da grande, e grande essendo, grandi le ho da sparar” oltre ad esser apprezzato dal pubblico si guadagna anche la sua simpatia. Ottima la Wakizono in “un’ora sola” e poi tutto il cast nel quintetto “nel volto estatico” tocca punte di patetismo accompagnate dalla direzione legata e trattenuta del maestro Rolli che qui conferisce un ottimo legante d’insieme. L’Alidoro di Simon Lin per tutte le parti di solo tra cui merita “là del ciel nell’arcano profondo” si mostra un basso dalla tessitura piena e completa, sia nei toni gravi sia in quelli più acuti, un cantante maturo che nonostante le origini orientali non segue semplicemente la parte pedissequamente ma la vive appieno mettendo quanto c’è di proprio e personale nel ruolo. Ecco che ne “il cocchio mio su cui voli a trionfar” il buon Alidoro mostra di aver il tocco fatato nel far giungere una luminosa carrozza, che sembra uscita esattamente da un libro di favole, proprio come la zucca tramutata magicamente nella fiaba di Perrault. Questi alcuni assaggi del primo atto, ma ancora la scena dei cantinieri con il divertente serpentone che il coro compie scrivendo il proclama, che don magnifico detta in preda al brio alcolico, poggiando sulla schiena l’uno dell’altro in una lunga fila indiana barcollante. Sino al gioco di pedane girevoli che porta alla formazione di un ponte dove il coro finale del primo atto “Mi par d’essere sognando fra giardini e fra boschetti” con una sorta di coreografia di gruppo mescola movenze e cantato tra il comico e il falecio soprattutto nel “gorgheggiando gli augelletti”. Del secondo atto la scena topica del temporale rossiniano non poteva che essere reinventata dai passi di danza che condiscono la scena con quel tocco ironico che affida ai ballerini parti semi serie e grottesche che in tutta l’opera segue un filo conduttore di comicità, secondo le coreografie di Lino Villa. Le scene di Franco Armieri mantengono un tocco di semplicità, dove i colori si fondano e si alternano venendo arricchiti dalle luci del regista Paolo Panizza, che nei frangenti di riflessi e chiari scuri permette alla semplicità di acquisire una dimensione ulteriore, come nel caso della sala del trono, richiamando stili di designer e artisti del secondo ‘900, dalla pop art al minimalismo, sfiorati dalla luce e rendendo i colori tenui delle scene più vivi. Il culmine si raggiunge nella scena finale dove tutto il cast popola il palcoscenico nel quale le precedenti scene delle sale si aprono, così come si aprono le pale di un organo, e aprendosi danno la struttura ad una cappella, che ricorda i modelli della città ideale del rinascimento, proprio come quella famosa disegnata da ignoto e conservata alla galleria di Urbino. Il coro ne “della fortuna istabile” prepara il finale gioioso de “il tutto cangia” mentre Cenerentola di Wakizono chiede la clemenza e il perdono con agili passaggi in acuto che ritroviamo nel “nacqui all’affanno” lasciando il teatro in un silenzio estatico. Magari un mezzosoprano con qualche fragilità sul grave ma che non teme le altezze elevate della parte, anzi mostra abile capacità e dominio nella parte sopra il pentagramma come il pregiato “non più mesta” che chiude il dramma giocoso di Jacopo Ferretti musicato da Gioacchino Rossini. Una regia semplice ma dalla sobrietà vincente, dove le azioni dei cantanti vengono intrecciate da ballerini e mimi, dove l’azione passa dall’intreccio ritmico melodico ai passi di danza arricchendo di umanità le scene di questa Cenerentola. La messa in scena è a tutti gli effetti una favola, una favola sincera e genuina che sicuramente ha lasciato una morale, un qualcosa su cui riflettere al pubblico che ha riempito il teatro, e soprattutto ai tanti bambini venuti a vedere l’opera. Quello prodotto da Opera Futura per la stagione della fondazione Arena resta un allestimento vincente, che fa i conti con i tempi difficili e cerca di mediare con le ristrettezze portando ad un felice risultato. Uno spettacolo godibile, ricco, divertente e dove nuovi talenti solcano il palcoscenico del filarmonico nel lungo percorso di esperienze che li porterà probabilmente alla crescita e al successo. E chissà al “trionfo della bontà” d’animo ma soprattutto della voce.
LA VOIX HUMAINE/SUOR ANGELICA [Renata Fantoni e William Fratti ] Firenze, 5 febbraio 2016.
Sulla scia di proposte culturali meno scontate, un po’ distanti dal solito repertorio, l’Opera di Firenze propone un dittico tutto al femminile. Chi attendeva una scenografia costruita attorno al telefono di Elle è indubbiamente rimasto deluso, poiché l’opera è stata inaspettatamente eseguita in forma di concerto. Ciononostante l’atto unico di Poulenc non ne ha risentito, poiché Annick Massis, dal momento in cui è entrata in palcoscenico, ha riempito lo spazio vuoto con la sua invidiabile presenza. Visibilmente indisposta non riusciva a prendere posto sullo sgabello, ma ciò non ha minimamente scalfito la resa vocale cristallina, ricchissima di fraseggio pregevole e raffinato. La sua Voix Humaine è carica di emozioni bipolari, dalla tristezza infinita alla gioia più grande, passando per il rammarico, la rassegnazione, la tensione, l’ansia, l’agitazione, l’attesa e le mille sfaccettature sapientemente descritte da Francis Poulenc e accortamente rese con il canto dal soprano francese. La accompagna un bravo Xu Zhong alla guida della precisa Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con suoni limpidi e puliti. Lo stesso nitore lo si riscontra anche nella direzione della successiva Suor Angelica, dove però l’eccessiva meccanicità va a discapito dello sviluppo sentimentale ed emotivo del dramma, oltre a prevaricare le voci in alcuni punti, complice anche la pessima acustica del teatro. Lo spettacolo di Andrea De Rosa creato un anno fa per il Regio di Torino è sempre efficacissimo, perfettamente filologico pur lontano dalla tradizione e da trasposizioni insensate. È un allestimento che fa pensare molto, soprattutto in questi giorni di polemica sui diritti civili: Angelica è stata privata del diritto di essere madre e crescere la sua creatura da una famiglia che voleva evitare uno scandalo, cui la chiesa si è resa complice attraverso la reclusione di un innocente che doveva scontare chissà quale peccato. Non c’è alcunché di spirituale in questa storia; dopotutto resta solo l’umano dolore di una mamma che sopravvive al figlio. E infine non c’è alcunché di mistico neppure nella grazia ricevuta dal cielo, ma solo l’inconscia capacità di perdonarsi nel momento del delirio causato dal veleno, anche grazie al gesto toccante di una paziente – indubbiamente più altruista delle sue carceriere – che le regala il proprio bambino – una bambola – per cercare di placare le sue angosce. E Angelica trova la pace prima della morte. C’è poco da aggiungere in merito all’interpretazione di Amarilli Nizza, che è arrivata ad un’interiorizzazione tale del personaggio che non può più neppure superare se stessa. L’alternare Verdi a Puccini nel corso della sua carriera l’ha vista centrare numerosi bersagli: il suo canto verdiano è al servizio della parola scenica attraverso l’accento e un fraseggio prevalentemente teatrale, mentre il suo canto pucciniano si presta al libretto in maniera più emotiva lasciando prevalere un fraseggio più realistico. Ogni volta in scena non si percepisce la presenza di Amarilli Nizza, ma solo il grandioso personaggio creato dalla mente geniale di uno o l’altro compositore. Argomentazione simile anche per quanto riguarda Anna Maria Chiuri, che negli ultimi anni si è imposta come interprete di riferimento in molti ruoli grazie ad una musicalità arricchita di morbidezza e duttilità che le permettono di primeggiare in diversi repertori. Oltre a Nizza e Chiuri arrivano dalla produzione di Torino anche le brave Silvia Beltrami, Claudia Marchi e Valeria Tornatore. Altrettanto efficace la suor Genovieffa di Patrizia Cigna accanto alle altre suore interpretate da Romina Tomasoni, Elisabetta Ermini, Marta Calcaterra, Irene Molinari, Tonia Langella, Simona Di Capua, Silvia Mazzoni, Paola Leggeri. Ottimo il Coro femminile e il Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino guidato da Lorenzo Fratini. Una particolare nota di merito ai figuranti speciali: Nenè Barini, Edy Bartolett, Sabina Cesaroni, Gaia Mazzeranghi, Patrizia Poeta, Jane Tayar.
IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO [Lukas Franceschini] Milano, 5 febbraio 2016.
Dopo il doppio appuntamento verdiano, nel cartellone del palcoscenico milanese torna l’opera barocca con l’oratorio di Georg Friedrich Händel nello spettacolo di Jürgen Flimm e Gudrun Hartmann. Al Teatro alla Scala per la prima volta nella sua lunga storia è stato rappresentato l’oratorio di Georg Friedrich Händel Il trionfo del tempo e del disinganno. La partitura fu composta e rappresentata a Roma nel 1707 quando il giovane compositore fece un viaggio di formazione per la durata di circa trionfo 1tre anni in Italia, soggiornando anche a Firenze, Napoli, Venezia. Nella capitale dello stato pontificio Händel entra con facilità nell’ambiente musicale molto prolifico delle corti private dei nobili cardinali romani. Era di casa dai Colonna, dai Pamphilij, dagli Ottoboni e dal marchese Ruspoli. Riceve in questo periodo molte commissioni di musica sacra tra cui l’oratorio in oggetto il cui titolo originario era La bellezza ravveduta nel trionfo del tempo e del Disinganno il cui autore del libretto fu il suo protettore Benedetto Pamphilij. La forma oratoriale del tempo non differenziava molto dall’opera lirica pur nella sua caratterizzazione per soggetto religioso o allegorico e la suddivisione in due parti. Nella Roma del ‘700 era lo spettacolo più rappresentato poiché l’opera lirica pubblica fu bandita perché ritenuta covo di malcostume e corruzione. L’oratorio “Il Trionfo” per quanto definito tale non s’identifica nello specifico dramma religioso ma non è nemmeno un’opera lirica essendo i quattro protagonisti personificazione di concetti astratti e non è possibile definirla neppure cantata per le ampie dimensioni. Potremo definirlo un “esemplare musicale” che raccoglie tutte le caratteristiche predette, nelle quali prevale una serie di arie di estrema raffinatezza in un alternarsi si situazioni e sentimenti contrapposti. Il tema principale è la relazione tra la falsità dei pacieri terreni e la verità della vita eterna, pertanto il libretto stilato dal cardinale è pressappoco una disputa sia morale sia teologica su un tessuto drammatico. Lo spettacolo cerato a Zurigo nel 2003 e coprodotto con la Staatsoper di Berlino era curato nella regia da Jurngen Flimm e Gudrun Hartmann, con scene di trionfo 3Erich Wonder e costumi Florence von Gerkan. L’idea registica un po’ bizzarra di ambientare l’erudita discussione fra Bellezza, Piacere, Disinganno e Tempo, attorno ad un tavolo di un elegante bistrot (si poteva scorgere la celebre Cupole di Parigi) trova una drammaturgia anche reale. I personaggi interagiscono con il mondo che affolla il locale, camerieri, venditori di passaggio, lavoratori. Penso che l’impianto della regia si fosse sviluppato sul concetto del comune mortale che discetta dotti argomenti, affrontando anche una conversazione morale-teologica seduta alla tavola del banchetto. La scena è astratta determinando che la discussione è adatta a tutte le epoche e non circoscritta a un periodo preciso. Tale concezione è rafforzata da costumi di varie epoche, dal segno della verità fuori dallo spazio scenico, cui fa da contraltare l’organo e il musicista settecentesco che si riferiscono al periodo della composizione. La scena è di forte impatto e molto elegante, cui contribuiscono dei costumi di raffinata sartoria, anche se è lecito rilevare che il personaggio di Disinganno poteva essere più curato. Musicalmente abbiamo apprezzato l’ottima orchestra del Teatro alla Scala su strumenti storici in collaborazione con “I Barocchisti” che ha reso il perfetto stile handeliano con una sonorità elettrizzante. Merito anche del direttore Diego Fasolis, esperto e filologico esecutore, che ha concertato la difficile partitura con assoluta competenza e ha vivificato le numerose arie con mano energica e altrettanta eleganza, calibrando con precisione e perizia la sonorità orchestrale con quella delle voci, le quali hanno avuto anche il pregevole apporto di frizzanti variazioni nei da capo delle arie. Nel cast primeggiava il Disinganno di Sara Mingardo, autentica raffinata cantante con stile inappuntabile e una precisione stilistica da manuale, sia nel recitativo sia nelle difficili arie. Leonardo Cortellazzi, Tempo, ha offerto una prova convincente e si sta affermando come uno dei maggiori interpreti in questo repertorio. Fornito di timbro caldo, pieno e sorretto da una tecnica rilevante, ha reso il ruolo con estrema precisione e incisività su colori e fraseggio. Lucia Cirillo, Piacere, ha offerto una pregevole interpretazione in ruolo di estrema difficoltà. Precisa nelle acrobazie vocali, anche se non sempre stilizzata, ha saputo reggere il ruolo con estrema eleganza e un’interpretazione molto emozionante soprattutto nell’aria “Lascia la spina”. Martina Jankova, Bellezza, era l’unica della compagnia con voce non particolarmente seducente e uno stile non sempre preciso, ma nel complesso portava al termine il suo compito con onore. Spettacolo e partitura sicuramente non facili e d’ascolto impegnativo che ha conquistato il numeroso pubblico in sala, il quale al termine ha tributato un vibrante successo a cantanti, direttore e orchesta. Ancora una volta questo repertorio è affrontato e messo in scena ai massimi livelli qualitativi, con scelte artistiche accurate e studiate, soprattutto in ambito musicale, senza tralasciare comunque l’importanza dell’intero allestimento.Diego Fasolis è un eccellente concertatore, perfetto nello stile e sul podio dell’Orchestra del Teatro alla Scala – che per l’occasione è stata dotata di strumenti storici ed impreziosita con la presenza de I Barocchisti della RSI Radiotelevisione Svizzera – dirige con notevole eleganza la bella partitura di Händel, lasciando uscire il lato più drammatico dell’oratorio, che pare perfetto in questa esecuzione che ne prevede la forma scenica. Ottima la prova degli strumentisti, in primis Gianluca Capuano e Paolo Spadaro Munitto al clavicembalo, nonché la spalla di Fiorenza De Donatis.Lo spettacolo firmato da Flimm e Hartmann, originariamene prodotto a Zurigo nel 2007, è efficacissimo nello sviluppo della drammaturgia, oltre ad essere piacevole da seguire, raffinato nelle scene di Erich Wonder e nei costumi di pregevole fattura di Florence von Gerkan, opportunamente accentuato nell’intimo terrore di Bellezza, modernissimo in tal senso, quasi a presagire le vicissitudini de L’affare Makropulos. Ottima la recitazione dei quattro protagonisti, resa ancora più accattivante dall’incessante interagire con i bravissimi mimi, che si prodigano anche in continue controscene e coreografie ad opera di Catharina Lühr. Non tutte le scelte di regia sono chiare e comprensibili, ma fanno pensare, come in una logica di simbolismo parzialmente inconscio, dunque la resa complessiva è davvero positiva. Molto buona è anche la qualità vocale, soprattutto nello stile e nel gusto, grazie alla presenza di cantanti specializzati nel repertorio barocco. Martina Janková è Bellezza, eccellente interprete nel personaggio, cristallina e brillante nella voce graziosa, anche se non arriva a toccare nel profondo le corde emozionali. Ottime le note basse in “Voglio cangiar desio”. Lucia Cirillo è Piacere, anch’ella riuscitissima nella caratterizzazione del ruolo, perfetta nello stile, ma apparentemente indisposta, poiché la voce appare a tratti sfibrata o stimbrata, pur riuscendo molto positivamente in “Lascia la spina”. Sara Mingardo è un Disinganno esemplare e pregevole, la linea di canto morbidissima ed omogenea, la resa di arie e recitativi sinceramente toccante, soprattutto la commovente “Crede l’uom ch’egli riposi”. Molto buona anche la prova di Leonardo Cortellazzi nei panni del Tempo, pur con qualche imprecisione nelle agilità di certe pagine, tra cui “Folle, dunque tu sola presumi”. Entusiastica la riuscita del bellissimo quartetto “Voglio tempo per risolvere”. Meritatissimo successo per tutti gli artisti al termine della bella serata.
LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE [Lukas Franceschini] Venezia, 11 febbraio 2016.
Preziosa proposta quella del Teatro La Fenice in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane, Centre de Musique Romantique Française, al Teatro Malibran è stata allestita per la prima volta in Italia l’opéra-bouffe Les Chevaliers de la Table ronde di Louis-Auguste-Florimond Ronger, detto Hervé. “E’ una delle miei migliori partiture, ma non sono le cose migliori ad avere successo presso il pubblico…” table 2Così scriveva Hervé nel 1881 a un critico teatrale. In effetti, non aveva tutti i torti ma la vita artistica del compositore fu molto alterna e messa in ombra (anche da una non nascosta rivalità) dall’altro musicista francese d’operette Jacques Offenbach. Harvé non è solo compositore, scrive i versi, la prosa e i soggetti delle sue opere, cantante (interpretava la maggior parte dei ruoli principali dei suoi lavori e anche di altri), si occupava della messa in scena e di tutto il lavoro di produzione. Muovendosi con difficoltà nella Parigi musicale di metà ‘800 deve interrompere la sua produttività per guai giudiziari (corruzione di minore) cui segue un periodo di carcere e un successivo peregrinare nella provincia francese spingendosi addirittura in Africa del Nord. Deve ricominciare tutto da zero. Offenbach intanto mieteva successi straordinari e si accaparrava i migliori teatri table 3della capitale per il genere. A Hervé non resta che accontentarsi di sale minori come il Théâtre de Délassements-Comiques per poi passare al Théâtre des Variétés nel quale presenterà il suo primo vero successo L’oeil crevé (1864). Offenbach, che monopolizzava la scena parigina, ebbe dei contrasti con la direzione del Théâtre des Bouffes-Pariseins e questa diatriba dette l’occasione per Hervé di presentare l’operetta in tre atti Les Chevaliers de la Table ronde il 17novmebre 1866. Non fu un trionfo ma nemmeno un fisco clamoroso. I parigini erano impegnati in altri ascolti (Mignon e La Vie parisienne), inoltre il soggetto leggendario, seppur attualizzato e table 4molto diverso, non entusiasmasse e i critici non erano dalla parte di Harvé causa un libretto che burlava dei mitici cavalieri. Il compositore credeva fermamente nel suo spartito tanto che nel 1872 ne propose una nuova versione, la quale ebbe un po’ più di fortuna della precedente, ma solo veicolata al territorio francese. Oltre confine il silenzio totale. Eppure l’opera-buffa di Hervé è molto divertente e ha pezzi di grande interesse, ad esempio il ritornello dei cavalieri che suona come una Marsigliese buffa, grandi ballate e arie sillabate tipiche dell’opera buffa settecentesca, ma va rilevato soprattutto il talento del compositore capace di grande ironia e raffinata musicalità ed è un peccato che sia cosi poco conosciuto. La proposta del Bru Zane e Fenice è pertanto di assoluto interesse offrendo al pubblico un repertorio oserei affermare quasi sconosciuto attualmente. La produzione è stata realizzata dalla Compagnie Des Brigands nella quale emerge un lavoro, più che sul singolo, sull’intero cast di attori e ballerini tipici dell’operetta, sfavillanti, dal senso teatrale ritmico incalzante e una vis comica di prim’ordine. Spettacolo itinerante, per questo volutamente snello ma elegante, con un impianto fisso senza una connotazione storica, potrebbe table 5essere una scena di grande produzione d’avanspettacolo di serie “A” alla quale ci siamo disbituati. Porte girevoli che permettono entrate e uscite repentine, costumi variopinti, divertentissimi di vario stile tra il moderno e lo storico. Tutto questo era realizzato con grande garbo e stile ironico da Pierre-André Weitz che firma regia, scene e costumi, ma sono soprattutto la verve, il brio e l’impatto frizzante che egli è riuscito a infondere all’intera compagnia a colpire lo spettatore, il quale segue i tre atti in un sol fiato senza intervallo divertendosi e ridendo con gusto. Le allusioni sociali, sessuali, atemporali non si contano e sono tutte azzeccate. La partitura utilizzata è una trascrizione per tredici cantanti e dodici strumenti da Thibault Perrine e funziona benissimo nella concertazione di Christophe Grapperon, che dirige sempre con polso brillante e senza perdere colpo di ritmo. La compagnia di canto era composta dagli artisti stabili de Les Brigands, i quali si cimentano in una recitazione teatrale vibrante e indemoniata, cui è parallelo un canto forbito e professionale anche se la precisione stilistica non era omogenea per tutti, ma il comune denominatore di un genere operistico, opera-bouffe in stile comique, era garantito. Per tali principi mi esento da una singola considerazione ma table 6accomuno tutta la compagnia in un plauso meritevole: Damien Bigourddan (Rodomonte), Antoine Philippot (Sacripante), Arnaud Marzorati (Merlino), Mathias Vidal (Medoro), Ingrid Perruche (Duchessa Totoche), Lara Neumann (Angelica), Chantal Santon-Jeffery (Melusina), Clémentine Bourgoin (Fleur-de-Neige), Rémy Mathieu (orlando), David Ghilardi (Adamigi), Théophile Alexandre (Lancillotto), Jérémie Delvert (Rinaldo), Pierre Lebon (Ogier). Successo strepitoso da parte del pubblico che purtroppo non affollava il Teatro Malibran come l’operazione culturale meritava, ma fiduciosi che tale scoperta continui con altri capolavori della musica francese.
TOSCA [Margherita Panarelli] Torino, 14 febbraio 2016.
Prosegue con Tosca di Giacomo Puccini l’ottima stagione del Teatro Regio di Torino: al timone dell’orchestra Renato Palumbo e la regia è di Daniele Abbado; María José Siri, Roberto Aronica e Carlos Álvarez i protagonisti. Una regia quella di Abbado concentrata sul privato dei protagonisti più che sull’ambiente nel quale si svolge l’azione, nonostante Roma sia presente attraverso le proiezioni (curate da Luca Scarzella) e le suggestioni sonore pucciniane. Gli ambienti sono stilizzati: tutto, o quasi, si svolge su una piattaforma rotante, spazio che sembra diventare sempre più soffocante e claustrofobico man mano che la vicenda si dipana, fino alla completa apertura del terzo atto, in cui unico suggerimento visivo dell’ambientazione è un enorme angelo. I costumi, di Luigi Perego come le scene, sfuggono ad una precisa collocazione temporale e amalgamano elementi del tempo del libretto ed elementi più moderni, in particolare dagli stili della prima metà del ‘900, quasi a voler trasportare la vicenda fuori dal tempo per collocarla in un tempo teatrale in cui resta immortale. La storia di Tosca, Cavaradossi e Scarpia è avvenuta in quell’epoca ma quello che ancora riescono a trasmetterci trascende tempo e luogo. María José Siri è una Tosca di strabiliante autenticità: dai capricci del primo atto, all’uccisione di Scarpia fino al suicidio finale. La voce è calda, dal timbro brunito, e il soprano rifugge ogni leziosità il chè rende la sua interpretazione fresca e genuina, sia dal punto vocale che dal punto di vista attoriale. Eccellente “Vissi d’arte” , vero momento culminante per il personaggio e per la cantante, che il soprano infonde di pietas sconfortata e autentica incredulità per la crudezza del fato. María José Siri è delicata e intensa, ed è riuscita a mostrarci la donna dietro la diva e le movenze. Forse meno sfaccettata l’interpretazione di Roberto Aronica nei panni di Cavaradossi, ma sicuramente è un valido coprotagonista sotto tutti i punti di vista. La prestanza vocale, lo slancio eroico nel secondo atto, la chiarezza di intenti e di espressione, in una performance sobria ma assolutamente efficace, rendono il suo Cavaradossi una figura energica quanto dolce e malinconica: delicato tocco della regia nel non far credere al pittore che l’esecuzione sia davvero simulata ma nel farlo stare al gioco con l’amata per posticiparle il più possibile un grande dolore. Elegante, insinuante, macchiavellico e autentico predatore dalle sembianze e dalle movenze feline. Questo lo Scarpia di Carlos Álvarez, che nasconde le proprie pulsioni abilmente sotto un’apparenza da vero gentiluomo fino al momento di scattare sulla ambita preda. Uomo politico, che non si sporca le mani se non perché non può fare altrimenti, abituato ad ottenere tutto e a non doversi scomporre eccessivamente per farlo, grazie alle sue macchinazioni. Se nel “Te Deum” il baritono è sovrastato non soprende e non deve sorprendere proprio per la natura della voce di Carlos Álvarez, i cui punti di forza sono la parola, quindi il fraseggio e la bellezza di un timbro qui usato sapientemente per rappresentare al meglio il carattere insinuante e mellifluo del personaggio. Azzeccatissime anche le figure di contorno, in particolare il Sagrestano scontroso di Roberto Abbondanza e l’Angelotti eroico di Gabriele Sagona. Eccellenti Luca Casalin nei panni di Spoletta, Nicolò Ceriani in quelli di Sciarrone, Lorenzo Battagion in quelli del Carceriere e il pastorello di Fiammetta Piovano. Renato Palumbo accompagna sapientemente in cantanti dal podio, a tratti esigendo dall’orchestra un suono troppo fragoroso, e la sua direzione è efficace e suggestiva. Ottima la prova dell’orchestra e dei cori, sempre preparati da Claudio Fenoglio. Calorosi gli applausi che il pubblico torinese di questa recita pomeridiana riserva a tutti gli interpreti.
L’OCCASIONE FA IL LADRO [William Fratti] Parma, 19 febbraio 2016.
Il Teatro Regio di Parma, dopo il fortunato esperimento di un paio di anni fa, torna ad allestire un’opera in collaborazione con il Conservatorio di Musica Arrigo Boito, dimostrando il suo impegno nella formazione e l’importanza che riconosce nei giovani interpreti. Incarico lodevole se non fosse eseguito a spese degli abbonati, che si trovano questa produzione, seppur di un certo livello, ad occupare un terzo del loro abbonamento a dei prezzi che non sono propriamente in linea con la qualità corrisposta. Ci sono altre istituzioni fortemente impegnate nell’istruzione e nella preparazione, con rinomate accademie e conseguenti messinscene, tra l’altro molto seguite dal pubblico, anche straniero, ma i prezzi dei biglietti sono decisamente differenti. E questo è proprio uno dei maggiori difetti del Teatro Regio di Parma: anche al botteghino si fregia di un grande nome che non ha più, poiché nei blog, nei forum e in alcuni corridoi è diventato invece occasione di scherno. Ancora una volta a firmare la regia della produzione giovanile è il bravo Andrea Cigni, che costruisce la sua vicenda all’interno dell’oggetto che ha creato tutti gli equivoci tra i vari personaggi: un’enorme valigia – ad opera dello scenografo Dario Gessati. Come sempre il lavoro sugli interpreti è eccellente, tanto nella gestualità quanto negli sguardi, come pure l’uso dei mimi e la costruzione di alcune controscene. Peccato per la caduta di stile con il ballettino nel terzetto Alberto, Parmenione, Martino e col giro dei ritratti nel quintetto. A parte ciò la regia è piacevolissima e, con l’aiuto dei bellissimi costumi di Simona Morresi, a tratti ricorda Stanlio e Ollio, i fratelli Marx e Charlie Chaplin. Giustamente identificato anche geograficamente, il viaggio per Napoli parte da Parma e subito si inizia a sorridere. Alessandro D’Agostini dirige con grande efficacia e sicurezza d’intenzione l’Orchestra del Conservatorio di Musica Arrigo Boito, che ancora una volta dimostra di sapersi districare molto bene anche all’interno di partiture complesse: le farse rossiniane, contrariamente a quanto pensano certi melomani parmigiani, sono tutt’altro che “operette” – per usare un loro termine. E se questo è il modo per portare un nuovo Rossini a Parma che non siano le solite quattro grandi opere comiche, allora ben venga, anche se basterebbe molto poco per alzare notevolmente ed indiscutibilmente il livello: non si può certo rivaleggiare con l’accademia di Pesaro, ma un responsabile musicale di comprovata esperienza al ROF e accanto a Zedda, da affiancarsi ai coordinatori della Scuola di Canto del Conservatorio, incrementerebbe a dismisura la qualità di questi spettacoli. Nao Yokomae è una brava Berenice, inizialmente non troppo intonata, ma poi puntuale e precisa, soprattutto nel duetto con Parmenione e nell’aria finale, anche se lo stile di canto è tutt’altro che rossiniano. Manuel Amati, che abbiamo già ascoltato in piccoli ruoli in altre produzioni, nei panni di Alberto dimostra indiscutibili doti di attore; in quanto alla voce si percepisce un ottimo potenziale, ma è ancora molto giovane e le imprecisioni ancora tante. Sarebbe auspicabile che si facesse ascoltare da un insegnante specialista nel repertorio rossiniano, poiché ha una vocalità molto particolare e non è detto che debba essere trattata come le altre. Tanta limpidezza non deve essere sprecata. Jaehong Jung è un bravo Parmenione, molto ben impostato e ben timbrato, seppur non troppo brillante e tende ad inserire troppe h nelle agilità. Molto bravo il Martino di Nicolò Donini che riesce davvero bene sia nell’interpretazione sia nel canto. Nota più che positiva per l’Ernestina di Federica Cacciatore, un poco tirata negli acuti, ma naturalmente dotata di grande musicalità e begli armonici. Efficacissimo il simpatico Eusebio di Davide Zaccherini. Sinceri e meritati applausi per tutti.
STRINGS [Mirko Gragnato] Verona, 9 febbraio 2016.
Il Corpo di Ballo dell’Arena di Verona con primi ballerini ospiti Dongting Xing e Dane Holland propone un balletto dal sapore contemporaneo, dove si intrecciano in un nodo coreografico i passi di danza e corde, rievocate dal violino virtuoso di Anna Tifu. Sciogli e lega “solvit et coagula” queste le parole che si leggono sulla carta del diavolo nei tarocchi marsigliesi, e su questa duplicità di legarsi e sciogliersi si muove la prima parte di queste balletto dove lunghe corde tese, tra il palcoscenico e le quinte, si aggrovigliano e si intrecciano con i passi del corpo di ballo. Lungo un percorso che va dalle musiche di Kreisler sino all’adagio per archi di Barber, viviamo un crescendo di pathos, un ridursi dei ballerini che da un passo a cinque arrivano ad un passo a due sino ad una coreografia quella dell’adagio dove seppur ritorni il numero dei cinque, in realtà essi sembrano isolati, ognun per sé, distanti in una tensione che li porta quasi a sfiorarsi. Così come il titolo si lega ai ballerini attraverso fili e corde, lo stesso si ha nella musica con un programma interamente concentrato sul violino, strumento della famiglia degli archi e in inglese della famiglia delle corde, “Strings” come il titolo affidato a questo balletto. Come nelle sale prove di danza un pianoforte è accomodato in sala, tra le prime file della platea accanto al proscenio, Pietro Salvaggio e Anna Tifu sono i conduttori musicali che daranno la musica a questa prima parte, permettendo ai candidi crini di sfregarsi sulle corde d’acciaio in uno scontro tra delicatezza e tensione che dal violino passa al palcoscenico nei passi di danza. Se string 1nel preludio allegro di Kreisler e nelle danze rumene di Bartòk si manifesta una dimensione giocosa e divertente, con il passo a tre, sulle note della Sarabanda dalla partita in re minore, si toccano momenti di patetismo e forte tensione emotiva. Alessia Gelmetti si alterna tra le braccia di Evghenij Kurtsev e Antonio Russo legandosi e slegandosi attraverso i fili prima l’uno e poi all’altro, in un contrappunto di corpi che segue la composizione di Bach. In un susseguirsi di prese, slanci e movimenti e intrecci col cordame, i diafani ballerini vanno poi a sparire nel fondale nero, restando sul palcoscenico, nella penombra, una sola ballerina, Donting Xing, allacciata come a delle cime che, al suono delle acute acciaccature del violino, lascia scivolare i lunghi fili che la trattenevano. Con lei Dane Holland inizia un pas de deux veramente emozionante, sulle note di uno dei pezzi più patetici di Rossini, “Del tuo stellato soglio”, così bello che lo stesso Paganini ne trascrive una variazione per violino. Le note tenute nelle altissime posizioni sulla quarta corda, che ne trattengono le vibrazioni e rendono i suoni più flautati, non fanno altro che accrescere la già forte tensione dei gradi congiunti ravvicinati dai cromatismi. In questo strascico di note i corpi dei ballerini si legano l’un l’altro per poi slanciarsi nel corso delle vivaci variazioni in agili balzi e prese, in una commistione di dolcezza e acrobazie che va a finire tra i vari salti violinisti delle veloci acciaccature sulla nota grave in un balzo con una presa, pregna di tenerezza. I movimenti dei ballerini non potevano meglio unirsi all’abile mano sinistra di Anna Tifu raggiungendo già con questo pezzo il culmine emotivo della prima parte, che con l’adagio di Barber, vuoi per i tempi tecnici per sistemare l’orchestra, vanno un po’ a scemare. L’ultima coreografia sembra sconfusionata, instabile, ogni ballerino è per sé, divisi anche dal colore dei costumi, unico elemento scenico, sul fondo, un telo bianco che pian piano viene arricchito dagli schizzi nervosi che i ballerini fanno escludendosi via via tra i passi e impadronendosi della tela. Anche l’adagio per archi è sicuramente un pezzo dove il pathos non manca, ma alcuni passi dei ballerini sembrano non ricalcare la linea melodica e le calde armonie di Barber, se non che nel finale quando Evghenij Kurtsev e Teresa Strisciulli si avvicinano a quel foglio ormai imbrattato, stringendosi e segnando col pennello i profili l’uno dell’altro nei gesti che poi simboleggiano un distacco, un dover allontanarsi senza volere, ma senza le forze per potervi porre contrasto. Con il calare delle luci questo loro abbandonarsi alle forze che li trascinano lontani li porta a denudarsi, a spogliarsi di ogni energia contrastante, in una arrendevolezza che li fa svanire al di là di quello stessa tela che ne evoca, ormai come ombre, solamente i loro confusi profili. Così si conclude la prima parte di questo balletto che non si può che definirsi egregia e di alto spessore per la qualità delle coreografie e la scelta delle musiche quanto più azzeccata, creando un binomio perfetto. Nella seconda parte sempre Anna Tifu accompagna i passi di danza con il concerto per violino di Beethoven. Un concerto talmente eseguito e noto che è difficile non lasciarsi trasportare dalla musica e seguire le cadenze del violino che, nonostante l’orchestra sia occultata nella buca, mette in secondo piano i passi dei ballerini. Sarà la coreografia che non sembra veramente coinvolgere, dove un palcoscenico totalmente scarno, denudato anche delle stesse quinte, resta popolato da degli scatoloni bianchi che prenderanno vita grazie ai ballerini che vi si nasconderanno al loro interno. Scatoloni che faranno poi piovere sul palcoscenico lembi di nylon che quasi come neve renderà il pavimento scivoloso per gli stessi danzatori, l’idea di farli passare con degli spazzoloni sulle note del concerto per sgombrare il palco non fa altro che mettere alla berlina una coreografia che sembra dialogare poco con la musica. La direzione del maestro Victor Hugo Toro, si scontra tra quelle che sono le necessità dello strumento solista e le necessità dei ballerini. L’orchestra non riesce a svincolarsi dall’accompagnare l’uno o l’altro orientandosi su un compromesso che dilata i tempi e svilisce le abilità di Anna Tifu, non permettendo di curare con la giusta premura le tante sfumature e finezze che il concerto di Beethoven racchiude tra i passaggi dello strumento solista e dell’orchestra, in una direzione poco orientata che spinge poco ad un risultato comune e condiviso. Ma nonostante questo, il pas de deux, che vede protagonisti i primi ballerini ospiti Dongting Xing e Dane Holland, sulle note del larghetto collima perfettamente nel binomio tra musica di Beethoven e danza. La musica struggente del secondo movimento, tra le lunghe note legate e i trilli misurati del solo e i pizzicanti degli archi, permette ai due ballerini di potersi muovere con piena naturalezza su un palco tinto di blu dove gli strascichi della pioggia di nylon crea un’ambientazione invernale quasi cajkovskijana. Così come per il passo a due sulle note di Rossini anche qui si sfiorano tensioni emotive di forte pathos permettendo alle due étoiles di mostrare tutte le loro abilità di danceurs. Purtroppo però sul salto che dal Re porta al La svanisce tutta l’atmosfera in questi slancio che dal larghetto porta alla splendida vivacità del rondò-allegro. Questo sicuramente resta la prova che un concerto per strumento solo è fatto più per dare ampio spazio al virtuosismo e alla musicalità del solista che per accoppiarsi con i passi di danza. Cosa diversa per i vari pezzi della prima parte tutte raccolte di danze o di variazioni svincolate ma rese quasi un corpus organico.Nonostante i tempi di grande allerta per l’orchestra e per il corpo di ballo, dobbiamo essere orgogliosi di quanto eseguito per questo balletto che mostra le abilità di quanto la Fondazione Arena custodisca tra le sue maestranze artistiche, che di questi tempi vengono prese di mira dall”aridità di bilanci poco accorti e decisioni prese alla leggera da chi purtroppo non ha mai imbracciato uno strumento. Renato Zanella direttore del corpo di ballo infatti ha rassegnato le proprie dimissioni, un grido soffocato per la situazione di amara tensione che in fondazione si respira.
JESSICA & ME [Mirko Gragnato] 20 febbraio 2016, Vicenza, Teatro Comunale
Attraverso una corporeità leggera, fatta di movimenti fluidi, contornati da fondali caleidoscopi e giochi di prospettive, Cristiana Morganti trasporta il pubblico in un viaggio sui perché del teatro alternando stupore e comicità in “Jessica & ME”. La Sala grande del Teatro Comunale di Vicenza è gremita per l’apertura della rassegna ” I Luoghi del Contemporaneo. Danza” ed è Cristiana Morganti, storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, che apre il calendario di eventi che vedrà alternarsi sul palco del Comunale varie compagnie tra cui ATERballetto.Vicenza, dopo le recite a Venezia, si mostra ancora una volta una città avanti a molte altre con un teatro all’avanguardia nel dialogo con il contemporaneo, ma anche di apertura verso il pubblico con biglietti dal costo contenuto e accessibile a tutti. Una politica che il teatro porta avanti, nonostante i tempi difficili per la cultura, con strenua tenacia e convinzione. “La camminata pregna di significato noooo!?!” con questa battuta di autoironia, che cerca di spezzare la seriosità del teatrante, inizia questo spettacolo. Le difficoltà di un corpo che cambia e di un’arabesque che nonostante gli sforzi deve fare i conti con una gamba che non sale come dovrebbe. Ecco quindi che l’artista riacquista quell’umanità sincera, fatta di difficoltà quotidiane e dei problemi comuni a tanti, certo non sempre per colpa di un’arabesque capriccioso, ma per esempio con una corsa fatta su un tappetino da palestra che non manca di fare la sua comparsa. Così Cristiana Morganti si leva di dosso i panni dell’artista intangibile ed etereo umanizzandosi ed entrando sin da subito in relazione con il pubblico; una risata risuonando nella sala indica che oramai il ghiaccio è rotto e lo spettacolo può veramente iniziare. “Lei vuole che io danzi o che io parli?” una domanda fatta ad uno spettatore a parole e con i gesti del linguaggio dei segni; parole e gesti, questo il magico intreccio che incarna la tecnica e lo spettacolo “Jessica & ME” altro solo di Cristiana Morganti dopo “Moving with Pina” del 2010. Parole e gesti, parole e azione, questo il fulcro del tanz theather che ha mosso i suoi primi passi negli anni settanta, dell’ormai secolo scorso, e che è stato tramandato a Cristiana Morganti attraverso le lezioni di Pina Bausch, scomparsa nel giugno 2009. Alternando una corporeità dai movimenti fluidi, quasi impensabili, che danno il peso e il valore della piena consapevolezza corporea, Cristiana mostra tutte le sfaccettature del teatro danza dialogando con il pubblico, su fondali che si alternano come un mondo caleidoscopico con sottofondo musiche etniche e dal sentore barocco suggerite da Kenji Takagi ed editate da Bern Kirchhoefer. Facendo poi la sua comparsa con un vecchio mangia nastri, anche quello del secolo scorso, porta sulla scena la voce stizzita e acida di un’improbabile ma possibile intervistatrice, Jessica, che attraverso incomprensioni e giochi di domande impertinenti permette, in un dialogo esilarante, di raccontare la storia di “Cristina, Tiziana…” Cristiana Morganti e del suo percorso a Wuppertal nel teatro-danza. Da qui parte un curioso confronto tra quella che è la storia di una giovane italiana, trapianta nella fredda e rigorosa Vestfalia, e le teutoniche compagne dove però, oltre all’arte del movimento e del teatro, le si insegna l’importanza del sorriso; il gesto che si mescola all’azione, la mimica che trascende il movimento, protagonisti del tanz theater, ci invitano ad una visione d’ottimismo nonostante le posizioni difficili e faticose, che non solo nella danza ci tocca affrontare. Segue poi un esilarante studio tecnico del gesto del fumatore, fatto con la stessa concentrazione e impassibilità che vede le ballerine alla sbarra impegnate con plié e tandu. Il tempo che passa, gli anni che ci portiamo addosso fanno poi i conti con un corpo che cambia, ed ecco una gigante Morganti proiettata, nei contorni di un fondale scuro, che pian piano scompare avvolta dalle manate di un inchiostro nero pece. La silhoutte cambia e, quasi come contenuta da un corsetto vittoriano, viene estremizzata sino ad ottenere un corpo dal vitino stretto e sottile; una critica forse al mondo delle apparenze, dove imperano le rifatte, o anche uno spunto per usare più spesso l’immaginazione al fine di forzare ed esasperare i cliché dell’estetica, ridicolizzandoli. Cristiana si avvia alla conclusione di questo spettacolo svestendosi e indossando gonne su gonne, in un trionfo di organza, che le mette addosso i panni della sposa. Sempre stravolgendo ruoli e costumi la si vede correre e saltare lungo il palcoscenico, mostrando gesti inconsulti che vengono, però, addolciti dal delicato planare e svolazzare dei candidi veli che ne avvolgono la corporeità. Ecco che accesa la sigaretta torna sul palco e stavolta, accompagnata da nuvolette fumose, ripropone live l’elaborata tecnica del gesto fumatorio. Lo spettacolo è pronto al termine quando scende tra il pubblico alla ricerca di un accendino, perché il suo, ormai scarico, l’ha tradita, un classico, una signora in terza fila, non curante delle ristrettive norme antifumo del teatro, raspa nella borsa e le presta il suo. Quando ecco che nel calare delle luci dove solo le braci scintillano ai suoi piedi inizia un lento rogo che la avvolgerà per intero consumandola nel silenzio delle luci spente. Emozionante, comico, stimolante e chiave di lettura per nuove riflessioni, lo spettacolo “Jessica & ME” permette di mettere in discussione il teatro, la danza, la gestualità nella sua veste seriosa andando a ricercare l’umanità che popola il palcoscenico, ritrovando nella semplicità delle emozioni l’autenticità della rappresentazione scenica, senza fondali, senza orpelli, ma solo con l’azione, mostrando un palcoscenico nudo e semplice, così come il teatro danza di Cristiana Morganti.
IL BARBIERE DI SIVIGLIA [Simone Ricci] Roma, 20 febbraio 2016.
A 200 anni esatti di distanza dalla prima rappresentazione, Roma ha ospitato un Barbiere di Siviglia dalle trovate moderne e frizzanti, al limite dell’esagerazione. L’inutil confusione: verrebbe voglia di riadattare in questo modo il titolo completo de “Il barbiere di Siviglia” nel commentare l’allestimento del Teatro dell’Opera di Roma per celebrare i 200 anni dalla sua prima rappresentazione. L’appuntamento era storico e importante, la Capitale (anche se nel 1816 la prèmiere avvenne al Teatro Argentina) ha accolto il capolavoro rossiniano con una regia interessante, ma al limite dell’esagerazione. Questa recensione si riferisce alla penultima recita in programma, quella di sabato 20 febbraio 2016. La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso tutto più solenne, poi il pubblico ha subito intuito di che prodotto si sarebbe trattato fin dalla prima nota della celebre sinfonia. Le illustrazioni curate da Francesco Calcagnini e i video di D-WOK hanno trasportato gli spettatori romani lungo le varie rivoluzioni della storia, a partire da quella francese, in modo da evidenziare il carattere rivoluzionario di quest’opera. I dittatori e i sovrani sono stati animati con la schiuma da barba del moderno Figaro, pronto a decapitarli un istante dopo. Un animale telecomandato ha attraversato più volte il palcoscenico: non si trattava di un gatto, una scelta che avrebbe evocato uno degli episodi più buffi e sfortunati della prima rappresentazione di due secoli fa, ma di un topo, ideato dal regista Davide Livermore in quanto elemento scomodo, sgradevole e in grado di “contrastare il primato dell’uomo sulla Terra”. La regia non ha alterato i rapporti tra i personaggi ma ha inserito troppi elementi sul palco, rischiando di confondere il pubblico: i costumi di Gianluca Falaschi erano all’insegna del bianco e del nero, come anche gran parte delle scene, spesso molto tetre. La presenza di ghigliottine, uomini e donne decapitate, sosia dei personaggi principali e un orso ha arricchito la storia, forse però ci si poteva limitare a meno trovate. Anche le gag e le soluzioni comiche sono risultate inizialmente divertenti, però alla lunga non hanno più convinto, in primis il braccio meccanico e rumoroso di Don Basilio: a ogni movimento si udiva il cigolio dell’arto, un suono sgradevole che rovinava quello dell’orchestra. La punta di diamante del cast vocale è stata senza dubbio Florian Sempey, un Figaro smaliziato e ammiccante, dotato di un timbro piuttosto gradevole, fonazione corretta, fraseggio vivace e un dinamismo interessante: la sfrontata sicurezza con cui si proponeva per organizzare le sue trame ha completato il tutto. Applausi convinti sono stati tributati anche a Ildebrando D’Arcangelo: nonostante la faticosa trovata della già citata mano meccanica, il suo Don Basilio si è caratterizzato per il volume importante, un timbro adeguatamente pastoso da basso e la ricchezza di armonici. Teresa Iervolino ha sostituito all’ultimo minuto Chiara Amarù nel ruolo di Rosina. Non è mancata la sicurezza nel dominare i momenti più ardui di questo personaggio, come anche l’omogeneità nell’emissione, anche se sarebbe stato apprezzabile un pizzico di convinzione in più nelle colorature. Il Don Bartolo di Simone Del Savio doveva affrontare la difficoltà di cantare alzandosi continuamente dalla sedia a rotelle imposta al personaggio: è stato comunque a suo agio, con una ricchezza decisiva di momenti scenici e una voce capace di rendere in modo fine lo spirito del tutore imbronciato e scornato. Il Conte d’Almaviva di Edgardo Rocha non aveva sicuramente un compito semplice a causa della complessa tessitura del ruolo: il tenore uruguaiano è apparso maggiormente in forma nelle agilità e risoluto nell’accento, un po’ meno nell’impostazione tecnica, con qualche squillo negli acuti che sarebbe stato ben gradito. Tra i commenti degli spettatori non sono stati pochi coloro che non hanno gradito il rondò conclusivo Cessa di più resistere. Il cast è stato completato più che degnamente dal Fiorello affamato e spensierato di Vincenzo Nizzardo, l’inquietante ma simpatico Ambrogio di Sax Nicosia, l’ufficiale mascherato di Riccardo Coltellacci e la briosa e convincente Berta di Eleonora De La Peña, decisamente a suo agio ne Il vecchiotto cerca moglie. Donato Renzetti ha diretto con piglio sicuro l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma: la sinfonia era piena di colore e di nerbo e non si è mai esagerato con momenti fragorosi o eccessivi come avviene a volte nella conduzione del Barbiere. La musica, inoltre, permetteva agli interpreti di accennare movenze rock che Renzetti ha assecondato quando il ritmo rossiniano lo consentiva. Corretto e preciso, infine, è stato il coro del Teatro dell’Opera di Roma, ben preparato come sempre da Roberto Gabbiani. Nonostante qualche spettatore che se n’è andato via polemicamente e fischiando, gli applausi hanno sancito il buon esito finale di questo Barbiere confuso ma comunque frizzante.
LES PECHEURS DE PERLES Firenze, 24 febbraio 2016.
Dopo molte peripezie che hanno causato un continuo cambio dei nomi in cartellone riguardo i due ruoli principali – male che accomuna Firenze ad altri teatri artisticamente guidati con polso poco ferreo, si pensi ad esempio all’ultimo Festival Verdi e all’imminente Roberto Devereux – si arriva ad una prima de Les pêcheurs de perles di Georges Bizet un poco tiepida, che non riesce a scaldare l’animo di alcun melomane. Pescatori grassiLo spettacolo di Fabio Sparvoli lo si conosce molto bene. Nonostante la sua semplicità, quasi banalità – o forse è proprio per questo – è approdato su molto palcoscenici dopo il suo debutto al Verdi di Trieste diversi anni fa, sempre con i medesimi pregi – è filologico e non disturba musica e canto – e i numerosi difetti: l’azione è mantenuta viva solo attraverso le coreografie di Annarita Pasculli – anche se anni fa la firma era differente, sembrano sempre mutuate dalle danze maori e dai rugbisti neozelandesi – la suggestione esotica è presente solo nelle scene vuote di Giorgio Ricchelli – che in terzo atto sembrano portarci dallo Sri Lanka alla Cambogia – e nelle luci di Vinicio Cheli, che però subiscono qualche intoppo; per il resto i personaggi sono poco appassionati pur vivendo emozioni infiammanti, i cori sono pressoché immobili, i costumi di Alessandra Torella un poco sempliciotti e non troppo corretti. Tutto sommato è funzionale ed efficace e si può chiudere un occhio. Ryan McAdams dimostra invece grande professionalità, poiché compie passi da gigante rispetto l’esecuzione dello stesso titolo di un anno fa alla RAI di Torino. Si possono riscontrare notevoli migliorie nelle dinamiche, nella gestione del suono, nel saper dosare i colori e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino lo segue con la consueta precisione ed omogeneità, trasmettendo adeguatamente la raffinatezza della partitura e i caratteri dei profondi sentimenti che la attraversano, tra cui l’inestinguibile amicizia tra Zurga e Nadir. Come sempre eccellente il Coro del Maggio guidato da Lorenzo Fratini, che si prodiga in un canto efficacissimo nel suono, compresi i numerosi pianissimi e fortissimi. Molto buona la prova di Nicolas Testé nel breve ruolo di Nourabad, mentre Luca Grassi, annunciato indisposto, è uno Zurga un poco discontinuo, che a tratti perde di smalto ed espressività. Ekaterina Sadovnikova, inizialmente prevista in secondo cast, sarà anche una cantante corretta, ma è talmente flebile ed evanescente che rende ben poco del canto e dell’interpretazione di Léïla. Ancor peggio per Jesus Garcia, il cui nome è comparso in cartellone dopo numerosi altri. Il suo Nadir manca totalmente di spessore, oltre a essere povero di colore, d’accento e di fraseggio, cui va sommata una dizione scadente e una certa mediocrità nel legato. Le note alte ci sono – anche se i do della celebre aria sono tutti in falsettone – ma le basse scompaiono chissà dove. Grande successo per il Coro e Ryan McAdams. Applausi per gli altri interpreti.
LUCIA DI LAMMERMOOR [William Fratti] Piacenza, 26 febbraio 2016.
La Stagione Lirica del Teatro Municipale di Piacenza prosegue col massimo capolavoro di Gaetano Donizetti, con la ripresa del popolare spettacolo di Henning Brockhaus già più volte ricomparso sui palcoscenici italiani. A guidare il lavoro di regia e coreografia è Valentina Escobar, che toglie tutti i precedenti elementi disturbanti a favore di una recita più pulita. Per il resto non c’è nulla da aggiungere. L’allestimento resta efficace e funzionale, suggestivo e seducente, con molto spazio di interpretazione lasciato ai protagonisti, pur recintato nell’idea romantica di Brockhaus. Sul podio della brava Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna è l’espertissima bacchetta di Stefano Ranzani, in assoluto uno dei migliori esecutori di questo spartito, filologico e didascalico, col solo difetto di far sempre prevalere il segno scritto piuttosto che un accento o un colore personale, risultando così un po’ piatto. A vestire i panni della sposa di Lammermoor è Gilda Fiume, che non è propriamente un soprano leggero e questo rende onore al compositore bergamasco che originariamente scrisse la parte per un drammatico d’agilità. La voce di Gilda Fiume è piena, rotonda, corposa e sarebbe stato interessante ascoltarla nella versione originale anziché nell’adattamento con cadenze e picchettati da tradizione. Ciononostante compie un ottimo lavoro – seppur non staccando egregiamente le agilità in “Spargi d’amaro pianto”. Altrettanto bravo è Giuseppe Gipali nel ruolo di Edgardo, limpido e omogeneo su tutta la linea di canto. Emozionante il duetto con Lucia in primo atto, ottimi gli acuti nel finale secondo, particolarmente morbida l’aria conclusiva dell’opera. Enrico è Mario Cassi, brillantissimo nelle squillanti note alte, eccellente nelle agilità di stampo rossiniano. Purtroppo quando la tessitura si fa medio bassa, soprattutto nei recitativi, la voce scompare nell’incertezza, il canto diventa parlato e pure l’interpretazione a quel punto perde d’efficacia drammatica. Enrico Iori è un Raimondo non troppo severo, più comprensivo che autoritario, e primeggia con un fraseggio particolarmente eloquente, di stampo verdiano. Matteo Desole è uno squillante Arturo, cui si perdona qualche nota calante. Roberto Carli è un buon Normanno. Nella mediocrità l’Alisa di Elena Traversi. Ottima la prova del Coro del Teatro Comunale di Modena preparato da Stefano Colò. Applausi appena tiepidi al termine dello spettacolo.
I DUE FOSCARI [Lukas Franceschini] Milano, 9 marzo 2016.
Alla Scala torna l’opera I due Foscari di Giuseppe Verdi, che mancava dal 2009, ora in una nuova produzione allestita per Placido Domingo nella sua diversa corda vocale che contraddistingue la parte finale della carriera. I due Foscari, tragedia lirica su libretto di Francesco Maria Piave, non ebbe una prassi esecutiva prolifica sin dall’esordio, Roma 3 novembre 1844; alla Scala si contano quattro edizioni nell’800 e bisognerà aspettare il 1979 per ritrovarla sulle tavole del Piermarini in un allestimento di Pier Luigi Pizzi e diretto dal giovane Ricardo Chailly (poi ripreso nel 1988 con la direzione del compianto Gianandrea Gavazzeni, del quale quest’anno ricorre il 20° anniversario della scomparsa). Seguirà la produzione diretta da Riccardo Muti e con regia di Cesare Lievi nel 2003 (ripreso nel 2009).I due Foscari è una delle opere del primo Verdi lungamente sottovalutata e obliata, da musicologi, critica ed esecutori, fortunatamente negli ultimi decenni si registra una controtendenza. Qualità peculiare dell’opera è l’atmosfera e il modo in cui è creata musicalmente. Tratta dal dramma omonimo di Lord Byron (non scritto per la scena), è nella vicenda cupa e di amara disperazione che il compositore coglie appieno mettendo in risalto gli strumenti a fiato, con assoli di clarinetto e flauto che esaltano la scena malinconica. Un passo avanti nella fase di crescita, siamo al sesto spartito, e Verdi in tale scritto riuscì a mettere in musica la tenebrosa visione che il dramma byroniano suggerisce. L’opera ha un carattere “intimo” e tinta truce, cui il compositore trova una vena particolarmente affascinante d’invenzione anche se statica, rivelando anche una struttura drammatica in continuità riutilizzando i temi specifici per i personaggi tracciando musicalmente un’evoluzione psicologica su essi. Lo spettacolo era molto convenzionale, Alvis Hermanis (regia e scene) non cerca soluzioni astruse, si concentra sulla sobria narrazione tuttavia senza scavare troppo nel profondo sulla psicologia dei personaggi. Aggiunge un gruppo di otto mini-danzatori superflui, talvolta irritanti in una coreografia banale (Alla Sigalova). Non convincono le luci di Gleb Filshtinsky, troppo accademiche e abbaglianti, come neppure i continui calare e alzare di siparietti che forniscono fondali bellissimi proponendo celeberrimi quadri veneziani dell’epoca, compreso Hayez. In sostanza la regia era statica e povera d’idee, sovente banale come l’ammasso di leoni veneziani nel carcere del II atto, e la scena finale nella quale il vecchio Foscari muore nel suo letto a baldacchino. Anche le entrate dei protagonisti non lasciavano traccia, il coro utilizzato come elemento di contorno e immobile scenicamente. Memorabili, invece, i bellissimi e sfarzosi costumi di Kristine Jurjane, che si rifacevano anch’essi a celebri dipinti d’epoca. Michele Mariotti si è impegnato in una lettura appassionata e precisa, cui si deve rilevare un’accurata calibrazione di colore e fraseggio orchestrale. In taluni casi scivolava su pagine enfatiche e forti, troppo marcate, non riuscendo costantemente a tenere compatto il rapporto con il palcoscenico (coro in particolare). Tuttavia si è trattato di una più che decorosa concertazione, anche in considerazione della difficile partitura e delle concessioni dovute a parte del cast e per questo taluni passi erano troppo routinieri. Il coro istruito da Bruno Casoni ha svolto con onore il suo compito senza lasciare tracce memorabili. Francesco Meli è un Jacopo giovanile e malinconico come serve, la voce è bella e luminosa, ricca di sfumature e preziosi accenti. Il settore acuto, che lo mette sovente in disagio, tendendo ad aprire i suoni, ma è stata una prova più che onorevole e, sottolineo, oggigiorno unica forse carta spendibile nel ruolo. Molto bravo e appassionato nel terzetto “Nel tuo paterno amplesso”. Anna Pirozzi è una Lucrezia con tanta voce, ma difetta in tecnica, la quale non le permette un canto omogeneo. La prima ottava acuta e stridula, mentre il sovracuto, stranamente è ben calibrato e scolpito. L’accento e il fraseggio sono anche pertinenti, il grave leggermente forzato, abbisognava inoltre di più cure registiche nel rilevare anche la disperazione della giovane moglie impotente agli eventi del destino. Molto bravo il severo Loredano di Andrea Concetti e precisi il Barbarigo di Edoardo Milletti, la Pisana di Chiara Isotton, il fante di Azer Rza-Zade, e il servo di Till von Orlowsky. Per ultimo Placido Domingo poiché merita un discorso a parte. La carriera del famoso tenore è ora spostata ai ruoli baritonali. Scelta opinabile quanto personale. Ho già avuto modo di scrivere delle sue interpretazioni da baritono, e anche in quest’occasione non posso esimermi dal costatare che ci troviamo di fronte a un tenore “vecchio”, corto di mezzi, sovente affaticato che tenta con grande temperamento passi decisamente ardui. La tinta è chiara e ovviamente manca il peso specifico vocale del ruolo. Si ammira, in parte, la forza di volontà e l’impegno, cui sommiamo anche una certa dose di temperamento interpretativo, ma per chi scrive non è sufficiente per definire Domingo un “baritono” verdiano”. Il pubblico, invece, ha gradito e al termine della quarta recita, cui ho assistito, ha decretato un autentico trionfo a tutta la compagnia, in controtendenza a quanto accaduto alla prima nella quale ci furono alcune contestazioni.
RIGOLETTO [Lukas Franceschini] Verona, 17 marzo 2016.
Rigoletto è il terzo titolo della stagione al Teatro Filarmonico, eseguita in chiave tradizionale, tale da non lasciare traccia ma passare per ordinaria routine. L’infelice spettacolo di Arnaud Bernard creato per la Fondazione Arena nel 2011, è stato riproposto senza modifiche anche minime che avrebbero reso un’idea di partenza anche suggestiva. Invece ci ritroviamo nel claustrofobico gabinetto anatomico e biblioteca circolare del Duca, il quale è intento in esperimenti umani e si potrebbe ipotizzare che il buffone di corte sia una sua creazione. In tale impostazione scenografica fissa di Alessandro Camera, che ricorda la Mantova cinquecentesca, trovano posto anche una sorta di tempietto (casa di Rigoletto) e un barcone nel III atto che funge da locanda di Sparafucile. Le libertà registiche non si contano, scene di stupro, urla schiamazzi, per definire il libertinaggio e i vizi privati che si celavano dietro il paravento di una corte brillante e sfarzosa tra le più rinomate d’Europa. Che il Duca non fosse un sant’uomo lo sapevamo, ma non così volgare e a titolo gratuito, lo stesso vale per i grezzi cortigiani. Idee confuse, sovente antiteatrali, hanno determinato una lettura noiosa e una visione troppo uniforme tra le meno riuscite che il Filarmonico ha proposto negli ultimi anni. E pensare che il titolo ha sostituito la prevista Manon di Jules Massenet, soppressa per difficile situazione economica della fondazione…. quanto rammarico! Fabrizio Maria Carminati dirigeva con solida esperienza, scavando nell’espressione dello spartito e riuscendo anche nel pertinente colore cupo e sinistro della vicenda. Avremo preferito talvolta scatti più energici da una bacchetta che sa il fatto suo ma probabilmente tenuta a freno da un cast mediocre. Leo An è stato un Rigoletto che potremo definire di routine. Il cantante non ha tutte le qualità che il ruolo richiede, incerto nella dizione, limitato nel settore acuto, tuttavia almeno nelle intenzioni riesce a esibire un “gobbo” non più che corretto dal fraseggio anche apprezzabile ma non costante. La migliore della locandina era la Gilda di Mihaela Marcu, soprano, che potremo affermare, in continua ascesa. La sua Gilda non è fanciullesca ma donna coerente delle sue scelte. La voce è piena e melodica in tutte le zone, particolarmente apprezzabili sia il registro acuto sia il centro pieno e rotondo, cui aggiunge un sensibile e partecipe accento nella ricerca di colori e fraseggio di buona espressione. Il giovane tenore Alessandro Scotto Di Luzio avrebbe le qualità vocali per interpretare un Duca di rilievo. Ha il phisique du rôle, la baldanza giovanile, e una voce adatta al ruolo, seppur non sempre squillante. Difetta a mio avviso, nel settore acuto (non esegue il da capo della cabaletta), e in un fraseggio ancora da rifinire. Il passaggio nel quartetto del III atto lo mette in difficoltà, ma dalla sua bisogna segnalare una linea di canto elegante e anche una certa enfasi passionale pertinente. Appena sufficienti lo Sparafucile di Gianluca Breda e la Maddalena di Clarissa Leonardi, quest’ultima, a mio avviso, cantante più adatta ad altro repertorio. Definirei molto interessante il Marullo di Tommaso Barea, giovane cantante che speriamo di sentire in prossime occasioni, nella performance veronese non è possibile esimersi dal registrare una caricata interpretazione ma presumo per imposizioni registiche. Buone le prove di Alice Marini, Giovanna, e Antonello Ceron, Matteo Borsa. Gli altri interpreti si ascrivono alla banale routine: Alessio Verna (Monterone), Romano Dal Zovo (Ceprano), Dario Giorgelé (usciere), mentre troppo esile e incerta è stata Francesca Martini (Contessa Ceprano/paggio). Alla terza recita il teatro era esaurito in tutti i settori e il pubblico ha riservato a tutta la compagnia, un caloroso successo al termine.
MEFISTOFELE [Stefano Solaster] Pisa, 18 marzo 2016.
Marcello Lippi, il temerario Direttore Artistico del Teatro Verdi, dopo la “gigantesca follia del DonGiovanniFestival” vince un’altra scommessa: a quarantaquattro anni di distanza dall’ultima rappresentazione (a Pisa Mefistofele fu dato nel 1972, e prima di allora solo altre cinque volte, nel 1885, nel 1892, nel 1904, nel 1915 e nel 1939, anno che vide Tancredi Pasero nel ruolo protagonista) il M° Lippi propone un nuovo allestimento di Mefistofele di Arrigo Boito al Teatro di Pisa in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca (dove sarà il 9 e il 10 aprile) e il Teatro Sociale di Rovigo (29 e 30 Ottobre). Enrico Stinchelli, con la sua mise en place ambisce a porre il pubblico pisano in Paradiso, al cospetto della celestiale voce di Dio; grazie a una macchina scenica nella quale le video proiezioni garantiscono una fonte inesauribile di Luce e di energia cromatica, a una scala che porta verso l’infinito costruita con cristalli che convogliano come antenne le energie universali e ad un coro di ben 250 elementi che costituisce una forza teatrale, acustica e visiva, davvero dirompente il celebre regista romano centra l’ambizioso obiettivo. Segnalo talvolta però un uso in contemporanea di un numero eccessivo di proiezioni che finiscono per disturbarsi tra di loro sabba classico come in occasione dell’inizio della scena della “Domenica di Pasqua”. Il direttore Francesco Pasqualetti offre una lettura attenta ed equilibrata della partitura; guida un’ottima Orchestra della Toscana in un’esecuzione convincente del capolavoro boitiano. Giacomo Prestia, al debutto nella parte di Mefistofele, ha l’arduo compito di non dover far rimpiangere le interpretazioni oramai famigerate dei vari Rossi Lemeni, Ghiaurov e Siepi. Il talentuoso basso, dotato di emissione morbida e timbro vellutato, convince: offrendo una lettura del personaggio più lusinghiera ed insinuante che prepotentemente demoniaca. Antonello Palombi è artista dalle grandi risorse vocali che affronta il ruolo di Faust più muscolarmente che prestando la dovuta attenzione alle sfumature espressive. Offre una prestazione discontinua dove emissione a tratti faticosa stride al quanto accanto ad acuti sicuri e di enorme bellezza. Valeria Sepe, astro in ascesa del panorama lirico, dotata di voce brillante e morbida, offre una prestazione pressoché perfetta per il ruolo di Margherita. Il rendimento della Sepe è talvolta velato da una carenza di spessore vocale nel registro basso ma i mezzi vocali e attoriali del giovane soprano napoletano sono indubbiamente hors catégorie. Nelle intenzioni del regista il punto focale dell’opera era il terzo atto con la Morte di Margherita che avveniva nel un vuoto assoluto (“una cella ridotta a una rapazzola a terra, un vecchio materasso sdrucito, una sediola da bambina, due candele, un cuscino”). In quel Nulla, Margherita può dimostrare il suo valore con una delle più straordinarie scene di pazzia offerte dal melodramma e la Sepe non tradisce le aspettative. Elisabetta Farris non canta Elena, lo è. Il giovane soprano sardo affronta la breve ma complessa parte della seduttrice greca supportata da una ragguardevole estensione vocale e da un’ottima tecnica. La Farris è dotata di un magnetismo scenico che non apprendi sui libri di testo e che solitamente è ad appannaggio di una ristretta pattuglia di cantanti che portano l’appellativo di fuoriclasse. Stanislavskij era solito ripetere: «Non ci sono piccoli ruoli, ci sono solo piccoli attori»; ebbene Sandra Buongrazio, cesella il ruolo comprimario di Marta con una una solidità vocale e una credibilità scenica di assoluto rilievo. Completavano ottimamente il cast il Sergio Dos Santos giovane tenore brasiliano, qui nel doppio ruolo di Wagner e Nereo e il mezzosoprano Moon Jin Kim – Pantalis. Assolutamente convincente anche la prova del Coro Lirico Toscano, diretto da Marco Bargagna, qui affiancato da altri tre cori: il Coro Laboratorio Lirico di San Nicola, il Coro dell’Università di Pisa (entrambi diretti da Stefano Barandoni) e i Pueri Cantori di San Nicola e Santa Lucia diretti da Emma Zanesi.
LA CENERENTOLA [Margherita Panarelli] Torino, 19 marzo 2016.
Con un brioso allestimento de “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini per la regia di Alessandro Talevi prosegue la stagione 2015/2016 del Teatro Regio di Torino. Cinecittà, anni ’50, fervono i preparativi per le riprese del nuovo kolossal ambientato nell’antica Roma e ancora si effettuano alcuni provini alle attrici. Tra la grande folla di giovani aspiranti al ruolo, civettuole e anche volgarotte, spicca il dolce sorriso di una fanciulla vestita modestamente che ritrovatasi per sbaglio di fronte alle telecamere scappa impaurita e torna alla sua umile dimora a provare a recitare di fronte al televisore, sognando di cambiare vita. Il sorriso però non è punto passato inosservato poiché il regista “Ali d’Oro” ha deciso che vuole quella ragazza, e quella soltanto, per il ruolo di protagonista e manderà la star del film, Ramiro, travestito da semplice cameriere degli studi, e Dandini, che invece vestirà i panni del divo Ramiro, a trovare la ragazza. Ed ecco che la favola può cominciare. Questa l’ambientazione della regia di Alessandro Talevi, in origine per l’Opera di Malmö, della Cenerentola rossiniana. Regia leggermente spaesante e che forse calca un pò la mano con le comparse, ma il risultato complessivo è assolutamente apprezzabile, specialmente nella caratterizzazione di Dandini e di Don Magnifico, e sempre comunque ancorata alle situazioni del libretto pur spostandole in contesti molto diverse. La festa di nozze diventa infatti la cerimonia di consegna del premio Oscar alla protagonista, così come la carrozza è una Vespa rossa fiammante e così via. Il cast è eccellente, a cominciare dalla protagonista, Teresa Iervolino, una vera stella emergente del panorama italiano e, ci si augura, presto internazionale. La voce è calda, pastosa, dal colore brunito e omogenea nei vari registri ed è adattissima al personaggio di Angelina proprio per la sua qualità dolce e la trama vellutata da autentico contralto. In contrasto, nonostante la correttezza, l’interpretazione di Antonino Siragusa risulta priva di mordente, in particolar modo nel secondo atto quando il Principe Ramiro dovrebbe tirar fuori un po’ di carattere. Per quanto Siragusa sia un ottimo professionista e comunque si disimpegni con onore nel ruolo, la parte andrebbe affidata ad un altro tipo di voce. Mattatore della serata è Paolo Bordogna nei panni di Dandini. L’aria d’esordio “Come un’ape nei giorni d’aprile” è un magnfico esempio di stile rossiniano per pulizia di emissione, tempi comici e cura delle colorature. Il pieno controllo dello strumento gli consente di muoversi con sicurezza nella partitura del compositore Pesarese ed offrire un’interpretazione da vero fuoriclasse. Eccellente è anche il Don Magnifico di Carlo Lepore, sbruffone al punto giusto; fraseggio e sillabato precisissimi, fa faville infatti in “Sia qualunque delle figlie”, ed è un eccellente coprotagonista nel duetto “Un segreto d’importanza”, uno dei momenti meglio riusciti della rappresentazione. Chiude la rosa dell’ottimo cast maschile l’Alidoro di Ferruccio Tagliavini, un altro fuoriclasse in questo cast di pesi massimi del repertorio rossiniano. Il suo Alidoro è una manna dal cielo per Cenerentola e per il pubblico, che finalmente ha occasione di vedere affidato questo ruolo ad un’autentica voce di basso, e la duttilità della voce di Tagliavini completa un’interpretazione assolutamente maiuscola. Simpatiche e adeguate ai loro ruoli Giuliana Gianfaldoni, Clorinda, e Loriana Castellano, Tisbe che riescono a infondere alle sorellastre una parvenza di dignità. Alla testa dell’orchestra del Teatro Regio, come sempre in splendida forma, c’è Speranza Scappucci la cui lettura è vivace e briosa, con un tocco di fascino elegante che ben si addice alla storia fiabesca di Angelina. Da segnalare l’ottima gestione del Finale I e del sestetto del secondo atto “Questo è un nodo avviluppato” calibrati magistralmente in velocità e intensità. Buonissima prova anche da parte dell’ottimo Coro del Teatro Regio, preparato da Claudio Fenoglio.
L’ITALIANA IN ALGERI [Lukas Franceschini] Firenze, 20 marzo 2016.
Felice conclusione della Stagione invernale all’Opera di Firenze con la ripresa de L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, spettacolo creato nel 2010 e coprodotto con altri teatri internazionali. L’allestimento di Joan Font, che potremo in parte collocare nel solco della tradizione, trova una giusta chiave di ita 2lettura nella continua ricerca del divertimento, mai stereotipato e dozzinale, pertanto la giusta idealizzazione è di affiancarsi alla musica e alla trama con modestia e rispetto. La musica di Rossini è già un supporto estremamente forbito e la brava regista non vuole forzare con una lettura sopra le righe ma s’incammina sulla strada già tracciata dall’autore e crea una visione molto divertente e d’elegante ironia. In tale ottica è molto efficace anche il lavoro di Joan Guillén, scenografa e costumista, la cui mano peculiarmente estrosa punta su coloratissimi costumi e una scena stravagante e lineare, di ottima fattura, i quali contribuiscono a un ottimo risultato di piacevole e divertente visione. Il pubblico, oltre a chi scrive, ha molto apprezzato. L’ottima Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino era istruita da Bruno Campanella, una bacchetta che non sentivo da qualche tempo, ma che ha contribuito ai maggiori successi rossiniani negli anni ’80 e ’90 del secolo appena trascorso. Campanella con Rossini trova un terreno d’elezione e anche in quest’occasione ha confermato la sua ottima conoscenza dello spartito che si è concretata in una lettura elegante, raffinata, ben calibrata nel rapporto buca e palcoscenico e contraddistinta da un’impeccabile omogeneità di colore e timbro. L’unico appunto che potremo rivolgergli è la percettibile carenza di mordente o brio in alcuni momenti, ma nel complesso è solo un aspetto secondario. Molto buona la prova del Coro istruito da Lorenzo Fratini. Protagonista era il validissimo mezzosoprano Marianna Pizzolato, la quale ha delineato un’Isabella di ottima fattura sostenuta da una precisa tecnica vocale cui va doverosamente sommato un timbro pastoso, omogeneo e una brillante interpretazione scenica. Marko Mimica, Mustafà, conferma le sue innate doti vocali sfoggiando una bellissima voce dal colore brunito e una brillantezza di fraseggio molto incisivo. Ad essere puntigliosi ci sarebbe da raffinare la parte tecnica, il sillabato e il canto d’agilità spinto lo mettono in taluni momenti a disagio, ma considerando la giovane età del cantante siamo fiduciosi che avrà modo di perfezionarsi, resta oggi una delle migliori promesse in tale repertorio. Tali aspetti sono stati già brillantemente superati e collaudati da Omar Montanari, il quale disegna un divertentissimo Taddeo assolutamente controllato sia nel canto sia nella spassosa interpretazione. Le note meno felici si registrano nell’interpretazione di Boyd Owen, un Lindoro anche musicale e brillante ma con significative mancanze nel settore acuto che suona spesso stimbrato, aspro e nasale. Ne fanno le spese in particolare le due arie solistiche del I e del II atto, quest’ultima poi in parte facilitata poiché ha eseguito “Oh come il cor di giubilo” in sostituzione della più impegnativa “Concedi amor pietoso”. Molto bravi e puntuali i cantanti nelle parti di fianco. Sergio Vitale ha avuto il suo momento nella precisa ed elegante esecuzione de “Le femmine d’Italia, Damiana Mizzi era una puntuale Elvira e Lamia Beuque una precisa Zulma. Alla recita pomeridiana cui abbiamo assistito il grande Teatro dell’Opera di Firenze era pressoché esaurito in ogni ordine di posto. Il numeroso pubblico ha decretato un convinto e sostenuto successo allo spettacolo anche se non sono mancati pochi isolati dissensi nei confronti del tenore.
CARMEN [Lukas Franceschini] Bologna, 22 marzo 2016.
La nuova produzione di Carmen al Teatro Comunale di Bologna naufraga clamorosamente in una lettura scompigliata e bizzarra, tra le meno riuscite degli ultimi anni. A mio parere l’errore principale del regista Pietro Babina, debuttante in campo operistico, è stato quello di voler attualizzare Carmen. Perché? Carmen è un opéra-comique (alla francese) tratta da una novella di un altro francese, Prosper Mérimeée, il quale non voleva assolutamente creare un lavoro folkloristico, da cartolina, stereotipo spagnolo, bensì raccontare la storia di una donna “libera” che va contro le convenzioni del tempo (forse anche di oggi). La domanda non è quale Carmen noi volgiamo vedere oggi ma quale lettura, o diversa lettura, può suggerire Carmen oggi. Di spettacoli non tradizionali ne abbiamo visti parecchi, Emma Dante e Calixto Bieito ad esempio, discutibili quanto si vuole ma coerenti e con una lettura chiara. La regia di Babina parte dall’idea che tutto quello che avviene nell’opera è finzione, volutamente confezionata per un pubblico di turisti low-cost. Abbiamo cosi una sorta di attore muto, che mette un disco LP dell’opera su un antico giradischi a car 2ogni inizio d’atto, diventando una specie di deus ex machina che coordina la vicenda come un divertissement creato nel villaggio turistico. L’idea è banale quanto inutile e la visione è sovente irritante. Del tutto cancellato esotismo e la ricerca di una coerenza con quanto avviene in palcoscenico sovente scivola nel grottesco. L’atto meno riuscito è certamente il terzo, nel quale la protagonista e suoi compagni sono contrabbandieri di esseri umani, il coro è ingabbiato in un recinto per profughi come tristemente vediamo nei tg. Ma il coro non è tutta la brigata di contrabbandieri? Canta pertanto una cosa mentre realizza scenicamente altra situazione. Escamillo è abbigliato come un esploratore montano che ricorda una celebre pubblicità di cioccolato, Micaela è vista come innocente e allampanata, quando invece è donna coraggiosa in netto opposto al coraggio di Carmen. Togliere dall’opera Carmen il momento della corrida, pur non condividendo tale pratica, è grave errore. Tale pratica ha caratterizzato la Spagna per anni e ha suggestionato poeti, scrittori stranieri, non può essere banalizzato a uno spettacolino per villaggio turistico, senza tralasciare tutto il cerimoniale iniziale e i tradizionali costumi che non possono essere “tradotti”. Il resto pur attualizzato è anche passabile, tolto il coro di voci bianche vestito da diavoletti, ma ancor più grave è aver ridotto i recitativi all’osso. Alla recita cui ho assistito nessuna contestazione, a differenza da quanto avvenuto alla prima, ma pubblico piuttosto sconcertato e deluso. In tale ottica anche la scena non lascia traccia, pochi elementi banali come la pubblicità dei voli economici, cartolina per car 3turismo iberico, anche i costumi non evocano particolari commenti. L’aspetto musicale è stato di tutt’altro verso. Frédéric Chaslin è direttore sicuro e preciso, non certo un cesellatore di tempi, dinamiche e colori ma sicuramene un buon esperto dello spartito che tiene ben salda la situazione e trova nell’orchestra, duttile e in buona forma, il mezzo con cui coordinare anche il palcoscenico. Ottima la prova del Coro del Comunale diretto da Andrea Faidutti e molto positivo l’intervento del Coro di Voci Bianche, sempre del Comunale, istruito da Alhambra Superchi. Veronica Simeoni, Carmen, trova in questo ruolo un terreno molto fertile per la sua voce sopranile ma scura, non forza mai il registro grave e questo è un gran pregio, trova un linguaggio vocale molto raffinato ed elegante forgiando una gitana molto femminile e anche sensuale, forte e decisa. Fosse stata aiutata anche da una regia diversa… avremo avuto molto, molto di più. Roberto Aronica, Don Josè, s’impone per una sostanziale tenuta vocale rifacendosi a un dragone virile e irruento a scapito di un fraseggio e una ricerca di colori più suggestivi. L’emissione è stranamente sovente aperta ma non si trova mai in difficoltà e imposta il personaggio, probabilmente voluto dal regista, come vittima violenta e con taglio drammatico, poco affine al lirismo. Simone Alberghini è uno spavaldo e credibile Escamillo in scena, vocalmente molto appannato e con canto non proprio vigoroso e brillante. Note ancor meno positive per la Micaela di Maria Katzarava, soprano lirico con tecnica precaria che non le permette di esprimersi in un canto morbido e passionale, la zona acuta è stridula, quella centrale sovente afona. Molto brave le due amiche di Carmen, Sonia Ciani è una Frasquita precisa e squillante, Antonella Colaianni, Mercedes, si apprezzano il timbro vellutato e l’incisiva caratterizzazione. Positiva la prova di Maurizio Leoni, Dancaire, e Paolo Antognetti, Remendado. Ottimi il Morales di Nicolò Ceriani e lo Zuniga di Massimiliano Catellani. Pubblico, come dicevamo sopra un po’ perplesso per lo spettacolo, ma prodigo di applausi a tutta la compagnia al termine.
LES HUGUENOTS [William Fratti] Nizza, 23 marzo 2016.
Mettere in scena un grand-opéra di Giacomo Meyerbeer non è un compito facile, poiché esige un impegno di risorse artistiche ed economiche davvero importante: numerosi solisti protagonisti e comprimari, doppio coro, grande orchestra, mimi e figuranti, danzatori, scenografie imponenti, durata dello spettacolo non indifferente.Nice Côte d’Azur risponde positivamente alle esigenze del canto, con l’impiego di artisti di buon livello, mentre il resto lascia un po’ delusi, a partire dalla direzione di Yannis Pouspourikas che non riesce a trasmettere in alcun punto il carattere maestoso e la grandeur della musica di Meyerbeer, anzi in primo atto e a tratti anche in terzo sembra addirittura un poco pasticciata, complici dei musicisti dell’Orchestre Philharmonique de Nice non adeguatamente preparati. Inoltre – forse costretto dalle scelte direzionali del teatro – compie dei tagli da macellaio sulla partitura, che vanno a ridurre l’opera di quasi un’ora andando a ledere drasticamente l’andamento drammatico, nonché la drammaturgia dell’intera vicenda. L’unico personaggio a salvarsi dal boia è Marguerite, spogliata di sole due battute, mentre gli altri si son visti eliminare pagine e arie intere. Un altro punto dolente è lo spettacolo ideato da Tobias Kratzer, che soffre di una grossa dicotomia: da un lato si riconosce un lavoro di regia puntuale e preciso, ben centrato sugli obiettivi prefissi, ben costruito nelle gestualità, in ingressi e uscite, nonché nelle numerose controscene, dando significati ben delineati e mantenendo sempre alto il livello di attenzione; dall’altro l’idea innovativa proposta, sommata ai numerosi tagli e alla rarità delle rappresentazioni di questo titolo, non permette un’agevole comprensione della trama originaria che si dispiega all’interno della visione del regista, da qui probabilmente sono scaturite le contestazioni del pubblico, cui si aggiunge un impianto scenografico davvero povero e dei costumi – entrambi ad opera di Rainer Sellmaier – di piacevole fattura per ciò che concerne quelli rinascimentali, ma di gusto terribile quelli di epoca moderna. Probabilmente se i mezzi a disposizione fossero stati maggiori e migliori, l’apprezzamento sarebbe stato differente. Nella concezione di Kratzer, Nevers è un pittore bohemien parigino che, indignato dalle distruzioni di opere d’arte attuate dagli integralisti musulmani, decide di dipingere una scena di alleanza tra due diverse fazioni religiose, cattolici e protestanti, mentre Marguerite è la sua mecenate e sostenitrice. Purtroppo la situazione gli sfugge di mano e i modelli incaricati iniziano ad odiarsi davvero, fino a decidere di trucidarsi. Uwe Stickert ha la vera voce del tenore eroico da grand-opéra, leggera e luminosa, ma capace di slanci passionali. Il suo Raoul è dunque appropriato e molto soddisfacente, anche se non sempre preciso, un po’ corto nei fiati e costretto a prendere aria molto spesso, inoltre il suono sembra talvolta non ben proiettato e tende ad andare all’indietro. Lo affianca la brava Cristina Pasaroiu nei panni di Valentine. L’artista rumena non è certo un soprano Falcon, ma è dotata di una vocalità prettamente lirica particolarmente rotonda che la rende perfetta al ruolo, sempre morbida ed omogenea e soprattutto molto brava nell’uso dei colori. È un vero peccato ch ogni tanto perda l’appoggio nel registro acuto. Jérôme Varnier è un ottimo Marcel, dotato di voce cavernosa in grado di eseguire in maniera salda e sicura le numerose note basse della parte. Eccellente è la resa del recitativo di sortita, nonché del bellissimo duetto con Valentine, mentre è un po’ in difficoltà della canzone ugonotta, dove appare un po’ lento e gli acuti sono calanti. Silvia Dalla Benetta, pur avendo accantonato il repertorio lirico leggero già da diversi anni a favore di quello drammatico di agilità, debutta nel ruolo di Marguerite con estrema disinvoltura, perfettamente a suo agio anche nella tessitura altissima presente in numerose pagine della parte, ancorata tra il passaggio e le note acute. La lunghissima aria la vede prodigarsi in un tripudio di colori nella prima sezione, impreziosita da un ottimo legato, nonché in un virtuosismo tecnicamente impeccabile nella parte centrale e nella cabaletta. L’accento drammatico rende il suo personaggio più regale e meno coquette e la aiuta ad imporsi nel concertato del finale secondo. Hélène Le Corre è un Urbain molto preciso e la voce corre e sa farsi sentire nonostante non sia particolarmente stentorea. Le agilità ben accurate sono eseguite in maniera molto morbida ed è un vero peccato che non sia stato eseguito il rondò di secondo atto. Marc Barrard è un efficace Nevers, soprattutto nella resa del personaggio, cui è affidato, in questa produzione, il ruolo del deus ex machina, pertanto lo si trova sempre in scena. Molto buoni De Tavannes e Bois-Rosé entrambi interpretati da Mark van Arsdale, che colpisce per la sua voce chiara e molto sonora, mentre la recitazione sembra purtroppo una macchietta. Adeguati ed opportuni gli altri artisti nei rispettivi ruoli: Francis Dudziak nei panni di Saint-Bris, Florian Cafiero è De Cossé, Frédéric Cornille è De Thoré e Maurevert, Arnaud Rouillon è De Retz, Thomas Dear è De Méru, Olivier Tousis è Un archer. Buona la prova del Coro dell’Opéra de Nice preparato da Giulio Magnanini, soprattutto i solisti impegnati nelle piccole parti comprimarie: Corinne Parenti, Sandra Mirkovic, Susanna Wellenzohn, Marie Descomps, Franck Bard, Thierry Delaunay, Stéphane Marianetti, Diego Saavedra, François Poutaraud, Eric Ferri, Dario Luschi. Al termine della serata il pubblico ha accolto molto calorosamente tutti gli artisti, con grande successo personale per Uwe Stickert, Cristina Pasaroiu, Jérôme Varnier e Silvia Dalla Benetta, mentre ha contestato Tobias Kratzer e Rainer Sellmaier.
ROBERTO DEVEREUX [Mirko Gragnato] Genova 23-24 marzo 2016
Dopo più di 20 anni torna nei cartelloni del Carlo Felice la terza Regina del ciclo Tudor, con un cast d’eccezione, la regia di Alfonso Antoniozzi, e la direzione di Francesco Lanzillotta. Scene dal sapore gotico e trionfi di organza ci portano all’era Elisabettiana della partitura Donizettiana. A Genova torna il terzo titolo del ciclo Tudor di Gaetano Donizetti, un ciclo non premeditato ma che si è sviluppato via via negli anni di composizione. Roberto Devereux mancava dai cartelloni dall’ormai lontano 1993, dopo Anna Bolena e Maria Stuarda qui è Elisabetta I la protagonista della vicenda interpretata nel primo cast da Mariella Devia, che è al suo debutto italiano nel ruolo. Questo nuovo allestimento è frutto di una collaborazione tra le fondazioni del teatro genovese con il Regio di Parma e la Fenice di Venezia. Costumi elaborati, attenti al dettaglio, e prodotti dalla mano di Gianluca Falaschi, arricchiscono le scene semplici e spoglie di Monica Manganelli, che propone un’ambientazione spoglia dove si muovono pareti lignee dal disegno gotico e un trono ispirato allo scranno conservato nella basilica di Westmister. L’intreccio narrativo si svolge proprio nella capitale d’Albione, nel 1601, dove gelosia, potere, sentimento amoroso e amor patrio si scontrano e si fronteggiano in questa storia che vede amori impossibili per logiche di un mondo costruito dalle apparenze, dalle strutture di un potere attento alla forma e alla sua liturgia.Il regista Alfonso Antoniozzi ha cercato di cogliere e sviluppare questa trama simbolica del potere un intento che si manifesta già durantel’ouverture nella quale avviene la cerimonia della vestizione. Una Elisabetta che scivola dalle quinte ma che assurge al trono investita di un corredo di orpelli rendendola una presenza sacrale. Una regina divinizzata, e quindi vincolata a seguire un copione che la disumanizza rendendola monumento di sé stessa, un’icona da adorare come statica presenza incensata e ricoperta d’oro. Nella corte tutti recitano una parte e seguono il copione per essere un perfetto cortigiano, emulando un protocollo che li vede puntare alla somiglianza con il sovrano non potendo essere sé stessi, portando tutti una maschera, non solo ideale ma che si materializza, si rendono tutti uniformi e uguali negli abiti e nelle movenze. Se la regina è donna anche tutti i membri della corte si genderizzano e portano la sottana, un’uguaglianza che più che ispirarsi all’equità punta ad un monotono livellamento. La corte infatti si manifesta come questa macchia di folla, insensibile, assetata di sangue e senza pietà. Tutta la vicenda si snoda su questo palcoscenico circolare che ricorda i movimenti teatrali dell’epoca di Shakespeare, ispirato al Globe Theater. Le conversazioni, i duetti e l’intreccio narrativo è sempre tenuto sott’occhio dalla corte onnipresente, un’ingombrante presenza che non manca mai, anche le scene più intime come gli incontri tra Sara e Devereux, o la Regina e l’amato, vengono origliati, tenuti sotto l’occhiuto interesse dei cortigiani. Muri che hanno occhi e orecchie, pareti traforate da intrecci goticheggianti che diventano l’avello di viscidi spioni, interpretati dai Mimi Deos. Tutta l’azione scenica è accompagnata dalla mano e dalla bacchetta di Francesco Lanzillotta, sul podio un gesto fluido e misurato, curato nelle movenze per essere chiaro e diretto ma nello stesso tempo espressivo. Una direzione lineare e ricca che però sembra poco trasmettere all’orchestra, mancando di un carisma che la possa tenere in pugno essa va nell’insieme compatta ma senza seguire troppo l’intenzione del direttore, i musicisti del Carlo Felice si mostrano capaci e in piena sintonia tra di loro portando ad un risultato musicale di tutto rispetto che però manca dell’impronta del maestro Lanzillotta. L’ouverture che apre l’opera con forti colpi percussivi accompagnati dai flash della regia, vengono seguiti dalla citazione dell’inno alla corona inglese sviluppandosi poi in un’agile sinfonia che ricorda le palpitazioni del cuore, con le scalette in detaché e ai pizzicati degli archi riuscendo a rendere benissimo lo stravolgere emotivo delle passioni che non risparmiano nemmeno re e regine. Il tema ritornerà nell’ultimo atto con la cabaletta che segna l’elegante rassegnazione del protagonista nel chinare il capo alla scure. Il passo tematico anticipa sia la trama noir dell’intreccio, che la vivacità dei sentimenti che riescono a trasmutareil modo di percepire la realtà. Si è molto dibattuto e si dibatte ancora sul senso filologico di questa sinfonia di apertura, essa mancava alla prima esecuzione al San Carlo, dove alle scene faceva da prologo un larghetto di sole 11 battute, una velleità musicale che scaturirà nella splendida ouverture, alla quale è difficile rinunciare per il suo slancio ritmico, ricco di acciaccature, accenti e dinamicità, uno slancio atipico per un Donizetti così amante dei preludi. Entrambi i cast che si sono susseguiti sul palcoscenico si mostrano essere di valevole taratura, di qualità e pregio vocali. Insomma chiunque sia andato a sentire l’uno ol’altro non è stato deluso dalle voci e dalla resa scenica dei cantanti. Nella recita pomeridiana del 23, dedicata soprattutto agli studenti e alle scuole, Elisabetta I è interpretata da Natalia Roman, una regina più giovane di quel che sembra, la quale però riesce bene nel suo intento di distaccato ma allo stesso tempo erotico affetto per il Roberto Devereux, interpretato da William Davenport, il quale sembra risparmiare sulla voce, mostrandosi abbastanza tenuto e senza troppo lasciarsi andare alla vocalità, per gli studenti rumorosi e molesti in effetti forse non è bene dar tutto sé stesso. Eppure la Roman ha dato prova di una voce all’altezza del ruolo e nei continui salti dall’acuto al grave della tessitura con una voce equilibrata e mai troppo spinta o tenuta. La Sara di Elena Belfiore non è certo da meno, il soprano e il mezzo soprano sono state scelte bene per avere un ottimo rapporto ed equilibrio timbrico. Il Duca di Nottingham interpretato con un cambio da Marco Di Felice, si mostra capace sia dal punto di vista scenico che vocale, ma vale lo stesso che per Davenport, per questa recita le voci maschili sembrano essersi date al risparmio. Non c’è da dargli torto, in effetti per queste pomeridiane il pubblico segue poco quello che avviene sul palcoscenico, le classi di studenti sono poco seguite dai docenti, alcune arrivano anche in ritardo, troppo tardi per gustarsi la bell’ouverture, e appollaiati sulle poltrone sembrano più interessati ai loro affari che a seguire l’opera. Per la recita del 24 sera, con il primo cast, la platea del teatro è quasi piena ma l’uditorio stavolta è più attento, più preso da quanto avviene sul palcoscenico. Per Mariella Devia, Elisabetta I, applausi già dalle prime note, un omaggio alla sua voce e alla sua carriera, personaggio in scena ben congegnato, vera Elisabetta, erotica e glaciasale, passionale e implacabile, nel ruolo scenico. Purtroppo la voce stanca, un po’ spenta, a differenza forse della prima del 17 e della recita del 20, per questa ultima rappresentazione di questo titolo le forze sembrano venire un po’ meno, soprattutto nell’intensità della voce e nelle note più gravi con i salti dall’acuto alla parte bassa della tessitura. Tuttavia fraseggio e cura delle agilità non mancano in particolar modo nell’acuto, segno che nonostante il numero di primavere la qualità di un’artista prosegue nell’approccio alla partitura e al personaggio che in “Alma infida, ingrato core” e “in quel sangue versato” di vera bravura e patetismo. Mirabile la Sara di Sonia Ganassi, che quasi offusca l’astro della Devia in questa recita. Ottima nella scena, disperata amante che non può osare ad amare, di quell’amor platonico che ricorda l’Amelia e il Riccardo de Il ballo in maschera, sentimento impossibile che divora i protagonisti, portati alla morte dalla gelosia e dalla sete di vendetta per un adulterio che non si è materializzato, ma solo sublimato dal sentire del cuore. Il duca di Nothingam di Mansoo Kim, ben calato nel personaggio soprattutto nel confronto col discoperto Devereux, l’odio e la sete di vendetta scoppiano posto davanti all’amoroso dono di Sara al suo migliore amico, e vocalmente facendo del trio tra Elisabetta, Notingham e Devereux il culmine di tutta l’opera, in una fantastica interpretazione dei tre tra la scena quinta e sesta del secondo atto. Va dato veramente merito al teatro Carlo Felice per questa stagione d’opera che accanto a titoli come Tosca affianca Roberto Devereux e Andrea Chenier, che andrà in segna dal prossimo 12 aprile. Titoli che latitano dai cartelloni dei teatri, partiture di rara bellezza che per essendo poco note ai più vengono messe in sordina, per far fronte ad un pubblico più pop in questo periodi di crisi e difficoltà. Lodevole questa scelta di cartellone, peccato che la promozione non vada a dialogare più con la città per attirare più genovesi in questo splendido Teatro mosso da scelte di qualità e rara bellezza.
MADAMA BUTTERFLY [Lukas Franceschini] Venezia, 24 marzo 2016.
Madama Butterfly è uno dei titoli che il Teatro La Fenice ha inserito nel “repertorio” della propria programmazione, come in uso nei teatri esteri. Reputo che tale scelta sia una delle più efficaci dal punto di vista imprenditoriale per una Fondazione, quale quella veneziana, che ha a disposizione un bacino di pubblico molto eterogeneo e diverso da altre istituzioni musicali. Lo spettacolo fu creato nel 2013 quale progetto speciale della 55ª Esposizione Internazionale dell’Arte della Biennale di Venezia: regia di Alex Rigola, scene costumi di Mariko Mori. Dello spettacolo ebbi modo di parlarne a suo tempo, rivisto a distanza di qualche anno, non sono cambiate le mie impressioni. Questa Butterfly s’ispira decisamente al teatro kabuki di origine orientale, e si discosta enormemente dalla concezione drammaturgica dell’autore il quale scelse solo il soggetto ambientato in Giappone ma con idee del tutto estranee al genere. La regia è molto linearie con una recitazione contenuta e manierata, mai un accenno al trasporto dei sentimenti che in Puccini è l’anima di ogni suo spartito. Fredda e glaciale drammaturgia, s’impone al centro una scultura astratta per tutta la durata dell’opera, scena inesistente creata solo da un fondale chiaro, costumi volutamente bianchi senza identità, luci abbaglianti. Uno spettacolo che non affascina, di difficile comprensione, il quale non disturba ma butt 3non lascia neppure traccia. Tuttavia l’interesse di questa ripresa consisteva nella presenza di Myung-Whun Chung sul podio e del soprano Vittoria Yeo, cantante sempre più in ascesa. Chung è direttore di prim’ordine, non serve ripeterlo, e sceglie una lettura molto raffinata e attenta al dettaglio. Complice una buona performance dell’orchestra, raramente così precisa e attenta, segue il segno drammaturgico con perizia maniacale senza mai perdere il filo narrativo e soprattutto il colore e il fraseggio musicale. Si potrebbe affermare che la sua direzione è un romanzo d’appendice di tragedia annunciata eseguita con mano dinamica quanto duttile ed emotivamente efficace. A chi scrive, tuttavia, è parso più scrupolosa e attenta al dettato pucciniano la seconda parte dell’opera rispetto la prima. Molto positiva la prova di Vittoria Yeo, la quale si conferma una delle più interessanti promesse sopranili. Dotata di voce integra in tutti i registri, rotonda e di bel colore, traccia una Cio-Cio-San rilevante sotto tutti gli aspetti. Purtroppo la regia statica non le permette di mettere in luce anche una personalità scenica di altrettanta fattura poiché nello stesso ruolo l’ho già ascoltata in teatri minori. Semmai unica cosa da eccepire sarebbe il fraseggio in quest’occasione meno risolto del solito, tuttavia, una prova sicuramente convincente, la quale potrà essere perfezionata e approfondita in seguito. Vincenzo Costanzo è un tenore con bella voce, purtroppo non sorretta da una tecnica raffinata pertanto il canto è sempre “aperto” e sovente ingolato. Questa caratteristica nega anche un fraseggio e una modulazione di colore monotono, quando avrebbe tutte le carte in regola per disegnare un Pinkerton apprezzabile. Manuela Custer si conferma un’ottima Suzuki, timbro corposo, bravissima fraseggiatrice. Luca Grassi è un bon cantante di mestiere e rende evidente uno Sharpless autorevole, preciso e senza sbavature, magari dovrebbe curare maggiormente accento e fraseggio poiché il grande duetto del II atto era piuttosto monotono. Buona la prova di Luca Casalin, un Goro interpretativamente subdolo e vocalmente preciso. Nelle numerose parti di fianco si mette in luce il bravo William Corrò, Yamadori, mentre il Bonzo di Cristian Saitta era troppo tonante e grezzo. Per dovere di cronaca elenco la buona professionalità degli altri: Julie Mellor (Kate), Salvatore De Benedetto (Yakusidé), Emanuele Pedrini (Commissario imperiale), Eugenio Masino (Ufficiale del registro), Marta Codognola (Madre di Cio-Cio-San), Alessandra Vavasori (la zia) e Sabrina Mazzamuto (la cugina). Bravissimo il coro istruito da Claudio Marino Moretti. Successo vivissimo, al termine, per tutta la compagnia, con particolari ovazioni per la Yeo e il maestro Chung.
WHATEVER WORKS [Lukas Franceschini] Bolzano, 1 aprile 2016.
La stagione Lirica dell’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano prosegue il suo percorso “Oper.a 20.21” presentando una novità assoluta per l’Italia: Whatever Works, opera satirica a quattro mani di Manuela Kerer e Arturo Fuentes. Il fatto che un’opera lirica sia frutto di due compositori diversi già determina la particolarità dello spartito, il quale ha avuto la sua prima rappresentazione al Rabenhof Theater di Vienna lo scorso 7 novembre 2015. Il librettista Dimitvré Dinev si è ispirato a un’idea del regista Michael Scheidl (il quale ha curato anche la messa in scena dell’opera) producendo una farsa satirica suddivisa in quattordici scene che palesa l’assurdità della burocrazia e della mala politica. Tema dell’opera l’arrivismo, la sete di potere, e il disprezzo per il prossimo, di due ambiziose politiche, le quali useranno i fondi per aiuti umanitari a proprio piacimento e uso personale. Difetti e modo d’agire di rappresentanti politici le cui gesta non si differenziano per nazionalità ma si accomunano per arroganza. Le affinità con molti fatti di cronaca contemporanei sono purtroppo molteplici. L’opera lirica si è sovente occupata di satira sociale, basti pensare a The Beggar’s Opera di John Gay e Johann Christoph Pepusch (forse la prima, sicuramente la più celebre), oppure nel secolo scorso a Die Dreigroschenoper di Kurt Weill e Bertold Brecht e a Candide di Leonard Bernstein, ma siamo ben lontani da questi capolavori sia per le liriche sia per la musica.Whatever Works, che si può tradurre anche in “qualunque cosa che funzioni”, ha quali protagoniste due donne: Umma, ministra degli wha 2affari esteri, ed Emma, Alto commissario ONU. Esse dovrebbero gestire i fondi economici per gli aiuti ai popoli bisognosi, ma come la prassi odierna insegna tali risorse non giungeranno mai a destinazione, per malaffare e anche una sommaria rivalità politica tra le due. Nelle quattrodici scene che compongono l’opera, della durata di circa ottanta minuti, assistiamo a situazioni parallele alle vicende cardine: tre autisti che si lamentano del loro lavoro (uno è l’amante della commissaria), il continuo cambio di risorse per i bisognosi che diminuiscono per entità, il carico poi preso dai terroristi, la politica che fa sempre propaganda, i vizi sadici sessuali della commissaria Onu col giovane amante, le inutili parole della politica ma efficaci per la stampa che deve enfatizzare le misere donazioni. Un quadro drammaturgico completamente scompigliato e scollegato seppur nella breve e serrata narrazione. Anche il regista Michael Scheidl non trova un sequenziale e avvincente coinvolgimento nella storia, ma preferisce creare scena dopo scena, che segmenta e fraziona l’idea del librettista, anche originale e moderna, ma sviluppata a compartimenti stagni e con linguaggio banale, talvolta scurrile. Manca nel finale un quadro sulla moralità della politica rispetto a tali beceri comportamenti.Gli autori musicali si sono divisi il loro compito di composizione musicando la Kerer sei scene, Fuentes le altre otto. La parte orchestrale era composta dai solisti della Haydn, un pianoforte, un violino, un violoncello, un flauto inserito in una struttura di legno, wha 3percussioni e musica elettronica. Non entusiasma il linguaggio musicale, piuttosto statico e molto ritmato con l’aggiunta di percussioni anticonvenzionali. Ci sono citazioni a celebri brani pop o d’opera (Carmen di Bizet), ma il tutto era di routine e sommariamente scontato. Se dovessi esprimere una preferenza, ritengo che la musica di Fuentes abbia un’originalità più cromatica rispetto a quella della Kerer, l’ausilio dell’elettronica favorisce nel primo un’estetica variegata di stili che sono assemblati in un unico linguaggio che coniuga la diversità di varie epoche. Nella musica di Manuela Keres prevalgono i timbri, nello specifico suoni isolati ripetuti e ribattuti, che disegnano uno stile proprio senza riferirsi a una precisa idea, piuttosto all’astratto.Lo spettacolo proveniente da Vienna e realizzato a Bolzano nella piccola sala sotto il Teatro Comunale è concepito dal regista Michael Scheidl in maniera minimalista ma troppo accademico, quasi un teatro d’avanguardia di collettivi anni ‘70 (presumo che anche il teatro austriaco fosse di piccole proporzioni). Molto spettacolare la scena XII nella quale Emma seduce il giovane amante in manette.I Solisti della Haydn erano concertati da Simenon Pirankoff, il quale non ha molto da sbracciarsi con tali spartiti, ma con grande impegno cerca di dare un certo ritmo e melodia a musiche che in sostanza sono astratte e di difficile coniugazione tra loro.Il cast era molto appropriato, spiccavano le due protagoniste femminili: Shira Karmon (Emma) e Sarah Maria Sun (Emma) per stile vocale, peraltro di difficile esecuzione, e aderenza al personaggio. Bravi anche i tre austisti, Kaja Reichert, Stefan Bleiberschnig e Martin Busen, piuttosto sfasato Vasily Khoroshev (capitano dei pirati), efficaci Bibiana Nwobilo (la dissidente) e John Sweeney wha 4(un funzionario). Pertinente il coro Ensemble Arcantus.Nel complesso questa nuova opera non entusiasma ma fa riflettere su un nuovo stile di musicalità che troverà spazio solo in rassegne specifiche e di nicchia.Al termine successo molto entusiasta da parte del pubblico (circa duecento persone) forse per la presenza della compositrice concittadina.
LA CENA DELLE BEFFE [Lukas Franceschini] Milano, 6 aprile 2016.
Caso strano quello dell’opera La cena delle beffe di Umberto Giordano. Eseguita in prima assoluta alla Scala il 20 dicembre 1924, diretta da Arturo Toscanini, ripresa l’anno seguente e mai più rappresentata fino alla stagione attuale. Non si può affermare sia uno dei migliori spartiti del ‘900, ma avrebbe meritato maggior veicolazione, invece le poche proposte si contano sul palmo della mano. Il soggetto è tratto dall’omonimo dramma di Sam Benelli, uno degli autori teatri di maggior successo agli inizi del secolo scorso. La pièce, del 1909, ebbe immediato successo e popolarità sia in Italia sia all’estero. Fu rappresentata peraltro a Broadway con John Barrymore e a Parigi con Sarah Bernhardt (in ruolo en travesti), la consacrazione anni dopo fu la pellicola cinematografica di Alessandro Blasetti con Amedeo Nazzari, Osvaldo Valenti, Valentina Cortese, Memo Benassi, Luisa Ferida, Elisa Cegani, Lilla Brignone e Clara Calamai, della quale si ricorda il primo seno nudo in un film italiano. Benelli fu considerato a sproposito un “D’Annunzio” in miniatura mentre fu un vero e proprio drammaturgo di grande stile. Durante il fascismo ebbe problemi con il regime al quale non erano graditi i suoi lavori poiché rappresentavano i difetti e non le virtù del popolo italiano, nel caso della “Cena”, una tipica lussuria toscana, il dramma è ambientato a Firenze all’epoca di Lorenzo il magnifico. Giordano crea un dramma in prosa musicale nel quale è peculiare l’arte declamatoria e in parte verista. L’impianto è tipicamente lirico ma sensuale anche se il comune denominatore è la vendetta. Opera modernissima e d’azione, con tinte cupe di tragedia, nella quale cena 3potremo ravvedere un tipico caso di bullismo, in altre parole un tema sociale di sopraffazione verso i deboli, una discriminazione intesa come spettacolo. Trattasi di storia eterna, anche se ambienta nel ‘400. Il libretto fu musicato come scritto ma ne fu tagliato per circa la metà dall’autore stesso per la scena operistica. Furono aggiunti dei versi per rendere più significato il personaggio di Ginevra. Il regista Mario Martone ha avuto l’idea che la musica di Giordano si sposa benissimo con gli anni ’20 americani capeggiati da bande di malavitosi. Firenze si sposta dunque a New York, nella Little Italy con bande mafiose, e si ammira una scena formata da tre piani diversi, che come un ascensore cambia a vista. Encomio alla creatrice Margherita Palli che sfrutta tutte le possibilità tecnologiche della Sacla, la grande sala de ristorante che ricorda “Il grande Gatsby”, la cantina cupa e truce, la modesta casa di Ginevra, tutto in stile perfetto e molto hollywoodiano. Bellissimi i costumi di Ursula Patzak, grande foggia ed eleganza che rimandano sempre a memorie cinematografiche. Martone gioca sul lato erotico del dramma e lo fa con mano sapiente e funzionale teatralità, lo spettacolo è preciso e molto accattivante, sembra di assistere alla proiezione di un film. In quasi tutto il cast trova attori che lo seguono con efficace incisività. Lascia perplessi la scena finale, la quale seguendo la linea drammaturgica del regista offre un colpo di scena inaspettato quando Lisetta entra nella stanza ove si appena consumato il delitto-beffa e assieme ad un gruppo di gangster, compie una carneficina tipica di episodi criminali dell’epoca. Scelta azzeccata dal punto di vista teatrale ma che differenzia cena 4notevolmente dal testo di Benelli. La direzione di Carlo Rizzi è stata di buon mestiere e professionale, centrata soprattutto sull’equilibrio tra buca e palcoscenico che è stato raggiunto in maniera egregia, complice un’orchestra in ottima forma. Potremo rilevare che talvolta mancavano peculiari sonorità sia da punto narrativo sia nelle scene erotiche, ma Rizzi doveva fare i conti con un cast non sempre all’altezza del compito, pertanto certe dinamiche erano impensabili. Quanto al cast penso che la Scala abbia proposto quanto di meglio oggi reperibile, pur con delle eccezioni. Marco Berti, Giannetto Malespini, è un tenore solitamente alterno ma in questo ruolo trova anche una certa misura nel canto declamato, purtroppo il legato non è raffinato, l’intonazione sovente precaria e il fraseggio assente. Meglio la prova di Nicola Alaimo, Neri Chiaramentesi, interpretativamente era più credibile, voce robusta e sonora cui però manca l’incisività, l’ampiezza vocale, e il segno del verismo canoro, tuttavia oggi forse è stata la migliore scelta nel panorama baritonale e nel complesso si ritaglia un personale successo, anche se non è cantante per tutti i repertori. Kristin Lewis, Ginevra, è il “tallone d’Achille” del cast, qui si che si poteva trovare di meglio. La cantante è penalizzata da una dizione arraffata e incomprensibile, cui dobbiamo sommare la totale assenza di sensualità e un timbro è sempre stridulo. Il lungo elenco dei personaggi in locandina prevedeva alcuni ruoli marginali ma fondamentali nella drammatica vicenda. Jessica Nuccio, Lisabetta, che coglie un personale successo per dolcezza e incisiva partecipazione vocale. Il Gabriello Chiaramentesi di Leonardo Caimi è perfettamente calato nel ruolo e buon cantante. Magnifico il sadico dottore di Bruno De Simone, è il caso di affermare che la classe non si appanna mai, come il sornione Tornquinci di Luciano Di Pasquale. Molto brava Chiara Isotton nel ruolo di Cintia e il giovane Edoardo Milletti, Lapo e un cantore, il quale ci regala una soave canzone nel IV atto. Per dovere si citano anche gli altri personaggi, tuti ben calibrati sia scenicamente sia vocalmente: Frano Lufi (Fazio), Giovanni Romeo (il Calandra), Chiara Tirotta (Laldomine), Federica Lombardi (Fiammetta), Francesco Castoro (il Trinca). Opera come si diceva non di repertorio che, tuttavia ha attirato molto pubblico curioso, il quale ha decretato un convinto successo al termine a tutta alla compagnia.
LA CENA DELLE BEFFE [William Fratti] 28 aprile 2016.
Le opere considerate minori di Umberto Giordano, così come quelle di altri autori italiani del primo Novecento, fanno parte di quel repertorio purtroppo bistrattato, anche se sarebbe decisamente interessante averle più spesso nei cartelloni dei palcoscenici europei. È una gioia trovare La cena delle beffe nella stagione della sala del Piermarini, anche se si è consapevoli dei numerosi rischi che si corrono nel mettere in scena un titolo così poco rappresentato oltreché di difficile esecuzione. Non si lascia intimorire Mario Martone che abbandona l’originale ambientazione rinascimentale a favore di una più attuale – e decisamente cinematografica – trasposizione a Little Italy, dove abiti gessati, spaghetti al pomodoro, rivoltelle e qualche piuma di uccello esotico rendono questa cena davvero appassionante. Complice il bellissimo allestimento con scene di Margherita Palli, che conduce la vicenda dal ristorante di Tornaquinci alle stanze di Ginevra al piano di sopra, fino alle cantine dove è rinchiuso il povero Neri. Eccellenti nel disegno e di pregevole fattura i costumi di Ursula Patzak. Piacevoli le luci di Pasquale Mari. In definitiva l’amalgama creato da Mario Martone rende lo spettacolo un perfetto lavoro per la tv e il cinema, che nella prima parte lascia lentamente entrare il pubblico, per poi condurlo in una serie di emozioni convulse, travolgenti e a tratti catartiche nella seconda e nel forte finale, degno de Il padrino e Boardwalk Empire. Indiscusso protagonista musicale è Carlo Rizzi, che dirige con estrema precisione e chiarezza d’intento l’Orchestra del Teatro alla Scala che si prodiga in un’esecuzione pulitissima e dai suoni cristallini. Il fraseggio orchestrale voluto da Rizzi, i cromatismi e le sfumature con cui conduce questo Giordano avaro, quasi privo di melodie accattivanti, sono di altissimo livello e la presa emotiva è davvero forte. La difficilissima parte di Giannetto è affidata a Marco Berti, che mette in mostra i suoi acuti smaltati e svettanti, ben posizionati in avanti e generosi per tutta la durata dello spettacolo. Purtroppo la zona medio grave non è della medesima bellezza, denotando una linea di canto un poco approssimativa e a tratti stonacchiata. È invece lontano da ogni imperfezione il Neri di Nicola Alaimo, dotato di una vocalità ben timbrata anche nei piani, morbida e omogenea dalla nota più alta fino a quella più bassa, impreziosita di un fraseggio eloquente e ben rifinito che sa farsi notare anche grazie ad un sapiente uso dei colori. Non male la Ginevra di Kristin Lewis che risulta vocalmente migliore rispetto sue precedenti performance. Resta il fatto che non si capisce una parola e che i piani sono spesso coperti dal peso orchestrale. Anche Jessica Nuccio, nei panni di Lisabetta, appare più adatta che in altri ruoli. Positiva anche la prova di Bruno De Simone nelle vesta del dottore. Adeguati gli altri comprimari: il Gabriello di Leonardo Caimi, il Tornaquinci di Luciano di Pasquale, il Fazio di Frano Lufi, la Cintia di Chiara Isotton, il Lapo e il cantore di Edoardo Milletti, nonché i solisti dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala: Giovanni Romeo, Chiara Tirotta, Federica Lombardi, Francesco Castoro.
MADAMA BUTTERFLY [William Fratti] Piacenza, 8 aprile 2016.
Il Teatro Municipale di Piacenza conclude la Stagione Lirica 2015-2016 nel segno del successo, dimostrando ancora una volta di essere tornato a produrre spettacoli di alto livello, degni di interesse internazionale. Per l’occasione il capolavoro pucciniano è diretto con vigore e passione da una delle bacchette oggi maggiormente impegnate su questo repertorio, Valerio Galli, che forse non riesce ad ottenere una perfetta pulizia di suono, ma indubbiamente sa far entrare l’ascoltatore nel dramma. Il bravo Maestro guida con impeto e fermezza di polso l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, che inizialmente sembra un po’ pasticciona, soprattutto negli ottoni e particolarmente nei corni, ma fortunatamente si riprende col procedere della vicenda. La regia di Sandro Pasqualetto è abbastanza noiosa, monotona e pressoché immobile, concentrata su una sorta di staticità da cartolina che va ad escludere molte delle didascalie del libretto di Illica e Giacosa. Gli interpreti sono posizionati quasi in una formazione da concerto, mentre sono apprezzabili i movimenti di mimi e figuranti che legano sapientemente le scene alle controscene. Leggendo le note di regia si desume che Pasqualetto non è stato in grado di raggiungere gli scopi prefissi, anche se la ragione non è molto chiara, poiché il risultato ottenuto è stato solo il nulla. Molto piacevole è invece l’allestimento progettato da Christoph Wagenknecht e Catherine Voeffray, poi curato da Pasqualetto e Rosanna Monti anche nei bei costumi, impreziosito dalle luci suggestive di Claudio Schmid. Si è già parlato decine di volte dei personaggi pucciniani interpretati da Amarilli Nizza e c’è il rischio di ripetersi, poiché anche in questa occasione la cantante scompare e resta solo Cio-Cio-San con la sua fragilità, la sua ingenuità, il suo immenso dolore. Amarilli Nizza, costretta dalla regia in una staticità che non le appartiene, sfoga il suo essere Butterfly in un fraseggio impareggiabile, così espressivo da arrivare a cantare ogni singolo sospiro della madre bambina, con una voce sempre piena e ben poggiata, anche nei piani timbratissimi, e il pubblico non riesce a trattenersi applaudendola a scena aperta a metà del secondo atto. Un vero trionfo personale più che meritato, soprattutto nel finale intriso di lacrime che ha commosso molti spettatori. Vincenzo Costanzo, nei panni di Pinkerton, ha una bella voce generosa, ma se continua a cantare in questo modo rischia di dover abbandonare il palcoscenico entro pochi anni: il suono non è ben posizionato, spesso fuori maschera, quasi mai sul fiato, tanto da arrivare a parlare nei recitativi e si nota subito una grande differenza con tutti gli altri colleghi. È un peccato che una tal vocalità, tipica da tenore all’italiana, venga sprecata dall’imprecisione e dal pressapochismo, pertanto c’è da sperare che si metta presto nelle mani di un bravo insegnante. Nazomi Kato è una bravissima Suzuki, non solo nell’elegante personaggio, ma soprattutto per la purezza e limpidezza della sua linea di canto, sempre pulita, mai forzata, mai ingrossata. Altrettanto vale per l’ottimo Sharpless di Mansoo Kim, ben timbrato e brillante, nonché bravo fraseggiatore. Davvero positiva è la prova di Luca Casalin nel ruolo di Goro e particolarmente efficaci sono Alessio Verna e Cristian Saitta nei panni di Yamadori e Bonzo. Buona la prova degli altri comprimari – Federica Gatta, Jin Heon Song, Giovanni Gregnanin – e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Lunghissimi applausi al termine della recita, con più alzate di sipario.
ŒDIPUS REX [Margherita Panarelli] Torino, 8 aprile 2016.
È l’opera-oratorio Œdipus Rex di Igor Stravinskij la protagonista del diciannovesimo appuntamento della stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Con un ottimo cast vocale e la voce recitante di Toni Servillo il risultato è un’esecuzione di grande vigore. Juraj Valčuha alla testa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, al suo penultimo appuntamento nei panni di Direttore principale, offre una lettura robusta e energica della partitura Stravinskiana, incisiva drammaturgicamente e sempre attenta alle esigenze dei solisti. Eccellente anche la prova della compagine maschile del Coro Filarmonico di Brno, guidato da Petr Fiala, i cui interventi ritraggono egregiamente gli abitanti della Tebe preda della pestilenza, che discaccia Edipo con una grande malinconia dopo i terribili eventi che seguono il disvelamento delle origini del loro Re. Toni Servillo è un narratore di gran classe e dall’enorme talento. Pur con poche righe, narra eloquentemente le tristi vicende del risolutore di enigmi trasportandoci fin da subito nell’atmosfera tesa e grave dell’opera-oratorio. Brenden Gunnel è un protagonista dell’emissione solida e stentorea, adatta all’alterigia inziale del personaggio. Riesce poi bene ad ammorbidire e piegare la voce alle paure e alla disperazione finale di Edipo offrendone un ritratto sfaccettato. Sonia Ganassi è una Giocasta dal timbro caldo e dalla grande sicurezza nel registro grave. Ottima anche l’intesa con il tenore. Alfred Muff è un eccellente Tiresia, vigoroso e imponente. Molto bravo anche Marko Mimica nel doppio ruolo di Creonte e del Messaggero, cui è affidato il drammatico racconto della fine di Giocasta ed Edipo. Facilità nel registro acuto e incisività nel fraseggio rendono i suoi interventi suggestivi ed efficaci. Ottimo anche Matteo Mezzaro nel pur breve ruolo del Pastore, unico conoscitore insieme al Messaggero della vera identità di Edipo. L’opera-oratorio è preceduta nel programma dalla Sinfonia n. 1 in re maggiore op.25 di Sergej Prokof’ev- Il sottotitolo “Classica” esprime perfettamente le atmosfere e le suggestioni di questa composizione giovanile del compositore russo, suggestione che sono trasparse anche nella bella esecuzione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai fresca e vivace. Il pubblico, numerosissimo, ha salutato con calore tutti gli interpreti.
LA DONNA SERPENTE [Lukas Franceschini] Torino, 17 aprile 2016.
Finalmente i palinsesti dei teatri italiani iniziano a essere più variegati e non rifugiarsi nei soliti titoli di repertorio con la scusa che il pubblico evita proposte diverse. In questo mese abbiamo avuto tre proposte molto interessanti di rara esecuzione: La cena delle beffe di Umberto Giordano alla Scala (di cui abbiamo parlato in precedenza), La campana sommersa di Ottorino Respighi a Cagliari e ora La donna serpente di Alfredo Casella al Teatro Regio di Torino. Penso che questa premessa sia doverosa poiché l’abituale frequentatore del teatro d’opera ha oggigiorno poche alternative rispetto ai titoli proposti soprattutto di autori italiani, dei quali soliti compaiono solo ed esclusivamente i titoli più conosciuti, gli altri collocati nell’oblio ad eccezione per alcuni festival. È dunque molto indicativa la proposta del Teatro Regio di Torino di allestire l’opera del proprio concittadino, la quale è rappresentata per la prima volta nel teatro torinese e parallelamente è stato organizzato un festival dedicato al compositore. Oltremodo La donna serpente si può considerare come l’unica vera e propria opera lirica di Casella poiché le altre sono un’opera da camera, un mistero in un atto e alcuni balletti. Peculiarità che il musicista, già affermato pianista e compositore di spartiti da camera, si sia avvicinato all’opera lirica solo dopo i cinquant’anni d’età. In effetti, la domanda era quale stile affrontare e come porsi nel teatro lirico dopo musicisti come Verdi, Puccini, Wagner e Strauss? Casella sceglie una strada non definita pur avendo ben chiaro che era doveroso scartare il verismo e il drammatico wagneriano, questo avviene nel periodo della sua piena maturità artistica. Nello scegliere una fiaba teatrale di Carlo Gozzi, il compositore volle “romanzare” l’intrinseca natura antirealista del melodramma forgiando un genere che in Italia era stato spesso ignorato ovvero il fiabesco. La drammaturgia è caratterizzata da varietà e velocità. Le componenti teatrali sono la commistione tra il tagico e il comico, quest’ultimo è distinto dall’inserimento all’intreccio fantastico ma drammatico delle maschere della commedia dell’arte, esperimento che utilizzò anche Puccini nell’ultima sua opera incompiuta. L’aspetto sentimentale dello spartito è rappresentato dai due protagonisti: la fata Miranda e il Re Altidor. Molto riuscita la scena nel finale secondo, nel quale ai bambini rimasti (momentaneamente) orfani è intonato un canto di consolazione di grande pathos. Altrettanto il grande assolo di Miranda del terzo atto, la protagonista canta un lamento a cappella, improvvisando, Casella s’ispira alla tradizione del seicentesco “recitar cantando”, non tralasciando anche donna 3uno stile di madrigalistica ispirazione. L’orchestrazione disegna il tema fiabesco con molteplici e continui colori, cui il compositore rivela ottima maestria di disegno, tuttavia non sempre efficace nel tessuto operistico, le forme sono originali, ma è evidente una recitazione statica. Le passate rappresentazioni dell’opera, riportate nel bellissimo programma di sala, tra esecuzioni teatrali e radiofoniche si contano solo sette proposte compresa questa torinese. Poche, tuttavia l’opera italiana del ‘900 non è prassi molto frequentata. Anche le reazioni della prima assoluta sono contrastanti, chi parla di scarso successo, chi di pubblico entusiasta, resta il dubbio… che non è fondamentale, piuttosto bene ha fatto il Teatro Regio di Torino di programmare l’opera utilizzando uno spettacolo creato la scorsa estate al Festival di Martina Franca. Proprio perché nato per uno spazio all’aperto lo spettacolo di Arturo Cirillo, con scene di Dario Gessati e gli sfarzosi costumi di Gianluca Falaschi, non ha trovato pienamente al chiuso l’aspetto fiabesco. La scena molto minimale, il palcoscenico era spesso vuoto, ma fortunatamente illuminato da Giuseppe Calabrò ottimo light designer, era costituita da quattro strutture moventi che utile rilevarlo erano utilizzate con maestria. Piuttosto sia le masse sia i singoli cantanti non trovavano una cifra teatrale narrativa, troppo statici, entrate banali, spesso lasciati al loro istinto piuttosto che guidati nel mondo fantastico e drammatico di Casella. Punto di forza le coreografie di Riccardo Olivier utilizzate in molti momenti orchestrali. Il vero artefice di questa riproposta è stato il direttore Gianandrea Noseda che fermamente convito del valore dello spartito ci ha regalato una lettura emozionante, ricca di sfumature, curata del dettaglio, incisività narrativa ed evidenziando con forza i molteplici aspetti della dimensione orchestrale ora cameristica, ora impulsiva e veemente. Tutto questo non sarebbe stato senza il contributo dell’ottima Orchestra del Regio con la quale il direttore ha rapporto d’eccellenza. La difficoltà d’allestire La donna serpente consiste anche nel radunare un foltissimo cast, il quale oltre ai protagonisti ha parti brevi ma molto importanti nel contesto musicale. L’occasione odierna è stata all’altezza del compito. Carmela Remigio, la fata Miranda, coglie in questo ruolo un successo personale molto superiore a sue recenti performance drammatiche. La scrittura lirica di base le permette di mettere in risalto una vocalità brillantissima, abbinata a una buona rifinitura del fraseggio e del canto recitato, questo si apprezza in particolar modo nell’assolo all’inizio del terzo atto (“Vaghe stelle d’orsa”). Non sono mancate una perizia in zona acuta e un’immedesimazione drammatica di pregio. Convincente anche Piero Pretti, che ha realizzato Re Altidòr accentando la parola e reggendo la non facile prova con una linea di canto pertinente e mai forzata. In alcuni passi forse la scrittura era impervia per la sua voce, ma il cantante ha saputo superare l’ostacolo con grande musicalità e partecipazione scenica. Di grande resa vocale e teatrale le quattro figure delle maschere, le quali hanno in Roberto De Candia, Pantul, un apice per carisma ed esperienza di scena, cui si sommano Fabrizio Paesano, Tartagil, Marco Filippo Romano, Albrigor, e Francesco Marsiglia, Alditruf. Molto brava Erika Grimaldi, Armilla, che si produce in un canto fluido e preciso. Pregevoli le prove di Francesca Sassu, precisa Frazana, e Anna Maria Chiuri, imperiosa Canzade. Più in ombra Sebastian Catana, un Demogorgon dalla ruvida vocalità Completavano la locandina con molta professionalità Fabrizio Beggi (Togrul) Kate Fruchterman (fata smeraldina), Donato Di Gioia (Badur), Emilio Marcucci (primo messo e voce di Geonca), Alejandro Escobar (secondo messo), Eugenia Braynova (prima fatina), Roberta Garelli (seconda fatina), Giuseppe Capoferri (voce interna). Il Coro del Teatro Regio, preparato da Claudio Fenoglio, ha fornito prova di grande professionalità aggiungendo al generale contesto un apporto impareggiabile. Teatro molto gremito per un’opera cosi poco rappresentata e in pratica sconosciuta, il pubblico ha gradito e ha tributato un caloroso successo, al termine, a tutti gli interpreti.
LA DONNA SERPENTE [William Fratti] Torino, 21 aprile 2016.
Il Teatro Regio di Torino centra l’ennesimo bersaglio con la messinscena de La donna serpente nell’ambito del Festival Alfredo Casella, celebrando degnamente e come si conviene il compositore torinese. L’opera fiaba deve essere vista, non solo perché godibile e piacevole, ma anche perché contiene spunti musicali davvero interessanti. Certamente oggi è possibile affermare di non essere di fronte a un genio incompreso, ciononostante l’ascolto dei suoi lavori genera una certa curiosità, che attende solo di essere esaudita, come un desiderio di qualcosa di nuovo. Produrre questo genere di spettacoli presenta sempre grossi problemi in ambito artistico, poiché non essendo di immediata presa sul pubblico, non essendo di repertorio ed eseguendosi solo molto raramente, per funzionare hanno sempre bisogno di grandi e veri professionisti. Ed in questo senso il Teatro Regio non bada a spese e raggiunge l’obiettivo, presentando in locandina nomi di assoluto rilievo, a partire dal direttore musicale che gioca la parte del padrone di casa. Gianandrea Noseda e la sua espertissima e preparatissima orchestra eseguono la non breve partitura con cura e precisione, dispiegandosi in una serie di suoni sempre puliti, ben amalgamati, nonché distinti al tempo stesso, mai confusionari o pasticciati neppure nelle numerose pagine che contengono qualche pericoloso tranello. Il secondo atto è addirittura migliore del primo, il terzo ancora più vincente, un’apoteosi con degli effetti corali davvero maestosi ed entusiasmanti, complice anche la bravura e la competenza del Coro guidato da Claudio Fenoglio. Protagonista della fiaba è la Fata Miranda qui interpretata dalla bravissima Carmela Remigio, sempre morbida e omogenea nella sua linea di canto, accompagnata dallo svettante e generoso Piero Pretti nei panni di Altidor. Eccellenti le comprimarie femminili capitanate dalla Farzana/Corifea di Francesca Sassu e dalla Canzade di Anna Maria Chiuri, musicali e precise, affiancate dalle efficaci Erika Grimaldi e Kate Fruchtermann nei panni di Armilla e Smeraldina/Voce nel deserto. Davvero ottime le parti dell’ombroso Togrul di Fabrizio Beggi e delle maschere, soprattutto i divertenti Albrigor di Marco Filippo Romano e Pantul di Roberto De Candia, oltre agli opportuni Alditruf di Francesco Marsiglia e Tartagil di Fabrizio Paesano. Autorevolissimo il Demogorgon di Sebastian Catana. Adeguate anche le altre parti di contorno: Donato Di Gioia, Emilio Marcucci, Alejandro Escobar, Eugenia Brayanova, Roberta Garelli, Giuseppe Capoferri. La regia di Arturo Cirillo, con le scene di Dario Gessati e i costumi di Gianluca Falaschi, è funzionalissima; l’impianto è facile e veloce da muovere nei continui e numerosi cambi di situazione, i cui ambienti sono inventati dalla suggestione creata dalle belle luci di Giuseppe Calabrò e dalle coreografie di Riccardo Olivier, operate dai bravissimi mimi e dai danzatori di Fattoria Vittadini.
LA FAVOLA DI ORFEO [Margherita Panarelli] Torino, 11 aprile 2016.
Compositore, pianista e direttore d’orchestra, organizzatore e animatore culturale: Alfredo Casella ha occupato un posto speciale nel panorama musicale italiano del Novecento e il Festival a lui dedicato che si svolge nella sua città natale, Torino, dall’11 al 24 aprile si propone di ricordarlo e celebrarlo. Il primo degli appuntamenti del Festival è l’opera da camera “La Favola di Orfeo”, composta nel 1932. La bella Euridice scappa dal pastore Aristèo da lungo tempo invaghito di lei, un serpente velenoso ne provoca la morte e la sfortunata sposa di Orfeo è quindi destinata agli inferi. Un gruppo di Driadi porta la notizia ad Orfeo che si precipita alle porte dell’Ade per salvare la sua amata. Grazie alla sua maestria nel canto riesce ad ottenere la salvezza di Euridice, a patto di non guardarla fino a quando essa non sia tornata tra i vivi. Orfeo, che la precede non riesce a trattenersi dal girarsi a pochi momenti dalla salvezza e vanifica tutti i suoi sforzi condannando Euridice alla permanenza eterna nel mondo dei morti. Disperato, il cantore giura di rinunciare alle donne e alcune Baccanti, dopo aver inutilmente tentato di irretirlo lo uccidono per aver maledetto l’amore e si lanciano in una danza sfrenata. La storia di Orfeo ed Euridice è nota ed è stata messa in musica innumerevoli volte, proprio l’opera di Casella è un omaggio, anche a partire dallo stesso titolo, a Monteverdi ed alla prima opera, al cui stile sobrio ed equilibrato si rifà il compositore torinese, ed è proprio ad uno stile sobrio e misurato che mira Silvio Gasparella alla guida dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio per questa rappresentazione in forma semi scenica al Piccolo Regio di Torino. Il cast è giovane e competente, e l’apporto della sezione femminile del Coro dell’Accademia Corale Stefano Tempia è eccellente. Protagonista, e in un ruolo affatto semplice, è Dario Prola. Il corpo robusto della sua voce e la facilità nel registro acuto lo rendono adattissimo ad interpretare un Orfeo virile e appassionato. Kate Fruchtermann è un’Euridice delicata e eterea. Mariasole Mainini ha interpretato egregiamente invece i due ruoli di Driade e di Baccante. Riuscendo ad infondere un carattere diverso ai due personaggi, il giovane soprano si è cimentata abilmente in entrambi con intonazione cristallina, proiezione del suono eccellente e un timbro corposo e caldo davvero affascinante. Xiayou Ran è invece Plutone, tonante Dio degl’Inferi, dal timbro sorprendentemente scuro vista la giovane età ma certamente maturo e avvincente. Non delude Devis Longo nei panni di Aristèo, e Edoardo Rossi è una convincente voce recitante per la breve introduzione iniziale. Applausi calorosi e convinti all’intero cast da parte del purtroppo non numerosissimo pubblico presente in sala.
IL TABARRO/SUOR ANGELICA/GIANNI SCHICCHI [Simone Ricci] Roma, 20 aprile 2016.
“Il tabarro”, “Suor Angelica” e “Gianni Schicchi sono tornate insieme al Teatro Costanzi con una regia dal sapore malinconico. Il bambino morto, il bambino negato e il bambino che verrà: Damiano Michieletto ha cercato di trovare un filo conduttore nel “racconto” registico del Trittico di Giacomo Puccini rappresentato al Teatro dell’Opera di Roma. Due piccole scarpette da neonato sono comparse in tutti i tre atti unici del compositore toscano, una idea interessante con alcune libertà di scelta che non hanno comunque stravolto le storie. È raro assistere al Trittico in un’unica serata: lo smembramento iniziò poco dopo la prima rappresentazione del 1918, quasi a voler dare ragione alle recensioni della prima ora, secondo cui “Gianni Schicchi” era l’opera più forte delle tre e forse l’unica in grado di entrare in repertorio. Al Costanzi si è puntato su delle scene, curate da Paolo Fantin, dominate da container freddi e imponenti. Questa recensione si riferisce alla recita del 20 aprile. Il Trittico è cominciato con “Il tabarro”: non c’era alcun riferimento al barcone da carico di Michele di cui si parla nel libretto di Adami, ma proprio i container facevano pensare a un porto malfamato e abbandonato. Il tormento del protagonista era rappresentato dal bambino avuto con Giorgetta e morto, ricordato con una carrozzina, dei giocattoli e le già citate scarpette. Forse poteva essere più efficace la scena finale, con il tabarro-giaccone che copriva solo parzialmente il corpo di Luigi, visibile a tutti. Michieletto ha scelto di far scoprire a Giorgetta e non a Michele il cadavere, con un urlo straziante che è servito a collegare la prima con la seconda opera. Giorgetta si è ritrovata proiettata in un convento molto simile a un ospedale psichiatrico, con tanto di luci al neon e lavatoi sconfinati per dar vita a “Suor Angelica”. La regia ha puntato sul terrore e i primi segni di follia delle novizie, mettendo bene in evidenza l’insensibilità della Badessa e della zia principessa, con un pizzico del loro rimorso nel finale. Anche in questo caso la libertà registica è stata quella di negare a Suor Angelica di vedere il figlio tanto amato e mai conosciuto: lo straziante e breve abbraccio tra la madre morta e il figlio era commovente, nonostante il dettaglio dei polsi tagliati al posto del veleno per il suicidio. I container, trasformati in stanze del convento nel secondo atto unico, sono stati poi tappezzati con una carta da parati vistosa e di grande effetto in “Gianni Schicchi”: azzeccata è stata l’idea di rinchiudere la “masnada” in uno dei contenitori metallici per consentire di concludere l’opera comica in tutta tranquillità, mentre le scarpette consegnate a Rinuccio e Lauretta facevano pensare a una gravidanza della ragazza. Per quel che riguarda il cast vocale, la serata è stata dominata da Asmik Grigorian e Kiril Manolov. Il soprano lituano ha tratteggiato una Giorgetta convincente, con sfumature azzeccate e ricchezze di armonici, cimentandosi poi con uguale successo nel ruolo di Suor Angelica: la patina drammatica era quella richiesta da un personaggio spesso sottovalutato, una maturazione vocale che ha permesso di approfondirne gli aspetti più intimi. Manolov ha dato vita a un Michele dal cuore spezzato per la morte del figlio piccolo, convincendo il pubblico romano con una voce ben salda, un buon fraseggio e una linea di canto di rilievo. Forse Nulla, silenzio! poteva essere apprezzata maggiormente con un ritmo più rallentato, ma il risultato finale non era da disdegnare. Il baritono bulgaro ha impersonato poi uno Schicchi efficace e di comprovata professionalità, simpatico al punto giusto e padrone della scena. Tornando a parlare de “Il tabarro”, vanno sottolineate le prove di Antonello Palombi, un Luigi omogeneo dal punto di vista vocale e capace di tenere testa a Giorgetta nei duetti, oltre a Nicola Pamio (Tinca) e Domenico Colaianni (Talpa), adeguati e precisi, e la vivace e intraprendente Frugola di Anna Malavasi. Il cast era completato da Vladimir Reutov (un venditore di canzonette) e dai due amanti, Ekaterina Sadovnikova e Matteo Falcier, in seguito riproposti come Lauretta e Rinuccio. In “Suor Angelica” vanno rimarcate le performance della zia principessa, interpretata da Natascha Petrinsky, insensibile come richiede il personaggio e dotata di una linea di canto di rilievo, senza dimenticare la Badessa autoritaria e decisa di Anna Malavasi, la suora infermiera di Rossella Cerioni, amorevole e delicata, e la gradevole Suor Osmina di Beatrice Mezzanotte. In “Gianni Schicchi”, invece, la già citata Sadovnikova ha affrontato con aria sognante e nuances pregevoli O mio babbino caro, conferendo al ruolo il giusto atteggiamento sognante e spensierato. Matteo Falcier è stato un degno Rinuccio, sobrio e dalla discreta presenza scenica. Meritano un cenno il Simone buffo e spassoso di Domenico Colaianni, la Zita goffamente sensuale e impeccabile di Natascha Petrinsky, la Nella dall’incisività leggera di Simge Büyükedes e il Maestro Spinelloccio dal gustoso accento bolognese di Matteo Peirone. Daniele Rustioni ha diretto col piglio sicuro e convinto dei suoi 32 anni: è stato un importante elemento di unione per le tre opere e ha preso da subito in pugno la recita, accompagnando gli artisti grazie a una orchestra compatta e che ha espresso al massimo la gioia di fare teatro. Prezioso ed elegante come sempre il coro del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Roberto Gabbiani. Il pubblico ha applaudito convinto, dimostrando di apprezzare il risultato complessivo.
LA SONNAMBULA [Lukas Franceschini] Verona, 21 aprile 2016.
La Sonnambula di Vincenzo Bellini è stato l’ultimo titolo della Stagione Lirica al Tetro Filarmonico prima del Festival estivo e la successiva conclusione della stagione in autunno. Una premessa. Le recenti vicende della Fondazione Arena sono note a tutti e non è il caso di ripeterle, tuttavia è giusto rilevare sonn 2che tutte le maestranze hanno partecipato alla produzione dell’opera in un clima di altissima incertezza per il proprio futuro poiché proprio in quei giorni il Sindaco di Verona Flavio Tosi, presidente del CdA, prese la decisione di liquidare la Fondazione in forma coatta, cioè chiusura e licenziamento di tutti i dipendenti. Il ministro Dario Franceschini ha deciso invece di commissariare la Fondazione e ha incaricato Carlo Fuortes, attuale sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, di verificare la reale situazione, egli dovrà consegnare al Ministero una relazione sonn 3entro il 30 giugno. Pertanto, tutto congelato per il momento, e sono decadute tutte le cariche di consulenza come quella del Sovrintendente e del Direttore Artistico. Tutto questo per porre l’accento in quale clima si sono svolte sia le prove sia le recite dell’opera; la professionalità dei lavatori della Fondazione è stata pari ad altre volte, a loro va tutta la solidarietà di chi scrive. L’allestimento de La Sonnambula, il quale porta la firma di Hugo de Ana, il quale come di consueto firma regia, scene e costumi, fu creato a Verona nel 2007, e oggi ripreso dal suo assistente Filippo Tonon. La scelta del regista è una drammaturgia onirica e fantastica. Nulla ci riporta alla Svizzera alpestre, piuttosto in una brughiera inglese, ove la linea sonn 4descrittiva potrebbe essere quella del romanzo d’appendice ottocentesco. Spettacolo bellissimo tutto da vedere e ammirare nel quale la vicenda di Amina si sviluppa tra eterei prati verdi e proiezioni immaginarie di eleganti palazzi, il castello del conte sul cui cornicione lei vaga sonnambula nell’ultima scena. Ogni movenza è studiata nel minimo particolare, come una ricercata “danza”, tutto è perfettamente calibrato con superbo gusto. La scena, quasi fissa, d’impatto magnifico ben si concreta nella vicenda con azzeccate luci. I costumi sono bellissimi, colorati e alta sartoria, che rievocano nobili in pic-nic primaverile in sostituzione dei villici di montagna elvetici. Un affresco d’altri tempi che commuove e la visione appaga. Il principale artefice della riuscita musicale è Francesco Ommassini, giovane direttore d’orchestra sempre in ascesa. Ommasini sceglie una lettura narrativa in stile con lo spettacolo, calibrata, leggera, descrittiva. Tali caratteristiche sono affrontate con un suono molto rifinito, orchestra molto puntuale, mai un suono forte, ritmo articolato in scelte belcantistiche e un’omogeneità complessiva davvero ammirevole. Grande prova canora quella del Coro dell’Arena di Verona preparato da Vito Lombardi. La protagonista Gilda Fiume è una cantante con buoni mezzi, voce molto bella, sicura e dalla precisa linea di canto, peccato che le agilità nelle cabalette non siano così brillanti come ci saremo aspettati. Giulio Pelligra è un Elvino credibile, molto intenso nel fraseggio, anche se la parte nel registro acuto talvolta lo mette a disagio, ma nel complesso realizza tutto con precisione. Meno incisivo il Conte Rodolfo di Sergey Artamonov cantante dotato di buoni mezzi ma troppo monotono nel canto, poco fraseggio, colore assente, cui va sommata una dizione artefatta, per tali caratteristiche forse non ha eseguito il capo della cabaletta. Bene le parti di fianco, Madina Karbeli disegna una Lisa molto vispa e vocalmente abbastanza rifinita. Elena Serra ha tracciato una Teresa più che professionale, sotto la mediocrità l’Alessio di Seung Pil Choi che con canto e personaggio belliniano aveva poco da condividere. Bene il notaro di Alex Magri.Teatro quasi esaurito, il pubblico al termine ha espresso un autentico successo a tutti gli artefici dello spettacolo.
IL NASO [Lukas Franceschini] Trento, 22 aprile 2016.
La stagione “Oper.A 20.21” dell’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano si è conclusa con una grande esecuzione dell’opera Nos (Il naso) di Dmitrij Šostakovič al Teatro Sociale. Opera di rarissima esecuzione, almeno in Italia, Il Naso è uno spartito che sorprende per la maestria musicale del compositore, considerando che è la prima opera lirica e che aveva solo ventiquattro anni. Šostakovič è oggi considerato un pilastro della musica non solo russa ma del ‘900, gli albori furono molto promettenti ma la sua vita non fu sempre costellata da successi e acclamazioni, vari problemi con il Partito Comunista Russo influirono alternativamente sulla sua produzione. Il Naso fu rappresentato il 12 gennaio 1930 al Teatro Malij di Leningrado, Šostakovič era già conosciuto, dopo la sua prima sinfonia, come il più singolare musicista della nuova generazione sovietica. Egli decide di comporre un’opera su un testo di un autore contemporaneo ma non trovandolo si serve di un soggetto ottocentesco di Nikolai Gogol’. Nel racconto è evidente la sferzante ironia con cui lo scrittore aveva criticato il regime reazionario zarista, la stessa incentrata sulla polemica antiburocratica si ritrova in tutte le epoche ma soprattutto al primo decennio rivoluzionario del XX secolo. Il racconto rielaborato in tre atti e un epilogo, al quale contribuiscono letterati come Gorni Jonin, Alexander Preiss ed Evgenij Zamjtin oltre allo stesso Šostakovič, è rigorosamente in linea con la concezione satirica. In sintesi: Kavaliov un brutto mattino si sveglia senza naso, il quale è visto naso 2nella cattedrale in vesti di Consigliere di stato. Kovaliov è rovinato, non potendo da bravo funzionario fare carriera e trovarsi una buona moglie se privo di naso, cioè il fiuto. Avvincenti avventure si susseguono fino a quando, senza motivo apparente, il naso torna al suo posto, e il protagonista può dirsi felice, corteggiando ragazze e interloquendo con burocrati al suo pari. Il senso ironico, anche se non si ride pienamente perché tragicommedia, si sviluppa in uno spezzettamento di scene rapidissime, facendo entrare con irrequieta velocità un’interminabile stuolo di personaggi in parte stralunati. Ma sarà la musica contemporanea di Šostakovič che rileva l’ironia e l’azione, gettando le basi del teatro moderno anni ’30. Anche la musica è caratterizzata a un ritmo incalzante, dodici quadri per circa due ore con orchestra da camera, vi sono citazioni della classica tradizione, del jazz e una sequenza di effetti moderni, anche un pianoforte in buca, contraddistinti da ritmo, tempismo drammatico, atonalità, forti dinamiche timbriche, stile di canto estremo (anche la polifonia), cui si aggiungono strumenti inconsueti come la domra, la balalaika e il felxaton. Un autentico gioiello musicale sia per genialità sia per originalità. Lo spettacolo, una coproduzione con Neue Oper Wien e CAFe Budapest Festival Mupa, era firmato da Matthias Oldag, il quale immagina un luogo astratto per identificare l’attualità della vicenda. In tale ottica abbiamo trovato una scena magra con elementi chiari che focalizzano i molteplici quadri nei quali la drammaturgia accuratissima nella recitazione trova una perfetta teatralità d’avanguardia valorizzata dalla bravura degli interpreti e dall’intuito del regista, ottimo coordinatore della scena. Stravaganti ma azzeccati i costumi di Frank Fellmann, il quale firma anche la scena. Straordinario l’apporto di Norbert Chmel, curatore delle luci, il quale svolge un lavoro portante nello spettacolo realizzando atmosfere surreali, talvolta comiche o drammatiche. Non è superlativo affermare che la resa musicale è stata eccezionale sotti tutti i punti di vista, e sarebbe quasi ingiusto fare dei distinguo ma lodare il lavoro d’insieme di coro, orchestra e solisti, ma alcune puntualizzazioni sono doverose. Walter Kobéra guida in maniera esemplare un Orchestra Haydn di Bolzano e Trento in forma splendida per duttilità, precisione e professionalità. Il direttore da par suo regge un ritmo per tutta l’opera di ragguardevole precisione, avendo intuito musicale di naso 3cambiare rapidamente stile nelle variegate pagine della partitura, la quale è stata altamente valorizzata e sviscerata nelle sue dinamiche più nascoste. Il coro Wiener Kammerchor, diretto da Michael Grohotolsky, coglie in quest’esecuzione una delle sue massime realizzazioni professionali, per precisione tecnica e bravura musicale. Da mozzafiato il pezzo a cappella eseguito nella seconda parte. Inoltre, tutti partecipavano all’esecuzione interpretando i tanti piccoli ruoli dell’opera. Cast con interpreti internazionali, ai quali innanzitutto va il plauso per una recitazione straordinaria. Il protagonista Platon Kuz’mic Kovalev era interpretato dal valido Marco Di Sapia, dalla bella voce sonora e bravo fraseggiatore. Igor Bakan era un divertente barbiere e istrionico viaggiatore, Pablo Camellese, commissario di polizia, e Lorn Wey, Ivan, molto autorevoli nelle difficili parti loro affidate. Consensi anche per gli altri interpreti: Alexander Kaimbacher (il naso), Tamara Gallo (Pelagia Podtocina), Ethel Merhaut (figlia di Pelagia), Megan Kaths (Praskov’ja), Georg Klimbacher (funzionario e dottore), Francis Tojar (mendicante e cocchiere). Una grande esecuzione i cui elogi saranno sempre inferiori alla vera difficoltà dell’esecuzione e alla bravura di tutti. Peccato che il Teatro era occupato da un pubblico molto esiguo, questo abbastanza prevedibile, ma il successo tributato è stato caldo e sincero.
SIMON BOCCANEGRA [Lukas Franceschini] Rovigo, 20 aprile 2016.
Interessante chiusura della rassegna Lirica al Teatro Sociale, che celebra la 200ª Stagione, con la rappresentazione dell’opera Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. L’opera fu commissionata dal Teatro La Fenice di Venezia e rappresentata nel 1857 con scarso successo, poche le riprese successive e lo sim 2spartito fu messo in un cassetto. Intorno al 1880 Verdi fu convinto dall’editore Ricordi di rimettere mano al Simone, convinto l’editore che si poteva recuperare un titolo di grande spessore, Verdi si persuase facilmente poiché aveva sempre amato questo lavoro. Il rifacimento del libretto fu affidato ad Arrigo Boito, impegnato al tempo anche nella stesura del successivo Otello. Celeberrima la frase “… convengo che il tavolo è zoppo, ma aggiustando qualche gamba credo potrà reggersi… a me pare che nei personaggi di Fiesco e Simone c’è qualche cosa da trarne buon partito”, che Verdi indirizzò al librettista. In effetti, il taglio della prima edizione era veramente tetro, cupo e troppo drammatico, anche se con pagine di grande valore. La revisione sim 3che sarà poi denominata del 1881, trova una drammaturgia meno lugubre e più funzionale, con l’aggiunta della gran Scena del Consiglio, pezzo forte per il protagonista. In questa nuova veste l’opera trionfò al Teatro alla Scala e da allora riprese lentamente un cammino che oggi potremo definire di “repertorio”, tuttavia sovente la difficoltà è di reperire cantanti adatti alle difficili parti. Resta indiscusso il valore sia teatrale-intimistico sia vocale del protagonista, ma tutte le altre figure, Amelia, Fiesco, Gabriele, hanno modo emergere in maniera rilevante, non da ultimo ricordiamo la figura di Paolo che potremo definire un antenato di Jago. Quando si rappresenta Simon Boccanegra, è prassi eseguire sempre la seconda versione, e così è stato anche a Rovigo, nel nuovo spettacolo coprodotto con Lucca, Livorno e Pisa.L’allestimento è ideato nella regia da Lorenzo Maria Mucci, il quale firma una convenzionale drammaturgia. È vero che l’opera è molto difficile nella “narrazione” ma non ho rilevato un particolare scavo psicologico nei personaggi, solo un racconto didascalico senza grandi pretese e sobrio. Molto azzeccate invece le scene di Emanuele Sinisi, le quali seppur minimaliste sono efficaci nei cambi scena, due grandi impalcature di legno che poste in angolazioni e prospettive peculiari creavano ambienti magri ma molto realistici. Molto belle le proiezioni sim 4del mare, elemento importante nell’opera. In stile i costumi di Massimo Poli, molto rifiniti e ben curati ad eccezione della veste di Boccanegra nella prima scena del I atto la quale non identificava per nulla un doge. Un grande apporto è stato fornito da Michele Della Mea, disegno luci, che ha creato atmosfere e ambienti di ottima resa visiva. La modesta Orchestra Filarmonia Veneta ha evidenziato molte lacune, probabilmente per le poche prove, e la bacchetta di Ivo Lipanovic non era certo in grado di reggere la difficile scrittura verdiana. Non c’erano traccia di ricercate finezze e cromatismi raffinati, ma una semplice conduzione a senso unico incentrata nel raggiungere la meta senza far ammirare i contorni. Le sonorità spesso trasbordavano in suoni eccessivamente frastornanti. Molto bravo il Coro Lirico Toscano CLT, puntuale e ben amalgamato, istruito da Marco Bargana. Il cast presentava nomi molto conosciuti nei teatri italiani ad eccezione del soprano. Stefano Antonucci, Simon Boccanegra, offriva una prova decorosa avendo dalla sua un’innata musicalità e un buon mestiere, quello che mancava era la zampata del grande personaggio con accenti, sfaccettature drammaturgiche e teatrali da memorizzare. Ilona Mataradze era un’interessante Amelia Grimaldi. Dotata di voce molto robusta, importante e bella, ella è stata capace di finezze, ha sim 5fornito un ottimo legato, cui si somma una particolare resa teatrale. Vocalmente potremo dire altrettanto per Ivan Momirov, Adorno, la voce è bella, importante e con squillo, peccato che difetti tecnici gravino sulla prestazione canora la quale è monotona, talvolta nasale o ingolata e non ha il minimo senso del fraseggio. Altero, ieratico anche se molto grezzo il Paolo Albiani di Ivan Marino, tuttavia riesce con esperienza a tracciare un decoroso personaggio, il quale magari con l’aiuto più oculato del regista avrebbe potuto essere più incisivo. Molto bravo Matteo Ferra, Pietro, e corretto il capitano di Vladimir Reutov. Per ultimo, ma per questo non certo ultimo, Roberto Scandiuzzi, il quale interpretava Fiesco. Il grande cantante veneto offriva una prova maiuscola di canto e personalità artistica. Non servono certo delucidazioni per commentare una delle più straordinarie carriere di basso, e sarebbe ridicolo oggi pensare che il nostro cantante sia in perfetto possesso dei suoi mezzi, una carriera ultratrentennale lascia anche i segni. Però l’impronta lasciata da Scandiuzzi è impressionante sia per la grande classe di attore sia per il pregevole timbro vocale di autentico basso. La voce talvolta deve venire a patti in qualche passaggio o puntatura, ma è il fraseggio eloquente, la scansione degli sim 6accenti, la morbida linea di canto che impressionano ancora. Una grande prova di come si canta e interpreta Verdi. Simon Boccanegra non è opera facile ma è conosciuta al pubblico, con mio grande stupore alla recita del venerdì la platea era quasi deserta. Eppure io ricordo che anni addietro il Teatro Sociale era sempre affollato, anche da appassionati delle città limitrofi, e per titoli non di repertorio. Che cosa sia successo lo ignoro, ma è molto triste vedere un teatro cosi glorioso e con tanta storia trascurato dai melomani. Quelli presenti hanno decretato al termine un sincero successo a tutta la compagnia con numerose chiamate.
IOLANTA [Lukas Franceschini] Firenze, 3 maggio 2016.
Brillante inaugurazione operistica al Maggio Musicale Fiorentino con Iolanta, rarità di Piotr Ilic Cajkovskij sua ultima opera. Lavoro lirico in un atto fu commissionato nel 1890 dal direttore dei Teatri Imperiali assieme ad un balletto, i quali sarebbero stati rappresentati in un’unica serata. Il balletto sarà un caposaldo della danza: Lo schiaccianoci. Il soggetto operistico fu individuato dallo stesso Cajkovskij riprendendo un dramma di Henrik Herz “La figlia di Re Renato” del 1845. L’incarico per la stesura del libretto fu affidato al fratello Modest, il quale aveva collaborato in precedenza alla La dama di picche. L’argomento, in parte fantastico, è ambientato nel ‘400 alla corte del duca d’Angiò, personaggio storico e realmente esistito. La vicenda è incentrata sulla sua figlia, bellissima e cieca, che ignora di essere non vedente poiché il genitore l’ha cresciuta in un eden isolato il cui accesso è riservato a pochissime persone amiche, le quali sono complici nel nasconderle l’esistenza della vita. Iolanda vive in quest’ambiente, probabilmente io 2non conscia del mistero, il quale sarà svelato dalla scienza e dall’amore. Un medico arabo, chiamato dal padre, profetizza che grazie alle sue cure ella potrà guarire purché lo voglia con tutta la sua forza. Il dubbioso esito scaturisce l’opposizione del padre. Sarà il giovane Cavaliere Vaudemont a svelarle il suo handicap e attraverso il suo amore Iolanda accetta le cure che la renderanno vedente e potranno vivere felici come nei più scontanti finali favolistici. La trama anche se vagamente strampalata è notevolmente poetica e onirica. Alla prima il successo fu molto vivo, anche se la critica storse il naso. La vicenda della sfortunata fanciulla che usa gli occhi solo per piangere è narrata da una musica tra le più raffinate che Cajkovskij compose, l’utilizzo di strumenti solisti “illustrano” un’atmosfera di giardini fioriti provenzali molto affascinante. E’ giusto rilevare che in questo spartito non s’identifica molto l’anima russa del compositore, piuttosto un appassionato influsso melodico non immediato ma doviziosamente cesellato, attingendo forse anche da nuovi musicisti, Debussy in particolare. Lo spettacolo è una coproduzione tra il Metropolitan di New York e il Teatro Wielki Opera Nazionale Polacca e porta la felice firma di Marius Trelinski. Il regista colloca la vicenda in una foresta immaginaria e atemporale, anche se con dettagli moderni che non disturbano. Il grande lavoro sulla drammaturgia è incentrato sulla protagonista che vive in una sorta di casetta isolata perennemente accudita da governanti cui si aggiunge l’amore tormentato paterno. L’incontro con il giovane rivelatore della menomazione è narrato con somma delicatezza, gli slanci e l’euforia dell’amore appena sbocciato sono sempre contenuti e realizzati con grande maestria teatrale. Indicativo che la piccola magione sia rotante, il vortice degli eventi che modificheranno la vita di tutti i protagonisti. Lascia leggermente perplessi il concertato finale, che dal punto di visa visivo si stacca completamente dalla delicatezza in precedenza profusa, schierando tutti i protagonisti al proscenio inneggiando l’happy-end, ma è solo un dettaglio. Boris Kudlicka, scenografo, realizza una foresta di grande impatto con alberi appesi, utilizzando anche videoproiezioni molto efficaci di Bartek Macias. I costumi eleganti di stampo attuale che rendono la concezione della fiaba perenne sono di Marek Adamski. L’orchestra del Maggio era in gran forma e il giovane direttore, Stanislav Kochanovsky, ha saputo cogliere appieno il lirismo della partitura realizzando una lettura di grande respiro orchestrale, ricca di colori, meravigliosamente precisa e sfaccettata nel dettaglio. Di assoluta professionalità la breve partecipazione del Coro del Maggio diretto da Lorenzo Fratini. Victoria Yastrebova, Iolanta, era una credibile protagonista, molto musicale e raffinata in un canto lirico ricercato anche se il volume io 4era leggermente debole. Bravissimo Ilya Bannik, Re René, baritono con voce di primordine e particolarmente ricercato negli accenti. Note meno felici per Vsevolod Grivnov, Vaudémont, tenore stentoreo e poco raffinato, con qualche sfibratura nel registro acuto. Mikolaj Zalasinski, Robert, si ritaglia un successo personale nel racconto inziale, sfoggiando mezzi ed espressione musicale ammalianti. Elchin Azizo, il medico islamico, è un preciso cantante e ottimo attore. Completavano la locandina con assoluta professionalità e carisma: Mateusz Zajdel (Alméric), Federico Sacchi (Bertrand), Mzia Nioradze (Marthe), Maria Stasiak (Brigitte), Irina Zhytynska (Laure). Teatro con parecchi vuoti, ma pubblico molto caloroso di applausi al termine per uno spettacolo che ha veramente meritato il successo raccolto.
IOLANTA [Renata Fantoni e William Fratti] Firenze, 3 maggio 2016.
Il Maggio Musicale Fiorentino, nonostante le serie problematiche che sta affrontando da diversi anni, nel periodo dedicato al Festival è sempre concentrato su livelli culturali ed esecutivi di alta qualità, dimostrando quanto sia preziosa la sua presenza e continuità nel sempre più deprimente e disorganizzato panorama artistico italiano. Iolanta, ultima opera del genio di Čajkovskij, vanta pochissime rappresentazioni nel nostro Paese – come il resto del catalogo del compositore pietroburghese purtroppo, fatta eccezione per i balletti e certi titoli di sinfonica – ma il successo decretato dal pubblico intervenuto a Firenze dimostra quanto sia piacevole, d’effetto e di gusto attuale. Iolanta yastrebovaLa buon riuscita dello spettacolo è soprattutto dovuta alla bravura di tutti gli interpreti, a partire dal suggestivo allestimento firmato da Mariusz Treliński alla regia, Boris Kudlička alle scene, Marek Adamski ai costumi, Marc Heinz alle luci, Tomasz Wygoda alla coreografia, Bartek Macias al video, con la drammaturgia di Piotr Gruszczyński, che porta l’ascoltatore in un mondo onirico, fiabesco, ma con un forte senso angoscioso e penoso, noir e un poco gotico, in perfetta coesione con la musica di Čajkovskij, che solo nel finale rallenta l’intensità del dramma per lasciare spazio a emozioni più leggere e gioiose.Buona la direzione di Stanislav Kochanovsky, che ottiene dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino un suono preciso e pulito, dotato delle giuste sfumature tematiche che disegnano le varie ambientazioni, pur difettando dell’effetto maestoso in certi passaggi. Victoria Yastrebova è una brava Iolanta, con voce ben impostata e timbrata, salda nei numerosi piani, efficace nel fraseggio che esprime il turbamento. Positiva anche la prova di Ilya Bannik nei panni di René, pur non possedendo l’adeguato spessore morale e vocale richiesto dal personaggio, che nella bellissima aria, oltre a dover esprimere maggior turbamento, dovrebbe mostrare più sicurezza in acuto e sul grave. Vsevolod Grivnov è un buon Vaudémont dotato di acuti limpidi e smaltati, nonché di un determinato gusto nell’uso dei colori, ma un po’ limitato da una certa discontinuità che non lo rende particolarmente omogeneo. Eccellenti e brillantissimi anche gli acuti di Mikolaj Zalasiński nei panni di Robert, che gli procurano un buon successo personale, ma nella zona centrale non è propriamente preciso e uniforme. Un encomio speciale è da riservarsi all’Ibn-Hakia di Elchin Azizov, autorevolissimo nel personaggio e nell’espressione vocale, entrambe davvero centrate, saldo e sicuro nel canto e nell’interpretazione. Particolarmente efficace anche la prova di Mateusz Zajdel e Federico Sacchi nei panni di Alméric e Bertrand, nonché di Mzia Nioradze, Maria Stasiak e Irina Zhytynska in quelli di Marthe, Brigitte e Laure. Unico neo della bella serata è la visione dell’apoteosi finale voluta dal regista Mariusz Treliński, che abbandona le finezze e le suggestioni precedenti per una scena che starebbe bene soltanto in Tutti insieme appassionatamente.
TOSCA [William Fratti] Genova, 8 maggio 2016.
Il Teatro Carlo Felice di Genova ripropone Tosca nello spettacolo firmato da Davide Livermore nel 2014 ed ogni recita ottiene grandi consensi di pubblico per tutti gli artisti coinvolti. L’allestimento, con i costumi di Gianluca Falaschi, è piacevole da vedere e seguire, intelligente e funzionale nell’impianto e nello sviluppo della vicenda, semplice ma accattivante, dunque pienamente godibile da parte del pubblico, ma sostanzialmente dannoso, quasi controproducente e quasi impossibile per i solisti, che si vedono costretti a muoversi continuamente su un declivio sovraumano, mettendoli chiaramente in grosse difficoltà, soprattutto Tosca e Scarpia in secondo atto. Detto ciò Livermore deve essere premiato per ciò che scrive nel programma di sala: “[…] i cantanti, artisti unici per le molteplici virtù che esprimono. Essere cantante d’opera è azione di coraggio rivoluzionario: un cantante fa cose in pura controtendenza con la nostra società: studia (rarissimo oggi) e vota la sua vita ad un’arte che la mediocrità di un paese tosca nizza_melialla deriva non sa né raccontare tanto meno valorizzare (all’estero sono considerati eccellenza); e per cantare Tosca si deve essere capaci di ricercare la verità di personaggi come Floria Tosca, Mario Cavaradossi e il barone Vitellio Scarpia nelle pieghe della propria anima. E poi c’è il Teatro Carlo Felice, il più grande edificio teatrale italiano, il terzo d’Europa, lo sapevate? “…ehh ma son palanche…” (costa molto). Quando a Parigi hanno costruito la Tour Eiffel si è ben presto scoperto che avrebbero dovuto spendere le suddette palanche in antiruggine; avevano due possibilità: smontarla oppure farla diventare simbolo della città, con i ricavi economici conseguenti. Che Genova crei le condizioni per cui questo teatro è nato: diventarne il simbolo e smentire definitivamente le menzogne del ventennio ultimo sfascista sull’inutilità della cultura e dell’arte […]”. La bravissima e cristallina Orchestra del Teatro Carlo Felice è guidata da Dmitri Jurowski che porta in scena una lettura puntuale e precisa, molto apprezzata per l’attinenza allo spartito e un poco ripulita dagli eccessi della tradizione. Eccellente anche il Coro preparato da Pablo Assante. Amarilli Nizza (una di quelle cantanti che studia e che sa cercare il personaggio dentro le pieghe della propria anima) “è” Tosca e ciò dovrebbe bastare a criticare o giudicare la sua performance. Come già ribadito in più occasioni, il soprano si spoglia sempre della sua umana esistenza diventando – e non interpretando – il ruolo. Se il primo duetto con Cavaradossi trasmette leggerezza, già il primo colloquio con Scarpia si tramuta in emozione pura. In secondo atto è letteralmente straziata dalle torture inflitte a Mario, poi lo è a causa del senso di colpa per il tradimento, infine la sua fede vacilla e la sua preghiera, più che un’implorazione, ha il sapore della domanda accusatoria. La affianca l’altrettanto eccellente Francesco Meli nei panni del pittore, che pur restando un gran bravo tenore – uno dei migliori – sta forse facendo il passo più lungo della gamba. “Recondita armonia” mostra acuti brillanti e luminosi sorretti da una linea di canto morbida, ma già dal duetto inizia ad eccedere con i falsetti, presumibilmente segno che frequentando un repertorio dalla tessitura troppo centrale, lo penalizza in alto, dove tempo fa aveva invece grande agio. Molto toccante la celebre “E lucevan le stelle”, ma anche in questa pagina esibisce le sue doti nei pianissimi (in falsetto) e non nella voce piena. Molto corretto il canto di Angelo Veccia, ma il suo Scarpia denota carenza di spessore e autorevolezza, risultando poco convincente, seppur adeguato. Ottimo l’Angelotti di Giovanni Battista Parodi, poiché la piccola parte ha comunque bisogno di una voce molto importante. Lo stesso vale per il bravo Sagrestano di Matteo Peirone. Efficaci gli altri ruoli di Spoletta, Sciarrone e il carceriere interpretati da Enrico Salsi, Raffaele Pisani, Roberto Conti.
LA FAVORITE [Lukas Franceschini] Venezia, 10 maggio 2015.
Spiace molto dover costatare l’infelice esito, sotto tutti gli aspetti, de La Favorite di Gaetano Donizetti al Teatro La Fenice. La Favorite, che fu rappresentata in prima all’Opéra di Parigi il 2 dicembre 1840, è un grand-opéra di grande fattura ma che attinge fav 2musica da lavori precedenti, in prevalenza non eseguiti, del maestro bergamasco. Partitura e soggetto si basano sostanzialmente su Ange de Nisida (1839) opera mai rappresentata al Théâtre de la Renaissance per fallimento della gestione del teatro. Obbligo precisare che alcune parti dell’Ange derivano a sua volta dall’opera Adelaide che Donizetti aveva iniziato a comporre e in seguito messo da parte intorno al 1834. L’autografo della partitura de La Favorite è pertanto un complesso intreccio di musica e soggetti diversi (alcuni con versi in italiano, poi sovrapposti da quelli in francese), la cui maestria del musicista italiano, il migliore è più poliedrico al tempo, fosse abilissima nell’assemblare parti differenti in un’unica drammaturgia nuova e un tema musicale sempre di grande spessore. Non mi dilungo facendo un elenco delle nuove musiche, pongo l’accento invece che la composizione della Favorite era destinata all’Opéra, il più prestigioso teatro della capitale francese, e poneva peculiari esigenze che dovevano soddisfare le pretese del pubblico parigino: un’opera in stile grand-opéra, con balletto e divertissement, suddiviso almeno in quattro parti, e fonte d’ispirazione storica. Altro aspetto rilevante dal punto di vista musicale fu che la scrittura fu confezionata sulle caratteristiche di Rosine Stolz, stella dell’Opéra nonché amante del direttore del fav 3teatro, la quale possedeva un’autentica voce di mezzosoprano di ampio registro, basato sulla concezione romantica che avrebbe avuto grande spazio nel nostro paese. La vicenda dell’opera è focalizzata sul fatto che Fernand (primo tenore) è innamorato dell’amante di Alphonse Re di Spagna (primo baritono). Fernand rappresenta l’ideale dell’amore cortese attraverso il suo idealismo puro, il coraggio fiero e il più alto senso dell’onore. La parte fu composta per Gilbert Duprez, altra stella parigina, il quale aveva modo di mettere in luce una declamazione eroica ma dolcissima rilevando una forte espressione del recitativo cui ovviamente va ad aggiungersi una spiccata propensione al registro acuto, anche sopra il rigo, ma sempre da cantare “doux”. Alphonse, il Re, è uno dei personaggi donizettiani più affascinanti essendo un re a tutto tondo ma mettendo in luce anche altri aspetti della sua personalità come la sensualità, la perfidia e il romanticismo. Tali caratteristiche appaiono evidenti in un canto sempre morbido e nobile, ricco di fraseggio e colore, il quale prevale su un’intensità drammatica. Altro importante personaggio è Balthasar, basso, che nella sua grande melodia del quarto atto potremo affermare, musicalmente, essere figlio di un Sarastro e padre di molteplici austeri simili personaggi verdi anni. Nel complesso un’opera come La Favorite potrebbe essere non particolarmente fastosa per le usanze de l’Opéra per uno sviluppo drammaturgico-musicale più intimo ripensato anche ad altre partiture dello stesso Donizetti, tuttavia, l’opera è da considerarsi fra le migliori dell’autore e giustamente come afferma William Ashbrook “…non si tratta di melodramma romantico italiano, bensì di un elegante grand-opéra francese e richiede il fuoco e l’incisività della versione originale affinché la sua passione controllata possa affiorare ed inoltre occorre rappresentarla chiaramente nello stile grand-opéra”.Quest’aspetto ma soprattutto le caratteristiche vocali dei protagonisti sono mancate nella produzione veneziana. Favorite necessita di quattro fuoriclasse, al pari de Il Trovatore se si vuole fare un parallelo, e non mettendo in dubbio che oggigiorno sia difficile da recuperare la scelta veneziana è andata al ribasso. Veronica Simeoni, Léonor, ancora una volta non mi distacca dalla convinzione che vocalmente trattasi di soprano corto con modeste tecniche vocali. Lo dimostrano un continuino abuso del grave, però afono, è una limitata perizia in acuto. Non si possono negare una partecipazione scenica e un rilevante accento, ma questi sono troppo esigui perché definiscano la performance accettabile. John Osborn, Fernand, era la carta più interessante della locandina ma nel complesso non supera la prova. Un tempo sua peculiarità era il registro acuto che a Venezia non abbiamo sentito, perché la sua interpretazione vocale era improntata tutta su mezzevoci, anche raffinate, ma che alla fine risultano monotone se non abbinate a un canto accentato, frutto di ragionati colori e pertinente. Lo smalto vocale non è mai stato particolarmente suggestivo e il limitato uso oggi di volate sovracute rende questo cantante molto ridimensionato. Vito Priante, Alphonse XI, era il cantante più contenuto e maggiormente in regola con la parte, tuttavia nella sua interpretazione mancava la tinta del grand seingeur baritonale, contraddistinto da accento, fraseggio, varietà di colori e ampiezza vocale tipica di un re di Spagna. Il Balthazar di Simon Lim presentava come il solito un timbro di basso molto interessante ma sovente ingolato e con appariscenti limiti tecnici emersi in particolar modo nell’aria del IV atto. Molto buona la prova di Ivan Ayon Rivas, Don Gaspar, tenore squillante e molto musicale, peculiarità meno felici per Pauline Rouillard, soprano troppo leggero e stridulo per la parte di Inés. Completava il cast con professionalità il Signore di Giovanni Deriu. Delude la direzione di Donato Renzetti per eccessi di volumi che sovente coprivano sia i solisti sia il coro. Inoltre, mancava una linea narrativa fondamentale per tale spartito, la sua concertazione era disomogenea con tempi altalenanti o vorticosi che sovente spaesavano; anche il balletto non aveva l’aurea del grand-opéra che ridotto scenicamente non lasciava traccia. Ottima la prova del coro diretto da Claudio Marino Moretti. Sullo spettacolo ci sarebbe poco o nulla da dire tanto era brutto e del tutto fuori linea con la drammaturgia. Rosetta Cucchi ha scritto nelle note pubblicate nel programma di sala “… ho voluto creare un mondo futuribile dove le convenzioni e le consuetudini che legano i rapporti tra uomini e donne si sono estinte nel momento in cui si sono estinti sia il patto sociale che la natura, cioè la forza che da linfa all’essere umano. Un mondo dove si conservano resti una natura morente e dove gli uomini sono stati scientemente divisi dalle fav 6donne, le quali hanno perso i loro diritti e vengono allevate per procreare una futura stirpe di guerrieri”. Questa la linea dello spettacolo. Personalmente non ho capito tale concetto né tantomeno cosa sia parallelo a La Favorite che narra di tutt’altre vicende. Pertanto abbiamo avuto una scena, per nulla suggestiva di Massimo Checchetto, quasi plastica, tetra e misera nella quale si muovevano con solennità i protagonisti, non c’erano traccia di una recitazione, di sentimenti e passioni, neppure di regalità o concetti religiosi. Una sorta di fantascienza che è da annoverare tra le più insignificanti produzioni della stagione. Costumi scialbi e poco funzionali di Claudia Pernigotti, luci sempre soffuse di Fabio Berettin, proiezioni non entusiasmanti di Sergio Metalli e ridicole le coreografie di Luisa Baldinetti che realizza un balletto da gran-opéra con due ballerine all’interno di un tubo di plastica. Spettacolo da dimenticare. Durante l’esecuzione il pubblico era piuttosto sconcertato, con rarissimi applausi agli assoli dei cantanti, ma al termine successo di misura per tutti.
LA FANCIULLA DEL WEST [Lukas Franceschini] Milano, 13 maggio 2016.
Il progetto Puccini iniziato da Riccardo Chailly lo scorso anno prosegue con il nuovo allestimento de La fanciulla del West e la regia di Robert Carsen. L’opera alla prima rappresentazione assoluta, New York Teatro Metropolitan 10 dicembre 1910, segnò il massimo successo di pubblico e critica per il compositore. Merito anche di un cast eccezionale: Emmy Destinn, Enrico Caruso, Pasquale Amato, e sicuramente la bacchetta di Arturo Toscanini. Lo spartito non ebbe mai prassi esecutiva facile perché i tre protagonisti sono impegnati vocalmente e scenicamente innegabilmente in parti molto gravose. Con Fanciulla il teatro musicale e umano di Puccini si trasforma rielaborando la propria visione teatrale. Il sentimento non è più fine a sé stesso ma è risonanza o compendio del dramma ambientalistico estraneo che lo circonda. Quel mondo violento del West, fosche passioni, esistenza di solitudine assetata di ricchezza, una sommaria brutalità di vita, è stato raffigurato in musica da Puccini con scorci potenti e scene impetuose. I tre protagonisti sono fondamentali nel racconto: Minnie una donna sincera e innamorata, Dick Johnson un idealista redento dal banditismo a sua volta ispirato da un sentimento sincero, e Jack Rance uno sceriffo avventuroso in amore ma che disegna anche aspetti carnali e truci con attimi violenti di vendetta. Le figure di contorno, sono molto riuscite pur nei brevi interventi e non mancano di esercitare il loro peso musicale nel primo atto con aspetti fan 3nostalgici o nell’ultimo quadro in un coro uniforme d’addio a Minnie e Dick. Scrivendo un’opera ambientata negli Stati Uniti, Puccini non si esime dal citare melodie dl folklore locale e a fianco di musiche proprie vi sono citazioni da “The old dog Tray”, “Dear old house” e “Dooda Day”. Il vero trionfatore di questa Fanciulla è Riccardo Chailly, direttore principale della Scala, che ha concertato l’edizione del manoscritto originale in sostituzione di quella solitamente eseguita che si rifà alle varianti e ai tagli effettuati da Toscanini in occasione della prima assoluta. Come spiega il maestro Chailly nell’intervista pubblicata nel programma di sala “…le modifiche di Toscanini furono necessarie per le condizioni d’acustica del Met di allora… in differente situazione sonora mi sembra oggi interessante proporre l’intenzione originale dell’autore”. Questa “prima” versione contiene l’inserimento di tre brani, circa centoventiquattro battute in più, tra cui un breve duetto Minnie-Billy, eliminata una cadenza del tenore (peculiarità voluta da Caruso), ed è possibile ipotizzare che le passioni sanguigne del compositore sono più morbide e sfumate. Pur seguendo questa linea Chailly, ha diretto, o meglio cesellato, l’opera con maniaca cura del dettaglio, nota per nota, creando un racconto di grande pathos teatrale e di largo respiro orchestrale, anzi portando proprio la splendida orchestra scaligera a vette altissime per coesione di suono e mirabile affezione. Una grandissima prova di direzione che ha rilevato tinte e trasparenze musicali a noi sconosciute, peraltro sempre in perfetta sintonia con la narrazione drammaturgica e in precisa simbiosi con i cantanti. Purtroppo la produzione ha dovuto trovare un accomodamento per l’improvvisa malattia della protagonista scritturata, e trovare un diverso equilibrio con Barbara Haveman, la Minnie recuperata all’ultimo, la quale pur dimostrando temperamento e buona arte scenica evidenziava molti limiti vocali in una così difficile partitura. Il registro acuto è molto limitato e le poche uscite erano stridule, la gamma delle sfumature e dei colori molto monotone ma nel complesso accettabile anche se data l’operazione di Chailly era lecito aspettarsi di più. Molto bravo Roberto Aronica, Dick Johnson, tenore oggi in piena ripresa che a differenza di una recente prova bolognese qui alla Scala trova un terreno fertile per mostrare grande musicalità, senso del fraseggio e una pertinenza vocale rilevante, aspetto che forse qualche anno fa non era ipotizzabile, ne siamo ben felici e speriamo che tale strada sarà seguita con altri successi. Carlo Sgura, Jack Rance, è baritono con voce solida e abbastanza potente, peccato che in tale ruolo non riesca a essere incisivo con un canto variegato, soprattutto modulato nei colori e ricercato nella complessa psicologia del personaggio. La lunga schiera dei ruoli di fianco, decisamente non marginali, era ben amalgamata. Impagabile sia musicalmente sia scenicamente il Nick di Carlo Bosi, tornito e preciso il Sonora di Alessandro Luongo, puntuale l’Happy di Francesco Verna e molto bravo Romano Dal Zovo nell’assolo di Larkens. È doveroso citarli tutti precisando l’ottima prova fornita: Gabriele Sagona (Ashby), Marco Ciaponi (Trin), Gianluca Breda (Sid), Costantino Finucci (Bello), Emanuele Giannino (Harry), Krystian Adam (Joe), Alessandro Spina (Billy), Alessandra Visentin (Wowkle), Davide Fersini (Jack), Leonardo fan 6Galeazzi (Castro) e Francesco Castoro (un postiglione). Robert Carsen firma uno spettacolo bellissimo, è coautore anche di scene e luci. Egli ha impostato una drammaturgia “classica” molto raffinata, focalizzando i punti più passionali con delicatezza encomiabile. Nulla è dato al caso, ogni gesto, ogni sguardo sono accuratamente studiati e ben tracciati nel racconto epico. In tale ottica si è avvalso di alcune “icone” (almeno per noi europei) del far-west, attingendo dal cinema con proiezioni brevi di film d’epoca che raccontano (a loro modo) l’epopea americana dell’Ottocento. Abbiamo rivisto squarci di “My Darling Clementine” di John Ford (con un giovanissimo Henry Fonda), e altri di cui non saprei il titolo, tuttavia queste visioni (molto limitate) non disturbavano, anzi accentavano il mondo del west in maniera molto efficace. Bellissima la scena del saloon, che si rifaceva a un celebre hotel costruito da Buffalo Bill ed elettrizzante la grande vallata proiettata sul fondo nel primo atto. Giustamente claustrofobica e sghemba la casa di Minnie nel II atto, e grande coup de théâtre nel finale: Minnie ormai star, fan 7perché il film omonimo fu un grandissimo successo, saluta i minatori davanti al Lyric Theatre di New York e tutti i minatori per poterla vedere un’ultima volta comprano il biglietto per entrare alla videoproiezione. Un racconto molto funzionale e stilisticamente ben ideato come Carsen è capace, una visione che appassiona e commuove allo stesso tempo. Le scenografie erano ideate in coppia con il bravo Luis Carvalho, bellissimi i costumi di Petra Reinhardt, straordinarie le luci dello stesso Carsen e Peter van Praet. Successo pieno.
LA FANCIULLA DEL WEST [William Fratti] Milano, 10 maggio 2016.
Che La fanciulla del West sia il capolavoro musicale di Giacomo Puccini pare ormai un fatto indiscusso; e che le numerose difficoltà nell’eseguire l’ardua partitura siano un grande ostacolo, nonché un deterrente al rappresentare più di frequente questo titolo è altro fatto assodato. Fortunatamente il direttore musicale del Teatro alla Scala, con la sua orchestra, il coro e gli artisti maschili in locandina sono all’altezza delle aspettative, poiché l’opera manca dal palcoscenico milanese da oltre un ventennio e tutti gli appassionati del melodramma sono trepidanti già dallo scorso anno nel seguire l’annunciato progetto dell’intera opera pucciniana. La serata del 10 maggio è in realtà una prima, poiché a causa dell’indisposizione della titolare del ruolo protagonista, nelle prime recite la sostituta non è stata in grado di eseguire lo spartito originale voluto da Riccardo Chailly con i “1000 cambiamenti fra minimi e importanti”. Ciò denota una grave mancanza da parte della dirigenza, poiché La fanciulla non è La Bohème, pertanto dovrebbero essere previste coperture adeguate, non rimpiazzi last minute. Detto ciò è doveroso riscontrare l’altissimo livello della performance, a partire dal “capitano” che ha guidato la nave con tale precisione che ogni singola nota era al suo posto, tanto gli strumenti, quanto le migliaia di migliaia di interventi vocali. Riccardo Chailly si riconferma un’eccellenza musicale italiana a tutto tondo, dall’accurata scrupolosità alla capacità di trasmettere emotivi turbamenti, come pure l’Orchestra del Teatro alla Scala che risulta matematicamente perfetta, limpidissima, pulitissima, brillante oltre ogni misura. Già la breve introduzione all’opera è di un’emozione strabiliante. Altrettanto eccellente è il sublime Coro preparato dall’intramontabile Bruno Casoni. In linea col livello qualitativo annunciato sono i protagonisti maschili, a partire dal Dick Johnson di Roberto Aronica che in questa occasione supera se stesso, con una morbidezza che mai aveva mostrato, omogeneità e leggerezza nella linea vocale, canto ben posizionato sul fiato, acuti brillanti e in avanti. Ottimo l’antagonista Jack Rance di Claudio Sgura, abile fraseggiatore, tanto dolcemente innamorato di Minnie, quanto febbrilmente geloso di Johnson. Ruvido e squillante al tempo stesso, la sua voce dà vita a un personaggio di prim’ordine. Eccellente Carlo Bosi nei panni di Nick; in questo ruolo complesso il signore dei tenori comprimari trova terreno particolarmente fertile e mostra una musicalità fuori dall’ordinario; impossibile trovare di meglio. Altrettanto vale per Alessandro Luongo nelle vesta di Sonora, puntuale e ben rifinito. Sinceramente pregevole anche la prova di tutte le altre parti, a partire dal Larkens di Romano Dal Zovo e dal Wallace di Davide Fersini; Marco Ciaponi (Trin), Gianluca Breda (Sid), Costantino Finucci (Bello), Emanuele Giannino (Harry), Krystian Adam (Joe), Francesco Verna (Happy), Alessandro Spina (Jackrabbit), Leonardo Galeazzi (Castro), Francesco Castoro (un postiglione). Un po’ cupa la Wowkle di Alessandra Visentin. È invece poco adeguata la protagonista; Barbara Haveman sostituisce l’indisposta titolare del ruolo di Minnie, ma non è all’altezza delle aspettative. L’interpretazione scenica è buona e di questo bisogna renderle atto, ma la linea di canto si presenta poco omogenea, con note basse molto infossate, centri poco proiettati e udibili a fatica nei recitativi – situazione che migliora nei cantabili – acuti non sempre piacevoli. Efficacissimo, esattamente a metà strada tra classicismo e innovazione, lo spettacolo firmato dalla bravura esemplare di Robert Carsen, che riempie letteralmente l’intera partitura di sguardi, gestualità e movimenti in perfetto sincrono con ogni singola nota, contribuendo ad enfatizzare la già ottima direzione di Riccardo Chailly, pertanto ciò che più si percepisce è il perfetto amalgama creato dall’intera squadra teatrale. Carsen firma anche le bellissime scene con Luis Carvalho e le incantevoli luci con Peter Van Praet. Ottimi i pregevoli costumi di Petra Reinhardt. Completano il gruppo di lavoro: Marco Berriel alla coreografia e Ian William Galloway al video.
LUCIA DI LAMMERMOOR [Margherita Panarelli] Torino, 18 maggio 2016.
La regia emozionante di Damiano Michieletto e un cast di bellissime voci per Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti al Teatro Regio di Torino nella Stagione 2015/2016. La torre in rovina della famiglia Ashton domina un palcoscenico buio e altrimenti vuoto se non per alcuni tavoli e sedie e proprio dalla torre si getterà Lucia quando decide di porre fine alla propria vita con gli ospiti al matrimonio che assistono alla scena agghiacciati. Una regia, questa di Damiano Michieletto, per la prima volta proposta in Italia, la cui forza risiede nell’evocazione, con i fantasmi e la simbologia delle rose che insegue i protagonisti dall’inizio alla fine, e nella recitazione degli interpreti. Nei panni della sfortunata Lucia, Jessica Pratt è molto dolce, anche se la sua eroina è ferma nei suoi propositi; la linea di canto scelta è lirica, fedele alle origini belcantiste del personaggio, il fraseggio morbido e naturale anche nel registro acuto, è evidente il pieno controllo sul proprio strumento da parte del soprano. Eccellenti “Regnava nel silenzio” e la funambolica scena della pazzia, cantata con gusto e cristallina precisione dall’alto della torre, splendidamente coadiuvata dal soave accompagnamento di Sascha Reckert alla glass harmonica. Soave almeno quanto i filati eterei di Jessica Pratt. Nel ruolo di Edgardo, Piero Pretti brilla per la morbidezza dell’emissione, per il bel timbro e per la partecipazione emotiva. Il suo ritratto di Edgardo è vivido è verace, appassionato e appassionante in ogni suo momento: dal duetto del primo atto, alla maledizione su Lucia del secondo, per chiudersi con un “Tombe degli avi miei” cantato con squisita malinconia e un “Tu che a Dio spiegasti l’ali” di struggente dolcezza. Possente l’Enrico di Gabriele Viviani; “Cruda funesta smania” è energico e intenso e il duetto “Il pallor funesto, orrendo” ottimamente interpretato. La sicurezza di Viviani nel registro acuto ha reso appieno la prepotenza e l’arroganza del suo personaggio. Possiede uno strumento podereso Aleksandr Vinogradov, e ne fa ottimo utilizzo nella sua interpretazione di Raimondo; Francesco Marsiglia è un Arturo affascinante e giustamente più sospettoso nei riguardi del matrimonio rispetto a quanto solitamente rappresentato. Ottimo supporto ai protagonisti è fornito da Daniela Valdenassi, fedele e preoccupata Alisa, e da Luca Casalin nei panni di Normanno. Gianandrea Noseda dirige la sempre ottima orchestra del Regio e la sua è una lettura vigorosa e vivida della partitura Donizettiana. Scelte dinamiche e metronomiche non usuali, come nel duetto tra Enrico e Lucia del secondo atto, consentono di assistere al dipanarsi delle vicende sotto una luce, se non diversa, insolita. Il pubblico presente, positivamente folto nonostante la recita si sia tenuta a metà settimana, ha applaudito con convinzione l’intero cast dopo una rappresentazione appassionante e di altissimo livello.
CAVALLERIA RUSTICANA [Simone Ricci] Roma, 19 maggio 2016.
Serata verista alla Garbatella: il Palladium, teatro dell’Università Roma Tre ha puntato su giovani e promettenti elementi per l’atto unico di Mascagni. Basta semplicemente pronunciare le due parole del titolo e non può non venire in mente l’opera “melodrammatica” per eccellenza. “Cavalleria Rusticana” non può che beneficiare dell’aria di Roma, la città dell’esordio trionfale del 1890, quando Pietro Mascagni trionfò con il suo atto unico al Concorso Sonzogno: il merito di una rappresentazione che ha celebrato idealmente i 126 anni esatti da quella prèmiere non è stato però, come allora, del Costanzi, bensì del Palladium, teatro che sorge nel quartiere della Garbatella e di cui è proprietaria l’Università degli Studi Roma Tre. Non è la prima volta che questa sede ospita un’opera, organizzare “Cavalleria Rusticana” non è certo semplice, ma l’entusiasmo giovanile e la volontà di mettere in mostra i migliori elementi possono fare la differenza. Il lavoro di selezione di Isabella Ambrosini è stato lungo e intenso e per mettere in scena il lavoro di Mascagni ci si è affidati alle scelte registiche di Enrico Stinchelli, nel segno di un profondo rispetto per quanto indicato dal libretto di Targioni-Tozzetti e Menasci, senza tralasciare qualche spunto moderno, come ad esempio la comparsa delle guardie del corpo di Alfio, costantemente alle sue spalle. La stessa Ambrosini era alla guida dell’Orchestra Roma Sinfonica e del Coro Roma Tre, due formazioni composte da giovani musicisti dei conservatori italiani: non si può parlare di una scommessa, ma della necessità di puntare su chi ha un futuro promettente. Il cast vocale previsto inizialmente è stato stravolto quasi per intero. Prima dell’inizio della rappresentazione sono stati annunciati i cambi dei cantanti e qualche titubanza dei sostituti poteva essere preventivamente compresa. Silvia Pasini non ha fatto pesare l’assenza di Tea Purtseladze: la sua Santuzza poteva forse avere qualche pecca dal punto di vista scenico (una eccessiva staticità in alcuni momenti dell’opera), ma il pubblico romano le ha tributato l’applauso più caloroso della serata, un premio meritato per la Santuzza che ha messo in mostra, toccante, espressiva nel fraseggio e nell’accento. Anche Manrico Carta ha sostituito il tenore originario, Fabio Serani: il suo Turiddu è stato volenteroso, con le potenzialità vocali giuste per un ruolo verista. Qualche piccola incertezza nella “Siciliana” iniziale, soprattutto per quel che riguarda il fraseggio, non ha comunque macchiato la prestazione complessiva, senza dubbio di tutto rispetto. Alessio Quaresima Escobar ha tratteggiato un Alfio sfrontato, aitante e sicuro di sè grazie a una buona padronanza della scena: personalmente ho gradito di più il duetto che precede l’Intermezzo rispetto alla prima aria del personaggio, “Il cavallo scalpita”, in cui il coro ha coperto qualche passaggio di troppo. Il timbro baritonale è in via di perfezione e si intravedono importanti qualità tecniche. Spesso il personaggio di Lola viene sottovalutato, nonostante la sua importanza nel contesto narrativo. Serena Muscariello ha messo in mostra l’eleganza e la sensualità giuste per questo ruolo, sfoggiando sicurezze nel registro acuto e nel fiato con un impeccabile “Fior di giaggiolo”. Molto efficiente, poi, la Mamma Lucia di Francesca Romana Cassanelli. L’orchestra diretta da Isabella Ambrosini eccedeva in qualche occasione con i tempi dilatati, in particolare quando si trattava di accompagnare il coro – vivace e intelligente negli attacchi. L’errore è apparso evidente anche nell’aria finale di Turiddu, quando il tenore e la musica non sono riusciti a combaciare come ci si potrebbe e dovrebbe aspettare. Il celebre Intermezzo è stato invece reso in modo efficace e con i tempi giusti per arrivare al cuore di chi ascoltava. Non capita spesso di ammirare “Cavalleria Rusticana” in solitaria: normalmente è accompagnata da “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo e non mancano gli accostamenti con altri atti unici che vengono ritenuti capaci di trasmettere lo stesso messaggio e la stessa freschezza musicale. Il Teatro Palladium ha deciso di concentrarsi esclusivamente su Mascagni, una scelta intelligente e che ha consentito di appezzarne ogni minimo dettaglio. Il pubblico è stato reso ancora più partecipe dall’ingresso di coro e comparse direttamente dalla platea: il teatro non è stato pensato propriamente per le rappresentazioni operistiche, ma gli spazi sono stati occupati in maniera strategica e senza creare confusione. Interessante la soluzione della donna che grida “Hanno ammazzato Compare Turiddu” dalla balaustra della galleria, un’altra soluzione per coinvolgere gli spettatori e far vivere più intensamente gli ultimi istanti dell’atto unico. Alla fine gli applausi sono stati generosi come il vino bevuto dallo stesso Turiddu prima del duello.
L’HEURE ESPAGNOLE/L’ENFANT ET LES SORTILEGES [Lukas Franceschini] Milano, 20 maggio 2016.
Alla Scala in una sola serata l’integrale della produzione operistica di Maurice Ravel, le due opere brevi L’heure espagnole e L’enfant et les sortilèges, con la direzione di Marc Minkowski e la regia di Laurent Pelly ideata per il Festival di Glyndebourne nel 2012. L’Heure espagnole è un’opera in atto, su libretto di Franc Nohain, e fu composta tra l’aprile e l’ottobre del 1907, la prima esecuzione ebbe luogo al Théâtre National de l’Opéra-Comique di Parigi il 19 maggio 1911. Insieme con altre composizioni, quali Alborada del Gracioso, l’opera rappresenta il versante iberico della personalità di Ravel, evocando temi e sonorità propri delle sue origini basche. È possibile definirla una ‘farsa amorosa’ con intenti moralistici e satirici. Infatti, l’intreccio umoristico, tratto dalla commedia musicale omonima di Fran-Nohain, è una pièce boccaccesca ambientata nella bottega di un orologiaio e focalizzata sulle intriganti avventure di Conception che in assenza del marito riceve i suoi spasimanti. L’accoglienza non fu esaltante, furono peraltro criticate la tessitura vocale dei personaggi e in particolar modo l’effimera melodia delle parti. L’heure non segue l’alternanza arie e recitativo, benché trattasi di commedi musicale ma articolata nello stile dell’opera di conversazione non rilevando però realismo psicologico dei personaggi, i quali sono goffi e ispirati a un automatismo a orologeria, marionettistico, che diventa parodia. Quello che invece differenzia la partitura è un’orchestra di grandi dimensioni che sostiene la commedia, in tale peculiarità Ravel fornisce una prova di elegante sensibilità compositiva inserita nel gioco di sonorità molto efficace. Ispirandosi alle classiche composizioni dell’opera buffa italiana, il finale è un quintetto (su un ritmo di habanera) nel quale tutti assieme i protagonisti si congedano da pubblico. Spettacolo atemporale a divertentissimo dove il regista e costumista Pelly ci trasporta in una Toledo quasi almodovariana, una stanza zeppa di orologi, magnifica la scena di Caroline Ginet e Florence Evrard, e i tempi ritmici della narrazione sono veloci e incastrati alla perfezione nel divertente racconto, che coinvolge, diverte, e al termine dei sessanta minuti dispiace sia già finita. Brillante e raffinata la regia cui si aggiunge una più che ottima parte canora capeggiata dalla Concepcion di Stéphanie D’Oustrac, assieme al bravissimo Ramiro di Jean-Luc Ballestra, al Gonzalve di Yann Beuron, al Don Inigo di Vincent Le Texier e non pe ultimo lo spassosissimo Torquemada di Jean-Paul Fouchécourt. Grande sorpresa la bacchetta precisa, armoniosa e graffiante di Marc Minkowski, concertatore molto più famoso in altri repertori, che con la musica “contemporanea” di Ravel trova un connubio di altissimo valore. Les enfants et les sortilèges è un’opera composta fra il 1919 ed il 1925, in collaborazione con Colette che scrisse il libretto intitolato inizialmente Divertissement pour ma fille. Si tratta della seconda ed ultima opera lirica di Ravel. Capolavoro di orchestrazione, L’enfant, è spesso eseguita in forma di concerto a causa dei continui cambi di scena previsti dalla storia. L’opera è costituita da una successione di quadri indipendenti nei quali è facile riconoscere la moltitudine di generi musicali: jazz, foxtrot, ragtime, polke e valzer. Con quest’opera Ravel ebbe modo di mettere in luce le sue capacità di compositore e di orchestrazione, riuscendo alla perfezione nella realizzazione di sonorità che evidenziano il particolare libretto di Colette, anche con l’utilizzo di strumenti-oggetti inconsueti: raganella, frusta, grattugia, ecc. L’enfant è più affine alla commedia musicale che all’opera e potremo definirla una composizione fine a se stessa nel catalogo raveliano, nella quale sono espresse pagine d’incantesimo e raffinata sensibilità espressiva musicale, nonché umoristica. La prima assoluta fu al Teatro de l’Opéra di Montecarlo il 21 marzo 1952 (direttore Victor De Sabata), e come spesso accade per i lavori originali e innovatori, non ebbe accoglienze lusinghiere. In seguito, tuttavia, l’opera ha conseguito un notevole successo, soprattutto sul pubblico dei bambini. L’enfant et les sortileges, fantasia lirica in singolare racconto coreografico, mette in particolare evidenza l’elemento onirico a discapito di quello realistico. Anche in questo caso la felice bacchetta di Minkowski trova un terreno fertile ed edificante per esprimere con grande maestria tutti gli stili orchestrali di Ravel, in una sequenza di esilarante modernità e precisissima orchestrazione. L’orchestra del Teatro alla Scala, in forma splendida, segue il direttore in un passo musicale di livello forse raramente raggiungibile. Laurent Pelly, che in questo caso è coadiuvato dalla fantasiosa scenografa Barbara De Limburg, trova spazio per manifestare invenzione e grande senso teatrale di narrazione fiabesca. Una parete mobile per gli interni della casa dell’enfant, mobili grandi da dove escono i sortilegi, per poi aprirsi in un fantastico giardino notturno dove tutto è anima e poesia commuovente, con alberi e animali parlanti, in un gioco divertente di eccelso valore teatrale. Il cast anche nel secondo tempo della serata, era di altissimo livello, nel quale Marianne Crebassa, la protagonista, tracciava prima un enfat-terrible poi un impaurito ma delizioso fanciullo vocalmente ineccepibile. Una menzione speciale per il Coro di voci bianche del Teatro alla Scala per la valida professionalità dimostrata. In locandina figuravano i validissimi: Delphine Haida (Maman/tazza cinese/libellula), Anna Devin (Bergère/pipistrello), Jean-Luc Ballestra (orologio/gatto), Stéphanie D’Oustrac (gatta/scoiattolo), Armelle Khourdoian (fuco/principessa/usignolo), Jerome Varnier (divanetto/albero), Jean-Paul Fouchécourt (teiera/vecchietto/raganella), Fatma Said (pastorella), Chiara Tirotta (pastore) ed Elissa Huber (gufo). Uno spettacolo assolutamente da non perdere che ha registrato con convinto e meritato applauso al termine delle due ore di esecuzione.
ALBERT HERRING [Lukas Franceschini] Firenze, 27 maggio 2016.
Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino segna il secondo successo consecutivo con la messinscena di Albert Herring di Benjamin Britten, dimostrando ancora una volta di essere un contenitore culturale di alto livello, attivo, innovativo e innovatore. Trionfale esecuzione di Albert Herring di Benjamin Britten, al Teatro alla Pergola, terzo titolo operistico del 79° Maggio Musicale Fiorentino 2016. Dopo The Rape of Lucretia Britten si cimentò con la commedia operistica, assieme al librettista Eric Crozier la scelta cadde su un adattamento da una novella di Guy de Maupassant “Le Rosier de Madame Husson”, spostando l’azione nella campagna del Suffolk e in stile tipicamente inglese. Albert Herring fu composto tra l’inverno 1946 e la primavera 1947 a The Old Mill a Piton, abitazione di Britten, il quale usò la stessa compagine strumentale utilizzata per la precedente opera. La prima esecuzione fu al Festival di Glyndebourne il 20 giugno 1947 (con l’Opera Company), istituzione della quale al tempo Britten era direttore. Come di consueto fu diretta dall’autore e quale protagonista figurava il tenore Peter Pears, suo compagno di vita ed interprete d’elezione di tutti i suoi lavori operistici. Alcuni contrasti insorti durante le prove accentuarono nel compositore il bisogno di creare a una compagnia indipendente, nacque così l’English Opera Group, e inseguito di dotarsi di una sede propria, fu fondato il Festival di Aldeburgh che fu inaugurato nel 1948 proprio con Albert Herring. L’opera è un lavoro musicalmente complesso, anche se all’apparenza può sembrare brillante e comico. Il testo è veramente divertente e lo spartito comprende una miriade di citazioni musicali. Come in quasi tutte le opere di Britten anche in Albert Herring c’è la relazione della società nei confronti di una persona “anomala”, in questo caso potremo dire strana, con tono generalista divertente e spensierato, non toccando per nulla temi drammatici come in Peter Grimes, Billy Budd o Turn of Screw. Alcuni biografi del compositore hanno intravisto nel protagonista tratti autobiografici di Britten stesso. Probabilmente è la stessa idea che ha avuto Alessandro Talevi, il regista, ambientando la nuova produzione dell’opera negli anni ’20 del secolo scorso, epoca che combacia con la giovinezza di herring 4Britten poiché era nato nel 1913. Allo stesso tempo il regista con grande mano narrativa, qui coadiuvato dalla bella scena e splendidi costumi di Madeleine Boyd, ironizza garbatamente sulle usanze del popolo d’oltre Manica, sbeffeggiando usanze paesane e una società bigotta e ottusa. Non manca di marcare l’accento, ma senza sconfinare troppo, sull’aspetto psicologico del timido e succube, da parte di madre, Albert Herring che in sostanza trattasi di altro emarginato. Con i tratti divertenti e soporiferi della borghesia e aristocrazia inglese, Talevi firma uno spettacolo bellissimo, forse finora il migliore visto da chi scrive, strizzando l’occhio, ma non copiando, a celebri film o serial inglesi. Anche nei passi che potrebbero essere più drammatici, punta a un’ironia sarcastica tipicamente inglese, dosando con metrica precisa una vicenda comica ma che lascia nello spettatore oltre il sorriso anche la riflessione dell’altro specchio della medaglia. Sul podio abbiamo ritrovato Jonathan Webb, eccellente concertatore anche di altre opere di Britten a Firenze. Webb ha impresso alla partitura la brillante esecuzione che merita, forgiando l’orchestra del Maggio Musicale in sonorità sempre accese ma di estrema rifinitura sonora e precisissima asciuttezza musicale, cui si somma una squisita lettura musicale ironica, divertente mai sopra le righe. Il cast assemblato era di prim’ordine sia musicalmente sia scenicamente. Bravissimo il protagonista Sam Furness, eccellente sempliciotto protagonista, strepitosa Orla Boylan, una Lady Billows che faceva il verso alla coeva Lady di “Downton Abbey”, brillante la Florence intrigante di Gabriella Sborgi, e magnifica Manuela Custer, Mrs. Herring, nella versatilità del ruolo di madre despota poi disperata in gramaglie. Ma ancora è doveroso citare per l’ottima professionalità Anna Gillingham (Miss Wordsworth), Zachary Altman herring 8(Mr. Gedge), Christopher Lemmings (Mr. Upfold), Karl Huml (Budd), Philip Smith (Sid) e Rachel Kelly (Nancy). Un particolare elogio ai giovani interpreti Sophie Gallagher (Emmie), Bonnie Callaghan (Cis) e Nicholas Challier (Harry) per la precisa e straordinaria esecuzione vocale espressa. Perfetta la locazione del contenuto Teatro alla Pergola e meritatissimi e prolungati applausi a tutta alla compagnia. L’edizione del maggio 2016 ha puntato su titoli desueti ma i risultati sono stati superiori alle buone aspettative, e Albert Herring è stato la punta di diamante della rassegna.
ALBERT HERRING [Renata Fantoni e William Fratti] Firenze, 27 maggio 2016.
Peccato che l’organizzazione dei programmi e la pubblicità dei calendari vada poco oltre l’Arno e nonostante l’ottima qualità degli spettacoli, tra i migliori in Italia, il pubblico intervenuto alla Pergola era così poco da poter entrare tutto al Goldoni. Colpa anche del fiorentino medio, che all’Opera si è abituato ad avere il parcheggio comodo e gratuito. Insomma, una serie di contingenze che hanno fatto di questa bellissima produzione un’occasione sprecata. Albert Herring è opera di vero teatro, che necessita di essere interpretata musicalmente e scenicamente con estrema perizia, altrimenti rischia di implodere in un’accozzaglia poco significativa. A Firenze Jonathan Webb fa tesoro di tutto il suo sapere britteniano conducendo la brava Orchestra del Maggio in suoni limpidissimi e in fraseggi espressivi piuttosto eloquenti e, con questa base, ottiene altrettanto dall’eccellente compagnia di canto, impreziosita dall’ottimo lavoro di regia di Alessandro Talevi, che assicura sguardi e gestualità da vero teatro inglese. I suoi divertentissimi personaggi sembrano in parte usciti da Downton Abbey e grazie anche alle belle ed efficacissime scene di Madeleine Boyd, che pure disegna costumi davvero pregevoli e azzeccati, in platea sembra di sentire il profumo della nebbia britannica, o quello delle pesche di Herring’s. Sam Furness, dotato di vocalità limpida e brillante, abile nei piani e nelle mezze voci, è un Albert molto ben riuscito, inizialmente remissivo, poi in preda alla catarsi, mai personaggio comico, ma sempre divertente nel suo aplomb inglese. Elegante oltre ogni misura la Lady Billows di Orla Boylan, che in questa veste fa invidia alla Violet Crawley di Maggie Smith. Inizialmente parte un po’ stridula, ma dopo poche pagine la vocalità spinta le permette di rendere al meglio tutte le insidie della parte, con delle salite all’acuto davvero efficaci. È affiancata da un’altrettanto eccellente Gabriella Sborgi nel ruolo di Florence Pike, che dimostra tutta la sua esperienza nel repertorio di Britten sfoggiando un ruolo, sia musicalmente, sia scenicamente, che rasenta la perfezione. Bravissimi i due innamorati: Philip Smith, Sid dalla voce chiara e pulita, quasi baritenorile, decisamente morbida e delicata; Rachel Kelly, una Nancy dal timbro vellutato ma leggero, perfettamente a suo agio nelle numerose note basse. Ottimi l’intensa Mrs. Herring di Manuela Custer, la brillante Miss Wordsworth di Anna Gillingham, il valido Mr. Gedge di Zachary Altman, il raggiante Mr. Upfold di Christopher Lemmings, il cavernoso Superintendent Budd di Karl Huml, come pure squisiti i tre bambini: Emmie di Sophie Gallagher, Cis di Bonnie Callaghan e Harry di Nicholas Challier.
POLLICINO [Margherita Panarelli] Torino, 28 Maggio 2016.
Prosegue con Pollicino di Hans Werner Henze la ottima Stagione 2015/2016 del Teatro Regio di Torino. Regia di Dieter Kaegi e Claudio Fenoglio alla direzione d’orchestra. Omaggi al passato e nuove idee: una raffinata commistione è la cifra della musica di Henze e Pollicino non fa eccezione. Tra reminescenze ed echi, amalgamati in maniera assolutamente originale e moderna, spunta anche una citazione diretta dal Rigoletto di Giuseppe Verdi che ha fatto sorridere il folto pubblico presente in sala, composto per lo più da famiglie e giovanissimi. Giovanissimi anche gli interpreti e gli orchestrali, con le dovute eccezioni, per un linguaggio musicale affascinante e mai banale, descrittivo e invitante, adattissimo all’età degli interpreti e del pubblico destinatario, perfettamente in linea con i dettami musicali e soprattutto pedagogici della Orff- Schulwerk di cui Henze è stato seguace. Semplice ed efficace è anche la messa in scena di Dieter Kaegi che sceglie di ambientare la prima parte in una stazione, dove una vecchia motrice abbandonata fa da casa alla famiglia di Pollicino, e una casa degli orchi in stile pop art con quadri di hamburger e salsicce alle pareti bicolori. In buca, eccezionalmente, Claudio Fenoglio, stimatissimo maestro del coro del Teatro Regio che si rivela direttore sensibile e preciso. Eccellenti il sostegno agli interpreti e la tensione narrativa durante l’intera rappresentazione. Egregio il lavoro svolto dall’Orchestra Giovanile “Il Pollicino”. Molto buono il cast: Giorgio Fidelio è un pollicino generalmente convincente sia vocalmente che recitativamente, nonostante qualche imprecisione tutto sommato trascurabile. Convincente è anche Fiammetta Piovano, l’orchessina Clotilde, perfettamente a suo agio nel ruolo. Kate Fruchtermann è una Madre dal timbro acidulo ma riesce a trasmettere tenerezza nonostante tutto. Michele Govi è invece il Padre, dalla vocalità più adatta al suo ruolo. Persuasivo e accattivante Emilio Marcucci nei panni dell’Orco Terribile, che porta a casa senza dubbio la palma della serata, ma la cui impresa non sarebbe stata possibile senza l’ottima collaborazione di Silvia Beltrami nel ruolo della moglie. La sua è stata un’interpretazione efficace e di eccellente livello. Deliziosi tutti i bambini solisti e del coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, egregiamente preparati dal Maestro Fenoglio. L’auspicio è naturalmente aver avvicinato, attraverso questa favola, la nuova generazione alla musica colta ed al linguaggio del teatro musicale in particolare.
L’AMICO FRITZ [Lukas Franceschini] Venezia, 31 maggio 2016.
Il Teatro La Fenice produce un nuovo allestimento de L’amico Fritz di Pietro Mascagni, opera oggigiorno quasi dimenticata, nell’area nord-Italia si ricorda come ultima ripresa un’edizione con cast bizzarro, Andre Bocelli e Cecilia Gasdia, a Verona nel 2001. L’amico Fritz è una commedia lirica in tre atti musicata da su libretto di Nicola Daspuro (sotto lo pseudonimo di P. Suardon) basata sulla commedia L’ami Fritz (1876) del duo Erckmann-Chatrian. La prima rappresentazione si tenne con successo al Teatro Costanzi di Roma il 31 ottobre 1891 con protagonisti Fernando De Lucia ed Emma Calvé. È indiscusso che Mascagni, come altri compositori suoi coetanei, fosse vittima di una certa stampa carica di pregiudizi e incomprensioni. L’opera che non vanta un impegno stilistico eccelso ha tuttavia una costruzione musicale ben più complessa di Cavalleria Rusticana, la quale passerà alla storia come il capolavoro primo e mai superato dell’autore. Lo spartito in oggetto è opera larmoyante e carica di melodico sentimento, un genere che a cavallo tra ‘800 e ‘900 godette di ampio favore tra il pubblico e gli interpreti lirici. Tali favori si protrassero fino agli anni ’60, culminate con due edizioni discografiche di riferimento. Amico Fritz non è un capolavoro, la questione è accertata da tempo e una certa fortuna la può trovare solo nel caso, non raro, di validissimi cantanti e notevole direttore. Essa è un’opera unica nel suo genere idilliaco che possiamo considerare una bella o, più semplicemente, una peculiare storia d’amore ma scadente e prolissa, pur nella brevità di novanta minuti, e poco teatrale. I toni idilliaci, tenui e le amenità paesaggistiche descritte in musica da Mascagni non possiamo negare abbiamo un indicativo “bozzettismo” e il tratteggio dell’ambiente attraverso il gioco delle mezze-tinte e i colori evocano un significato che qualcuno affianca alla scapigliatura, movimento artistico in voga sul finire del XIX secolo, senza tralasciare l’aspetto teatrale in musica in cui prevalgono affetti e idilli, assieme alla nostalgia del crepuscolarismo della romanza salottiera. Non mancarono come suddetto critiche feroci alla partitura e al libretto, Verdi lo definì “scemo”, ma anche attestati di stima, come quello di Gustav Mahler che diresse l’opera ad Amburgo nel 1893 e in seguito a Vienna, ove ottenne un trionfo. La nuova produzione veneziana affidata alla regia di Simona Marchini, Massimo Checchetto scenografo e Carlos Tieppo costumista, delude per il senso chiuso di una scenografia a forma di cartolina, sempre uguale, e da una sostanziale ingessatura della narrazione, la regia mi è parsa molto latitante, non creando quell’aspetto salottiero e idilliaco che lo spartito richiede. Non aiutavano i costumi, piuttosto dozzinali, talvolta ridicoli se prendiamo ad esempio Beppe conciato come un corsaro. Nel complesso una soporifera e pesante ruotine senza anima, cui si sommano inserimenti mimici inutili e talvolta ridicoli. Fabrizio Maria Carminati sarebbe concertatore sicuro e preciso, buon narratore e diligente equilibrista tra buca e palcoscenico, peccato che le sonorità erano talvolta eccessive per il contenuto teatro veneziano, avremo preferito più leggerezza ma non possiamo negare che la direzione sul canto di conversazione era molto meritevole. Delude nel suo complesso il cast. Alessandro Scotto di Luzio, Fritz, sfodera un timbro molto bello ma non va oltre l’esibizione, dimostrando una sommaria capacità di fraseggio e accenti. Inferiore la Suzel di Carmela Remigio, la quale avrebbe avuto i requisiti per tale ruolo, ma recenti trasbordi di repertorio hanno comportato una modifica sostanziale della vocalità che in quest’occasione è risultata con colori troppo incisivi e con accenti drammatici del tutto estranei al ruolo inoltre, il personaggio adesso le sta stretto interpretativamente. Elia Fabbian, David, ha solo interpretato un buon personaggio ma il canto era aspro e sfasato. Leggermente meglio il Beppe di Teresa Iervolino, dalla quale però mi sarei aspettato più pathos e vena malinconica, ma la voce è bella e probabilmente la regia l’ha fortemente penalizzata. Ottime le parti di contorno: William Corrò e Alessio Zanetti, Hanezò e Federico, sono due sgargianti amici del protagonista e Anna Bordignon una precisa Caterina. Buona la prova del Coro istruito da Claudio Marino Moretti. Teatro con qualche vuoto sia nei palchi sia in galleria, successo di cortesia al termine.
LE NOZZE DI FIGARO [Lukas Franceschini] Vicenza, 3 giugno 2016.
Felicissima esecuzione de Le Nozze di Figaro, il titolo mozartiano scelto dal direttore artistico, fondatore e concertatore della XXV Edizione della Settimane Musicali al Teatro Olimpico. La rassegna vicentina ha raggiunto negli anni un livello rilevante nel panorama regionale delle manifestazioni musicali, programmando opere liriche, concerti da camera tematici e quest’anno una doppia esecuzione della Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, nell’ideazione lungimirante di Giovanni Battista Rigon. Con le quattro recite in programma del dramma giocoso, in quattro atti su libretto di Lorenzo da Ponte, si conclude il ciclo delle tre opere mozartiane con la regia di Lorenzo Regazzo e Rigon sul podio. L’ambiente del Teatro Olimpico, capolavoro di Andrea Palladio, è una delle visioni più stupefacenti dell’arte architettonica rinascimentale, e per tale prerogativa sottoposto a rigidi vincoli di utilizzo, pertanto la scenografia era composta di pochissimi nozze 1elementi che la sovrintendenza alle belle arti ha permesso di utilizzare. Regazzo, come nelle altre occasioni, ha voluto fortemente modernizzare il dramma, rilevando e accentuando gli spunti di una società settecentesca che si possono discerne anche nella nostra epoca. Idea non nuova, tuttavia la felice intuizione del regista non si rifà al già visto ma inventa e suggerisce intuizioni garbate che devono far scaturire nel pubblico il sottile ragionamento che in tutte le epoche tradimenti, sotterfugi, ambiguità, accomodamenti si sono sempre perpetrati, magari in meccanismi diversi ma con prodotto eguale. Dunque abbiamo un Conte che supportato dalla sua posizione seduce più per potere che per fascino, una Susanna anche innamorata del suo Figaro, ma dedita agli intrighi di Palazzo e anche ad altri vizi diversi dal compito di cameriera. La contessa, donna infelice e trascurata, ha solo quale consolazione la posizione sociale che tiene ben stretta sottostando ai diversivi del marito, speranzosa di futuri più amorevoli. Figaro, buon giovane, scaltro e pragmatico, non si fa cruccio delle usanze sia di palazzo sia della futura sposa, e nel suo assolo sentenzia il genere femminile, sapendo cosa lui deve fare come viver meglio. Il regista mette molta carne al fuoco in questo contesto di società non proprio moralmente elevata, ma con giusta causa sottolinea in parallelo gli stili di vita antichi e moderni, volendo e giustamente credendo che le cose non sono molto cambiate. I personaggi sono tutti molto focalizzati e ben istruiti in una drammaturgia sempre incalzante e molto teatrale, ironica e coinvolgente. Anche le parti di fianco sono tutte focalizzate in un loro coinvolgimento in questa narrazione moderna, lo fanno in modo sarcastico e ottima arte teatrale, adattandosi ai suggerimenti del regista con assoluta disinvoltura. L’unico appunto nozze 3che potrei rivolgere a Regazzo è di aver mescolato troppe cose in queste Nozze, talune anche non chiaramente decifrabili, e di aver voluto affettare molte scene in una chiara impostazione moderna, mentre per chi scrive, avrebbe potuto restare più in equilibrio nell’ambiguità non tanto celata del libretto e del carattere dei personaggi. Poco funzionale la caratterizzazione di Don Curzio come lo scemo del palazzo, balbuziente e in pantaloncini corti, e soverchio il selfie nel finale atto I, ma è solo idea personale. Ottimo il lavoro di Carla Conti Guglia, scenografa, e molto belli ed eleganti i costumi attuali di Riccardo Longo, al quale tuttavia suggerisco maggior attenzione al fisico dei cantanti nel far loro indossare mise molto minime. Sul versante musicale abbiamo trovato in Giovanni Battista Rigon l’artefice assoluto di questa bellissima esecuzione. Già sapevamo che è esperto mozartiano ed eccellente concertatore, anche in quest’occasione abbiamo ritrovato l’eccellente musicista, cui va riconosciuto il grande senso musicale-taratale, una ricca e sfaccettata tavolozza di colori, e una ricercata perizia del particolare. La direzione di Rigon è sempre stata precisa e lineare con tempi incalzanti mai trasbordanti, l’elemento giocoso è stato trattato, o meglio plasmato, con arguta grazia, preferendo un compiaciuto equilibrio e mai rifuggendo nell’estremo. Dobbiamo aggiungere che l’Orchestra di Padova e del Veneto è stata partecipe di un’ottima prestazione, attenta alle indicazioni del maestro e mai sentita cosi precisa e nitida nel suono. Altro merito di Rigon è stato quello di eseguire l’opera nella versione integrale, comprese le arie di Marcellina e Basilio, solitamente omesse, e di aver suddiviso l’opera in due parti con un solo intervallo, diversamente da quanto era stato preventivato in origine. Molto buona la prova del coro I Polifonici Vicentini istruito da Pierluigi Comparin. Un particolare plauso va al maestro al cembalo Stefano Gibellato, bravissimo nell’accompagnare i fondamentali e lunghi recitativi. Il cast era molto omogeneo, ben assortito nei rispettivi ruoli vocali e molto rilevante nella recitazione. Daniele Caputo, Figaro, è un giovane baritono di ottime caratteristiche vocali, preciso, brillante, che ha reso il personaggio con splendidi accenti canori. Sullo stesso piano e mai petulante era la Susanna di Carolina Lippo, altrettanto incisiva e raffinata cantante. Marco Bussi, il nozze 4Conte d’Almaviva, sfoderava il suo istrionico accento e l’innata musicalità in un ruolo calzato a pennello anche scenicamente, classe e fraseggio hanno contribuito all’ottima realizzazione. Patrizia Bicciré, la Contessa Rosina, è stata chiamata all’ultimo per sostituire una collega infortunata, debuttando il ruolo. Il giudizio non può essere che positivo, lei ha superato la prova sfoderando il talento musicale, che le riconosciamo da tempo, cantando con grande garbo e stile cui va aggiunta una pertinente vena malinconica ma aristocratica che il personaggio richiede. Molto brava Margherita Rotondi, esuberante Cherubino, giovanile, malizioso e ben calibrato in una voce rotonda e precisa. Impagabile scenicamente la Marcellina di Giovanna Donadini, scatenata e divertentissima cui va sommata la consueta professionalità. Molto buono il Bartolo di Antonio De Gobbi, e bravo il Basilio di Filippo Pina Castiglioni acidissimo prete di campagna rifinito nei suoi compiti vocali. Non ultimi, ma relegati ai loro marginali interventi, Elvis Fanton, Francesca Cholevas e Claudio Zancopè, rispettivamente Don Curzio, Barbarina e Antonio, che hanno dimostrato ottime capacità canore e interpretative. Alla prima recita il Teatro era del tutto esaurito in ogni posto, e al termine il pubblico ha decretato un convinto e meritato successo a tutta la compagnia.
FAUST [William Fratti] Losanna, 8 giugno 2016.
Dopo il grande successo avuto sul palcoscenico di Torino, il Faust di Charles Gounod nello spettacolo di Stefano Poda è messo in scena all’Opéra de Lausanne con addirittura maggior cura e dettaglio, e la visione estremamente poetica del regista italiano acquisisce ulteriori significati filosofici, che trovano nel coro celeste del finale una liberazione catartica dell’anima di Faust, piuttosto che di quella di Marguerite, come se l’intera vicenda fosse solo un sogno delirante del vecchio dottore, disposto a vendere l’anima al demonio per un pugno di emozioni, ma che in effetti sembra vivere solo nei meandri della sua mente malata.La direzione musicale di Jean-Yves Ossonce è particolarmente sentita, intensa e vibrante e ciò lo si nota fin dall’ouverture ricca di colori brillantissimi che impreziosiscono tutta l’opera senza soluzione di continuità. L’Orchestre de Chambre de Lausanne lo segue perfettamente prodigandosi in suoni limpidi e puliti, addirittura maestosi dove occorre, pur non essendo particolarmente numerosa. Strabiliante il Choeur de l’Opéra de Lausanne, diretto per la prima volta dal bravo Marcel Seminara, che canta Gounod con la disinvoltura che si riserva al repertorio di frequentazione quotidiana. Altro debutto a Losanna, oltreché nel difficile ruolo del titolo, è quello di Paolo Fanale che, ogni volta che compie un ulteriore passo nella sua carriera, continua a sorprendere per l’intelligenza delle scelte musicali: la sua voce è grazia pura, usata con classe ed eleganza. Già nei primi due atti il bravo tenore dispiega la sua morbidezza lungo una linea di canto omogenea e impeccabile, ricca di sfumature e cromatismi che rendono il suo fraseggio particolarmente emozionante, eccellente nell’uso delle mezze voci, che sono reali, tenute sul fiato, mai emesse in falsetto, che sfociano in un entusiasmante “Je t’aime” eseguito in pianissimo così come scritto sullo spartito e come ben pochi altri artisti sanno fare. L’intonazione perfetta e le finezze più sottili e delicate lo portano ad interpretare un’intensissima “Salut! Demeure chaste et pure” che poi trova una vera apoteosi nel terzetto finale. Maria Katzarava resta una cantante approssimativa e imprecisa come già notato in precedenti occasioni. La sua vocalità e la sua presenza scenica sono piuttosto ineleganti, di poco gusto e nel ruolo di Marguerite è quasi ridicola, poiché in terzo atto sembra recitare nel teatro comico anziché in un dramma. In molti passaggi pare che i suoni non siano in maschera o che prendano delle posizioni a caso, ed è dunque costretta a parlare invece di cantare; talvolta è stonata; nei pezzi d’assieme urla a dismisura; le poche agilità che occorrono alla parte sono pasticciate e nella celebre aria dei gioielli deve addirittura inserire delle H aspirate in “C’est la fi-hi-hi-hi-hille d’un roi”. Kenneth Kellog è un buon Méphisto, dotato di un fraseggio drammatico piuttosto eloquente che ha il sapore del demoniaco, autorevole come un dio del male in “Le veau d’or”. Peccato che la gola tenda a chiuderglisi quando sale troppo in acuto e che alcune note basse non siano propriamente salde. Toccante il Valentin di Régis Mengus, dotato di vocalità brillantissima, quasi tenorile, ma ben dosata nei gravi e soprattutto provvista di una buona musicalità. Carine Séchaye ha una vocalità molto particolare, piacevolmente ibrida, e pare perfetta per il ruolo di Siebel che esegue con ottima cura, particolare attenzione al suono e con un’interpretazione efficace. Buona anche l’esecuzione di Marthe da parte di Marina Viotti. È invece meno adeguato il Wagner di Benoît Capt. Grande successo per tutti gli interpreti al termine dello spettacolo ed è un vero peccato notare come in molti, anzi troppi, non sappiano distinguere il bel canto dal mal canto, ma di ciò si può solo incolpare la mala educazione all’arte, alla musica e alla cultura in generale.
DER ROSENKAVALIER [Lukas Franceschini] Milano, 10 giugno 2016.
Ritorna al Teatro alla Scala, con maggiore frequenza rispetto al passato, il capolavoro di Richard Strauss Der Rosenkavalier diretto da Zubin Mehta e con la regia di Harry Kupfer. L’opera, la cui prima fu a Dresda il 26 gennaio 1911, fu composta in pieno sentimentalismo viennese, straordinariamente supportata dal libretto di Hugo von Hofmannsthal, rivelandoci un mondo onirico dell’aristocrazia d’oltralpe attraverso uno spartito ove si riscontra il tratto sinfonico dell’autore, il quale ha impresso una raffinata scrittura malinconica ma anche sensuale. Forse il comune denominatore è il tempo che passa, tema quanto mai attuale, e l’unica che inconsciamente non se ne accorge o non vuole rendersene conto è la figura della Marescialla, la quale pur rinunciando al giovane amante, fatica ad accettare l’inesorabile destino, ma lo fa con un contenuto amaro sorriso. Una commedia, dolce e ricca di sentimenti, che ci trasporta nel fantastico impero settecentesco asburgico, con chiari riferimenti a colei che fu regina progressista e amata: Maria Teresa. Il regista Harry Kupfer, che ha ideato lo spettacolo al Festival di Salisburgo la scorsa estate, mantiene questo equilibrio puntando soprattutto sulla lettura della commedia all’antica. Molto calibrata la recitazione, tutti i personaggi sono perfettamente credibili, e collaborando con Hans Schavernoch, scenografo, ci trasporta in mondo fantastico la cui scena è composta di pochi elementi, ma le proiezioni, in bianco e nero, dei tetti della capitale austrica affascinano e fanno affiorare ricordi personali nel riconoscere luoghi e palazzi visitati, il Palazzo Reale, il Prater, ecc. Merito del bravo regista video Thomas Reimer che nel primo atto coglie il momento migliore assieme al regista per realizzare quest’affresco moderno. Nel secondo atto manca la magnificenza nel grande momento dell’ingresso di Octavian e la grande atmosfera della residenza di Faninal, ma nel complesso funziona anche una lettura cosi asciutta. In parte meno riuscito il terzo atto, la scena della taverna di second’ordine, è un po’ troppo sovraccarica di recitazione e gags, le proiezioni sono magnifiche (il Prater, addirittura con autovolante), e comunque il regista ci riserva un finale quasi cinematografico quando la marescialla e Faninal lasciano i giovani amanti transitando su una vettura automobilistica di lusso. Pur rispettando a puntino tutta la drammaturgia, il regista e lo scenografo, spostano l’azione negli ultimi anni dell’Impero, intorno al 1920, creando un epilogo romanzato di quello che fu la grande Vienna. Molto belli i costumi, di gran classe e ottima fattura sartoriale di Yan Tax, particolarmente efficace l’apporto di Jurgen Hoffmann, il quale ha ideato le luci. Sul podio dell’orchestra del Teatro alla Scala abbiamo ritrovato il maestro Zubin Mehta, che negli ultimi anni ha iniziato a rifrequentare il teatro dopo lunga un’assenza, in parte ingiustificata. Bacchetta tra le più apprezzate da sempre, in epoche recenti si è spesso lasciata coinvolgere dagli allori “rilassandosi” su routine anonime, pur sempre prestigiose. In quest’occasione siamo in parte ritornati ai festosi momenti di grande concertazione. Coadiuvato da un’orchestra particolarmente ispirata, egli ha diretto in maniera superba cercando soprattutto una lettura teatrale raffinata e vivida, esclude la leziosità a priori e punta con efficacia alla narrazione. Potremo affermare che egli focalizza principalmente la melodia, esemplari in tal senso l’accompagnamento del monologo della Marescialla al primo atto e il terzetto del terzo, ma non è superficiale, anzi il contrario, nelle molte scene d’assieme (bagarre del II atto e scena della locanda al III atto), nelle quali dimostra di possedere elegante e perfetta sensibilità di teatro musicale. L’unico momento deludente, in parte, è stata la scena della presentazione della rosa, ove mi sarei aspettato maggior enfasi e vibrazione. Delude la protagonista Sophie Koch, Octavian, la quale ha una voce non particolarmente seducente, ma sono i problemi di volume a metterla a disagio ed essere coperta dalle altre voci o dall’orchestra, cui si deve aggiungere che gli acuti non sono del tutto efficaci e sovente si riscontrano carenze nell’intonazione. Molto più convincente la Marescialla di Krassimira Stoyanova, la quale sfodera un timbro molto seducente, fraseggio eloquente, e soavità canore nel canto di conversazione rilevanti, tuttavia ritengo che il ruolo non le sia del tutto congeniale per mancanza di fascino e carisma, molte frasi sono lasciate al caso, anche se ben cantate, e il tormento interiore non del tutto messo a fuoco. Gunther Groissbock è un Barone Ochs con voce chiarissima, fin troppo, però la gamma vocale è precisa e nitida sia nel grave sia nell’acuto, bella la voce, sfumati i colori e apprezzabile il fraseggio. Inoltre, si deve considerare la grande arte attoriale, la quale gli permette di interpretare un personaggio cesellato nella sbruffoneria e nell’arroganza. Meno riuscita la Sophie di Christiane Karg, la quale manca di velluto vocale e si adagia su una voce lieve e spesso flebile ma poco emotiva, non dimostra neppure una recitazione rilevante. Molto bravo il Faninal di Adrian Erod, voce ben timbrata e pastosa, professionale la Marianne di Silvana Dussman, simpatica Deunna molto teatrale. Garbato e puntuale vocalmente il Valzacchi di Kresimir Spicer, sfogata e disomogenea l’Annina di Janina Baechle. Rilevante il tenore Banjamin Bernheim, il cantante italiano, in possesso di ottimo timbro e particolare accento nel settore acuto. Gli altri interpreti hanno dimostrato una grande professionalità nei loro brevi interventi, ma una citazione va alle tre orfanelle: Theresa Zisser, Mareike Jankowski e Kristin Sveinsdottir per la deliziosa sintonia dimostrata. Sotto l’aspetto teatrale ma anche musicale è doveroso segnalare che tutti i comprimari hanno realizzato le loro interpretazioni con una verve apprezzabilissima. Il Coro ha come il solito fornito un perfetto apporto, mentre di assoluto rilievo l’esibizione del Coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala diretto da Bruno Casoni. Una particolarità: il giovane Mohammed, solitamente interpretato da un ragazzino, qui era impersonato da un giovane adulto, al quale il regista ha riservato atteggiamenti quasi d’innamorato della Marescialla, visione pertinente e simpatica. Meritato e convinto successo al termine.
DER ROSENKAVALIER [William Fratti] Milano, 14 giugno 2016.
Nel corso del ventesimo secolo Der Rosenkavalier è stato rappresentato al Piermarini in sole sette produzioni, mentre dal 2003 il capolavoro di Richard Strauss è stato allestito già tre volte e ciò lascia sperare che sia entrato stabilmente in repertorio. Il Cavaliere della Rosa è opera sublime che sa legare passato e futuro e proprio in quest’ottica si posizione il gradevole spettacolo di Harry Kupfer, con scene di Hans Schavernoch, costumi di Yan Tax, luci di Jürgen Hoffmann e video di Thomas Reimer, originariamente prodotto a Salisburgo. I grandi spazi vuoti ospitano pochi elementi scenografici e videoproiezioni che sanno sapientemente ispirare delle bellissime e suggestive ambientazioni neoclassiche, oltre a permettere un puntuale e determinato lavoro di regia sui singoli personaggi, che non lascia mai adito alla monotonia, mentre è sempre intriso d’azione, comunque raffinata e rifinita, anche nei momenti più comici. Peccato che gran parte della visuale sia alterata nei piani superiori dei palchi e nelle gallerie. È un poco più deludente la direzione musicale di Zubin Mehta, che pur essendo estremamente preciso come di sua consuetudine, inizialmente appare monotono, parco negli accenti e nei colori, quasi fosse esclusivamente un metronomo. In secondo atto riesce fortunatamente a rinvigorire la situazione, anche nei bellissimi valzer che hanno un esito dal maggior piglio; ma è soltanto in terzo atto che Mehta sa far sentire il polso con cui abitualmente, in passato, ha sempre diretto questo titolo. Eccellenti come sempre Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Sophie Koch è un Octavian poco soddisfacente, spesso tirata al limite negli acuti, dove è talvolta in difficoltà, oltre ad avere una vocalità un poco ruvida e aspra. Il personaggio non è malvagio, ma forse carente di passionalità. Krassimira Stoyanova è la personificazione dell’eleganza, tanto nel portamento quanto nella presenza scenica, tanto nella resa della Feldmarescialla quanto nella linea di canto. Musicale e molto omogenea, è un’artista raffinata e di classe, dotata di voce sublime e morbidissima. Günther Groissböck è un Barone Ochs davvero efficace, soprattutto nel fraseggio particolarmente eloquente. La voce non è molto brillante, ma lo è la sua interpretazione che si arricchisce di buona intensità nel finale secondo. Christiane Karg è un’ottima Sophie, dotata di una vocalità delicata, leggera e vellutata come una piuma bellissima e morbidissima, molto attenta alla purezza dei suoni, soprattutto gli eccellenti acuti di secondo atto. Adrian Eröd è un Faninal davvero ben riuscito, in possesso di una vocalità ibrida tra tenore e baritono particolarmente interessante. L’Annina di Janina Baechle ha poco carisma e la vocalità non è purtroppo delle più prestanti, pur essendo comunque interprete corretta. Lo stesso vale per il Valzacchi di Kresimir Spicer. Ottimo timbro quello di Benjamin Bernheim nei panni del cantante italiano, che certamente migliorerebbe la sua performance stando più attento ai legati. Buona la prova di tutti gli altri interpreti: la Marianne di Silvana Dussmann, il commissario di polizia di Thomas Bauer, i due maggiordomi di Franz Supper e Michele Mauro, il notaio di Dennis Wilgenhof, l’oste di Roman Sadnik, le tre orfane di Theresa Zisser, Kristin Sveinsdottir e Mareike Jankowski, la modista di Cecilia Lee, il venditore di animali di Sascha Emanuel Kramer, i quattro lacchè di Massimiliano Difino, Emidio Guidotti, Massimo Pagano e Andrea Semeraro, oltre ai mimi David Meden nei panni di Leopold e Yannick Lomboto in quelli di Mohammed.
LUCI MIE TRADITRICI [Lukas Franceschini] Bologna, 14 giugno 2016.
Per la prima volta l’opera Luci mie traditrici di Salvatore Sciarrino è allestita in una Fondazione Lirica nell’ambito della sua stagione annuale, finora è sempre stata rappresentata in festival di musica contemporanea o in esecuzioni in forma di concerto. Luci mie traditrici è un’opera in due atti su libretto e musica di Salvatore Sciarrino la cui prima esecuzione, in lingua tedesca e con il titolo “Die Blume todliche”, fu il 19 maggio 1998 nello Schlosstheater Schwetzingen al Festival omonimo. Il compositore iniziò a comporre lo spartito nel 1996 traendo spunto per il soggetto dal famoso omicidio che Carlo Gesualdo compì nel 1590 nei confronti della moglie e del suo amante. Durante la lavorazione Sciarrino seppe che anche Alfred Schnittke stava componendo un lavoro teatrale basato sull’identico soggetto, fu allora “obbligato” a un cambio, eleminando ogni riferimento ai fatti di Gesualdo, riversò le sue attenzioni al dramma “Il tradimento per l’onore” di Giacinto Andrea Cicognini, un dramma simile al precedente, che fu dato alle stampe circa sette decadi dopo i fatti predetti. E curioso tuttavia che tale testo, ben lontano dallo stile di Cicognini, autore in campo musicale dei libretti di Orontea di Antonio Cesti e Giasone di Francesco Cavalli, fosse in realtà opera di Francesco Stromboli, le “furbizie” non sono solo recenti. Sciarrino elimina molte pagine del dramma, riducendolo in due atti (anche se la durata di ottanta minuti scarsi identifica l’atto unico) e con solo quattro personaggi: il marito, Il Malaspina, la moglie, La Malaspina, l’Ospite e il Servo. Coppia felice che duetta l’amore ma luci 2l’arrivo dell’Ospite fa scaturire una passione, la quale sarà svelata dal servo, forse inconsciamente innamorato della padrona, a Il Malaspina, egli sarà bieco autore del duplice omicidio pur sapendo del tormento eterno che lo accompagnerà. In questa versione bologne è utilizzato un brano, una sorta di prologo, l’elegia “Qu’est devenu ce bel oeil” di Claude Le June (1608) cantata dietro le quinte da un con coro di voci bianche. Tematiche e drammaturgia molto avvincenti ma non è possibile non affermare che la voce è elemento primario, per Sciarrino è la parola messa in musica a essere nucleo dell’opera, suoni tenui ripetuti, lirici ribattuti, supportati da un’orchestra ridotta, ove le percussioni hanno un segno predominante. Non possiamo parlare di canto lirico vero e proprio ma di una forma “astratta di canto” basata sull’atonalità delle brevissime frasi riservate agli interpreti. L’evoluzione moderna del canto, che non copia il precedente ma lo trasforma. Tale ottica è attuabile solo su un testo come quello scritto da Sciarrino e su una drammaturgia che lascia allo spettatore molta immaginazione e facile comprensione del dramma borghese cui assiste. Lo spettacolo del Comunale di Bologna, in coproduzione con la Staatsoper unter den Linden di Berlino, aveva la bellissima regia di Jurgen Flimm, il quale ha stupendamente messo a fuoco sia la scena d’amore tra marito e moglie sia l’irrompere dell’ospite e il tragico finale, il tutto in un ambiente borghese che fa pensare a Ingmar Bergman. Luminosa ma anche claustrofobica la scena di Annette Murschetz, e di grande effetto la crepa sulla parete quando gli eventi sviluppano nella nuova passione de La Malaspina. In stile primo novecento i costumi, elegantissimi, di Birgit Wentsch, e di grande effetto le luci di Irena Selka. Sul piano musicale la presenza di Marco Angius è una garanzia in questo repertorio, creando atmosfere musicali di grande effetto teatrale, una narrazione anticonformista con gli orchestrali bolognesi, precisi e di somma ispirazione, in una concezione musicale di elevata intelligenza. Notevole anche la prova del Coro di Voci Bianche diretto da Alhambra Superchi. Sui cantanti non potremo esprimere giudizi adottati per i consueti esecutori, dobbiamo considerare la reale difficoltà della scrittura “sciarriniana” e dobbiamo pertanto valutare con lode tutti i quattro protagonisti, capaci di mettersi al servizio sia musicale sia teatrale con grande professionalità e spontanea naturalezza: Otto Katzameier (Il Malaspina), Katharina Kammerloher (La Malaspina), Lena Haselmann (Ospite) e Christian Oldenburg (Servo). Alla prima, serata inserita nel turno di abbonamento, il teatro Comunale era abbastanza gremito, nei limiti di un’opera contemporanea e al termine di una partecipe ascolto ha decretato un trionfo inaspettato a tutti gli interpreti, il team artistico e il compositore.
CARMEN [Lukas Franceschini] Verona, 24 giugno 2016.
Inaugurata la stagione Lirica all’Arena di Verona con la ripresa dell’opera Carmen di Georges Bizet nello storico allestimento di Franco Zeffirelli. Una premessa. Le recenti situazioni della Fondazione Arena sono conosciute a tutti attraverso organi di stampa pertanto il Festival corrente, 94° della cronologia, causa difficoltà economiche non presentava nessun nuovo allestimento. La Fondazione è commissariata da qualche mese e ha rischiato di essere messa in liquidazione coatta, in altre parole chiusura, azzeramento dei conti e licenziamento di tutti i dipendenti, duecento sessantaquattro lavoratori. Il commissario Carlo Fuortes, nominato dal ministro, ha trovato tra molteplici difficoltà, l’unica soluzione per evitava un simile epilogo: la riassunzione di tutti i dipendenti per dieci mesi annuali a termine e il ridimensionamento della produzione, così facendo è auspicabile che nell’arco di tre anni i conti torneranno in pareggio usufruendo anche della cosiddetta legge “Bray”. Dunque, il clima di questa “prima” areniana, l’evento più mondano cittadino, non era dei migliori e l’aria era significativamente palpabile. Tuttavia, la situazione creatasi a Verona non è certo dovuta al caso ma ha dei responsabili ben precisi dei quali non si parla, inoltre è a me ignoto come un Consiglio d’Amministrazione abbia potuto in passato approvare talune scelte non pertinenti senza battere ciglio o almeno porsi dei dubbi, non senza considerare che in Italia la responsabilità delle azioni in tali istituzioni non abbiano seguito giuridico poiché non si vogliono applicare le leggi, il risultato è che a farne le spese sono sempre i lavoratori, partendo da quelli che si trovano nella parte bassa dell’impianto strutturale. Vedere in occasione di questa prima volti che hanno contribuito allo sfascio di una delle più importanti Fondazioni italiane, il festival all’aperto più antico del mondo, permettetemi di dire che è stato urtante, un dignitoso celarsi sarebbe stato più opportuno. Ma torniamo alla nostra cronaca. L’allestimento di Franco Zeffirelli, regia e scene, è una rivisitazione del precedente spettacolo ideato nel 1995, più ristretto e contenuto considerando che la Sovrintendenza dei Beni Monumentali ha limitato l’utilizzo delle scenografie sulle gradinate. Trattasi di uno spettacolo che diventa brutta copia dell’originale, peraltro discutibile, ma ormai logoro, monotono e sorpassato, in parte di poca emozione. Da qualche tempo ci sono voci di pensionamento ma la decisione tarda ad arrivare. Oggi la regia è banale e i luoghi carmen 4comuni si sprecano, della Carmen originale resta ben poco sia come ambientazione sia come fascino, restano fortunatamente i bei costumi di Anna Anni e una presenza mastodontica di masse in palcoscenico. Poco funzionali anche le luci. Eliminato il balletto spagnolo di El Camborio, si è fatto tutto in casa con il Corpo di Ballo della Fondazione Arena, coordinato da Gaetano Petrosino, che si è ritagliato meritato e mirabile successo sulle identiche coreografie oggi riprese da Lucia Real. Sul podio abbiamo trovato il direttore cinese Xu Zhong, il quale l’avevamo conosciuto in un concerto non indimenticabile al Teatro Ristori la scorsa primavera. Zhong ha solo il pregio di tenere in riga orchestra e palcoscenico senza grossolane sbavature. Il resto è ordinaria routine, mancano accenti, colori, dinamiche e narrazione musicale. carmen 5L’orchestra dell’Arena segue ordinatamente il concertatore ma bisogna rilevare che l’opera è ormai di repertorio nell’anfiteatro e non ha fatto fatica a esprimere professionalità. Buona la prova sai del Coro dell’Arena diretto da Vito Lombardi sia del Coro di Voci Bianche A.Li.Ve istruito da Paolo Facincani. Il cast scritturato per questa inaugurazione, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del Festival, non era certo dei migliori ma forse si deve considerare che vista la situazione sopra descritta i solisti sono stati scritturati con molto ritardo rispetto alla logica tempistica. Luciana D’Intino, Carmen, ha avuto modo di sfoggiare il suo mirabile timbro, tuttavia, ritengo che il ruolo non le sia mai stato particolarmente idoneo neppure in tempi passati, e oggi deve fare i conti con una voce ancora notevole ma in parte forzata in acuto, afona nel centro e spinta nel grave ove abusava di petto. Nel complesso si ammira l’artista, dopo lunghissima carriera, che riesce ancora a dare un valore a un canto elegante e un personaggio magari carmen 6impacciato ma mai volgare. Note molto più dolenti per Jorge De Léon, Don José, il quale manifestava gravi problemi d’intonazione e si spendeva in un canto stentoreo atto più far prevalere la potenza polmonare che un pertinente fraseggio e una personalità interpretativa. Migliori erano Ekaterina Bakanova, Micaela, corretta cantante e interprete anche se con voce molto flebile e fiati limitati, e Dalibor Jenis, Escamillo, baritono autorevole nel canto e capace di dare risalto a un torero elegante e sensuale. Le gitane Madina Karbeli, Frasquita, e Clarissa Leonardi, erano sufficientemente professionali, anche se la prima piuttosto stridula, ben amalgamati il Remendado di Paolo Antognetti e il Dancario di Gianfranco Montresor, tutti insieme hanno realizzato un buon quintetto nel secondo atto. Completavano la locandina il grossolano Zuniga di Gianluca Breda e il corretto Morales di Marcello Rosiello. Ottima performance dei ballerini solisti: Alessia Gelmetti, Teresa Strisciulli, Amaya Ugarteche, Evghenij Kurtsev e Antonio Russo, i quali assieme al corpo di ballo hanno danzato un passo da l’Arlesienne di Bizet al IV atto. Anfiteatro gremitissimo, anche se non esaurito, e successo convinto per tutti al termine.
CARMEN [William Fratti] Torino, 26 giugno 2016.
Considerato uno dei direttori wagneriani più raffinati dei nostri tempi, Asher Fisch non ha disatteso le forti aspettative del pubblico torinese. L’accento drammatico con cui ha intriso la partitura di Carmen, anche nel mezzo degli elementi più folcloristici, ha decisamente colpito nel segno, risultando intenso, vibrante e particolarmente emozionante. Gli archi con cui ha aperto l’opera sono stati un chiaro biglietto da visita. I suoni puliti, mai sovrastanti, la scelta dei tempi e dei volumi, sapientemente usati per intensificare l’accento, hanno davvero entusiasmato tutto il pubblico. Purtroppo lo stesso non vale per lo spettacolo proveniente da Zurigo firmato da Matthias Hartmann e da una lunga squadra di collaboratori – Volker Hintermeier alle scene, Su Bühler ai costumi, Martin Gebhardt alle luci – che si sono prodigati nel mettere in scena il nulla. L’impianto scenografico è composto da una desolante pedana circolare in declivio e da pochissimi altri elementi, allestimento che avrebbe potuto sortire qualche effetto in una piazza di provincia durante una rappresentazione all’aperto. I costumi vintage sono pure tristi; la sola nota positiva è che hanno perlomeno un senso con la trasposizione voluta dal regista. Le luci funzionano, ma non sanno dare alcun tono di suggestione. La regia è pressoché inesistente: qualche movimento dei cori, qualche coreografia, il resto sembra uno spettacolo messo in piedi in giornata, con qualche prova al pomeriggio come fanno le compagnie itineranti. Anche le aspettative per il ritorno di Anna Caterina Antonacci erano molto alte, sfortunatamente superate solo in parte. La celebre artista ha classe da vendere e la sua raffinata interpretazione di Carmen è di ottimo gusto, seppur mancando di passionalità in alcuni momenti, come nell’aria “Près des remparts de Séville”. La voce invece non possiede più lo smalto di un tempo e numerosi sono i passaggi pressoché parlati piuttosto che cantati. Molto buona è la prova di Dmytro Popov nei panni di Don José, dotato di timbro leggero ben poggiato e saldo sulle note più basse. Ottima l’intonazione e molto buoni i pianissimi, rende molto bene la famosa “La fleur que tu m’avais jetée” col solo appunto di mancare nello stile italiano e francese del canto sul labbro, e si sente molto la gola. Irina Lungu piace sempre moltissimo al pubblico torinese, ma la sua Micaëla non è da considerarsi oltre la sufficienza. Così come lo scorso anno in Marguerite, pur cantando correttamente, manca di corposità: soprattutto l’aria di terzo atto, ancor più del duetto del primo, è troppo pesante e oltre le sue possibilità timbriche. Anche Vito Priante rende un Escamillo adeguato ed efficace, ma nulla di più. È corretto, ma poco brillante e parco nel fraseggio. La Frasquita di Anna Maria Sarra e la Mercédès di Lorena Scarlata Rizzo sono abbastanza musicali e ciò contribuisce positivamente alla buona resa del bel quintetto “Nous avons en tête un affaire”, ma entrambe le vocalità sono un po’ troppo flebili per lasciare un segno negli altri punti della partitura. Molto buono il contributo del Dancaïre di Paolo Maria Orecchia e del Remendado di Luca Casalin. Ottimo lo Zuniga di Luca Tittoto, che si vorrebbe udire in parti di maggior prestigio, mentre poco intonato è il Moralès di Emilio Marcucci.
AIDA [Lukas Franceschini] Verona, 3 luglio 2016.
La seconda opera al Festival all’Arena di Verona, come di consueto, è stata Aida di Giuseppe Verdi, nello storico allestimento con la regia di Gianfranco De Bosio e le scene ricavate dai bozzetti originali del 1913 di Ettore Fagiuoli. Su quest’Aida non mi pare ci sia molto da aggiungere a tutti gli elogi che giustamente ha raccolto fin dalla sua proposta nel lontano 1982. È un’Aida “classica” nel termine nobile della parola, che emoziona ancor oggi. Pochissimi i cambiamenti apportati da una regia ancora godibile e appropriata come si potrebbero immaginare nell’onirico pensiero di un mondo egiziano romanzato. Puntuale nei momenti d’assieme quest’allestimento di Aida merita un plauso incondizionato per l’aspetto di magnificenza che rappresenta in stile con gli spettacoli areniani di tempi addietro. La versatilità del cambio scena poggiato sulla mobilità di otto colonne è ancora funzionale e di grande effetto visivo. L’idea registica di utilizzare le spoglie gradinate con numerosissime comparse è frutto d’ingegno cui si deve la realizzazione a De Bosio, il quale supera brillantemente il duplice clima intimistico e spettacolare che aida 3compone l’opera. Tuttavia, sono la linearità e l’eleganza a colpire di questa messa in scena che resta tra le migliori e più gradite al pubblico e mi permetto di aggiungere anche alla critica. Unico neo è la realizzazione teatrale con tre lunghi intervalli, i quali potrebbero essere ridotti in un’unica interruzione magari adottando tecniche oggi più moderne. Ancora una volta porgiamo un plauso alle belle coreografie di Susanna Egri, ben realizzate dal Corpo di Ballo (purtroppo in dismissione) dell’Arena. Il versante musicale si è invece assestato su una classica routine un po’ troppo sotto le righe e gli standard che la Fondazione Arena meriterebbe. La bacchetta di Julian Kovatchev non brillava per particolare dinamismo ma si accomodava in una banale, sovente lenta e slegata concertazione poco indicativa e senza fraseggio. L’orchestra eseguiva da par suo con consolidata esperienza la partitura, ma istruita da tale bacchetta non dava il meglio, e proprio in questo titolo sappiamo che è capace di molto meglio. Il coro diretto da Vito Lombardi ha dimostrato buona professionalità, anche se è doveroso rilevare che nelle grandi pagine d’assieme del II atto si sono riscontrate alcune sfasature ma come predetto molto influenzate dalla direzione. L’unico cantante del cast che ha meritato un plauso incondizionato è stata la protagonista Hui He, la quale dimostrato ancora una volta ottima aderenza al ruolo, realizzato con voce bella, piena, uguale nei registri e un apprezzabile aida 5utilizzo delle mezzevoci. Evita, saggiamente, la puntatura del terzo atto, ma è piccola cosa a fronte di un canto pregevolissimo e di gran classe. Walter Fraccaro canta il suo Radames guerriero e impostato sulla potenza vocale, la quale non manca ma non è affiancata da un’eguale dinamica variegata nei colori e nel fraseggio. Tuttavia, il tenore è sicuro e preciso e nel presente una garanzia, al quale non è possibile chiedere finezze ricercate. Ildiko Komlosi, Amneris, segna chiaramente il passo alla lunga carriera e ormai le sue esibizioni possono essere classifica sulla difensiva utilizzando marcatamente suoni di petto eccessivi, riscontrando sovente problemi d’intonazione. Resta inalterata l’aderenza interpretativa al ruolo e una certa enfasi drammatica che il personaggio richiede, ma è cosa molto limitata. Buona la prova di Ambrogio Maestri, Amonasro, il quale ha sfoggiato la consueta potenza vocale ma non equilibrando una scansione di ricercato fraseggio. I due bassi Rafal Siweke e Carlo Cigni, disegnavano con professionalità rispettivamente Ramfis e il Re, anche se avrei preferito uno scambio di ruoli, essendo Cigni maggiormente forbito nel canto. Professionali il messaggero di Francesco Pittari e la sacerdotessa di Alice Marini. Applausi convinti al termine.
LA TRAVIATA [Lukas Franceschini] Verona, 5 luglio 2016.
Come annunciato l’Opera Festival all’Arena di Verona non avrà nessun nuovo allestimento, pertanto si è scelto di riproporre i migliori degli ultimi. È il caso de’ La Traviata di Giuseppe Verdi ideata da Hugo de Ana nel 2011. Allestimento in pieno classicismo fine secolo XIX realizzato in un’imponente scenografia composta di grandi cornici vuote, che raffigurano un ambiente decadente e in parte “falso” come il mondo vive e circonda Violetta. Il lussuoso ambiente è solo apparenza, pregiudizi e dogmi della classe sociale sono regole dalle quali non si può prescindere. Infatti, le cornici vuote di specchi e quadri potrebbero identificare il vuoto di una vita vissuta nella lussuria e che l’amaro destino non puà colmare una sorta di redenzione quando l’occasione si presenta. Spettacolo improntato sulla magnificenza, ricco di colore e luci, ma piccoli dettagli e una regia di alto livello non tralasciano il dramma borghese dei protagonisti. Non vi sono parole per descrivere la bellezza dei costumi, ideati come le scene dallo stesso de Ana. Grandi momenti d’effetto durante le due feste, con tanto di fuochi d’artificio in quella del secondo atto, cui si somma la bellissima prova del Corpo di Ballo che s’impegna nelle belle coreografie di Leda Lojodice.Sul podio dell’Arena debuttava, salvo errori, Jader Bignamini, direttore ormai conferma del panorama nazionale. La sua lettura è stata asciutta e ben calibrata nella scansione delle dinamiche, tuttavia si deve rilevare una generale sfasatura tra buca e palcoscenico, probabilmente dovuta alla scarsa esperienza nell’anfiteatro, e una generale lentezza nei tempi, magari rifiniti, ma poco teatrali. Il coro diretto da Vito Lombardi esegue con insolita ruotine il suo compito. Discreta la performance di Nino Machaidze la quale non ha particolare attrattiva nella zona centrale e il duetto con Germont ne risente. Più a suo agio, anche se non nitidissima nei passi d’agilità e stranamente per accento drammatico nella parte conclusiva. Francesco Demuro non trova in Alfredo un personaggio ideale per la sua tara vocale, la quale è sovente messa in difficoltà nel settore acuto ma anche nella proiezione vocale la quale è malferma. Meglio il Germont di Gabriele Viviani, il quale avrebbe dalla sua una voce rilevante ma poco duttile e sovente spreca le sue risorse in fraseggi banali e colori opachi, ma il personaggio nel complesso è contrato. Molto bravi gli interpreti secondari, i quali seppur in brevi passi e grande presenza scenica danno lustro allo spettacolo. Molto efficaci la Flora di Clarissa Leonardi, il Gastone di Paolo Antognetti e il Marchese di Romano da Zovo, ai quali si trav 6sommano le prove positive di Alessio Verna (Barone), Paolo Battaglia (Grenvil), Madina Karbeli (Annina), Cristiano Olivieri (Giuseppe) e Victor Garcia Sierra (domestico e commissinario). Anfiteatro abbastanza gremito per una recita infrasettimanale di luglio con un pubblico molto entusiasta e generoso negli applausi finali.
SIMON BOCCANEGRA [Lukas Franceschini] Milano, 8 luglio 2016.
L’ultima opera in cartellone al Teatro alla Scala, prima della pausa estiva, è stata Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi nell’allestimento di Federico Tiezzi del 2010. Simon Boccanegra è opera mai uscita dal repertorio alla Scala anche se ripresa con intervalli decennali, tuttavia sarà la celeberrima edizione Abbado/Strehler a fare storia e avere una significativa presenza e rivalutazione dello spartito dal 1971 al 1982. Nel periodo in cui Daniel Barenboim fu direttore musicale, si programmò una nuova produzione la quale fu coprodotta con la Staatsoper di Berlino, altro teatro ove egli era direttore stabile. La produzione di Federico Tiezzi (oggi ripresa da Lorenza Cantini) con scene di Pier Paolo Bisleri e costumi di Giovanna Buzzi, si colloca nel solco della tradizione ma con buon effetto teatrale e lineare concezione drammaturgica. Molto belle le scene di Bisleri che non ricalca scorci genovesi ma trova efficacia nella sghemba visione della città marinara e sontuosità nelle scene interne ricche di magnificenza. Spettacolari i costumi della Buzzi per cromatismi e sfarzosa ricchezza sartoriale. La regia di Tiezzi non scava particolarmente nei drammi dei personaggi ad eccezione del protagonista, al quale segna una particolare irruenza nel prologo, appropriata incisività di potere in seguito accomunata da paterno sentimento e debolezza umana nel finale. Lettura appropriata e anche di stile che si vede con piacere senza trovare innovazioni ma neppure deliri cui siamo abituati dalle odierne regie. Il vero trionfatore di questa ripresa è stato il direttore Myung-Whun Chung, bacchetta che conosciamo da tempo e che ogni volta ascoltiamo con grande piacere. La sua lettura scava in maniera minuziosa nello spartito verdiano, scardinando tutte le dinamiche più variegate. Memorabili sono i passi intimistici del primo atto, ricchi di morbidezze e grandi sfumature dei recitativi. Ancora, la grande scena del consiglio è truce e incisiva ma altrettanto efficace è la concezione generale impostata su suoni timbrati, variegati e di grande senso teatrale. Per raggiungere tali vette il direttore ha avuto a disposizione un’orchestra di rilievo assoluto, precisa, attenta, e in forma smagliante confermandosi eccellenza a livello internazionale. Lo stesso si può affermare per il coro, istruito dal bravo Bruno Casoni, puntuale e di emozionante ammirazione professionale. Per Simon Boccanegra è d’obbligo un protagonista di statura, considerata la “nuova” carriera di Placido Domingo per la Scala, è stata d’obbligo la scelta accumunata in alternanza con Leo Nucci, altro “vero” baritono anche se in fase conclusiva di carriera. Su Domingo baritono ho già espresso le mie opinioni in altre occasioni, sinteticamente le ripeto. Non è per niente un baritono, ma un tenore con lunga carriera che marca il passo e il tempo. Anche in quest’occasione si riconfermano, tuttavia pur rilevando che i fiati sono sempre più corti e il canto forzato, l’attore è di grande fascino e impatto teatrale, ma è troppo poco per considerare queste performance memorabili, anzi ci si domanda spesso il significato. Ben diversa la prova di Krassimira Stoyanova, la quale passa con molta facilità dalla Marescialla straussiana all’Amelia verdiana e questo è gran pregio. La cantante è molto precisa, ben impostata con un’emissione stilizzata, ottimo utilizzo del fraseggio e dei piani ma altrettanto capace di slanci passionali amorosi e drammatici. Una prova sicuramente lodevole. Il Fiesco di Dmitry Belosselskiy s’impone per una voce molto importante e di autentico vero basso profondo. Purtroppo la tecnica è sommaria, i colori mediocri e il fraseggio latente. Peccato. Molto buona la prova di Giorgio Berrugi, anzi mi permetto di dire la miglior prova finora da me ascoltata. Tenore dotato di bella voce, slanciata, ben amalgamata nei registri che gli permette di realizzare un efficace Gabriele Adorno soprattutto nella zona acuta. Magnifica la performance di Massimo Cavalletti che disegna un Paolo Albani di tutto rispetto sia sotto l’aspetto teatrale sia canoro, utilizzando una voce potente e solida affiancata da un fraseggio molto pertinente. Completavano la locandina il bravo Ernesto Pannariello (Pietro) e i professionali Luigi Albani (capitano) e Barbara Lavarian (ancella). Successo trionfale al termine con ovazioni per Domingo e Chung.
MIRANDOLINA [Lukas Franceschini] Venezia, 12 luglio 2016.
Il Teatro La Fenice offre quale ultimo spettacolo estivo una preziosa rarità, l’opera comica Mirandolina del compositore ceco Bohuslav Martinů, in una nuova produzione curata da Gianmaria Aliverta. Martinů nacque nel 1890 in una famiglia di umili origini ma dimostrò sin dai primi anni di vita il suo talento musicale, studio violino dall’età di 8 anni. Si scrisse ai corsi di composizione del Conservatorio di Praga, ma ne fu espulso due volte per motivi disciplinari; si appassionò in seguito alla letteratura e al teatro. Dopo un periodo nel quale fu secondo violino nell’Orchestra Filarmonica vinse ad una borsa di studio e nel 1923 si traferì a Parigi dove studiò con Albert Roussel. Ebbe occasione di conoscere Igor Stravinskij e Arthur Honegger, sviluppando un grande interesse verso le idee dei poeti surrealisti. Lasciata la Francia a causa degli eventi bellici si trasferì negli Stati Uniti dove insegnò all’Università di Princeton. Dopo la guerra riprese i contatti con l’Europa e la natia patria ma gli avvenimenti del 1948 lo indussero a restare negli Stati Uniti dove ottenne la cittadinanza. Si trasferì poi a Nizza e Basilea, morì nel 1959 per un cancro allo stomaco. La maggior parte delle sue composizioni nel periodo compreso fra il 1930 e il 1950 possono essere definite in stile neoclassico, ma nei suoi ultimi lavori iniziò a includere cenni rapsodici e un senso della forma più sciolto e spontaneo, che determinano la sua qualità migliore che consiste nella semplicità quasi infantile, non priva di un virtuosismo di grande eleganza. È il caso specifico dell’opera Mirandolina, tratta dalla commedia La Locandiera di Carlo Goldoni. Del testo goldoniano nell’opera di Martinů non resta quasi nulla se non il filo conduttore dei personaggi, ma qui molto limitati rispetto all’originale. Le intenzioni del compositore erano di avvicinarsi alla Commedia dell’arte, escludendo a priori il settecento. Il libretto, scritto da lui stesso, è il tallone d’Achille del lavoro, poiché la scarsa dimestichezza con la lingua italiana rende il testo sovente pesante e ripetitivo, con errori palesi. Inoltre, Mirandolina non è una vera e propria opera comica, bensì un intreccio di commedia che sovente parafrasa un genere cinematografico degli anni ’50 ma non arriva allo spessore intrinseco del testo goldoniano. La musica, non delle migliori composte, è intrisa di tradizioni ceche, di ritmi moravi e di una comicità tipicamente ceca. Lo stile italiano è appena accennato, la melodia ininfluente, il dialogo rasenta il Singspiel, e molte scene rimandano proprio allo stile est-europeo, mancando in parte in arguzia e sentimento che invece, credo, avrebbero reso la partitura più vibrante. Ma è doveroso aggiungere che il compositore non voleva fare un’opera in tale stile, si concentrò sulla modernità del linguaggio musicale, sarebbe un errore pertanto ritrovare in Miradolina uno stile italiano, ma conoscendo Goldoni è abbastanza difficile non fare dei paralleli. Occasione meritevole di ascolto quella veneziana, ma non certo di memorabile ricordo, di un compositore che meriterebbe più frequenza nei programmi concertistici. La nuova produzione della Fenice puntava sul giovane regista Gianmaria Aliverta, il quale è innegabile sia uno dei più interessanti e innovatori artisti della nuova generazione. Egli prendendo spunto che l’opera si distacca completamente dal ‘700 ha voluto trasportare la vicenda in epoca moderna. Avrebbe avuto più efficacia e originalità un’ambientazione fine anni ’50, epoca in cui fu rappresentata l’opera al Teatro Smetana di Praga. Invece l’ambientazione è in una beauty-farm odierna che potrebbe essere anche interessante, ma la scarsa fantasia registica non trova cenno una parodia frizzante e narrativa anche sottile, che sfocia invece nella triviale farsa paesana, immediata la citazione con film pecorecci della commedia italiana di serie B anni ’70, con stereotipi talvolta imbarazzanti e sbagliati. Tuttavia segue un filo narrativo lineare ma non lascia traccia e non entusiasma. Forse tale visione era voluta considerando i costumi kitsch di Carlos Tieppo, al quale sarebbe consigliabile qualche accortezza prima di spogliare in scena alcuni cantanti. La scena mobile di Massimo Checchetto era funzionale ma sommariamente spoglia e non creava effetti particolari di un ambiente lussuoso oggi molto frequentato Il fatto che la Fenice impieghi personale interno per una nuova produzione, la dice lunga sui temi del risparmio. John Axelrod è concertatore molto prezioso, ha scavato nella partitura le molte miniature dinamiche e sonore, accentuando forse con enfatica sonorità che seppur pertinenti sarebbero dovute essere più calmierate. Più convincente sul versante lirico, ben supportato da una buona orchestra. Silvia Frigato, la protagonista, si disimpegnava con efficacia ma mancava di mordente, anche se il fraseggio era abbastanza curato. Molto meglio il Fabrizio di Leonardo Cortellazzi precisissimo nel canto, dotato di voce bella e ben amministrata, oltre ad essere un convincente attore. Omar Montanari sfodera tutta la sua bravura nel ruolo del Cavaliere, accento, vocalità e vis teatrale molto rilevanti. Bruno Taddia interpreta un Marchese simpaticissimo e ben cantato, Marcello Nardis è leggermente inferiore nella vocalità ma buon attore. Simpatiche ma troppo caricate nella recitazione le brave Giulia Della Peruta e Laura Verrecchia rispettivamente Ortensia e Deinara. Divertentissimo il servitore del cavaliere interpretato da Christian Collia. Teatro quasi esaurito e molti applausi al termine per tutta la compagnia.
NABUCCO [Simone Ricci] Roma, 30 luglio 2016.
La stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma è stata impreziosita da un nuovo allestimento del celebre primo trionfo di Giuseppe Verdi. Oh mia Roma sì bella e perduta: è quasi spontaneo parafrasare uno dei principali versi del Va pensiero (come successe anche nell’Italia risorgimentale) per descrivere il “Nabucco” allestito dal Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla per la stagione estiva 2016. Il fascino antico di una città che non c’è più ha fatto da sfondo ideale al primo vero successo di Giuseppe Verdi, ambientato in questo caso tra macerie non meglio precisate che potevano pensare alle città della Siria o dell’Iraq dei giorni nostri. L’aggiunta di transenne di ferro ha suggerito però l’idea di un cantiere abbandonato, come purtroppo ce ne sono molti oggi nella Capitale. Questa recensione si riferisce alla replica di sabato 30 luglio. La regia di Federico Grazzini non ha esagerato con le forzature troppo moderne, anche se ha peccato di una eccessiva staticità in diverse scene, un dettaglio che avrebbe aggiunto maggiore drammaticità al racconto. Quello che è rimasto delle Terme di Caracalla ha sicuramente aiutato, il fumo che si levava verso il cielo ha contribuito a rendere l’atmosfera più magica. Molto interessante è stata la scelta dei costumi, curati da Valeria Donata Bettella, in particolare quelli dell’esercito di Nabucco: le armature potevano sembrare moderne, ma non mancavano i richiami all’antico. Di grande impatto visivo sono state le proiezioni sulle stesse rovine romane, tra tutte la colonna di teschi umani, inquietante ed evocativa allo stesso tempo. La voce e i “panni” del protagonista del titolo erano affidati a Sebastian Catana, baritono romeno di volume vocale apprezzabile: magari non era perfetto dal punto di vista scenico, ma è stato intenso nelle arie più toccanti del suo personaggio, in primis Dio di Giuda, aria esplorata con doveroso rispetto e coinvolgendo il pubblico romano. Raffaella Angeletti ha tratteggiato una Abigaille dalla buona elasticità nella coloratura e nei passaggi di sbalzo: c’è stata qualche timidezza negli acuti nel corso del primo atto, ma Su me…morente…esanime è stata cantata in modo convincente. Vitalij Kowaljow non aveva dato il 100% nelle recite precedenti, in questo caso si è dimostrato uno Zaccaria in grado di gestire con attenzione le note gravi: il suo canto era sicuro e pulito in Come notte a sol fulgente e la recitazione è stata una delle migliori in assoluto del cast. Anche la Fenena di Alisa Kolosova merita un voto positivo. Il ruolo ibrido creato da Verdi per quest’opera richiede proprio i colori e le intonazioni che ha offerto durante la recita: Oh! Dischiuso è il firmamento ha commosso gli spettatori per qualità tecnica e compostezza. Antonio Corianò ha disegnato un Ismaele sufficientemente credibile, anche se sarebbe stato apprezzato un numero maggiore di sfumature di fraseggio. Nello specifico, era difficile credere che fosse realmente spaventato dalla maledizione dei Leviti. Il cast vocale era completato da Alessio Cacciamani, Gran Sacerdote di Belo inflessibile e presentato nelle vesti di un combattente moderno; Pietro Picone, un Abdallo corretto; Simge Büyükedes, precisa e attenta nel ruolo di Anna. La direzione di John Fiore mancava in alcuni tratti della sfrontatezza giovanile che Verdi ha saputo trasmettere in quest’opera. Il preludio era il momento migliore per scatenare le sonorità più agguerrite, ma si è preferito puntare su una lettura dalle caratteristiche accorte e trattenute. I suoni che sono emersi in maniera realmente nitida sono stati invece quelli delle arie “sofferenti”, quasi a voler sottolineare la psicologia complessa dei personaggi piuttosto che l’impeto risorgimentale del primo trionfo verdiano. Il coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto come di consueto da Roberto Gabbiani, si è dimostrato professionale e preciso, conquistando anche un bis dopo l’esecuzione del pezzo più famoso dell’opera, il già citato Va pensiero. Francamente non condivido queste richieste estemporanee del pubblico: fino a quel momento gli applausi erano stati tiepidi (nonostante il fresco del ponentino romano che è così tipico della stagione estiva del Teatro Costanzi) e poco convinti, soprattutto dopo i finali delle prime due parti, ma improvvisamente il brano più celebre ha risvegliato tutti, quasi fossero in attesa soltanto di quel momento. Fiore ha concesso il bis, replicando anche l’ultima nota eccessivamente lunga. Buona è stata anche la fattura di È l’Assiria una regina. Al termine dello spettacolo il gradimento è stato discreto, con le ovazioni principali che sono state indirizzate a Catana e Angeletti.
I CAPULETI E I MONTECCHI [Lukas Franceschini] Padova 31 luglio 2016.
La stagione Lirica del Teatro Verdi di Padova è iniziata con un’anteprima estiva al Castello dei Carraresi, dove è stata allestita l’opera I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, la quale sarà replicata successivamente a Bassano del Grappa. Per la prima volta l’estate operistica padovana è ospitata nell’antica piazza d’armi del Castello dei Carraresi, il quale in fase di restaurazione necessita ancora molti lavori per essere locazione adatta a uno spettacolo lirico. Inoltre anche la platea e la tribuna romeo 3avrebbero bisogno di maggiore cura. Si è avuta l’impressione di molta approssimazione nell’organizzazione, non riscontrabile al Teatro Verdi, poiché durante l’esecuzione era un continuo andirivieni di fotografi, tecnici, e anche taluni spettatori si accomodavano a spettacolo iniziato. E’ scontato che uno spettacolo all’aperto non può avere la stessa atmosfera del teatro, tuttavia più accortezza non sarebbe guastata, speriamo che il prossimo anno saranno risolte queste malfunzioni. Lo spettacolo è stato affidato nella sua interezza, regia, scene, costumi e luci a Paolo Giani, il quale ha avuto grandi problemi per creare una cornice scenografica nel grande spazio all’aperto con un vasto palcoscenico senza delimitazioni di quinte. L’effetto era notevolmente spoglio, l’unico elemento era un busto con testa mozzata, la quale era a terra dalla parte opposta, la cifra di lettura non è chiara ma non disturbava. Non abbiamo visto una ricerca particolare nella drammaturgia, il solo Romeo aveva dei tratti romeo 4teatrali, Giulietta immobile e statica, il coro si esibiva in una continua processione anche nella parte posteriore del Castello, ma senza grandi effetti. I costumi erano banali e tutti simili, le luci accettabili. Per creare un po’ d’effetto si è utilizzato un gruppo di ragazzi allievi forse di qualche scuola di scherma, ma anche questa trovata lasciava perplessi, troppa mimica inutile. L’Orchestra di Padova e del Veneto è in continua crescita e l’amalgama generale e la buona impostazione sonora dell’insieme sono evidenti, purtroppo il direttore Andrea Albertin non ha sfruttato tali potenzialità anzi la sua concertazione era oltremisura lentissima, la quale ha reso non solo l’opera soporifera e noiosa, ma ha messo in evidente difficoltà pure i solisti. Note non positive anche per il Coro, diretto da Dino Zambello, sovente sfasato e in molte occasioni non intonato. Del cast l’unica ad esprimere un’onesta professionalità è stata Annalisa Stroppa, un Romeo molto appassionato e di buona tempra vocale con buon uso di fraseggio e colori, peccato che la zona grave non sia particolarmente rifinita e incisiva, tuttavia la prova è stata positiva. Ekaterina Sadovnikova, Giulietta, avrebbe una bella voce e anche uno stile appropriato, ma il canto è stato sempre scialbo e romeo 5monotono, assenza totale di colore ed interpretazione che hanno reso la sua performance noiosa e di routine. Abbastanza appropriato il Tebaldo di Giordano Lucà, svettante nel settore acuto ma poco preciso nel passaggio, tuttavia da risentire in un differente contesto. Non lasciano traccia il Lorenzo di Matteo D’Apolito e il Capellio di Daniel De Vicente.Al termine di una lunghissima esecuzione il pubblico, accorso tutto sommato numeroso, ha premiato tutta la compagnia con convinti applausi.
IL TROVATORE [Lukas Franceschini] Verona, 10 agosto 2016.
Il quinto titolo del Festival all’Arena di Verona è stato Il Trovatore di Giuseppe Verdi, ripresa del celebre spettacolo di Franco Zeffirelli creato nel 2001. Quest’allestimento è probabilmente il migliore che il regista toscano ha realizzato per l’Arena. Un impianto quasi fisso con una grande torre al centro, e due monumentali guerrieri speculari ai lati, palcoscenico roccioso, grande effetto di luce notturna, e soprattutto cambio scena rapissimo, l’opera si rappresenta di due parti. L’aspetto scenografico è grandioso e spettacolare, ancor più incisivo quando al secondo atto la torre si apre trasformandosi in chiesa per l’entrata in convento di Leonora. Tratto registico tradizionale ma con buoni spunti, costumi di gran pregio di Raimonda Caetani e una coreografia stilizzata di El Camborio. Un classico spettacolo da Arena, imponente e di grande effetto visivo, la cui drammaturgia è assolta bene pur con qualche libertà. Infatti, com’è uso di Zeffirelli, l’esagerazione si può riscontrare nella scena finale del secondo atto, nella quale le suore che accompagnano una dama di compagnia di una principessa in convento sono numerosissime, sarebbero state eccessive anche per una regina, lo stesso dicasi per il corteo di frati nel “Miserere”, o per i gitani dell’accampamento. Ma sono piccole chiose e il palcoscenico è grande, tutto sommato ci può stare. Rilevante su tutto la mano dello scenografo (sempre Zeffirelli) che prevale notevolmente sul regista, una mano che appaga i desideri del pubblico, il quale gradisce applaudendo. Sul podio abbiamo ritrovato con piacere il maestro Daniel Oren, il quale ha concertato con sapiente professionalità, traendo dalla buona orchestra colori appropriati e un respiro narrativo rilevante. Elegiache le parti romantiche, sostenute nel ritmo quelle di tensione, sempre in un buon equilibrio di suono. Discutibile invece la scelta di eliminare tutti i da capo, e l’inserimento nel II e III atto di alcuni stralci del balletto (composto per Parigi da Verdi). Buona la prova del coro, per uniformità e compattezza, diretto da Vito Lombardo. Il cast scritturato per le poche recite previste, era sulla carta molto allettante ma alla fine è risultato deludente. Marco Berti, Manrico, canta il ruolo come tutti gli altri che interpreta. Non ci sono traccia di accento, colore, fraseggio. Trattasi di una prova sempre basata sulla forza e l’impeto, che risulta monotona e ormai stentorea, gravata in taluni casi da qualche problema d’intonazione. Devo rilevare che comunque è un cantante sicuro, che va per la sua strada e arriva al termine, ma senza lasciare particolari tracce. Grande delusione ci ha riservato il soprano Hui He, Leonora, la quale accusava evidenti problemi di fiato e nel registro acuto. Sono purtroppo passati i bei dì della cantante che in possesso di un mezzo vocale di grande valore riempiva l’Arena con suoni dolci, lunghi filati e una sicurezza nelle agilità tanto da porsi come una delle migliori in questo repertorio. Oggi la voce è molto indurita e ridotta notevolmente in acuto, dovuto sicuramente alla scelta troppo pesante del repertorio, cui resta solo un accento gradevole e una contenuta espressività. Molto meglio gli altri due coprotagonisti. Dalibor Jenis disegna un con Conte di Luna aristocratico e fiero, usando i suoi mezzi con buona perizia tecnica e un ragguardevole accento, dimostrando una buona attitudine al canto legato e mai forzato. Azucena era Violeta Urmana, ritornata ultimamente al registro di mezzosoprano, che ho sempre preferito alle sue prestazioni sopranili. Anche in questo caso la lunga carriera e il passaggio di registro hanno contribuito a mettere dura prova una voce di classe superiore. Tuttavia l’accento era pertinente e l’utilizzo dei mezzi abbastanza appropriato. Molto a suo agio nel registro acuto, anche se il do era appena accennato, e ancora molto valida nel centro e nella zona grave, seppur con qualche abuso di petto. Nel complesso una buona prova cui va sommata una non comune arte scenica. Di assoluta routine il Ferrando di Sergey Artamonov. Buoni Elena Borin, Ines, Antonello Ceron, Ruiz, e Cristiano Olivieri, un messo, inappropriato il trov 6vecchio zingaro di Victor Garcia Sierra. Fa molto pensare vedere un’Arena semivuota per un titolo di grande repertorio come Il Trovatore, le risposte forse ci sono ma le prime osservazioni che vengono alla mente sono i prezzi troppo altri e l’assenza di promozione. Purtroppo l’opera non è terminata per un temporale, mancavano solo una decina di minuti al termine.
IL MATRIMONIO SEGRETO [Lukas Franceschini] Innsbruck, 12 agosto 2016.
Il celebre festival della città austriaca è giunto quest’anno alla 40ª edizione. Innsburcker Festwochen der Alten Musik ha scelto come motto per il 2016 “Tragicomedia” presentando come primo spettacolo operistico il capolavoro di Domenico Cimarosa Il matrimonio Segreto. L’opera è un dramma giocoso su libretto di Giovanni Bertati, il quale lo trasse dalla commedia The clandestine Marriage di George Colman The Elder e David Garrick del 1766 eseguita al Drury Lane Theatre di Londra. La prima esecuzione assoluta fu il 7 febbraio 1792 al Burgtheater di Vienna, con Dorothea Sardi-Bussani (Fidalma) e Francesco Benucci (Conte Robinson). Il successo durante l’esecuzione fu trionfale, il pubblico applaudì con entusiasmo il lavoro di Cimarosa e chiese numeri bis. Ma al termine dell’opera avvenne un fatto mai accaduto nella storia del teatro musicale: il bis dell’opera intera. Infatti, all’imperatore Leopoldo II, sovrano che paradossalmente non aveva particolari interessi per la musica, il lavoro piacque così tanto che decise di farlo matrimonio 2replicare subito dopo una cena alla quale invitò l’intero cast. Il trionfo non fu solo viennese, l’opera suscitò grandissimi entusiasmi ovunque rimanendo fino a pochi anni fa nei palinsesti dei maggiori teatri lirici di tutto il mondo ed è considerata un’opera viva, carica di freschezza e una delle opere buffe per eccellenza, restando da sempre nel repertorio dei grandi cantanti di tutti i tempi. Altra curiosità fu che per il Congresso di Verona del 1822 è andata in scena in forma privata negli appartamenti dell’imperatore d’Austria a Verona con Isabella Colbran, Verger, Antonio Tamburini e Filippo Galli. L’opera fu il titolo scelto per inaugurare il Teatro “Piccola Scala” nel 1955. Il libretto è una situazione ideale per giocare su un tessuto “ricamato”, quasi in punta di piedi, crescendi frenati che restano sospesi nel linguaggio musicale, brillanti forte-piano improvvisati. La musica che alterna sereni cantabili, arie maliziose, duetti esilaranti, comune denominatore della scuola napoletana dell’opera buffa. I fatti sono drammatici, la freschezza musicale (ancor oggi percepibile) e il senso di happy-end che s’instaura nell’ascoltatore, porta il pubblico a immedesimarsi nella giocosità e in parte nel vivere di prima persona le caratteristiche dei personaggi, cui la musica fornisce un tappeto di rilevanza assoluta per manifestare sentimenti e situazioni buffe. Il successo, del quale ho detto sopra, resterà inalterato per oltre due secoli, purtroppo negli ultimi tempi l’opera non è da considerarsi di repertorio, questa è una grave ammenda che bisogna fare ai direttori artistici, il Festival di Innsbruck ha in parte posto rimedio a un’assenza ingiustificata. Il nuovo spettacolo al Festwochen è stato ideato da Renaud Doucet, assieme al costumista e scenografo André Barbe. Il regista ha ideato una drammaturgia fantastica, mi permetto di dire quasi disneyana, ambientando l’opera in un pollaio, i cui protagonisti evocano sotto taluni aspetti il verso degli animali. In effetti, è vero che l’intrigo di tre donne che cercano il loro sposo e si scontrano per questi in un intricato guazzabuglio porta alla memoria di liti “da pollaio”. Ma la genialità del regista è stata quella di non scendere cosi grettamente nel mondo animale ma fermarsi su un brillantissimo equilibrio tra genere umano e animale, al quale i cantanti facevano qualche movenza per ricordare situazioni divertentissime. Tutto questo ispirandosi alla grande tradizione dell’opera buffa, con gags divertenti senza eccedere nella bieca macchietta. Una visione che ci ha conquistato e divertito per l’originalità e la simpatica concezione. A questa magnifica idea ha contribuito il bravissimo André Barbe che ha disegnato una scena unica d’ispirazione favolistica, e sbizzarrendosi in costumi originalissimi, in matrimonio 3stile settecentesco, con leggere pennellate che si rifacevano a un’ironia molto pertinente sia del mondo animale sia del ‘700 stesso. Alessandro De Marchi a capo dell’Orchestra Montis Regalis si conferma uno specialista del genere. La sua concertazione è stata vivace, brillante con tutte le incursioni nei momenti patetici. Egli coglie appieno lo stile dell’opera, sapendo come estrarre dall’ottima orchestra, suoni precisi, colori vivissimi, dinamiche calibrate, accomunate a una sapiente e superlativa narrazione musicale. L’opera è stata eseguita integralmente e senza tagli, e il maestro ha saputo con energia e grande senso teatrale trascinare il pubblico nelle oltre tre ore di musica con innato coinvolgimento. Il cast nel suo insieme rappresentava un equilibrio di alto livello, creando un unicum molto apprezzabile. Due fuoriclasse come Renato Girolami, Conte Robinson, e Donato Di Stefano, Geronimo, avevano man bassa per far emergere i rispettivi personaggi con grande classe e verve teatrale ragguardevole. Questo avveniva senza eccedere in un canto macchiettistico, ma reggendosi su una grande scuola di cantanti buffi, variegati, istrionici e di classe. Molto positiva la prova degli sposini “segreti”. Giulia Semenzato, Carolina, ha brillato per una linea di canto non comune e capace di essere frizzante nei momenti richiesti. Lei è una cantante che trovo in continua ascesa e l’augurio è di ritrovarla spesso sui nostri palcoscenici. Il Paolino di Jesus Alvarez era correttamente controllato, in un canto elegiaco e amoroso di ottima fattura. Non da meno sono state le due zitelle Klara Ek, Elisetta, e Loriana Castellano, Fidalma. La prima ha avuto un’azzeccata presenza scenica e una professionale prova vocale di rifinito accento. La seconda, che sostituiva una collega infortunata forse all’ultimo, ha dato un tangibile segno di eleganza interpretativa, accumunata a un’interpretazione musicale, forse contenuta, ma di pregio artistico. Una recita molto divertente, brillante e spassosa, cui giustamente il pubblico che gremiva il Landestheater ha decretato un autentico successo trionfale.
OTELLO [Simone Ricci] Macerata, 13 agosto 2016.
Il titolo verdiano era una delle scelte della cinquantaduesima edizione dello Sferisterio Opera Festival, incentrato sul Mediterraneo. Otello fu…un trionfo. La cinquantaduesima stagione dello Sferisterio Opera Festival di Macerata ha avuto una delle sue punte di diamante proprio nel titolo verdiano, messo in scena con un cast di primo ordine e con scelte registiche interessanti. Questa recensione si riferisce alla terza e ultima replica dei quattro atti su libretto di Arrigo Boito, una serata caratterizzata da applausi scroscianti e convincenti per tutti. L’edizione 2016 del festival marchigiano aveva come tema principale il Mediterraneo e si è deciso dunque di puntare sul Moro di Venezia, non solo simbolo di gelosia ma anche di conflitto etnico. La regia di Paco Azorin – una coproduzione di Macerata Opera e Festival Castell de Peralada – era dominata da tre pannelli giganti che venivano spostati di continuo. Non poteva certo mancare il Leone di Venezia, mentre sulla parete di fondo si ammiravano i ritratti di Verdi e Shakespeare e alcuni sonetti del bardo tra un atto e l’altro. Azorin è stato piuttosto rispettoso del libretto e della trama, senza eccessive forzature: la soluzione degli “sgherri” che accompagnavano di continuo Jago (sorta di spiriti invisibili ai protagonisti) è stata intrigante e rafforzava i lati misteriosi dell’opera. A onore del vero, forse poteva essere evitato il soffocamento provocato da una di queste figure agili e atletiche ai danni di Desdemona, visto che a Otello veniva lasciato il resto del “lavoro” con un cuscino. Tutti i cantanti sono stati accolti con grande entusiasmo dal numeroso pubblico maceratese. Le ovazioni più forti non potevano che essere tributate ai tre personaggi principali. Jessica Nuccio ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta: la sua bella voce, ampia, timbrata e con accenti sempre adeguati, ha dato il meglio di sé nella “Canzone del salice” con un gioco davvero incredibile di pianissimi, mentre la presenza scenica è stata costantemente piena di fascino. È apparsa emozionata di fronte agli applausi degli spettatori, ma è stato un tributo più che meritato. “Jago” era il titolo originale dell’opera di Verdi e Roberto Frontali ci ha fatto capire perché. Il baritono romano ha messo in evidenza il lato più viscido e abietto dell’alfiere di Otello, sottolineando quanta goduria gli procurassero le fragilità del Moro. L’organo vocale era compatto e solido, capace di aggiungere espressività a ogni accento. Frontali ha convinto soprattutto in Credo in un Dio crudel, vera e propria apoteosi artistica e musicale. Stuart Neill completava il terzetto delle ovazioni con il suo Otello ricco di sfaccettature. Non ha deciso di strafare con l’Esultate iniziale, a cui si è approcciato con la regalità che si addice a questo personaggio e con acuti misurati. Inoltre, ha aggiunto slancio e temperamento all’interpretazione; se si vuole trovare proprio il pelo nell’uovo ci sarebbe qualche pecca nella dizione, visto che alcune sillabe suonavano in maniera strana, un “difetto” che si può comunque perdonare in una serata del genere. Il Cassio di Davide Giusti era pieno dell’ingenuità e della baldanza del rivale di Otello, in questo caso la voce è sembrata appropriata e interessante nel corso del brindisi del primo atto. Il pubblico dello Sferisterio ha dimostrato di apprezzare anche Tamta Tarieli, mezzosoprano georgiano che ha tratteggiato una Emilia dolce, ma anche appassionata quando si è trattato di svelare le trame del marito Jago. Il cast era completato dal Roderigo baldanzoso di Manuel Pierattelli, il solenne e preciso Lodovico di Seung Pil Choi, il Montano adeguato e professionale di Giacomo Medici e l’araldo di Franco Di Girolamo. La direzione di Riccardo Frizza, guida sicura dell’Orchestra Regionale delle Marche, ha convinto fin dall’inizio con una lettura a tutto tondo del titolo verdiano. In particolare, è stata reso in tutta la sua drammaticità e potenza il finale del terzo atto. Il Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” è stato ben diretto da Carlo Morganti, una presenza fondamentale e alla continua ricerca di colori, sfumature e finezze che l’orchestra ha assecondato ogni volta. Non sono mancati gli applausi per il Coro di voci bianche “Pueri Cantores “Zamberletti” che ha reso in modo delicato e tenero il momento della presenza in scena di fanciulli e marinai. Oltre a Otello, titolo non frequente ma comunque caro a Macerata, sono stati proposti quest’anno “Norma” e “Il Trovatore” per una edizione matura e piena di spunti che hanno invitato a riflettere.
LA DONNA DEL LAGO [Lukas Franceschini] Pesaro, 5 agosto 2016.
Il Rossini Opera Festival 2016 è stato inaugurato all’Adriatic Arena con un nuovo allestimento de La donna del lago diretta da Michele Mariotti e Damiano Michieletto alla regia (prova generale). La donna del lago è un’opera lirica di Gioachino Rossini su libretto di Andrea Leone Tottola, il quale trasse il soggetto dal poema The Lady of the Lake di Walter Scott, pubblicato nel 1810. La prima rappresentazione fu al Teatro San Carlo di Napoli il 24 ottobre 1819, l’opera divenne molto famosa in Europa e anche in America, e divenne cavallo di battaglia dei più illustri cantanti dell’epoca, successivamente scomparve dai repertori dei teatri nella seconda metà del secolo. Rossini scrisse ai genitori che la sua nuova opera è un soggetto un po’ romantico ma gli pareva d’effetto, speranzoso in Dio che andrà bene. In effetti, il pubblico sulle prime restò perplesso, anche se il cast era stellare, decretò l’autentico successo solo alle ultime repliche. Quando Giacomo Leopardi assistette a una recita a Roma scrisse “… eseguita da voci sorprendenti è una cosa stupenda, e potrei piangere ancor io, se il dono delle lagrime non mi fosse sospeso, giacche m’avvedo pure non averlo perduto affatto…”. La donna del lago è uno dei titoli della grande riscoperta rossiniana operata del Rof fin dalla sua creazione. Per essere precisi vi donna 2furono in precedenza alcune proposte dello spartito, casi isolati in contesti di Festival (Maggio Musicale Fiorentino) o di significativi cantanti (Caballé alla Rai), ma bisognerà aspettare il II Rof nel 1981 per avere la prima edizione critica della partitura e un cast di riferimento, almeno per le due interpreti femminili, Lella Cuberli e Martine Dupuy, lo spettacolo era curato da Luca Ronconi con scene di Gae Aulenti (alla quale l’edizione odierna è dedicata). L’opera fu ripresa nel 1983 con altro cast e incisa per Fonit-Cetra, e possiamo affermare che in seguito La donna del lago è eseguita abbastanza regolarmente, allo stesso Rof siamo giunti oggi alla quarta edizione. Il nuovo spettacolo di Damiano Micheletto, regista tra più affermati e richiesti oggi, trova una chiave di lettura all’opposto del romantico, scavando tra i sentimenti di rinuncia e rimpianto. L’opera è rappresentata in flash-back, poiché all’inizio vediamo Elena e Malcom nella loro vecchiaia ricordare gli eventi remoti del loro amore, soprattutto la rinuncia di Elena ai sentimenti con Uberto e i trascorsi bellici di Malcom, si parla di rimpianto, di rinuncia, ma ipotetico perché non si può tornare indietro dicendo se gli eventi avessero avuto svolte differenti. Il regista scava dunque nel privato ipotizzando che non tutto è pura felicità, citando le parole finali di Elena. Una lettura anche pertinente ma l’aspetto visivo non è stato al pari. L’opera definita dallo stesso regista “umida” non trova corrispondenza in un libretto (forsanche strampalato) ma sicuramente romantico. Lo stesso romanticismo e la natura selvaggia del poema di Scott si riscontra in una scena fissa anche efficace, di Paolo Fantin, una casa ottocentesca diroccata e invasa da vegetazione lacustre, ma che alla lunga stanca per fissità. Seguendo poi la linea registica ho provato insofferenza per la continua presenza in scena degli alter-ego anziani dei protagonisti, cui va la lode teatrale trattandosi di Giusi Merli e Alessandro Baldinotti. Mai un cambio scena, ma una staticità incombente claustrofobica negli ambienti dimessi di un’abitazione che potrebbe rappresentare tutto e anche niente. Nel finale si ritorna alla scena iniziale in cui Elena ritorna “vecchia”, ma anche questa scelta seppur coerente avrebbe dovuto suggerire al regista che sarebbe stato opportuno non impegnare la protagonista in un cambio in scena proprio nel rondò finale. Il lago si può intuire dal folto canneto collocato dietro la maestosa struttura dell’abitazione, efficace ma non affascinante. Molto belli i costumi di Klaus Bruns che fanno notare una Scozia ruvida, ma leggermente bizzarro quello di Giacomo V, efficaci le luci di Alessandro Carletti, anche se per volontà di Michieletto sono sempre improntate sullo scuro. Michele Mariotti, ormai una presenza fissa al Rof, offre una lettura anche interessante ma con molte licenze personali. Doveroso rilevare che l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna è ben lontana oggi dai sui dorati giorni di anni addietro e si può ravvedere nel settore fiati. Mariotti segue una linea romantica in parte appropriata ma spesso sceglie tempi lenti e colori meccanici seguendo un suo concetto personale e poco attento al cast di cui disponeva. Anche il respiro orchestrale è parso troppo schematico, dove mancava lo slancio e gli effetti che una partitura così peculiare richiede, assolutamente discutibili i tempi eseguiti nel rondò finale con dei pianissimi appena percettibili. Non sono mancati però momenti molto belli come l’entrata di Rodrigo, il finale atto I e la grande scena del duetto poi terzetto del II atto diretto con molta incisività. È auspicabile che nelle recite le cose migliorino, soprattutto nei tempi. Il coro del Teatro Comunale, diretto da Andrea Faidutti, non emerge per compattezza dimostrando parecchie falle nell’intonazione e nelle sezioni maschili e femminili. Il Rof dovrebbe essere il fiore all’occhiello internazionale sulle proposte canore, tuttavia in tempi sterili deve attingere alla propria Accademia, scelta forse discutibile, forse appropriata, ma che pone molti dubbi. La protagonista Salome Jicia ha una voce molto interessante, brunita e ben amalgamata nei diversi settori. Regge con espressione e disinvoltura le agilità e si dimostra capace d’interpretazione vocale appropriata e variegata nell’accento e nel fraseggio. Alla recita donna 3cui ho assistito il momento meno significativo è stato il rondò finale, ma come detto in precedenza forse hanno contribuito regista e direttore a non rendere al meglio la pagina, anche in questo caso ci saranno mi auguro degli aggiustamenti. Juan Diego Florez ritorna al ruolo di Giacomo V/Uberto che ha segnato felicemente la sua carriera e i confronti si fanno solo con sé stesso. Un confronto che quest’anno perde per incisività, ma la gamma del settore acuto è ancora salda, la linea di canto esemplare e l’eleganza dello stile intatta. Inoltre inutile ripeterlo, anche se con qualche difetto, resta il migliore oggi in questo repertorio. Il Malcom di Varduhi Abrahamyan è soprano che si spaccia per mezzo poiché possiede un centro abbastanza corposo. Punta tutto sull’aspetto romantico del canto e ci riesce in parte, ma la zona grave è artefatta e spesso vuota, meglio il settore acuto in cui però la coloratura non brilla, raggiunge una modesta prestazione senza infamia senza lode. Molto meglio il Rodrigo di Michael Spyres che sfoggia ancora un’esuberanza vocale degna di plauso. La usa aria d’entrata è ben donna 4cantata, tolto qualche accento, il registro acuto saldo e molto fiorito nelle note estreme e infine possiamo affermare che il rapporto con l’altro tenore rende con merito lo stile dello spartito. Note dolenti, purtroppo, per Marko Mimica, Douglas, che pur avendo a disposizione un materiale di prim’ordine dimostra un’assenza totale di tecnica ed emissione, rendendo la sua aria una monotona sequenza di suoni duri e ingolati, e conferma le perplessità avute lo scorso anno nel ruolo del Podestà. Molto bravi le parti di secondarie, Ruth Iniesta, Albina, e Francisco Brito, Serano/Bertram, timbri solari e ben appropriati nei ruoli secondo lo spartito. Successo trionfale al termine.
LA DONNA DEL LAGO [William Fratti] Pesaro, 17 agosto 2016.
La prima opera romantica di Gioachino Rossini compie trentacinque incantevoli e vivissimi anni. Scomparsa dalle scene troppo presto all’epoca della sua composizione, ha ritrovato nuova vita “nella bellezza della sua originaria foggia, a Pesaro, il 16 settembre 1981, per la regia di Gae Aulenti e sotto la direzione musicale di Maurizio Pollini” con protagonisti: Lella Cuberli/ Elena, Philip Langridge/ Giacomo V, Martine Dupuy/ Malcom, David Kuebler/ Rodrigo. Da allora questo titolo è stato regolarmente messo in cartellone nei teatri più importanti del mondo, anche se non così spesso come si meriterebbe, entrando a far parte delle grandi opere serie rossiniane. Protagonista indiscusso di questa nuova produzione del ROF è Juan Diego Florez che torna ad interpretare il ruolo di Giacomo, uno dei suoi cavalli di battaglia, proprio in occasione del suo ventennale. È davvero difficile commentare una performance così intrisa di grazia, dove la classe lascia spazio solo alla passione, ad un fraseggio intriso di ardore, che mai abbandona lo stile del compositore. Tutto è al suo posto, dalla nota più alta a quella più bassa, dai filati raffinati della cavatina ai Do infuocati del terzetto. Lo accompagna un collega molto amato a Pesaro, soprattutto nelle parti bari tenorili: Michael Spyres è un ottimo Rodrigo ed entra in scena dispiegando perfettamente i suoi 10 minuti di terrore che altrimenti potrebbero essere fatti cantare da un contralto, un tenore e un basso. La sua linea di canto rossiniana è precisa tecnicamente come pure l’interpretazione. Il terzetto che comprende “il furibondo duello, condotto a suon di Do sovracuti” è una delle pagine più appassionanti della serata. Altra positiva riconferma è la bravissima Varduhi Abrahamyan, eccellente belcantista che veste i panni di Malcom al suoi debutto al ROF. L’uso delle colorature e dei fraseggi rossiniani è davvero pregevole, il tutto impreziosito da un timbro particolarmente brunito. L’aria di secondo atto è sinceramente toccante e d’effetto. Molto buona anche l’interpretazione di Marko Mimica nelle vesta di Duglas, decisamente più a suo agio che nel ruolo di Gottardo ne La gazza ladra della scorsa edizione. Adeguate pure le parti di contorno, con l’Albina di Ruth Iniesta e Serano/Bertram di Francisco Brito. Menzione a parte merita la protagonista Salome Jicia, plasmata e preparata ad hoc dal ROF per il debutto in questo ruolo particolarmente complesso. Già ai tempi della sua prima apparizione in Italia il soprano georgiana si presentava tecnicamente molto forte e indubbiamente Rossini le è entrato nell’anima e nelle corde grazie all’Accademia pesarese, con la conseguente partecipazione a Il viaggio a Reims, nonché il debutto in Semiramide sotto la guida di Albert Zedda. E a tale proposito occorre esprimersi in sincere approvazioni riguardo alla riuscita del rondò finale, momento intenso in cui sa catturare l’attenzione dalla prima all’ultima nota, tutte eseguite in maniera più che corretta. Per il resto è però da segnalare una certa durezza nella sua vocalità, che talvolta sfocia nell’asprezza e nella secchezza. Inoltre l’interpretazione, che necessiterebbe di un certo fare romantico intriso di metafore e astrazioni, non è delle più riuscite, risultando a tratti un poco monotona. Ad individuare magistralmente i caratteri ambigui, fantasiosi, indeterminati, ma allo stesso tempo fortemente circoscritti dalla storia e dalla mente umana, è lo spettacolo di Damiano Michieletto che produce una delle sue migliori trasposizioni, mettendo al centro della vicenda la vecchia Elena – magnificamente interpretata da Giusi Merli, accompagnata dal vecchio Malcom di Alessandro Baldinotti – che dopo tanti anni si trova ancora interiormente divisa dall’amore per Giacomo e Malcom, cui si aggiunge anche il ricordo di Rodrigo. Superlative le scene di Paolo Fantin, azzeccatissimi i costumi di Klaus Bruns, efficacissime le luci di Alessandro Carletti. L’esecuzione musicale perfetta la si deve alla bacchetta di Michele Mariotti, che in più di un’occasione e sui palcoscenici di tutto il mondo si è distinto come uno dei migliori interpreti rossiniani. La matematica musicale con cui esegue la partitura è assolutamente cristallina, impreziosita di colori, fraseggi, sfumature ricche di intenzioni e di sentimenti, anche personali. Alla guida della sua bravissima Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – fatto salvo, in questa occasione, per qualche scivolone nei fiati – e con il Coro diretto da Andrea Faidutti, compie un prodigio in termini di interpretazione musicale rossiniana, senza però dimenticare la collaborazione preziosissima dell’eccellente Giulio Zappa.
IL TURCO IN ITALIA [Lukas Franceschini] Pesaro, 6 agosto 2016.
Il secondo titolo presentato al Rossini Opera Festival 2016 è stato Il Turco in Italia in nuovo allestimento ideato da Davide Livermore e con il debutto del direttore e concertatore Speranza Scappucci, prima donna a salire sul podio al Rof (prova generale). Il Turco in Italia è la tredicesima opera del pesarese e si colloca nei primi anni di produzione. Infatti, la prima assoluta fu al Teatro alla Scala il 14 agosto 1814 con protagonisti Filippo Galli, Giovanni David e Luigi Pacini. Rossini aveva già all’attivo importanti opere serie (Tancredi), le cinque farse veneziane, e opere buffe (Italiana in Algeri). Alla Scala egli esordì trionfalmente nel 1812 con La pietra del paragone, in seguito a tale successo e la sempre più acclamata fama fu invitato a scrivere una nuova opera per il teatro milanese. Tuttavia, il pubblico scaligero non accolse con favore il nuovo lavoro rossiniano perché fu considerato un rimaneggiamento di ripiego rispetto a L’italiana in Algeri. Il successo arrivò qualche anno più tardi nel 1821 e in seguito fu confermato nelle molteplici riprese in altri teatri italiani ed europei i cui artefici furono i coniugi De Begnis, autentici cantanti-attori rossiniani. Come per altri spartiti dalla seconda metà del 1800 l’opera scomparve dai cartelloni e bisognerà aspettare il 1950 per avere una prima riproposta moderna a Roma al Teatro Eliseo con Maria Callas e Sesto Bruscantini diretti da Gianandrea Gavazzeni. In seguito, seppur lentamente, l’opera iniziò a essere rappresentata in vari teatri italiani ed esteri, cui seguì anche una versione critica dello spartito. In tale veste fu rappresentata al Rof per la prima volta nel 1983 con Samuel Ramey e Lella Cuberli quali protagonisti. Al festival pesarese fu in cartellone anche nel 1985 e 2007. Per questo nuovo allestimento il Rof ha deciso di affidare l’incarico a Davide Livermore che nella stessa rassegna riprende anche Ciro in Babilonia del 2012. Livermore ha voluto ispirarsi ancora una volta al cinema presentando un “dittico” cinematografico per le due opere. Scelta un po’ azzardata poiché anche “Ciro” era stato allestito con la stessa chiave, ma di questo parlerò in seguito. L’idea del regista è stata di ispirarsi ai film di Federico Fellini, inventando una drammaturgia ove ogni interprete del “Turco” si rifaceva a una complessa e lunga carrellata di personaggi felliniani, in parte scolpiti nella memoria di tutti noi. L’operazione a mio avviso è riuscita a metà, poiché il punto di partenza potrebbe essere interessante, ma quando un regista si fa prendere la mano con aggiunte recitate ecco che l’opera rossiniana è compromessa nel suo animo. E che questo sia permesso al Rof che com’è naturale rappresenta le opere in sede di esecuzione critica è ancor più grave. Il rispetto dello spartito è prenderlo cosi com’è, bello o brutto che sia, ma soprattutto perché creato da altri. All’inizio della rappresentazione assistiamo a un inutile dialogo (senza musica) tra gli interpreti che fanno percepire ciò che avverrà, la realizzazione di un film, il cui Poeta-Prosdocimo non è altro che il Mastroianni-Fellini del celebre film 8½, creatore e autore della commedia. Da questo punto di vista le cose avrebbero potuto funzionare meglio se l’allusione cinematografica fosse stata presa come segmento narrativo e non come vero e proprio elemento che sovrasta l’opera e non la accompagna. Inoltre le continue interruzioni parlate (ciack scena prima, ecc.) non divertivano ma annoiavano. Il coro e un folto gruppo di comparse erano costituiti da tutti i personaggi felliniani, si poteva ravvedere Sandra Milo, la tabaccaia di Amarcord, la donna barbuta, circensi, eccetera, e alla fine il gran minestrone era spesso abbondante a scapito di una drammaturgia intricata che avrebbe avuto esiti più squisiti se l’accostamento fosse stato più moderato e delicato. Non si può tuttavia negare una teatralità efficace, molto compatta anche se troppo confusa o mescolata tra narrazione e finzione, prova e recita. La scena non colpisce particolarmente poiché costituita da pochi elementi e grandi tendoni bianchi, divertente la passerella turco 3finale, ma poteva essere utilizzata meglio, che evocava sempre il celebre film di Fellini. Straordinari invece i costumi di Gianluca Falaschi che riprendeva con qualche variante celebri abiti cinematografici, esemplari e di grande fattura sartoriale quelli di Fiorilla e Selim, ma anche i richiami alle molteplici muse felliniani presenti nel coro e nelle comparse. Il direttore Speranza Scappucci a capo della non perfetta Orchestra Filarmonica “G. Rossini”, ottoni in particolare, si adopera con piglio narrativo abbastanza solido e una soddisfacente impronta narrativa. Dovrà raffinarsi soprattutto nei colori e nelle dinamiche che mi sono parse statiche e poco frizzanti, ma avrà tempo e comunque questo debutto pesarese è positivo e mi auguro in un futuro di crescita. Non brilla il Coro del Teatro della Fortuna di Fano “M. Agostini”, diretto da Mirca Rosciani, ma si disimpegna con onore. Il Selim di Erwin Schrott è l’unico cantante a fornire una voce pregiata e di grande spessore. Scenicamente sfavillante, parafrasava “Lo sceicco bianco” ma vocalmente non in possesso di agilità rossiniane perfette e una certa monotonia d’accento, aspetto quest’ultimo abbastanza strano considerata l’istrionica versatilità del cantante. Grande delusione è stata Olga Peretyatko nel ruolo di Fiorilla. Ho sempre sostenuto che le parti rossiniane drammatiche erano oltre il suo limite, ma ero convinto che in questo ruolo avrebbe avuto un fertile terreno. Invece mi sono trovato di fronte ad una cantante in continua difficoltà d’intonazione, scarso volume, e zona acuta molto ridimensionata. Il momento più imbarazzante si è avuto nella grande aria del II atto nella quale non trovata l’accento drammatico e nel finale in palese difficoltà con i fiati, tuttavia il personaggio scenico era molto azzeccato. Grande classe teatrale ha dimostrato Pietro Spagnoli, Prosdocimo, capace di rendere il suo compito sia scenicamente, da manuale il personaggio, sia ancora vocalmente fraseggiando con garbo. Diametralmente opposto il Geronio di Nicola Alaimo, in grave difficoltà nel sillabato e nel registro acuto, abbozza un marito sui generi senza molta traccia. Rene Barbera, Narciso, è appena accettabile considerando che anche per lui il settore acuto è malmesso, in aggiunta canta entrambe le arie, e la zona più efficace sarebbe quella centrale che utilizza poco. Il personaggio è reso a macchietta dalla regia ed egli non riesce a cogliere nulla di espressivo. Brava Cecilia Molinari nel ruolo di Zaida, cantante precisa, dotata di buona voce e superba attrice. Encomio particolare per Pietro Adaini, Albazar, tenore in continua crescita che sfoggia una voce intonata, dotata di musicalità e squillo molto bello. Avrei preferito uno scambio di ruolo con Barbera. Buon successo e molti applausi al termine.
IL TURCO IN ITALIA [William Fratti] Pesaro, 18 agosto 2016
L’ultima rappresentazione de Il turco in Italia è sicuramente la meglio riuscita rispetto alle precedenti, continuamente oggetto di critiche piuttosto sentite, anche sui social network. Il nuovo allestimento curato da Davide Livermore, che si presenta come una sorta di compagno di pellicola di Ciro in Babilonia, si rifà al mondo di Federico Fellini e la resa della fotografia – per dirla in termini cinematografici – è assolutamente vincente, pur avvalendosi di scenografia modesta, complici soprattutto i pregevoli costumi di Gianluca Falaschi e le luci suggestive di Nicolas Bovey. Buono anche il rendimento della recitazione e delle gestualità, ma solo se considerato separatamente scena per scena, mentre valutato nel complesso della vicenda appare decisamente poco frizzante, tenuto conto anche dei numerosi tagli apportati ai recitativi. Speranza Scappucci debutta sul podio del ROF e dà sicuramente prova di ottima professionalità, ma compie un passo più lungo della gamba. Innanzitutto è doppiamente impegnata, poiché sorregge la bacchetta e siede al fortepiano. Inoltre la sua visione del Turco denota poco mordente e una certa mancanza d’accento. Sicuramente complice è la carenza di precisione da parte dell’Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini, che comunque dà segni di miglioramento rispetto a precedenti edizioni. Poco più che sufficiente la prova del Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini diretto da Mirca Rosciani. Erwin Schrott, anch’egli debuttante sul palcoscenico pesarese, non è certo interprete rossiniano di riferimento, ma è artista a tutto tondo dotato di una voce naturalmente bella, ben timbrata, eccellente nella rotondità del suono, tale per cui ben poco conta lo stile, sapientemente celato dietro a una somma eleganza. Pertanto il suo Selim ha il valore aggiunto di una vocalità che corre e che sa molto bene cosa significhi recitar cantando. Olga Peretyatko, bersaglio principale delle molte critiche nelle recite precedenti, durante l’ultima rappresentazione dimostra di possedere una grande professionalità e una tecnica ferrata. La brava cantante decide di attenersi molto allo spartito originale di Fiorilla, eliminando tutte quelle variazioni nel settore acuto e sovracuto che sempre hanno contraddistinto le sue performance rossiniane – e per cui tutto il pubblico la attendeva – dando prova di grande intelligenza musicale, seppur deludendo chi si aspettava tante note alte. Ottimi i duetti con Geronio e Selim. Nicola Alaimo è sempre artista eccellente, ma il suo Geronio, rapportato ad altre sue interpretazioni, è abbastanza modesto, come se stesse risparmiando voce ed energie. René Barbera, nella parte di Narciso, mostra le medesime perplessità dello scorso anno, con agilità poco sgranate, note basse precarie, acuti molto spinti. Eccellente il Prosdocimo di Pietro Spagnoli, che torna a Pesaro dopo molti anni di assenza. Il fraseggio e l’intenzione rossiniana sono sopraffini, eloquenti e ben cesellati, sicuramente significativi e da considerarsi come lezione di canto. Ottima la prova di Alice Molinari nel ruolo di Zaida e molto efficace l’Albazar di Pietro Adaini.
LE NOZZE IN SOGNO [Lukas Franceschini] Innsbruck, 19 agosto 2016.
Il Festwochen der Alten Music per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione ha presentato una “nuova” opera di Pietro Antonio Cesti Le nozze in sogno, la quale non era rappresentata da oltre tre secoli. Pietro Antonio Cesti (1623- 1669), sovente denominato anche Marc’Antonio, fu un compositore principalmente di opere liriche, ma anche tenore, organista, maestro di cappella a Innsbruck e riconosciuto come uno dei maggiori compositori italiani della sua epoca. Circa la sua formazione musicale abbiamo notizie frammentarie e non certe. Spesso il suo nome è associato alla città di Venezia ove ebbe enormi successi, egli studiò musica con vari maestri, direttori delle cappelle musicali, tra cui Giacomo Carissimi. Cantò spesso nel coro di voci bianche e fattosi francescano divenne organista della Cattedrale di Volterra e Santa Croce a Firenze, dopo un periodo romano. In quell’epoca entrò sotto la protezione della famiglia De’ Medici, comparendo per la prima volta in qualità di cantante d’opera per l’inaugurazione del teatro di Siena. Aderì al circolo letterario fiorentino l’Accademia dei Percossi, grazie al quale, conobbe Giovanni Filippo Apolloni e Giacinto Andrea Cicognini, due librettisti con i quali collaborò in seguito. Nel 1649 interpreta a Venezia il ruolo di Egeo nella prima assoluta de Il Giasone di Francesco Cavalli. Il debutto operistico certo fu Alessandro vincitor di se stesso, rappresentato a Venezia durante il carnevale del 1651, seguito a breve tempo da Il Cesare amante. L’anno successivo entrò regolarmente al servizio dell’arciduca Ferdinando Carlo a Innsbruck, dove vi rimarrà per circa cinque anni. Durante questo periodo mise in scena le sue opere più celebri: L’Argia, rappresentata per celebrare la presenza in città della Regina Cristina di Svezia, e Orontea. Nel 1665 fu scritturato alla corte di Leopoldo I d’Asburgo, presso la quale svolse l’incarico di maestro di cappella a corte e compose Il pomo d’oro. Rientrato a Firenze, grazie alla protezione dei Medici, morì nel 1669, a causa, secondo l’opinione di alcuni biografi, di un avvelenamento. I suoi lavori teatrali più celebri furono La Dori (Innsbruck, nozzesogno 31657), Il Pomo d’oro (Vienna, 1668) e Orontea (Innsbruck, 1656). Molti dei suoi drammi erano assai elaborati e includevano una grande orchestra, numerosi cori e diversi congegni meccanici, usati per rappresentare situazioni come gli dei che discendevano dal paradiso, battaglie navali e tempeste. Orontea, con le sue diciassette riprese nei successivi trent’anni, fu una delle opere più allestite nella seconda metà del Seicento. Molto rilevante fu il periodo trascorso nella capitale del Tirolo, stagione nella quale ebbero luogo molte composizioni allora celeberrime. Le nozze in sogno, un dramma civile per musica, su libretto di Pietro Susini, fu rappresentata al Teatro degli Accademici Infuocati di Firenze il 6 maggio 1665. Solo recentemente studi musicologici hanno potuto attribuire con quasi certezza la paternità dello spartito a Cesti e se non la circostanza della messa in scena almeno la dedica che reca il nome del Cardinale Carlo De’ Medici. La vicenda, tipicamente barocca, fonde e amalgama elementi tipici delle opere di quel periodo: il gioco amoroso, lo scambio delle coppie, il travestimento attraverso l’ambiguità sessuale. I fatti si svolgono a Livorno, città libera creata dai Medici (ove persone di diverse culture, religioni e attività trovarono fertile terreno anche in virtù del porto commerciale), cui si spiega il titolo Dramma civile deriva da “civitas”. Un ricco mercante vuole maritare la giovane nipote per interessi economici con un altro attempato signore benestante. Ma la giovane ama, riamata, altro coetaneo che non riesce a incontrare, pertanto quest’ultimo si traveste da donna, poiché siamo a una festa di Carnevale. I tentativi andati a vuoto, cui si deve aggiungere l’amore ingannevole del fratello di lei per il giovane ragazzo creduto donna, ma poi sfociato per l’altra donna del dramma, si concretano quando le giovani coppie organizzano una commedia nella commedia ingannando i vecchi, cui è stato somministrato un sonnifero, nel cui stato di sogno approvano il matrimonio dei giovani e sono giustamente gabbati. Molto complessa nel suo insieme ma non distante da tutte le altre commedie in musica, nelle quali è possibile ravvedere anche degli abbozzi della futura produzione Mozart-Da Ponte. Interessante rilevare che i personaggi interagiscono tra loro alterando gli schemi sociali e come pone l’accento il regista Pizzech “solo in una citta come Livorno, terra libera per tutti, ciò poteva avvenire”. Tale situazione è riscontrabile anche in un libretto forte e sovente irriverente nelle metafore dei personaggi. Altri temi sono l’eterno scontro tra giovani e anziani (i secondi ancorati al conservatorismo e al denaro saranno sopraffatti, la scaltrezza della classe inferiore dei servi (nel nostro caso uno di questi è parte importante nella risoluzione del dramma), e il teatro nel teatro, attraverso il quale emerge la sincerità del sentimento dei nostri protagonisti. La musica è indubbiamente di prim’ordine con toni sia comici sia drammatici, che non possono non sedurre l’ascoltatore attraverso una ricca gamma di emozioni in continuo scambio. I tre atti originali, in questa prima ripresa moderna nozzesogno 4concentrati in due, si differenziano nella prima parte come un’esposizione dei personaggi, dei fatti e dell’antefatto, la seconda in una drammaturgia più incalzante e briosa. Ma è il susseguirsi di arie, recitar cantando e sublimazione di affetti che affascina e segna in questa riscoperta barocca un elemento di assoluto interesse musicale. Lo spettacolo è stato rappresentato all’aperto nel Cortile della Facoltà di Tecnologia dell’Università cittadina, un ambiente ristretto ma caratteristico che ben si adoperava per un’opera con pochi personaggi, assenza di coro e orchestra con organico ridotto. L’estro e la brillantezza del regista Alessio Pizzech hanno avuto la meglio su uno spettacolo realizzato con molta fantasia e grande senso drammaturgico che appagava nelle tre ore d’ascolto e visione. La scena funzionalissima e scarna di Davide Amadei, era composta di grandi container di legno per spedizioni, rifacendosi all’attività commerciale portuale, i quali si aprivano a vista e creavano interni secondo la vicenda. Lo stesso scenografo ha curato anche i costumi, molto belli, di fattura che pur ricalcando un taglio tradizione sommavano con gusto elementi più moderni. Quest’aspetto era voluto per assecondare l’idea drammaturgica del regista. Il quale è stato molto efficace nell’affrontare un libretto e una vicenda intricatissima. A mio avviso ha avuto la saggia idea di scegliere un’ambientazione “ibrida”, non storica ma neppure tutta moderna, utilizzando una via sempre in equilibrio e molto ironica sulle situazioni, paradossalmente talvolta assurde, ma anche veritiere che pur rifacendosi alla commedia dell’arte contengono elementi sempre attuali. All’inizio abbiamo visto il travestimento di Flammiro travestito da drag-queen. Ad essere sinceri avevo in un primo momento temuto il peggio invece era un tocco originale di modernità, poiché il tema della festa di carnevale era molto sottolineato nel testo. I personaggi erano molto ben recitati, la drammaturgia briosa, la narrazione accattivante, e il susseguirsi delle scene realizzate in una lettura che come denominatore comune s’ispirava al classico teatro. Un lavoro perfettamente riuscito, e dobbiamo lodare Alessio Pizzech per aver saputo scavare in un libretto ostico, di non immediata percezione e con momenti stantii nella prima parte, realizzando una lettura che coinvolgeva e faceva sorridere. Lo stesso regista ha realizzato anche l’adattamento drammaturgico, spostando delle scene o delle arie nella loro sequenza per rendere più fluida la narrazione, senza ovviamente interferire sulla parte musicale. Posso dedurre che questo importante e difficile compito fosse stato già valutato ed elaborato molto tempo addietro con il maestro Alan Curtis, il quale avrebbe dovuto dirigere l’opera a Innsbruck se la repentina scomparsa non fosse sopraggiunta lo scorso anno. Lo spettacolo era a lui dedicato, poiché è stato una delle presenze più indicative del Festival. Tuttavia, la sostituzione sul podio è stata molto interessante: Enrico Onofri, violinista d’indubbia fama del “Giardino Armonico”, molto esperto del repertorio barocco. Il direttore, che disponeva dell’ottimo Ensemble Innsbruck Barock, orchestra bravissima per aderenza stilistica e meraviglioso suono, ha saputo fondere teatro e recitazione in una concertazione di alto livello, sviluppando dinamiche sempre sostenute, una fluidità musicale di accompagnamento di ottima fattura e soprattutto di elevato spessore filologico. Il cast oltre a esprimere nella sua complessità un ottimo apporto musicale, è doveroso osservare che sono stati anche straordinari attori, guidati con mano sicura e saggia dal regista. Arianna Vendittelli era una Lucinda deliziosa e romantica che avuto modo di mettere in luce una voce molto duttile e ben organizzata nei diversi nozzesogno 5registi. Molto espressivo il Flammiro di Rodrigo Sosa Dal Pozzo, magari non sempre fermo nell’intonazione, ma valido in un fraseggio efficace. Yulia Sokolik, Emilia, evidenziava un personaggio arguto e brioso, disponendo di buona e duttile voce. La Filandra di Francisco Fernandez-Rueda era divertentissima nel ruolo en-travesti senza cadere nella volgare macchietta e avendo una riguardevole impostazione musicale. I due vecchi ricchi mercanti erano interpretati con grande classe scenica da Rocco Cavalluzzi, Pancrazio, e Jeffrey Francis, Teodoro (anche nel breve ruolo di Ser Mosé). Il primo ha sfoderato una voce bella, pastosa molto armonica e con ottimi colori, il secondo, dopo lunga carriera, ancora in grado di sostenere il ruolo di caratterista con voce ferma e sapiente musicalità. Lelio era il giovane Bradley Smith, tenore dalla voce chiara ma molto pertinente in un canto armonioso e patetico. Bravissimo il controtenore Konstantin Derri, Scobrio, puntualissimo nei suoi difficili interventi, ha dimostrato una rilevante padronanza tecnica con una voce solida e molto sicura nel registro acuto. Esuberante il Fronzo di Ludwig Obst, giovane baritono di buone attese che ha sapientemente accomunato personaggio e vocalità precisa nei suoi interventi. Il Cortile dell’Università era gremito dagli appassionati del Festival e al termine tutta la compagnia ha ricevuto un meritato e doveroso trionfo.
ROMEO ET JULIETTE [Mirko Gragnato] Verona, 19 agosto 2016.
Per il quarto centenario della morte del bardo l’estate teatrale veronese chiama il Ballet du Grand Theatre de Geneve per il balletto Romeo et Juliette su musiche di Sergej Prokof’ev con la coreografia di Joelle Bouvier. Romeo e Giulietta a Verona è un testo che scotta, spesso abusato e reso stucchevole è di difficile approccio in una città in cui molto ruota attorno a questa “eccellentissima e lamentevolissima” storia. I Veronesi lo sanno bene e guardano con un certo scetticismo chiunque osi approfittare del dramma Shakespeariano. Aspettarsi un balletto tal quale come nella partitura di prokofev è forse il passo sbagliato per apprezzare l’interpretazione che il balletto di Ginevra e la coreografa vogliono dare; un punto di vista che non vuole essere innovativo, ma altro, dando spunti di riflessione e soprattutto emozioni al pubblico. Tutto inizia con un viaggio nel tempo, siamo al teatro romano, a Verona, e un ballerino armato di una lunga asta inizia una delirante piroetta a moto perpetuo, un orologio che torna indietro e ci porta ad un tempo indefinito, che non è oggi, ma che come tutte le storie comincia con un “c’era una volta, tanto tempo fa”… a Verona. Ecco che il palcoscenico si popola, il corpo di ballo si palesa, in abiti neri, un flash forward su quello che probabilmente accadrà, un prologo danzante che ci mostra i due schieramenti: Capuleti e Montecchi già abbigliati a lutto. Non è spoiler, sappiamo già tutti come andrà a finire; Romeo e Giulietta, sono qui un qualsiasi ragazzo, una qualsiasi ragazza, che vengono mossi come marionette da un mondo che li obbliga a seguire convenzioni e rigide regole sociali, alle quali purtroppo non si può far altro che soggiacere. I due giovani innamorati in una sorta di momento onirico si incontrano, si sfiorano, ma i due schieramenti li strappano letteralmente l’uno dall’altro, il preludio di un amore impossibile. In questa rilettura di Shakespeare, Montecchi e Capuleti non hanno stemmi, non hanno casacche diverse, fanno tutti parte di uno stesso mondo, sia maschi che femmine seguono lo stesso identico copione, passo dopo passo. Le scene sono semplici e sobrie, una lunga rampa curva si staglia sul palcoscenico, quella stessa linea di curvatura che ha seguito il viaggio a ritroso nel tempo. La danza forse più che la prosa riesce qui nell’intento di dare letture diverse, altri punti di vista e interpretazioni, accennando con i movimenti e le coreografie le sensazioni, le emozioni, ispirando pensieri e percezioni. Uscendo dai luoghi comuni si torna all’essenziale, quel poco che basta per portare avanti l’intreccio spinto da gesti e scontri. Il corpo di Ballo di Ginevra, in questa interpretazione di danza contemporanea, si mostra ancora una volta una compagnia di eccezione; che attraverso ballerini di formazione classica rompe un po’ gli schemi, esce fuori dagli stilemi uomo-donna, che nella danza governano sovrani, e a discapito del ” gender” esce dai ruoli di genere, senza limiti.
I brani che vanno a comporre le varie parti della musica, vengono rimescolati, ripescati, riadattati alle necessità sceniche, chi prima chi poi sembrano ricollocati in modalità random, ma in realtà rispondono ad una chiara linea narrativa, quella voluta da Joëlle Bouvier. Interessante la citazione di un rondò medievale, una danza in circolo, nel momento della festa in casa Capuleti, così come il tema dei mandolini nel quale avviene il duello, tra Mercuzio e Tebaldo, tra il grottesco e il falecio ma portando inesorabilmente alla morte di uno dei due. La morte di Mercuzio avviene, quasi per caso, tra scherzi e risate, una goliardata finita male, ma l’odio di Tebaldo invece viene mostrato rigido e saldo nei giochi di sguardi e nei movimenti scattanti e nervosi che vede i due affrontarsi. Tutt’altra tempra l’incontro tra Tebaldo e Romeo, un vero e proprio duello voluto dai due, dove un innocente Romeo si sente mosso dal vigore inesperto della giovinezza alla furia della vendetta. Dopo le prime difficoltà nell’affrontare Tebaldo, l’impacciato Romeo più volte messo al tappeto mette fine alla vita dell’avversario con un colpo profondo e ben assestato; la prima morte in scena, a differenza della più sardonica e discreta fine di Mercuzio che si accascia sulle spalle dei compagni verso le quinte. La morte si palesa in carne ed ossa, col volto coperto, imbracciando il corpo dell’ormai spento Tebaldo e caricandoselo sulle spalle. Lo trascina, in un gioco di luci che lo fa sembrare un’ombra raminga per il palco. Il lungo velo che avvolgeva la morte squarcia in due la città, le mura “fuor delle quali non esiste mondo” si spezzano e così ancora più rancorosa e cruda diventa la faida tra Montecchi e Capuleti.I due giovani amanti erano appena usciti da un idillio amoroso, dove l’erotismo del corpo in un silente passe deux si mostra in tutta la sua nuda innocenza: i due corpi si intrecciano nella penombra, una luce fioca che ne mantiene il pudore, quella genuina verecondia del giovane inesperto che vive l’esperienza sessuale come un qualcosa di nuovo, da scoprire con una certa timidezza. Non c’è musica, risuonano soltanto le carezze e lo scivolare di un corpo sull’altro accompagnati dallo scorrere delle Adige, nella corsa d’acqua tra le rapide di Ponte Pietra. Un attimo che non ha tempo ma che emoziona per l’infinita dolcezza in cui si svolge. Tuttavia la notizia della morte di Tebaldo e della città spezzata portano all’esilio di Romeo; Giulietta crolla nel torpore di una pseudo morte, il suo corpo si intreccia ad una lettiga di legni incrociati e il corteo funebre la fa scivolare come una bella addormentata su di un lato del palco. Romeo si palesa incredulo sulla scena, in un momento di una tenerezza infinita, Giulietta, sfuggente come una goccia d’acqua tra le mani, scivola tra le braccia di Romeo, il suo corpo instabile non risponde più al caldo abbraccio e resta un freddo corpo inerme. Ecco che in questo delirio di abbandono Romeo rivede i fantasmi di Tebaldo e Mercuzio che lo invitano a sé, Romeo si lascia morire, va verso di loro e passo dopo passo inizia ad accasciarsi, il veleno compie il suo infausto dovere, lasciando Romeo riverso al suolo a pochi passi dalle quinte, lontano dalla sua Giulietta. Lei si risveglia lo vede, ma è sola, isolata, lontana dal suo amato; ecco che le ombre la circondano e la sollevano in uno slancio verso l’alto: è idealmente il pugnale che si affonda nella carne e la spinge verso il suo Romeo al quale però il suo corpo senza vita resta lontano, nella parte opposta del palco, se c’è l’aldilà saranno assieme? Non è dato sapere, ma in questo mondo i due sono l’uno senza l’altro, lontani anche nel momento in cui il cuore ha dato l’ultimo battito. La fine di questa tragedia. Una rilettura veramente forte, profonda e di impatto che ha dato una ventata di freschezza ad una storia ahinoi trita e ritrita tra le mura veronesi. La scena dei funerali risente di un tocco di ispirazione dalla fotografia dei film di Orson Welles dei lontani anni ’50. Il corpo di Ballo di Ginevra ha riscosso un notevole successo al teatro Romano, fragorosi applausi e “bravo” hanno riempito la cavea e il pubblico entusiasta ha salutato con entusiasmo questa serata di danza nel cartellone dell’estate teatrale veronese che ancora una volta ha dato prova di proporre artisti di altissimo livello a Verona.
CIRO IN BABILONIA [Lukas Franceschini] Pesaro, 7 agosto 2016.
Il terzo e ultimo titolo presentato al Rof è stato Ciro in Babilonia, ripresa della produzione del 2012 curata da Davide Livermore, con il debutto di Jader Bignamini al festival pesarese (prova generale). L’opera Ciro in Babilonia, ossia la caduta di Baldassarre, è la quinta opera lirica del catalogo rossiniano e la seconda nel genere serio. Per precisione non sarebbe un’opera lirica vera e propria, ma un dramma con cori per musica che Rossini compose per il Teatro Comunale di Ferrara, ivi fu eseguita nella Quaresima (febbraio ?) del 1812. Non sappiamo con precisione se fu rappresentata in un vero e proprio allestimento scenico, oppure eseguita in forma oratoriale. Tali peculiarità devono essere intese come varianti per aggirare il divieto di allestire spettacoli d’intrattenimento durante la Quaresima. Il soggetto, in parte biblico, e l’utilizzo di grandi cori contribuirono alla dicitura “oratoriale” dello spartito e in tal senso ottenne il benestare dalle autorità religiose. Fu lo stesso librettista, Francesco Aventi, un ferrarese letterato per diletto e ufficiale della Guardia Nazionale, a proporre al giovane Rossini, che stava affermando il suo valore compositivo a Venezia, l’occasione del debutto a Ferrara. La musica è quasi completamente originale, ad eccezione della Sinfonia, dall’Inganno felice, e alcuni imprestiti da Demetrio e Polibio ed Equivoco stravagante. L’opera rappresenta il germe d’inizio dell’opera seria: elaborati accompagnamenti orchestrali, l’utilizzo di strumenti solisti nell’accompagnare le arie, marcie funebri, scene nelle prigioni e scene sotterranee. Come per gli oratori di altri compositori d’oltralpe Rosini scrisse un’aria per ciascun cantante, elemento rarissimo e non riscontrabile in altri lavori. In definitiva non potremo definire Ciro un capolavoro, ma in esso si trovano pagine di assoluto rilievo e inizi compositivi che poi troveremo in partiture successive e più famose. Ciro in Babilonia è anche uno degli spartiti, pochi per precisione, del quale non esiste l’autografo, ma il compito del Fondazione Rossini e del Rof è proporre l’opera omnia basandosi su studi musicali e revisioni critiche. All’appello manca ancora il centone Eduardo e Cristina.Lo spettacolo ideato da Davide Livermore quattro anni or sono, convince più oggi che al debutto. Il regista ha un accentuato amore per il cinema antico e pertanto adatta molte sue drammaturgie operistiche basandosi sull’arte della pellicola. Qui le cose funzionano molto meglio rispetto al Turco della sera precedente. Innanzitutto, Livermore s’ispira ai kolossal del cinema muto in maniera più coerente e sceglie una lettura drammaturgica magari “forzata” in stile con la recitazione del tempo ma lineare e molto appropriata nella drammatica trama della lotta tra Ciro e Baldassarre. Si possono pertanto rivedere quel tipo di films epici che hanno caratterizzato la prima fase dell’arte cinematografica. Il regista si aiuta anche con alcuni video originali, altri girati appositamente con i cantanti, sempre in un filo conduttivo chiaro e piacevole. Bella la scena di Nicoals Bovey, tutta a scacchi bianco e nero, per non tradire l’impianto originale, straordinari e da mozzafiato i costumi di Gianluca Falaschi e riempiono la cena con uno sfarzo raramente visto nel teatro d’opera odierno. Ottima la direzione di Jader Bignamini. Il direttore lombardo si ritaglia un particolare successo in questa produzione e quindi La Traviata veronese è da considerarsi una piccola deviazione di percorso. La sua concertazione, che surclassa notevolmente quella del collega della precedente edizione, s’impone per la scelta di tempi molto appropriati, la dinamica dei colori e la sferzante direttiva imposta all’Orchestra del Comunale di Bologna. Non da meno è da rilevare il grande lavoro orchestrale sui recitativi, che in quest’opera sono lunghissimi e numerosi, ma anche il tono narrativo, che è variato nel susseguirsi delle scene, e il particolare impeto nei momenti virtuosistici. In definitiva una grande prova del compito del direttore d’orchestra. L’orchestra ha svolto il suo compito con dovere professionale anche se qualche falla si è avuta nella sezione degli ottoni. Il Coro, istruito da Andrea Faidutti, non sempre calibrato ha dimostrato maggior professionalità rispetto la prova precedente. La protagonista era Ewa Podles illustrissima cantante spesso ignorata dai grandi circuiti e dal Rof stesso nei suoi anni migliori. Ritrovarla oggi dopo quattro anni non ci permette di dire che la signora sia in ottima forma. Si registrano molti difetti, causa anche l’età e la lunga carriera, di un mezzo ormai usurato che non riesce più a legare, si potrebbe parlare di tre voci differenti, e di una zona centrale ormai inesistente. Eppure la sua prova è stata molto rilevante per chi ha saputo cogliere quello che ancora può fare: l’accento specifico del canto rossiniano, la diversità di fraseggio nei diversi momenti, l’impeto e lo stile del personaggio eroico. In quest’ultimo caso resta maestra, aiutata molto anche dal responsabile direttore, e può ancora dare lezione a tutti i cantanti più giovani del Festival. Sembra che questa produzione di Ciro abbia potuto avere eseguita solo perché la signora Podles ha accettato di ritornare al Festival cortesemente e dopo molte pressioni, diversamente forse si doveva cambiare titolo. Erano voci che giravano alla fine della recita. Antonino Siragusa ha interpretato un Baldassarre molto autorevole, dimostrando di aver corretto alcune fissità e passaggi nasali presenti nelle sue ultime prove. Elegante nel fraseggio e nel canto, ha superato la prova, non facile, con la capacità dei suoi ragguardevoli mezzi cui ha contribuito una musicalità innata. Pretty Yende, Amira, sarebbe cantante troppo leggera per la parte, e non così afferrata nel canto di colorature. Tuttavia, bisogna riconoscerle una volontà ferrea d’impegno, anche se i mezzi sono limitati, lei ha profuso un accento e un fraseggio più che meritorio, anche se nei momenti di coloratura spianata ha dovuto patteggiare con la sua voce situazioni non proprio felici come nell’aria del secondo atto e l’intonazione non sempre precisa. Lasciano poca traccia lo Zambri di Oleg Tsybulko e il Daniello di Dimitri Pkhaladze per stile anche se in possesso di mezzi non comuni ma non ancora rodati. Discreta la prova di Isabella Gaudi, un’Argene corretta anche se non sfavillante e Alessandro Luciano, Arbace, che si fa onore cantando la difficile aria con buona professionalità. Successo pieno a termine con punte di trionfo per la Podles e Bignamini e appuntamento al prossimo anno con una nuova produzione de Le Siège di Corimthe e le riprese di Torvaldo e Dorliska e La pietra del paragone.
CIRO IN BABILONIA [William Fratti] Pesaro, 20 agosto 2016.
Dopo pochi anni dalla sua prima assoluta al ROF, torna sul palcoscenico del Rossini Ciro in Babilonia nello spettacolo di Davide Livermore, con le bellissime scene e progetto luci di Nicolas Bovey, l’eccellente video design di D-Wok e i pregevolissimi costumi di Gianluca Falaschi. Visto una seconda volta, a distanza di qualche anno, l’allestimento è molto più godibile, poiché il tempo culturalmente necessario per assorbire una novità artistica rende l’ascolto e l’ascoltatore molto più completi, più concentrati sul dramma e aiutati da tutti gli elementi aggiuntivi che inizialmente potevano sembrare distrazioni. L’eleganza di tutta la produzione, compreso il finissimo lavoro di regia, resta l’elemento imprescindibile di questo spettacolo. Altro ingrediente assolutamente necessario al buon esito di questo Ciro è la sapienza rossiniana di Gianni Fabbrini, che in questa occasione siede anche al fortepiano accanto al violoncello di continuo di Mattia Cipolli.Alla guida della sempre eccellente Orchestra del Teatro Comunale di Bologna è il talentuoso Jader Bignamini, debuttante al ROF, ma sinceramente dotato di ottima mano nello stile del pesarese. Colori e accenti sono davvero accattivanti, il gusto musicale è centrato sul dramma, i fraseggi sono eloquenti. Pure ottimo il Coro diretto da Andrea Faidutti. Questa produzione segna anche l’atteso ritorno della grandiosa Ewa Podles, che ancora una volta divide la platea: da un lato i suoi irriducibili fan la acclamano e la applaudono come una vera dea, dall’altro molto pubblico si guarda attorno attonito, senza capire il motivo di tali ovazioni. L’artista è di grane levatura, l’interpretazione è appassionante, lo stile rossiniano e l’intenzione del fraseggio sono da insegnamento. Ma la voce cambia colore e timbro ogni 3 o 4 note e sembra provenire da persone diverse, risultando totalmente disomogenea, oltre a certi suoni fuori maschera. Ottima l’interpretazione di Pretty Yende, sempre bravissima anche se non perfettamente cristallina, poiché in certe occasioni le note più alte appaiono un poco secche e, seppur raramente, qualcuna è calante. È tuttavia davvero magnifica la sua seconda aria, musicalmente e sentimentalmente, accompagnata dal fantastico violino di Marco Ferri. Antonino Siragusa è alle prese con un ruolo che non è il suo. La sua voce incantevole, morbida e leggera, il suo sapere rossiniano, l’abilità tecnica nel canto di agilità che sempre lo contraddistinguono, a poco possono in una tessitura da baritenore dove le troppo numerose note gravi, in cui si trova in difficoltà, lo affossano obbligandolo a spingere negli acuti, diventando disomogeneo. Oleg Tsybulko è uno Zambri abbastanza opaco e poco elastico; Alessandro Luciano, pur avendo una bella voce ed essendo ben formato, è un Arbace un poco incerto; Dimitri Pkhaladze è un Daniello piuttosto tiepido; Isabella Gaudi è un’Argene abbastanza adeguata.
TURANDOT [Lukas Franceschini] Verona, 23 agosto 2016.
Il quarto titolo programmato al Festival dell’Arena di Verona è stato Turandot di Giacomo Puccini, nell’allestimento curato da Franco Zeffirelli. Recensisco una recita di agosto poiché quando andai a luglio, la rappresentazione fu sospesa dopo il primo atto per una violenta bomba d’acqua che si rovesciò sul centro di Verona e rese impossibile il proseguimento della recita. Lo spettacolo con regia e scene di Franco Zeffirelli ha sempre riscosso molti plausi e consensi sin dalla prima proposta. Tuttavia, dobbiamo rilevare che non è un vero e proprio nuovo allestimento poiché si tratta dell’impianto creato per il Teatro alla Scala nel1983 poi modificato e riallestito al Teatro Metropolitan nel 1988 e ora riadattato per gli spazi dell’anfiteatro veronese. È indubbio che il grande colpo d’occhio della scena della reggia di Pechino sia emozionante e imponente e non può che suscitare meraviglia per un fascino di colori ma è cosa già vista. Inoltre, per realizzare questo si sacrificano molte altre importanti scene costrette in spazi limitati sul proscenio e come da stile zeffirelliano affollatissime di comparse e mimi all’inverosimile, soventi inutili. Della traccia registica non c’è gran che anche se oggi è stata ripresa da un coordinatore interno alla Fondazione, spesso i cantanti solo lasciati al loro istinto, e come il solito si apprezza più lo scenografo che il regista. Molto belli e ricchissimi i costumi di Emi Wada, che da soli creano una scena stupefacente, però quello della Principessa poteva essere più imponente giacché non aveva nulla di regale e di distinguo con le altre figure femminili della corte. Sul podio abbiamo ritrovato il veronese Andrea Battistoni, il quale dimostra una maturazione professionale rilevante e più affinità con i grandi spazi areniani accomunata da uno stile più appropriato nella difficile partitura pucciniana. A essere precisi qualche sfasatura tra il coro e i solisti c’è stata, ma molto marginale, piuttosto si è notata l’intenzione del direttore di scavare a fondo nello stile cercando di rendere evidenti timbri e cromatismi che trovano una loro logica nell’incompiuta e in parte innovativa opera pucciniana, anche se l’esecuzione all’aperto soffre di limiti. Buona la prova del Coro, pur notando in alcuni momenti qualche imprecisione, e apprezzabile il Coro di Voci Bianche “A.d’A.Mus” diretto da Marco Tonini. Oksana Dyka, la principessa Turandot, avrebbe dalla sua una voce adatta al ruolo accomunata a un variegato fraseggio, pur non essendo esplicitamente drammatica, ma lo spessore nella zona grave è sovente assente e gli acuti di spesso limitati e forzati. Il Calaf di Walter Fraccaro è apparso stanco e molto affaticato, il settore acuto era stentoreo e mancava quello squillo energico che distingue il ruolo ma nel complesso ha dimostrato una buona professionalità. Diverso il giudizio su Donata D’Annunzio Lombardi, Liù, la quale ha una voce molto bella e lirica, una spiccata dolcezza nel canto assieme ad un variegato uso dei colori. Purtroppo nell’aria del primo atto, peraltro iniziata molto bene, giunta alla smorzatura funale la voce si è inceppata in una sorta di “scrocco”, tal effetto ha condizionato la sua esibizione dal punto di vista emotivo poiché in seguito ha giocato molto di rimessa forse per paura di altri incidenti. Peccato perché credo avrebbe fatto una buona recita, speriamo di risentirla in prossime occasioni. Rilevante il Timur di Carlo Cigni, bel timbro e molto partecipato il personaggio. Bravi i tre ministri Ping, Marcello Rosiello, Pong, Francesco Pittari, Pang, Giorgio Trucco, cha hanno dimostrato un’ottima professionalità canora e tur 4un’animata prova teatrale, molto ben eseguita la scena prima del II atto, nella quale hanno trovato un equilibrio molto apprezzabile. Ben realizzato il flebile Imperatore da parte di Cristiano Olivieri e positivo il mandarino di Paolo Battaglia. Anfiteatro quasi esaurito in questa recita di fine stagione e infrasettimanale e successo entusiasta al termine.
IL TROVATORE [Lukas Franceschini] Verona, 26 agosto 2016.
L’ultima recita de Il Trovatore di Giuseppe Verdi all’Arena di Verona ha avuto due interessanti cambi cast. Dello spettacolo con regia e scene di Franco Zeffirelli ho già parlato nella recensione del 10 agosto. Lo spettacolo si riconferma, pur con qualche distinguo, uno dei migliori non solo del maestro fiorentino ma dell’intera proposta areniana degli ultimi anni. Godibilissimo, imponente e credibile. Inoltre l’opera si rappresenta in due parti con un solo intervallo, è auspicabile che nelle future nuove realizzazioni la Fondazione Arena prenda seriamente in considerazione tali soluzioni offrendo al pubblico una serata con tempi accettabili. Sul podio sempre il maestro israeliano Daniel Oren, il quale si conferma in una direzione precisa, impostata nel solco della tradizione (tutti i da capo tagliati) e con qualche arbitrario accomodamento tonale. Tuttavia, è doveroso rilevare che i trov 3tempi erano sovente molto lenti, ad esempio finale atto primo, e certe sezioni dei duetti, mentre nelle grandi scene corali l’impeto è pertinente e vivace. Non ho mai capito perché sin dall’inizio in quest’allestimento sono stati inseriti brevi frammenti delle danze, composte in seguito da Verdi per l’edizione parigina. Non si poteva eseguire tutto il balletto? Sarebbe stata una preziosa perla che pochi ascoltatori conoscono. Tuttavia Oren sa condurre l’opera e non avendo fuoriclasse sul palcoscenico conduce la nave in porto con onore, senza intralci e rilevanti sfasature. Protagonista era il giovane tenore Murat Karahn, il quale pare sia stato “cover” per la produzione e premiato con quest’ultima recita. Una bella scoperta e sorpresa per chi scrive. Il cantante è in possesso di voce bella, rotonda e ben impostata, con l’aggiunta di una spiccata facilità in acuto. Caratteristiche che sono alla base per il ruolo di Manrico. Qualche problema, molto limitato, si è avuto nella zona del passaggio ma dobbiamo considerare sia la giovane età sia il debutto nella trov 4produzione. La grande aria “Ah, si ben mio” è stata eseguita con ammirevole partecipazione, ricchezza di armonici e colori, cui è seguita una cabaletta di tutto rispetto. L’altra new-entry è stata quella del baritono veronese Simone Piazzola, Conte di Luna, il quale ha dimostrato ancora una volta, di essere una delle voci giovani di grandi speranze del panorama italiano. Piazzola ha sfoderato una proprietà d’accento e stile molto apprezzabili, eseguiti attraverso un canto morbido, musicalissimo e nobile, ritagliandosi un personale successo tutto meritato. Diversamente da quando ascoltato in teatro al chiuso, ho notato un leggero contenimento di volume, ma non è possibile dare un giudizio preciso considerato l’amplificazione oggi utilizzata in Arena. Il resto del cast era eguale alle altre recite. Hui He, Leonora, mantiene sempre un timbro affascinante ma i limiti tecnici sono evidenti sia in zona acuta sia nel legato, che vanno a discapito delle bellissime mezzevoci di un tempo, cui si aggiunge la difficoltà di mantenere l’intonazione. Un vero peccato, però dobbiamo anche osservare che la continua insistenza su un repertorio pesante, con qualche eccesso di ruolo, hanno prodotto la situazione attuale. Violeta Urmana, Azucena si riconferma, ancora una volta egregia cantante e buona interprete, che utilizza un mezzo vocale, ora rientrata nel registro di mezzosoprano, molto uniforme, di grande senso drammatico e teatrale. Qualche acuto è leggermente forzato ma è poca cosa rispetto alla resa di un personaggio ben realizzato senza svarioni e di grande personalità. Sergey Artamonov, Ferrando, era molto più composto e lineare rispetto all’altra recita, più preciso e vocalmente meno scomposto, facendosi ben apprezzare. Completavano la locandina con onesta professionalità: Elena Borin (Ines), Antonello Ceron (Ruiz), Victor Garcia Sierra (vecchio zingaro) e Cristiano Olivieri (un messo). Anfiteatro quasi esaurito e successo trionfale al termine. Un’appendice. La situazione della Fondazione Arena è nota a tutti, pertanto non serve aggiungere altro. Dobbiamo registrare che la stagione estiva è stata molto positiva per presenza di pubblico, oltre le aspettative, ma restano ancora da sciogliere nodi importanti. La nomina del nuovo sovrintendente, cosa ne sarà del corpo di ballo, i due mesi di sospensione dell’attività artistica, la futura programmazione invernale. Nessuna comunicazione a oggi sia dai vertici della Fondazione sia da Palazzo Barbieri. Attendiamo con fiducia e speranza.
IL TEMPLARIO [William Fratti] Salisburgo, 30 agosto 2016.
Riscoperta a Chemnitz in Sassonia nel 2008, Il templario di Otto Nicolai è stata proposta al Salzburger Festspiele 2016 nella sua primissima e originaria versione torinese del 1840, la cui edizione critica è stata curata da Michael Wittmann in collaborazione con Florian Bauer Opera di puro belcanto e di grande attualità, è perfettamente aderente ai modelli dell’epoca nella prima parte, ma ricchissima di novità musicali, teatrali, caratterizzazioni psicologiche e intensità drammatiche in secondo e terzo atto; e se si considera anche la scrittura del titolo più conosciuto di questo compositore, ovvero Die lustigen Weiber von Windsor, si è arrivati a presumere che “se a Nicolai fosse stata garantita una vita più a lunga, oggi potremmo riscrivere la storia dell’opera tedesca”. La direzione musicale di Andrés Orozco-Estrada alla guida della magnifica Wiener Philharmoniker è davvero ammirevole. Ogni tratto del belcanto è opportunamente accentato, ogni pagina drammatica è consapevolmente condotta, i pezzi d’assieme sono amalgamati con ottimo gusto ed eccellente precisione. I suoni sono pulitissimi. Il dialogo tra il podio, i musicisti e i cantanti è sempre vivo e guidato con la giusta enfasi. Juan Diego Florez è un Vilfredo elegantissimo. La sua voce incantevole è impreziosita da un fraseggio di primissimo livello, che attraverso un esemplare uso di colori e sfumature sa passare dall’eroico, al drammatico ed infine al patetico, con una morbidezza vellutata e un’omogeneità sinceramente toccante, altresì invidiabile. Non è da meno il Briano di Luca Salsi, baritono brillantissimo, timbro naturalmente bello, cantante dotato di ottima intelligenza musicale, sempre coerente alla sua correttissima linea di canto, alle prese con una scrittura che gli sembra cucita addosso. Pure aderente al suo ruolo, Clémentine Margaine esegue una buona Rebecca, anche se il fraseggio non è così rifinito e i colori non sono particolarmente emozionanti. Ad esempio nel finale ci si sarebbe aspettato molto più pathos e accento patetico durante la preghiera; migliore il duettino conclusivo. Ottima la Rovena di Kristiane Kaiser; efficacissimo Franz Supper nella parte di Isacco, padre di Rebecca; più che adeguato il Cedrico di Adrian Sâmpetrean; particolarmente interessante, nel ruolo del gran maestro dei templari, la vocalità di Armando Piña, giovane baritono uscito dalle Accademie di Zurigo e Philadelphia. Perfetta la prova del Salzburger Bachchor guidato da Alois Glassner. Grandioso successo con ovazioni da stadio per tutti gli interpreti e i musicisti, nella speranza che ciò decreti il ritorno in repertorio di questa bellissima opera.
LA SERVA PADRONA [Lukas Franceschini] Vicenza, 8 settembre 2016.
L’appuntamento con l’opera all’interno della rassegna Vicenza in Lirica si è svolto alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari ove è stato eseguito l’intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi La Serva padrona. L’opera fu composta per il compleanno di Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel (madre di Maria Teresa d’Austria) su libretto di Gennaro Antonio Federico, e rappresenta in prima al Teatro San Bartolomeo di Napoli il 28 agosto 1733, quale intermezzo all’opera seria Il prigionier superbo, dello stesso autore, la quale sarà destinata a non raggiungere neppure lontanamente la fama della Serva padrona. Con questa realizzazione è da considerarsi a tutti gli effetti l’inizio del nuovo serva 2genere dell’Opera buffa. Il successo fu immediato e mai tramontato nel corso dei secoli. Significativo fu il grande successo della ripresa del 1752 dell’Académie Royale de Musique, la quale sviluppò una disputa, nota come la ”Querelle des bouffons”, fra i sostenitori dell’opera tradizionale francese, incarnata dallo stile di Jean-Baptiste Lully e Jean-Philippe Rameau, e i sostenitori della nuova opera buffa italiana fra cui alcuni enciclopedisti (in particolare Jean Jacques Rousseau, anch’egli compositore). La disputa divise la comunità musicale francese e la stessa corte per due anni (la regina, ad esempio, simpatizzava per gli italiani) e portò a un veloce cambiamento del gusto musicale francese, il quale si orientò verso modelli meno schematici e più moderni. Piccola operina, solo per la durata, ma eccelsa per linguaggio musicale e sviluppata attraverso due soli cantanti. Un gioiello frizzante, ironico e moderno, che giustamente il teatro mai ha ignorato, proprio perché incarna figure vere e teatralmente innovative. Il bellissimo cortile barocco delle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari era la cornice ideale, in un tardo pomeriggio settembrino, per la realizzazione demi stage ideata da Andrea Castello. Un tavolo, due sedie, qualche oggetto minimo (tazze, bicchieri, bottiglie), erano più che sufficienti per una lettura drammaturgica spigliata e briosa, ove ha contribuito soprattutto l’ottima presenza scenica degli interpreti. Davide Giangregorio, Uberto, è in giovane basso di grandi potenzialità vocali (selezionato allo scorso Festival di Sarzana) che ha fornito una prova molto convincente, ben calibrata, con buon fraseggio, e una generale valida padronanza di mezzi mantenendo l’eleganza del canto senza macchietta. La Despina di Ilenia Tosatto, forse non proprio maliziosa e peperina, ma piuttosto malinconica e dolce, ha avuto una buona realizzazione attraverso mezzi vocali rifiniti ed esprimendo una musicalità precisa. Lo stesso regista Castello ha garbatamente interpretato il servitore muto (mino) Vespone. L’Ensemble Corte Armonica era istruito da Alberto Maron, il quale era anche maestro al cembalo. La sua concertazione è stata briosa e stilizzata in un contesto quasi cameristico tale da rendere di livello il fraseggio musicale con un’accuratissima focalizzazione degli strumenti ad arco, eccellenti gli esecutori. Un risultato finale di grande stile, cui ha contribuito l’ambiente intimistico, anche se all’aperto, del cortile del Palazzo. L’esecuzione è stata preceduta da una sapiente conferenza introduttiva di Alessandro Cammarano.
NORMA [Lukas Franceschina] Venezia, 14 settembre 2016.
La riproposta dell’opera Norma di Vincenzo Bellini alla Fenice aveva come principale attrattiva la presenza di Mariella Devia nelle vesti della sacerdotessa. Dello spettacolo creato nel 2015 dall’artista americana Kara Walker, ne ho già parlato a suo tempo. Riconfermo anche oggi le impressioni, personali, che ne ebbi allora. Trasportare la vicenda nell’Africa coloniale è stata idea bizzarra e pur nulla accattivante norma 2ma probabilmente ciò è avvenuto per mancanza d’idee. Non metto in dubbio l’autorevolezza della signora Walker nel suo campo artistico, che peraltro conosco poco, ma per questo non ci s’improvvisa regista d’opera. Infatti, lo spettacolo mancava di drammaturgia, una linea interpretativa teatrale, cui aggiungiamo costumi banali (coro al limite della risata), e una scenografia statica, probabilmente molto artistica, ma per nulla soddisfacente. La Walker sarà una delle artiste di maggior spicco del momento, è appunto invitata alla Biennale e lo spettacolo era un progetto speciale Biennale Arte 2015, ma questo non giustifica l’operazione soprattutto per il profilo artistico della signora che è improntata sulla specificità del suo paese d’origine, e tutto questo poco o nulla in comune con Norma. Tuttavia la produzione è stata realizzata e dovrà esser utilizzata per qualche anno, ma la dimenticheremo presto. Ben diversi i risultati musicali. Daniele Callegari, maestro direttore e concertatore, ha diretto con grande senso teatrale e meticolosa filologia, capace di tempi perfettamente equilibrati, cui si alternavano azzeccate intuizioni liriche-romantiche ad altre più strettamente drammatiche, risolte con efficace maestria e devo aggiungere una delle migliori prove da me ascoltate in teatro dal direttore milanese. Lo assecondava una precisa Orchestra della Fenice, la quale negli ultimi anni ha raggiunto un buon livello qualitativo tra i complessi delle Fondazioni Liriche, tuttavia anche in questo caso si deve registrare un’impronta sonora troppo norma 3fragorosa che va a scapito sia dell’ascolto sia nel prevalere sulle parti cantate, infatti, durante la recita il direttore continuava a indicare ai professori un contenimento di volume facendo segno di “piano” con la mano destra. Sarebbe auspicabile un ridimensionamento dell’organico poiché le dimensioni del teatro sono ristrette e tale disfunzione si è registrata anche in altre occasioni. Molto buona la prova del coro istruito da Claudio Marino Moretti. Il Pollione di Roberto Aronica è stato molto approssimativo perché spesso forzato e stentoreo, credo che il cantante non fosse in piena forma fisica. Tuttavia, bisogna riconoscergli un volenteroso tentativo rendere variegato il fraseggio e modulare l’accento, ma il risultato è stato comunque limitato e inferiore alle attese. Bella sorpresa l’Adalgisa di Roxana Constantinesco, più soprano che mezzosoprano, la cui vocalità combaciava bene con quella della protagonista, del resto la parte di Adalgisa fu composta in origine per soprano, in seguito soprattutto nel ‘900 fu affrontata prevalentemente da mezzosoprani per diversificazione di voce con Norma. La sua interpretazione è stata realizzata con un giusto accento molto espressivo, e un fraseggio variegato; qualche acuto era leggermente forzato ma nel complesso una prova positiva e personalmente mi auguro di risentirla in ruoli più sopranili che strettamente legati al mezzosoprano. Simon Lim, Oroveso, non lascia traccia pur avendo una voce corposa ma sperperando un valore canoro in un canto monotono e senza carisma. Molto bravo il Flavio di Antonello Ceron, professionale la Clotilde di Anna Bordignon. Infine Norma, Mariella Devia. Il soprano ligure è la maggior cantante italiana da oltre trent’anni e su questo non vi sono dubbi o eccezioni. Ora giunta anche a un’età per un soprano ragguardevole (e voglia questo, essere un complimento) si può parlare di miracolo canoro per tecnica encomiabile, utilizzo dei fiati, varietà di colori e brillantezza nei passi di agilità. Tuttavia, Norma non è il suo ruolo e si sapeva ancor prima del debutto bolognese, confermato poi dalle recite sia a Napoli sia ora a Venezia. Le dobbiamo però l’attenuante che giunta nella terza fase della carriera ha tutto il diritto di affrontare ruoli non propriamente ideali, forse per sfizio oppure per sfida. La Devia non è un soprano drammatico d’agilità e pertanto non ha la struttura vocale idonea per i passi citati, per invettive furiose e per un recitativo (in Norma sovente impostato sul registro grave) ideale. Non sono critiche ma oggettive limitazioni di una voce che ci ha regalato momenti straordinari in altri repertori. La signora Devia però canta tutta la parte come la deve cantare e con la sua voce, le sue possibilità e soprattutto senza trasporti che potrebbero forse facilitare l’impresa. Inoltre affronta il ruolo in tono, il che è già un pregio rilevante. Pertanto troviamo una cantante che come sapevamo non ha una zona grave robusta e spesso è coperta o dall’orchestra o dagli altri cantanti in taluni passi dei concertati, ma ha accenti vigorosi, il fraseggio è molto migliorato (rispetto a Bologna) e la varietà di colori ancor più diversificati, qualsiasi tratto o patetico o drammatico trova un senso, anche se l’emotività teatrale e misurata. norma 5Qualcuno grida al miracolo, se non lo è, ci siamo molto vicini. La professionalità, l’incredibile talento, la ferrea volontà sono elementi che mi hanno fatto apprezzare la sua esibizione veneziana, cui concludo con un vero plauso e anche segno indicativo di vera grande artista applicata al canto. Teatro esaurito in ogni ordine di posto, splendido successo per la compagnia e trionfo personale per Mariella Devia.
DIE ZAUBERFLÖTE [Lukas Franceschini] Milano, 21 settembre 2016.
Il Progetto Accademia del Teatro alla Scala 2016 è stato la realizzazione dell’opera Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart in un nuovo allestimento curato dal regista Peter Stein. Come annunciato quando fu presentata la stagione odierna, questa produzione costituisce la prima tappa di un progetto di collaborazione tra il Teatro alla Scala, l’Accademia Teatro alla Scala e uno dei più prestigiosi registi del nostro tempo, Peter Stein, per flauto 2presentare ogni anno i migliori giovani cantanti internazionali in un contesto d’eccellenza e al termine di un percorso artistico inedito per qualità e livello di approfondimento. Il regista tedesco ha offerto la sua disponibilità per iniziare un lavoro di formazione e preparazione dei giovani artisti da un anno prima del debutto. Questa rilevante operazione segna il cambio di marcia straordinario nell’ambito delle cosiddette masterclass, il Teatro alla Scala per primo introduce un nuovo sistema di preparazione affidandosi a un regista e un direttore d’orchestra in uno “studio e formazione” di assoluta importanza e per la durata di unicità. Nel singspiel Die Zauberflöte, sintetizzando, l’argomento si rifà alla mitologia dell’antico Egitto in un clima in cui alla storia di Iside e Osiride si attribuiva una particolare influenza su tutte le religioni successive. Per il resto l’opera spazia in una varietà di ambientazioni, ove l’Egitto occupa solo una parte, una gamma di costumi esotici, il rituale massonico, ma anche il divertimento favolistico, infantile, in bilico tra lo spettacolo marionettistico e quello circense. Mozart conclude l’opera sulla base della concordia, questa avviene con la sconfitta delle tenebre in favore della luce e della gioia anche esteriore. Bellissimo lo spettacolo creato da Peter Stein, assieme allo scenografo Ferdinad Wogerbauer e alla costumista Anna Maria Heinrich, nel puro e gratificane solco della tradizione. Perfettamente rispettata l’opera e la drammaturgia, in un allestimento che inizialmente pareva fin troppo minimale, ma in seguito si visto un grande lavoro di tecnica scenografica con il crearsi delle diverse scene a vista, un impianto perfettamente riuscito e di grande senso teatrale. Il regista di suo ha imposto una recitazione calibrata, asciutta ma con un’impronta teatrale validissima poiché ci invita in questo spettacolo magico anche nella costruzione, e saremo noi a dare delle risposteflauto 4 all’intricata vicenda che attinge su diverse fonti. Non ha forzato la mano in “concetti astrusi” cercando un suo linguaggio, una sua concezione, ecc., non ha messo l’io davanti uno spartito di altri. Di questo lo ringraziamo e lo plaudiamo vivamente. Bellissimi i costumi, sapientemente azzeccati per ogni personaggio, e di grande pregio il disegno luci di Joachim Barth. Sul podio Adam Fischer, esperto direttore mozartiano che proprio alla Scala diresse il titolo trent’anni fa. La lettura musicale è precisa di grande spessore sinfonico, forse anche in sintonia con l’impianto registico, ma anche sapendo di avere sul palco dei giovani, il quali sono stati sorretti con grande maestria in un racconto piacevole, in tempi serrati e rigida compostezza. L’Orchestra e il Coro (diretto da Alberto Malazzi) dell’Accademia del Teatro alla Scala lo seguono con diligenza strabiliante, dimostrando non solo impegno ma grande professionalità. Tra le voci ci sono state alcune belle nuove conoscenze. Il Papageno di Till von Orlowsly, brillante cantante e bravissimo attore dotato di voce pastosa, morbida e buon timbro. Martin Summer, Sarastro, ha un bel timbro vocale e si permette di cantare in zona grave con provata esperienza, anche se l’intonazione non era sempre precisa. Martin Piskorski, Tamino, è un giovane di buone speranze che cura positivamente il fraseggio e nell’insieme supera l’ardua prova con decoro. La Pamina di Fatma Said è stata molto musicale e ha sfoggiato un bellissimo timbro, peccato gli accenti non erano particolarmente suggestivi. Note dolenti per Yasmin Ozkan, una Regina della notte che non possiede né la drammaticità del personaggio tantomeno la tecnica necessaria, lascia perplessi nelle agilità e la zona acuta non è ancora perfettamente calibrata. Brillante e vivace la Papagena di Theresa Zisser, simpatico e ben cantato il Monostatos di Sacha Emanuel Kramer. Il resto della compagnia era molto preciso e ben preparato scenicamente: Philipp Jekal e Thomas Huber (Oratore e secondo sacerdote), Elisa flauto 6Huber, Kristin Sveinsdottier e Mareike Jankowski (le tre dame), Mortiz Plinger, Clemens Schmid e Raphael Eismayr (tre fanciulli), Francesco Castoro e Victor Sporyshev (due uomini corazzati), Marcel Herrnsdorf, Tenzin Chonev Kolsch e Thomas Prenn (tre schiavi) e Jorge Abarza Sutter (sacerdote.) I tre fanciulli geni erano i bravissimi solisti del Wiltener Sangerknaben che non facevano rimpiangere il blasonato Tolzen Knabenchor. Pochi applausi durante l’esecuzione, ma calorosi e prolungati al termine per tutta la compagnia che giustamente li meritava.
AMINTA/ORFEO [Lukas Franceschini] Rimini, 24 settembre 2016.
La Sagra Musicale Malatestiana, giunta alla 67ª edizione, propone da qualche anno spettacoli di nicchia nella parte finale della rassegna. Quest’anno è stata la volta di Aminta/Orfeo uno spettacolo di lirica e prosa di cinquecentesca memoria. Arguto ideatore è stato Alessandro Taverna, figura di spicco in campo musicale e culturale da anni e di consolidata esperienza. In questo spettacolo si fondono due generi, musica e prosa, che al tempo era definita festa teatrale. Infatti, ci sono passi di Aminta, favola pastorale, di Torquato Tasso, scritta a Ferrara nel 1573 e Orfeo dolente di Domenico Belli. Il tutto avviene storicamente a Firenze, Palazzo della Gherardesca, nel 1616; alla favola teatrale, ove si racconta dell’amore di Aminta e Silva, sono interpolati cinque intermedi in stile musicale. Questa era una pratica assai frequente a cavallo tra i secoli XVI e XVII. Trattasi del germoglio che poi fiorirà nell’opera lirica, emblema musicale e culturale italiano della più fiorente esportazione. Le affinità drammaturgiche dei due testi si sviluppano sul sentimento dell’amore, inconsolabile in Orfeo aminta 2per la perdita di Euridice, e in parte sconfitto scendendo negli inferi, consolatorio quello di Aminta che trova supporto nelle braccia di Silvia. Prima rappresentazione moderna, quella di Dominico Belli a 400 anni dalla prima rappresentazione, nella splendida cornice della Sala Pamphili del Complesso degli Agostiniani. Spettacolo bipartito e non associato, questa la linea adottata dagli artefici della messa in scena: Luca Brinchi e Daniela Spanò, assieme alla collaborazione drammaturgica di Erica Z. Galli e Martina Ruggeri (di Industria Indipendente). La dissociazione è evidenziata dal predominante sviluppo di Aminta in forma teatrale e videoregistrata, con musiche non proprio seducenti di Franz Rosati, mentre l’esecuzione di Orfeo è relegata nel fondo buio della sala, ove è collocato l’ensemble strumentale e i cantanti. Insomma un binomio che non si rifaceva a un ideale di rievocazione di Festa teatrale cinquecentesca, anzi il moderno prevarica soprattutto in Aminta, ove un culturista provocatorio, Satiro, si cosparge il corpo di terra dorata, mettendo insieme, forse intenti diversi ma simili. Le prove attoriali, però registrate in video, di Francesco Bonomo, Giorgia Visani e Michael Schermi, sono molto efficaci, convincono anche i video ben realizzati con un efebo Aminta (Lorenzo Anzuini) e un’enigmatica Silvia (Clelia Scarpellini). Ben diversa e di altra statura l’esecuzione musicale di Orfeo, anche se realizzato in forma concertistica. Eccellente la direzione di Francesco Cera, qui in veste anche di clavicembalista, per l’aderenza allo stile primiero della parola cantata. aminta 1Contribuisce a questo rilevante risultato il ristretto complesso strumentale, di raffinata musicalità. I solisti si distinguono per lo stesso stile e impegno rilevante. Riccardo Pisani è un Orfeo capace di sfumature e timbri molto appropriati. Molto bravo anche Walter Testolin, voce grave di pregevole recitar cantando. Nel ruolo di Calliope spiccava la voce grave con ottimo fraseggio di Damiana Pinti. Le tre grazie, Santina Tomasello, Letizia Calandra e Lucia Franzina fornivano una buona professionalità. Completavano il reparto vocale Andres Montilla-Acurero e Alberto Allegrezza, che assieme agli altri formavano anche il coro di grande musicalità. Esito ambiguo e non entusiasmante al termine, presumo per la realizzazione scenica più che per quella musicale, ma sicuramente un’occasione rara per ascoltare un autore dimenticato e dove un’attenta analisi può anche razionalizzare gli affetti di Orfeo con quelli di Aminta
SEMIRAMIDE [Lukas Franceschini] Firenze, 27 settembre 2016.
La stagione d’Opera 2016-2017 al Teatro d’Opera è stata inaugurata con Semiramide di Gioachino Rossini, un titolo che fino a pochi anni fa’ era molto rappresentato, ora invece è da considerarsi “rarità”. Semiramide era caduta nell’oblio ancora alla fine del secolo XIX quando le voci di contralto specializzate nel repertorio d’agilità sparirono dal panorama teatrale. Fu proprio Firenze nel 1940 durante il 6° Maggio Musicale Fiorentino a proporre il titolo, in maniera pioneristica, con un cast di validi cantanti ma de tutto estranei a quello che in seguito sarà denominata Rossini-Renaissance: Gabriella Gatti, Ebe Stignani, Ferruccio Tagliavini, Tancredi Pasero. Sarà invece il grande soprano australiano Joan Sutherland a riproporre il titolo, alla Scala nel 1962, e poi a cantarlo spesso in coppia con Marilyn Horne, ripristinando uno stile consono e forse insuperato. Non mancarono anche altri interpreti d’elevato spessore nel corso di circa tre decenni, duranti i quali l’opera è stata nei cartelloni di tutto il mondo. Semiramide è un melodramma tragico in due atti su libretto di Gaetano Rossi, tratto dalla Tragédie de Sémiramis di Voltaire e dalla vita sem 2della regina Semiramide. Fu rappresentata in prima assoluta al Teatro La Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823 con Isabella Colbran nel ruolo della protagonista. E’ l’ultima opera che Rossini compose espressamente per palcoscenici italiani, prima del suo trasferimento a Parigi. A Firenze è stato ripreso uno spettacolo di Luca Ronconi, creato per il San Carlo di Napoli nel 2011, anche con l’intento di ricordare il regista, da poco scoparso, che con il Maggio Musicale ebbe una stretta collaborazione dal 1976 al 2014. Trattasi però delle non migliori realizzazioni di Ronconi, che in questa Semiramide cancella volutamente tutta la fastosità di Babilonia, creando piuttosto un ambiente intimo e sviluppato sugli aspetti personali degli interpreti. Avrebbe potuto forse essere una chiave di lettura funzionale, ma è del tutto estranea rispetto alla vicenda e alla musica di Rossini. Inoltre, il regista era sempre stato infastidito dal coro, anche alla Scala in occasione di Aida lo voleva relegare nei palchi di proscenio, qui a Firenze è collocato in buca, facendo mancare alla drammaturgia l’aspetto monumentale non secondario. Anche la scena povera e scarna, di Tiziano Santi, non affascinava, piuttosto annoiava, i costumi di Emanuel Ungaro, in parte diversi, a Napoli la protagonista aveva un busto di plastica che la mostrava come fosse a seno nudo, ora invece completamente rivestita, non lasciavano traccia, troppo anonimi, troppo uguali. Infine della regia non c’è grande traccia, non abbiamo visto un disegno drammatico che definisca il carattere, le pulsioni almeno dei quattro protagonisti, tutto era relegato alla mobilità, con due fastidiosi cubi mobili che spostavano i cantanti da una parte all’altra del palcoscenico. Durante le quattro ore della rappresentazione era la noia che prevaleva rispetto all’entusiasmo per la musica. Stefano Ragni intitola il suo saggio nel programma di sala “Senza primedonne non si cantan Semiramidi”. Non v’è titolo più indicativo per far comprendere le difficoltà per allestire quest’opera. A Firenze le due primedonne non c’erano, anche se è giusto rilevare che oggigiorno trovare un cast adeguato è ardua impresa. Jessica Pratt, la protagonista, ha dalla sua una buona musicalità, una spiccata predisposizione al canto virtuoso e fiorito, qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare in questi anni recenti. Ma Semiramide è tutt’altra cosa. Innanzitutto, non è solo un personaggio virtuoso ma è sem 4altrettanto drammatico e con accenti che necessitano un canto incisivo nel grave e un accento solido, qualità che la Pratt non ha di natura e cantando un ruolo totalmente spostato dal suo reale repertorio. Ne deriva una prestazione anche apprezzabile ma con rendimento dimezzato poiché solo nei passi sopracuti abbiamo sentito la cantante, nelle altre zone era spesso afona o coperta dai colleghi nei concertati, cui va aggiunto un fraseggio faticoso e scarsamente vibrante. Silvia Tro Santafé avrebbe dovuto essere l’altra primadonna, ovvero Arsace, ma anche in questo caso i risultati non stati apprezzabili. Più diligente della Pratt, ma con meno personalità, ha realizzato il suo compito con una certa padronanza timbrica, ma la voce è piena solo nel centro, le discese nel grave erano abbozzate e nel settore acuto i limiti erano evidenti, della belcantista rossiniana virtuosa c’era ben poco. L’Assur di Mirco Palazzi affronta un ruolo oltre il limite delle sue possibilità, poiché a parte il timbro bello, non possiede lo squillo, il volume e perizia tecnica sufficiente per l’ardua parte. Tali effetti si sono notati soprattutto nella grande aria del secondo atto, nella quale l’arioso era anche sem 5apprezzabile, ma la cabaletta l’ha messo in evidente difficoltà, sia per l’utilizzo dei fiati sia per il virtuosismo, dovendo chiudere il brano a malo modo e in maniera pasticciata. Juan Francisco Gatell è stato un decoroso Idreno. Molto migliore rispetto a un suo recente Barbiere pesarese, ha difettato solamente negli estremi acuti, ma la voce è bella, sufficientemente variata, molto musicale ed espressivo. Nel complesso una prova positiva. Corretto l’Oroe di Oleg Tsybulko, voce piena e molto incisiva, senza note particolari gli altri interpreti: Tonia Langella, Azema, Andrea Giovannini, Mitrane, e Chanyoung Lee, l’ombra di Nino. Se il cast non era eccellente, la vera sciagura di questa produzione era il direttore Antony Walker, un maestro concertatore di grande curriculum ma che con Rossini ha poco da spartire. Si comincia con una sinfonia, anche impersonale, ma pregevole, passando poi improvvisamente a una direzione lenta, slegata, e per nulla teatrale. Di questo ne hanno fatto le spese non solo il pubblico, che sarebbe potuto cadere in letargo, ma soprattutto i cantanti, i quali già di suo avevano i loro problemi cui il mancato sostegno del direttore ha contribuito alla resa poco felice della recita. sem 6Inspiegabilmente nel finale, come in un improvviso risveglio, concertava con tempo di cabaletta il magnifico terzetto “L’usato ardir”, rovinando la preziosa pagina. Da segnalare che poteva contare sull’ottimo organico orchestrale del Maggio Musicale Fiorentino e sul bravissimo Coro diretto da Lorenzo Fratini. Un’occasione mancata e piuttosto noiosa, tuttavia al termine il pubblico ha salutato i cantanti con calorosi applausi, mentre al direttore è stata riservata una pesante e meritata contestazione.
SEMIRAMIDE [William Fratti e Renata Fantoni] Firenze, 27 settembre 2016.
Fare Rossini con la R maiuscola al di fuori di Pesaro è un progetto assai ambizioso in termini di stile e di intenzione. Negli ultimi trentasette anni il ROF e l’Accademia Rossiniana diretta da Alberto Zedda si sono imposti come punto di riferimento per lo studio dell’interpretazione del compositore pesarese e devono essere presi come base architettonica su cui costruire ogni tipo di esecuzione. Il Rossini serio soprattutto è affare assai arduo e audace e l’intento, l’accento, l’espressione di ciascuno degli artisti coinvolti vale certamente non poco. In questa felice occasione, all’inaugurazione della Stagione 2016/2017 dell’Opera di Firenze, ci si avvale innanzitutto di uno degli ultimi spettacoli di un vero regista rossiniano, Luca Ronconi, che negli anni della Rossini Renaissance è stato in grado di condurre alla portata del pubblico moderno dei titoli altrimenti difficilmente rappresentabili. Questa sua Semiramide non ha alcuna pretesa, non è mastodontica, non è spettacolare, non è eccessivamente tradizionale né contemporanea. Impiega pochi elementi scenici al fine di lasciare spazio alla parola, a costo di sembrare fin troppo scarna. In questo lavoro della maturità il compositore è voluto ritornare sulle proprie orme, verso schemi musicali che ormai stava abbandonando, per incontrare i gusti di un pubblico diverso e senza saperlo ha aperto le porte ai grandi drammi dei suoi successori – si pensi a Norma e Nabucco – prediligendo modelli ormai consolidati a discapito di alcune novità che da qualche tempo stava sperimentando. E la regia di Ronconi sembra proprio seguire questo filo conduttore: un ritorno al classico per rappresentare il moderno. Eccellente è il lavoro di adattamento operato da Marina Bianchi e Marie Lambert, sulle suggestive scene di Tiziano Santi e con i piacevoli costumi di Emanuel Ungaro sapientemente ripresi e riassestati sui nuovi interpreti da Maddalena Marciano, con le belle luci di AJ Weissbard qui riviste da Pamela Cantatore. Il lavoro di concertazione svolto da Antony Walker, che non può essere certamente considerato un rossiniano puro, né la sua lettura del dramma potrà mai passare negli annali, è buono in termini di accento, soprattutto nel colore, anche se talvolta manca di nervo, ma sulla lunga partitura riesce a dare un significato univoco, omogeneo e compatto. Lo segue molto bene l’eccellente Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – fatta eccezione per qualche piccolo neo dei corni, ma con certi passaggi dei violini davvero superbi – come pure il superlativo Coro diretto dal bravo Lorenzo Fratini. Jessica Pratt, il vero interesse di questa occasione, veste i panni di una buona Semiramide, la cui tessitura è giustamente arricchita di variazioni verso l’alto per renderla più consona alle sue corde. La bravissima cantante forse manca un poco di autorevolezza e di accento drammatico, ma sa cantare, sa quello che fa col suo strumento e rende una regina babilonese, almeno dal punto di vista vocale, davvero piacevole. Il tempo renderà la sua interpretazione indubbiamente più adeguata e vitale. Forse il personaggio maggiormente reso più interessante è l’Arsace di Silvia Tro Santafé, nelle cui vene scorrono maggiormente il sangue di Bellini e Donizetti piuttosto che quello di Rossini, ma possiede una musicalità, una capacità d’accento e soprattutto un fraseggio davvero invidiabili. Inoltre la sua voce corre anche nell’immensa sala sorda dell’Opera di Firenze, facendo notare ancor meglio la sua precisione, il suo vigore, oltreché il suo bel timbro. Ottimo il colore dell’Assur di Mirco Palazzi, che inizialmente appare debole e con poco nervo, oltreché calante, ma subito dopo l’introduzione dimostra la pasta di cui è fatto, che trova forza e compimento nella bella scena della pazzia prima del finale secondo. Davvero buona la resa dell’Idreno di Juan Francisco Gatell, che si prodiga nell’introduzione, ma soprattutto nelle due terribili arie a lui affidate, con estrema perizia. Anche per lui certi passaggi sono perfettibili, ma nel complesso la sua prova è sinceramente di altissimo livello. Molto buono anche l’Oroe di Oleg Tsybulko, in netto miglioramento rispetto al Ciro di Pesaro. Efficaci l’Azema di Tonia Langella e il Mitrane di Andrea Giovannini. Ottimo in acuto, impreciso e traballante in basso, il Nino di Chanyoung Lee. Applausi e ovazioni, da un teatro vicino al tutto esaurito, per tutti gli interpreti al termine della lunga rappresentazione, che giustamente è stata proposta nell’edizione critica curata da Philip Gossett e Alberto Zedda. Scontenti gli irriducibili affezionati alle grandi dive del passato.
L’INCORONAZIONE DI POPPEA [Lukas Franceschini] Milano, 27 settembre 2016.
Al Teatro alla Scala è stata ripresa l’opera di Claudio Monteverdi L’incoronazione di Poppea nell’allestimento di Bob Wilson, che era stata proposta in prima la scorsa stagione. Di questa produzione ebbi modo di scrivere lo scorso anno in occasione delle recite di febbraio, ma è doveroso rilevare che la celebre opera del ‘600 è poppea 2stata rappresentata in una nuova “collazione” acritica, revisione, completamento ed edizione dei manoscritti cosiddetti di Venezia e Napoli a cura di Rinaldo Alessandrini. Pertanto basandoci su studi e manoscritti sappiamo oggi che le musiche sono da attribuirsi non solo a Monteverdi ma anche a Francesco Cavalli e il finale, uno dei più famosi della storia dell’opera, fu composto da Francesco Sacrati e Benedetto Ferrari. Resta invariato il risultato, seppur più preciso, che si tratta di un capolavoro assoluto dell’intera produzione operistica italiana. Lo spettacolo curato da Bob Wilson, regia, scene e luci, assieme a Jacques Reynaud per i costumi, ricalca l’impostazione generale delle altre opere Monteverdi, rappresentate alla Scala nelle recenti passate stagioni. Se alla prima visione lo spettacolo poteva anche attrarre, in seconda battuta devo affermare che è stata soprattutto la noia a prevalere su una sorta di regia coreografica di un teatro astratto senza particolare recitazione, la cui mimica attoriale tutta impostata in tableaux a fermo immagine, seppur ricercati, sono ormai obsoleti e sorpassati, anche perché tutte le regie di Wilson sono create in maniera identica, come nel caso del Macbeth bolognese. Restano molto belli i costumi, ispirati a un seicento barocco di alta scuola sartoriale, la scena invece è pressoché spoglia, qualche oggetto compare ma non lascia traccia. Resta fastidiosa, come nel Macbeth citato, la posizione di una luce al neon a livello del palcoscenico, la quale già dopo quindici minuti creava disturbo alla visione, figurarsi dopo quasi tre ore di ascolto. Rinaldo Alessandrini conferma una spiccata sensibilità al repertorio, oltre ad essere uno studioso è anche ottimo concertatore, sempre ricercato nei colori orchestrali, nelle dinamiche, e nel largo e coinvolgente senso narrativo. Rispetto a sue esecuzioni precedenti in questo caso il direttore ha preteso dai cantanti un canto più volutamente recitato e pochissima differenziazione tra i recitativi, le arie, i duetti, forse troppo monotona con scelte timbriche troppo uniformi. Bravissimo l’Organico Strumentale e il basso continuo di Concerto Italiano. Il cast era quasi invariato rispetto al 2015, la new entry più famosa era Carmela Remigio nel ruolo della protagonista. La signora Remigio affronta questo tipo di repertorio, non nuovo per lei anche se non molto frequentato, con innata musicalità e grande senso professionale. Purtroppo nella prima parte dell’opera la voce ha fatto un po’ fatica a scaldarsi e spesso risultava vuota nel centro con colori poco variegati. In seguito le cose sono andate meglio ed è possibile concludere che la performance è stata convincente. Molto migliorato il Nerone di Leonardo Cortellazzi rispetto alle recite della passata stagione, più attento al fraseggio, recitativo accurato e un canto pieno, molto preciso e armonioso. Sia Sara Mingardo sia Monica Bacelli, hanno dovuto adattarsi alla concezione del direttore, pertanto le loro prestazioni erano o appiattite o troppo caricate d’accento, ma le cantanti sono autentiche specialiste del repertorio che io preferisco in altra versione. Resta inalterato il valore canoro e musicale delle due artiste. Andrea Concetti era un bravo Seneca, preciso e di grande respiro vocale, Maria Celeng una incoronazione professionale e spiritosa Drusilla. Adriana Di Paola e Silvia Frigato hanno reso ottimamente i loro ruoli, Arnalta e Amore. Furio Zanasi confermava la spiccata predilezione in questo repertorio cantando i ruoli di Lucano, primo soldato, secondo famigliare e secondo console, Mirko Guadagnini si è fatto onore nei ruoli di Valletto e primo console. Più stilizzata e divertente la nutrice di Giuseppe Di Vittorio e ben assortiti Luigi De Donato, Monica Piccinini e Andrea Arrivabene che completavano la locandina. Purtroppo il teatro registrava parecchi vuoti, forse il titolo ha spaventato molti, i quali hanno perso occasione per ascoltare dal vivo un vero capolavoro.
GIOVANNA D’ARCO [Lukas Franceschini] Parma, 20 ottobre 2016.
Dopo una breve assenza durata solo un paio di edizioni, il Festival Verdi torna a far vivere la prestigiosa cornice del Teatro Farnese, gioiello ligneo dell’architettura barocca unico al mondo. L’opera è da sempre un discusso spartito: in parte amato dal pubblico fin dalla prima esecuzione, sovente dissacrato dalla critica. Talvolta si usa giovanna 1affermare che la verità sta nel mezzo, non questa volta, Giovanna non è un capolavoro. A parte questo non è che tutto sia da buttare, qualche melodia, aria e un terzetto sono rilevanti sempre però commisurati con gli “anni di galera” di Verdi, nei quali oltre ad una frenetica produzione (l’opera fu scritta i due mesi) vi fu una ricerca continua di stile, innovazione, i quali sarebbero sfociati integralmente e in veri capolavori dopo pochi anni. E’ vero che anche opere minori devono avere la loro luce e spazio, in particolare in un festival monografico, si potrà così apprezzare anche in parte, qualora un cast rilevante fosse in condizione di eseguire questo. Caduta presto giovanna 2nell’oblio, Giovanna d’Arco ebbe una prima ripresa nel 1951 durante le esecuzioni per il cinquantesimo della morte di Verdi, e progressivamente fu riscoperta gradualmente per arrivare ai giorni odierni, nei quali la frequenza è abbastanza assidua. Curioso che in una ripresa ottocentesca a Palermo, per problemi con la censura borbonica che si oppose al soggetto, la musica fu adattata a un nuovo libretto dal titolo: Orietta di Lesbo. Per la seconda volta nel corso della sua esistenza, il Verdi Festival si trasferisce dal Teatro Regio al vicinissimo Teatro Farnese all’interno del complesso della Pilotta. Gioiello dell’architettura italiana, autore fu Giovanni Battista Aleotti, non fu un edificio dedito all’opera, bensì a feste, e altro tipo di manifestazioni tipiche dell’epoca. Pertanto l’acustica non è delle migliori e gli spazi devono essere ripensati per uno spettacolo operistico odierno. Rispetto al Falstaff di qualche anno fa la disposizione è capovolta, l’originale palcoscenico è coperto da una platea inclinata che arriva fino alla cavea d’entrata, nella quale è stato costruito a destra un ristretto palco tondo e a sinistra lo spazio per la posizione giovanna 3dell’orchestra. In quest’area ridottissima i registi Saskia Boddeke e Peter Greenway inventano una regia molto moderna utilizzando belle proiezioni al laser e giochi di colori. Assieme al loro staff, Elmer Leupen (video), Annette Mosk (scenografa, a impegno minimo), Cornelia Doornekamp (costumi), Floriaan Ganzevoort (luci), Peter Wilms (video design), Lara Guidettti (coreografie), creano uno spettacolo troppo invadente con troppe idee e non sempre realizzate al meglio. Già lo scenario naturale offre una grande suggestione, utilizzarla con un progetto laser (si è visto durante la sinfonia) sarebbe stato sufficiente, invece il team di registi ha giovanna 4voluto aggiungere di tutto e di più in maniera superflua. In primis le due bravissime ballerine, che raffigurano Giovanna innocente e guerriera, una serie d’interminabili proiezioni d’immagini sacre, che sovente disturbano la concentrazione dall’esecuzione. Il rosso è il colore predominante che determina passione, sangue, e violenza, e quando appare il Re, il potere, si visualizza una corona ferrea, idea questa originale e pertinente, nella quale predomina il colore oro È risultato pure superfluo tutta l’attualizzazione della vicenda storica, in seguito supportata anche dalla leggenda. Il muro costruito dai mini con ovvi riferimenti europei, la proiezione logora e abusata di campi di concertamento di ieri e di oggi, le immagini di profughi che potrebbero fare riferimento alla Siria. In un’opera di due ore scarse di musica abbiamogiovanna 5 visto troppo, capito forse anche meno di quanto hanno voluto farci vedere, e se mi è permesso, credo che i due registi si siano lasciati prendere la mano nel timore di non creare nulla di nuovo o di sensazionale. In tale ottica, come predetto, molto era superfluo, mancando invece di creare una linea drammaturgica più incisiva sui personaggi, in particolare la protagonista, lasciata sola in figura statica, quando invece sia nell’opera sia nella storia era tutt’altro. I costumi erano piuttosto banali, pertinenti le luci, discutibili le entrate e uscite del coro sempre in processione sugli spalti del teatro, ma è anche doveroso affermare che con tale giovanna 6disposizione non c’erano tante altre possibilità. Validissimo invece l’apporto che I Virtuosi Italiani hanno dato all’esecuzione musicale, anche se la bacchetta, Ramon Tebar, pur essendo stata molto musicale e prudente nella sonorità, talvolta mancava di slancio e talune dinamiche erano appiattite. Molto buona la prova del Coro del Teatro Regio diretto da Martino Faggiani. Molto volenteroso il cast, il quale nel complesso ha fornito prova professionale. Vittoria Yeo, la protagonista, ha una bellissima voce ed è molto musicale, ma la sua interpretazione mancava di colore e accenti che un ruolo come Giovanna richiederebbe a priori quale eroina, nel complesso, pur non cadendo mai in errori, la sua esibizione era piatta e senza emozioni. Luciano Ganci, Carlo VII, possiede doti naturali non comuni e ha offerto una prova positiva per ricchezza di colore e incisività nel fraseggio. La sortita non era particolarmente felice nel settore acuto, ma nel corso della recita le cose sono andate in crescendo e possiamo considerare la sua giovanna 7esibizione più che positiva. Altrettanto si può affermare per Vittorio Vitelli, Giacomo, che ho sentito dopo anni in un’esecuzione molto precisa e di efficace temperamento, anche se in taluni punti qualche suono era nasale, nel complesso abbiamo un baritono ben preparato e di bella voce. Molto bravo Luciano Leoni, Talbot, che mi auguro di sentire in ruoli più impegnativi, e molto apprezzabile anche la prova di Gabriele Mangione, Delil. Devo rilevare che taluni personaggi non sono apparsi del tutto pertinenti teatralmente ma questo era dovuto senza dubbio a una lettura registica piuttosto ambigua. Teatro affollato in ogni ordine, con cospicua presenza straniera, ma molto gelido nei confronti degli esecutori, le arie, i duetti e gli assiemi passavano in assoluto silenzio. Comunque al termine è stato loro tributato un intenso applauso.
GIOVANNA D’ARCO [Lukas Franceschini] Parma, 30 settembre 2016.
(prova generale). Nelle precedenti occasioni si erano riscontrati, come previsto, diversi problemi di acustica dovuti soprattutto alla conformazione del pavimento e alla mancanza della copertura del sottotetto, andato perduto. Ma quest’anno è stata apportata una eccellente miglioria: le gradinate – scomode e alquanto pericolose per il pubblico – sono diventate la scenografia naturale dello spettacolo; una piccola porzione della platea è stata adibita a golfo mistico, con l’aggiunta di una pedana che funge da palcoscenico; sulla restante parte della platea e del palcoscenico originale è stata costruita una struttura in legno che non solo ospita gli spettatori più comodamente, ma funge da cassa di risonanza e migliora l’acustica. È un vero peccato che non si sia pensato anche di appendere dei pannelli in legno fonorifrangenti laddove si sono posizionate le americane, poiché ciò avrebbe ulteriormente contribuito a un più valido risultato. Lo spettacolo di Saskia Boddeke e Peter Greenaway inizia nel migliore dei modi: già dalla sinfonia i meravigliosi archi che sovrastano le gradinate del Teatro Farnese si illuminano e si dipingono attraverso videoproiezioni a cura di Elmer Leupen e Peter Wilms che sembrano raccontare la musica di Giuseppe Verdi oltre alla storia di Giovanna d’Arco. Ma entrano il Coro e il Re Carlo VII e già si notano i primi problemi: l’interprete in scena è goffo e impacciato, non certo perché incapace, ma evidentemente lasciato a se stesso, nel vuoto assoluto, senza un gesto o uno sguardo studiati a dovere. Lo stesso vale per il personaggio di Giovanna. Poco dopo iniziano a crollare anche le proiezioni: ciò che sembrava essere l’elemento vincente della messinscena si presenta come un’accozzaglia eccessivamente eclettica di simboli e simbolismi che generano solo confusione. Il lavoro di regia sui solisti rasenta il nulla e la coreografia di Lara Guidetti, pur avendo un suo buon valore se considerata fine a sé stessa, è altro elemento fuorviante e ben difficile da comprendere, soprattutto non trasmette emozioni in questo preciso contesto. I costumi di Cornelia Doornekamp sono poco più di tuniche bianche e le scene di Annette Mosk sono forse la pedana circolare e dei cubi bianchi e neri che nel finale vengono montati per formare una parete con una croce su di un lato. Le luci sono di Floriaan Ganzevoort. Come sempre ottima è la prova del Coro del Teatro Regio di Parma guidato da Martino Faggiani, che qui si impone come vero protagonista. Molto buona anche l’esecuzione de I Virtuosi Italiani diretti da Ramon Tebar, che mostra una mano salda e sicura, con una certa capacità di fraseggiare. Alcuni accenti avrebbero potuto essere più marcati, ma ciò si potrebbe imputare all’acustica della sala. L’interpretazione scenica dei singoli personaggi, come già sottolineato, è da considerarsi insufficiente, molto probabilmente a causa delle scelte di regia, mentre il lavoro in termini vocali è da valutarsi molto bene. Ci sono imprecisioni e passaggi da correggere e migliorare, ma si tratta pur sempre di una prova. Vittoria Yeo dimostra di possedere un bel timbro, che pare particolarmente adatto al ruolo di Giovanna e a questo tipo di repertorio; soprattutto il suono è molto ben proiettato e corre ovunque. Molto piacevoli sono lo smalto e la pastosità di Luciano Ganci nella parte di Carlo. Sempre ottimo il fraseggio di Vittorio Vitelli che qui veste i panni di Giacomo. Pure efficaci il Delil di Gabriele Mangione e il Talbot di Luciano Leoni.
THE TURN OF THE SCREW [Lukas Franceschini] Milano 30 settembre 2016.
Al Teatro alla Scala per la prima volta si rappresenta l’opera di Benjamin Britten (nel 40° anniversario della scomparsa) The Turn of Screw nella versione originale in lingua inglese. Le due precedenti edizioni furono rappresentate alla Piccola Scala e in lingua italiana. È difficile dire se quest’opera è il capolavoro del compositore inglese, tuttavia è certamente al vertice della sua produzione. Il lavoro fu commissionato dalla Biennale di Venezia, il soggetto fu tratto dal racconto omonimo di Henry Joyce (1898), librettista fu Myfanwy Piper storica collaboratrice di Britten. L’opera ebbe la prima esecuzione assoluta al Teatro La Fenice il 14 settembre 1954, segnando un successo rilevante (mai venuto meno in seguito) nell’attività produttiva di Britten dopo qualche insuccesso e il ritorno all’opera da camera. L’opera è suddivisa in un prologo e due atti, questi ultimi in otto scene come il racconto. Trattasi di una conturbante vicenda di fantasmi che ruota attorno al rapporto di corruzione ossessiva infantile, l’ex servitore Quint e Miss Jessel, da lui sedotta in precedenza, sono fantasmi la cui sfera erotica influenza la vita dei due giovani orfani. La governante cerca invano di salvare i piccoli, ma vano è il tentativo. Opera cupa e drammatica, che lascia un finale tragico aperto, è possibile credere ai fantasmi, o pensare piuttosto a un’immaginazione della governante, della quale è ignoto il nome. La brillante composizione di Britten, con una ricercata espressione vocale, punta a realizzare un dramma quasi horror ma con accenti eleganti che inchiodano e affascinano lo spettatore. Gli stessi sentimenti che ha avuto il pubblico della Scala assistendo allo spettacolo di Kasper Holten, il quale racconta la vicenda a capitoli, come nel racconto, attraverso una struttura fissa nella quale si aprono alternativamente le stanze nelle quali si svolte la truce vicenda, un sipario nero copre le altre. Oltre alla bella scena di Steffen Aarfing, che cura anche le luci e i costumi con grande maestria, c’è un disegno drammaturgico di raffinata recitazione, molto teatrale credibile, e di grande effetto emotivo. Durante gli zoom sugli spazi della casa di Bly il gesto, lo sguardo, le ieratiche movenze degli interpreti, impressionano per la tensione che riescono trasmettere. Eccellente bacchetta quella di Christoph Eschenbach, di rarefatta stilizzazione, scavo cromatico nella difficile partitura, oltre a essere eccellente pittore di colori orchestrali di rilievo quasi assoluto. Lo assecondano i dodici bravissimi esecutori dell’orchestra del Teatro alla Scala.Ottima la compagnia di canto raggruppata per questa produzione, a cominciare dai due ragazzi, Sebastian Exall (Miles) e Louise Moseley (Flora) membri del Trinity Boys Chorus, diretto da David Swinson, che hanno fornito l’adeguata fragilità dei personaggi unita a un’eccellente prova canora. La Governante di Miah Persson offre una prova di grande teatro canoro, musicale, precisa e con grande enfasi drammatica. Ian Bostridge, alla sua prima opera nel teatro milanese, trova nel canto di Britten terreno fertile, fraseggio ricercato ed espressione centellinata, che lo colloca oggi tra le migliori scelte in tale repertorio. Bravissime anche Jennifer Johnston, Mrs. Grose, e Allison Cook, Miss Jessel, le quali entravano del demoniaco giro teatrale con puntualissima presenza sia attoriale sia vocale. Successo trionfale al termine, giustamente meritato dalla compagnia, direttore e orchestra strumentale.
DON CARLO [Lukas Franceschini] Parma, 11 ottobre 2016.
Dopo quasi un ventennio di assenza dal palcoscenico del Teatro Regio, l’opera più impegnativa di Giuseppe Verdi torna a Parma nella versione in quattro atti. Il Festival Verdi 2016 è stato inaugurato con una nuova produzione di Don Carlo di Giuseppe Verdi nella versione di Milano 1884. È la prima volta che il Festival di Parma allestisce Don Carlo e sceglie la versione più breve che il compositore rivide per le recite alla Scala. E’ da augurarsi che questa sia la prima tappa dell’opera a Parma, che mancava dalla stagione 1998, poiché il Festival avrebbe il dovere di farci ascoltare e vedere anche le altre versioni dell’opera a cominciare dall’originale in francese e con balletto di Parigi 1867, e in seguito, magari, le cinque diverse alternativi: originale e integrale (in francese) precedente i tagli effettuati anteriormente alla prima rappresentazione 1866, la partitura pubblicata nel 1867 in cinque atti con balletto (in francese), la versione di Napoli 1872 (in italiano), la versione di Modena 1886 in cinque atti senza balletto (in italiano). Nessun’altra opera di Verdi raccoglie tanto materiale variegato alternativo o sostitutivo, e ogni volta che non si sceglie la versione di Milano, che moltoi considerano erroneamente “la definitiva”, siamo di fronte a versioni “collage” con tagli e aggiunte arbitrarie secondo le ispirazioni dei direttori. Il Festival Verdi avrebbe il compito di rappresentare le molteplici versioni. Delude il nuovo allestimento di Cesare Lievi, il quale si avvale di un valido scenografo e costumista come Maurizio Balò. Egli ha ideato una scena anche suggestiva, pur con qualche scivolata nel ricreare le tombe degli Asburgo all’Escorial di marmo bianco e la cartina geografica nello studio di Filippo che traccia l’Impero con errori di conquista. I costumi sono belli e in linea con la cattolicissima e austera corte spagnola del tempo. Bizzarro il mantello cappotto di Filippo con tanto di collo in pelliccia che parafrasava una moda molto più recente. Tuttavia è la scelta registica a penalizzare lo spettacolo, con scelte non solo discutibili, talvolta stravaganti e del tutto fuori linea nella situazione storica, e la mancanza di caratterizzazione dei personaggi, i quali sono complessi ma molto precisi nella visione dell’autore. A questo si devono aggiungere scene del tutto superflue, in particolare il frate che pulisce il pavimento delle tombe nella prima scena, il ridicolo balletto delle damigelle durante l’esecuzione della “Canzone del velo”, e l’inutile presenza di Elisabetta nell’assolo di Filippo all’inizio del III atto. A questo va detto che il regista, pur dovendo osare di più, ha avuto anche idee molto apprezzabili nella seconda scena del II atto (piazza di Nostra Signora d’Atocha) quando nella sfilata dei carri degli eretici appare anche un carro colmo di libri (volumi di cultura eretica) e nel momento in cui Filippo esclama riv “Disarmato sia”, i deputati fiamminghi bloccano le guardie che avrebbero dovuto eseguire l’ordine. Nel complesso uno spettacolo visibile ma che ci saremo aspettati più incisivo e “scolpito” drammaturgicamente. L’Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” non era nella forma ideale della sua fama e Daniel Oren non concertava con dovuta perizia che solitamente usa in altri repertori, disordinato nel gesto, sbiadito nei colori e con piatte dinamiche orchestrali. Il Coro del Teatro Regio, diretto da Martino Faggiano, assolve il suo compito con buona professionalità. Il cast era piuttosto alterno, anche se la serata ha subito un’influenza negativa per un malore in scena. All’inizio del primo atto quando Don Carlo ha iniziato il duetto “Dio che nell’alma infondere” Rodrigo di Posa, Vladimir Stoyanov, si accasciava come svenuto sulla struttura di un inginocchiatoio. Portato dal collega dietro le quinte, dopo circa un quarto d’ora riprendeva il suo posto e finiva la scena, con esito non certo eccellente, ma plausibile era la situazione, il pubblico ha compreso e salutato con un caloroso applauso d’incoraggiamento. L’opera continuava senza intervallo e quando il paggio annuncia il Marchese di Posa che entra nel giardino della scena seconda, vediamo arrivare un altro cantante. Non era possibile avvisare il pubblico, si è fatto dopo l’intervallo, Stoyanov è stato sostituito da Gocha Abuladze, presente in teatro come doppio. Sul primo ovviamente non è possibile esprimere giudizi, abbiamo saputo in seguito che ha avuto un abbassamento di pressione e non era in grado di sostenere il ruolo. Del secondo, tolto l’aspetto terrorizzato iniziale (comprensibile per le circostanze improvvise in cui è stato catapultato in scena) possiamo dire che possiede voce molto bella e di buona proiezione. Nel corso dell’opera ha preso anche più vigore e sicurezza e nella seconda parte abbiamo avuto un serio e volenteroso professionista, il quale è anche in possesso di calibrato fraseggio. Sarà interessante ascoltarlo in futuro in situazioni meno burrascose. José Bros, Don Carlo, dopo una partenza buona nel corso della rappresentazione ha avuto un calo di prestazione, forse per lo scompiglio iniziale, e la resa carlo 5non è stata delle migliori rispetto allo standard dell’artista: voce sovente nasale e stentore, un limitato uso del registro acuto, il quale è emerso nella scena della Piazza di Atocha e nel finale. Essendosi fatto annunciare all’inizio del II atto non è possibile dare un giudizio reale, tuttavia non era il cantante che ben conosciamo. L’Elisabetta di Serena Farnocchia difettava per scarso carisma, assenza di colore vocale ed espressione a senso unico. Eppure la voce sarebbe interessante ma è poco proiettata e questo aggrava un canto che dovrebbe essere più lirico, ricco di sfumature e ispirato. Marianne Cornetti, Principessa Eboli, ha parecchia difficoltà nel canto fiorito della romanza del velo, inoltre le cadenze sono raffazzonate e il registro acuto parecchio compromesso. Nelle altre due scene sfodera più vigore e un accento anche più incisivo, pur non rimediando ai difetti d’impostazione generale, gli acuti sono sempre compromessi anche se si deve riconoscere una certa veemenza e un discreto temperamento. Pregevole il Grande Inquisitore di Ievgev Orlov, anche se l’accento potrebbe essere migliorato, brava Lavinia Bini, Tebaldo, frizzante e delizioso fanciullo di carlo 6buona espressione. Simon Lim era un corretto Frate e Gregory Bonfatti un eccellente Conte di Lerma e Araldo reale. Un plauso particolare va ai sei deputati fiamminghi, coesi nel canto e con voci armoniche e molto possenti. Pe correttezza li citiamo: Daniele Cusari, Andrea Goglio, Carlo Andrea Masciadri, Matteo Mazzoli, Alfredo Stefanelli e Alessandro Vandin. Infine, ma non per questo ultimo, Michele Pertusi, Filippo II, che salvo errori di chi scrive debuttava il ruolo. Il cantante ha sempre centellinato e ben calibrato, nel corso della ormai lunga carriera, le sue esibizioni in terreno verdiano. È arrivato ora, giustamente, alla soglia dei dieci lustri, ad affrontare un ruolo di basso considerato tra i più importanti per la sua corda vocale. Egli lo canta con la sua voce, tendenzialmente chiara, senza cercare inutili imitazioni. Il risultato è positivo, ed è il cantante che maggiormente ha convinto. Eccellente la scansione della parola, il ricercato fraseggio, l’espressione regale abbinata a una movenza teatrale rilevante. Nella grande aria del III atto trova accenti ed espressioni di grande pathos ritagliandosi un meritato successo personale. Vorrei aggiungere che l’assolo del violoncello nell’introduzione era superbamente eseguito dal professore dell’Orchestra Toscanini. Al termine di una recita che sarebbe potuto essere interrotta, il pubblico ha premiato il volenteroso impegno di tutta la compagnia con calorosi applausi, con punte per Pertusi, ma siamo ben lontani da una rappresentazione memorabile, ma uno spettacolo dal vivo riserva anche questi inconvenienti, stavolta è andata così.
DON CARLO [Lukas Franceschini] Parma, 5 ottobre 2016.
Il celebre grand-opéra è stato escluso dai festeggiamenti del 2001 e del 2013 e si è dovuto attingere ad un’altra produzione per la realizzazione dei cofanetti “Tutto Verdi”. Considerata la lunga attesa i melomani più agguerriti si aspettavano l’edizione integrale, magari in francese, mentre hanno dovuto accontentarsi. Lo spettacolo di Cesare Lievi è ambientato in un immaginario mausoleo di Carlo V d’Asburgo e, per come è disposto l’impianto di regia, acquisisce un maggior senso la decisione di rappresentare l’opera in quattro atti: tutto inizia e tutto finisce ai piedi della tomba dell’Imperatore, che pare rivivere attraverso un frate. In tal contesto risultano molto efficaci le scene di Maurizio Balò, ma si va a perdere completamente il fasto che dovrebbe adornare i giardini della regina e la scena dell’autodafé. Meno apprezzabili sono i costumi, sempre di Maurizio Balò, poco caratterizzati e dettagliati, con riferimenti ad una moda generica che va dal XV al XVIII secolo e visibilmente low cost. Forse la mano della sartoria è stata trattenuta dal budget a disposizione. Per quanto riguarda la parte musicale si segnalano le consuete debolezze nelle varie sezioni dei fiati della Filarmonica Arturo Toscanini, difetti non certo risolti né affievoliti dalla direzione di Daniel Oren, che è sempre Maestro di interpretazione guerresca, ma qui risulta grossolano, scoordinato e in alcuni punti fuori stile, ad esempio sembra cercare di voler trasformare in cabaletta la parte conclusiva del duetto Posa Filippo. Manca inoltre di omogeneità col palcoscenico e sembra che ognuno degli artisti canti per sé, senza uniformità e compattezza con i colleghi. José Bros, celebre tenore universalmente riconosciuto come uno dei migliori belcantisti, soprattutto nel repertorio belliniano e donizettiano, veste i panni di un Don Carlo squillantissimo e dimostra chiaramente di poter esprimere qualcosa attraverso questo ruolo se eseguito nelle giuste condizioni. In effetti si possono notare alcune piccole forzature quando orchestra e colleghi fanno la voce grossa, mentre è totalmente a suo agio nei momenti in cui può manifestare un carattere più intimo, giocato sui colori e sulle sfumature. Non è un caso che la parte migliore della serata sia l’ultimo atto, grazie anche all’interpretazione di Serena Farnocchia nel ruolo di Elisabetta. Il soprano manca di qualche accento drammatico, non ha un timbro particolarmente morbido e non possiede una zona centrale sufficientemente ampia, ma è musicalissima, tecnicamente ferrata e dotata di un’ottima linea di canto, molto omogenea. Anche il Filippo II di Michele Pertusi non ha il caratteristico spessore regale previsto per il ruolo, né la giusta autorità, tanto da sembrare sempre impaurito o in difetto al cospetto degli altri personaggi, ma ragionando in termini di canto, la sua è sempre una lezione: i suoni bellissimi, i passaggi armoniosi, i fiati lunghi, i legati addirittura commoventi, le note piegate alle parole. Ecco perché nella pagina in cui davvero deve essere atterrito e intimorito, ovvero nel quartetto con Elisabetta, Eboli e Posa, risulta eccellente oltre ogni misura.Vladimir Stoyanov, nei panni del Marchese di Posa, mostra gli stessi pregi e difetti che lo contraddistinguono negli ultimi tempi: fraseggio elegante, linea di canto raffinata, ma con un suono spesso opaco, sbiancato e talvolta addirittura sfibrato, tanto da sembrare usurato. Inoltre ci si sarebbero aspettati qualche trillo e qualche appoggiatura in più. Marianne Cornetti è una Eboli dalla vocalità molto stentorea e soprattutto intelligente, poiché sa come mascherare alcune delle sue lacune. Purtroppo solo in parte, poiché non può nascondere una linea di canto ormai zoppicante che non può, neppure con la migliore delle volontà, riuscire nella canzone del velo. Nelle altre pagine non deve affrontare le agilità, ma comunque risulta disomogenea e se non carica, il suono esce velato. Ievgen Orlov è un Grande Inquisitore eccessivamente discontinuo, che non è spendibile in Italia, tantomeno a Parma; Simon Lim è un frate accettabile, un po’ in difficoltà nelle note più estreme, sia in basso sia in alto; Lavinia Bini è un buon Tebaldo, come pure Gregory Bonfatti è un valido Conte di Lerma e Araldo Reale; efficace la Voce dal cielo di Marina Bucciarelli. Non particolarmente incisivi i deputati fiamminghi di Daniele Cusari, Andrea Goglio, Carlo Andrea Masciadri, Matteo Mazzoli, Alfredo Stefanelli, Alessandro Vandin. Buona, ma non eccellente come di consueto, la prova del Coro del Teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani.
WRITTEN ON SKIN [Lukas Franceschini] Bolzano, 7 ottobre 2016.
La Stagione d’opera edizione 2016-2017 denominata “Oper A 20-21” dell’Orchestra Haydn, intitolatala “Amore e altre crudeltà”, si è inaugurata al Teatro Comunale con la rappresentazione di Written on Skin di George Benjamin, in prima esecuzione italiana. Composta dal britannico George Benjamin è stata rappresentata in prima assoluta al Festival di Aix-en-Provence il 7 luglio 2012 diretta all’autore e con protagonisti Barbara Hannigan, Bejun Mehta e Christopher Purver. Il libretto di Martin Crimp si basa su una leggenda del trovatore Guillaume de Cabestanh, raccontata anche nel Decameron di Giovanni Boccaccio, nella quale si narra di un intreccio fra amore, erotismo, potere e morte, nell’ambiente di un ménage a trois con epilogo tragico. L’azione si svolge nel XII secolo in Provenza. Il ricco Protettore paga Il ragazzo per creare e illustrare un manoscritto sul potere della sua famiglia. Il libro e l’autore spingono alla sollevazione della quieta moglie dell’Uomo, Agnes, la quale è attratta e innamorata, corrisposta dal ragazzo. Il Protettore non potendo accettare questa situazione il ragazzo e costringe Agnès a mangiarne il cuore. La moglie coerente con l’impeto di ribellione si toglie la vita piuttosto che essere ammazzata. La vicenda è osservata da tre “Angeli” che commentano l’azione dal punto di vista dei nostri giorni. Il successo dell’opera, che in cinque anni conta già altrettanti diversi allestimenti, ha spinto la Royal Opera House Covent Garden (ove fu eseguita la prima ripresa) di Londra, a commissionare una nuova opera a Crimp e Benjamin, che dovrebbe essere rappresentata nel 2018, il cui titolo non è ancora noto. Le musiche di Benjamin, di grande fattura ed eseguite dall’orchestra posta sul palcoscenico ma dietro la scena e quasi nascosta, sono una serie di continui raffinati colori orchestrali e d’ingegnose invenzioni timbriche, anche attraverso l’ausilio di strumenti peculiari come la glassarmonica, la viola da gamba bassa, due mandolini, un campanaccio e percussioni sullo steel drums (tubi d’acciaio). La sonorità è molto altalenante, costituendo un giusto written 4equilibrio tra le sfaccettature drammatiche della vicenda. La musica non si pone sul concetto del bello, ci obbliga invece all’ascolto nell’inserimento di un contesto, qui tragico, e proviene da dietro volutamente per segnare che arriva allo spettatore da “dentro” i personaggi. Dovremo definire coraggiosa la scelta del direttore artistico di Bolzano, Matthias Losek, nel presentare un titolo cosi particolare nella compagine di una stagione d’opera fuori dai circuiti di musica contemporanea, ma occorre rilevare che l’Orchestra Haydn, cha da qualche tempo intrapreso un cammino musicale odierno, è posta oggi in tal senso come punto di riferimento nazionale. Bellissimo lo spettacolo creato dal regista Nicola Raab, assieme alla costumista e scenografa Mirella Weingarten e Andreas Volk (light designer). Si sono immaginati due mondi uno reale e uno immaginario o storico. Due grandi specchi contrapposti, che rappresentano l’uomo di oggi, invadono la scena nuda nella quale interagiscono una doppia quindicina di comparse, un popolo, una società muta che fa da spettatore e protagonista della vicenda, a seconda da che prospettiva si voglia osservare. Elettrizzante la mano registica nella drammaturgia di un testo raffinato della terribile vicenda, che parafrasando il titolo, è sulla protagonista femminile che traccia il segno, appunto “scritto”. Si rappresenta e si amplifica un aspetto dell’essere odierno, il teatro di oggi non racconta, non insegna, piuttosto si magnificano le angosce. Eccezionale la professionalità dell’Orchestra Haydn, diretta dal validissimo Rossen Gergov, i quali trovano una written 6sintesi e comunicativa musicale rilevante, in particolare equilibrando le eccessive sonorità della partitura. Le difficoltà di esecuzione sono risolte in maniera appropriata e cristallina, mai perdendo come filo conduttore il libretto. Bravi anche i tre solisti, Vera-Lotte Bocker è un’Agnès con timbro raffinato e delicatissimo e altera nel fraseggio. Vocalità solida e incisiva per Andrew Schroeder, brillante e spietato Protettore. Ancor più lodi meriterebbe il controtenore Bernhard Landauer, The Boy e primo Angelo, per una voce fortunatamente molto incisiva e duttile, non fastidiosa, in un timbro unico ma sfaccettata e risolta nel doppio ruolo, ora seducente poi distaccato. Bravi anche gli altri due interpreti Anna Werle, secondo Angelo e Marie, e Daniel Ralphsson, terso Angelo e John.Teatro affollatissimo, cosa rara per un titolo così contemporaneo, e successo entusiasmante al termine, pienamene meritato. Peccato che questa produzione “nasca e muoia” nella città del Sud-Tirolo.
UN BALLO IN MASCHERA [William Fratti] Piacenza, 7 ottobre 2016.
Come di consueto il Teatro Municipale di Piacenza inaugura la nuova stagione con una produzione realizzata nell’ambito del Progetto Opera Laboratorio. Il celebre baritono Leo Nucci è sempre il capitano della grande squadra e in questa occasione si cimenta con la regia di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, che risulta essere davvero deliziosa. È molto classica, didascalica, ma viva e intensa, ricca di emozioni soprattutto nei gesti e negli sguardi. Con la collaborazione di Salvo Piro, le belle scene di Carlo Centolavigna e i curatissimi costumi di Artemio Cabassi, Leo Nucci crea dei momenti davvero suggestivi, come la scena nell’antro di Ulrica e l’intero atto de “l’orrido campo”, la cui atmosfera è ulteriormente impreziosita dalle luci significative di Claudio Schmid. Purtroppo il palcoscenico piacentino funziona ancora a chiodi e martello e lo spettacolo prevede tre pause, con grande disappunto di molti intervenuti. L’ambito musicale è meno convincente. Donato Renzetti sembra avere perso la precisione di un tempo. Non è la prima volta che dà questa impressione e non è chiaro se si tratta di un segno di stanchezza o di troppo lavoro. Resta sempre uno dei migliori direttori verdiani nelle pagine in cui bisogna dare, come nei concertati che chiudono la prima e la seconda scena di primo atto, ma nei momenti più sottili, ad esempio il preludio, si sentono tutti i difetti. E così l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini parte con dei suoni abbastanza spiacevoli, per poi migliorare lungo la serata. È invece sempre eccellente il Coro del Teatro Municipale di Piacenza guidato da Corrado Casati. Il protagonista è Vincenzo Costanzo e l’impressione che si ha è sempre la medesima, senza alcun segno di miglioramento negli ultimi mesi. Voce naturalmente bellissima, colore e timbro caldi e piacevoli, ma tecnicamente non sicuro, poco consistente nei centri e affaticato nella zona più bassa. C’è qualche bell’acuto, ma sembra essere messo lì da solo, al di fuori di una linea di canto, che è pressoché assente. Amelia è Susanna Branchini, che dimostra grande volontà nel voler tenere a bada la sua voce particolarmente stentorea, ma riuscendovi solo a tratti. Vengono così a mancare quasi tutti i piani e le sfumature della primadonna verdiana. Si notano miglioramenti, rispetto al passato, nell’appoggio e nell’intonazione. Renato è interpretato da Mansoo Kim, sempre squillante, ma in questa occasione appare un poco insicuro e in alcuni momenti addirittura calante. Considerando i buoni risultati degli ultimi tempi potrebbe essere un’indisposizione temporanea. Paola Leoci è un Oscar frizzante al punto giusto. La vocalità leggera è ben adoperata e le incertezze iniziali, forse imputabili all’emozione, poi scompaiono col procedere della recita. Ulrica è Agostina Smimmero, mezzosoprano dal timbro davvero interessante, soprattutto si riscontra una base solida nell’intonazione e ogni nota è emessa senza alcuna difficoltà. Purtroppo è molto disomogenea e grossolana, con una dizione incomprensibile. Lo strumento sembra essere ottimo pertanto, messa nelle mani di un buon insegnate, otterrebbe certamente i giusti risultati. Efficaci e adeguati i personaggi di contorno: il Silvano di Giovanni Tiralongo, il Samuel di Mariano Buccino, il Tom di Cristian Saitta e il giudice e servo di Amelia di Raffaele Feo. Scroscianti applausi al termine della recita da parte del pubblico piacentino che decreta il successo dell’inaugurazione.
ROSMONDA D’INGHILTERRA [Renata Fantoni e William Fratti] Firenze, 12 ottobre 2016.
L’Opera di Firenze ha aperto la Stagione 2016/2017 nel migliore dei modi, con due bellissimi titoli del belcanto italiano, di cui uno di raro, con compagnie di artisti di alto livello e un mini festival dedicato proprio allo stile di canto del primo Ottocento. Rosmonda d’Inghilterra, riesumata dal suo lungo e ingiustificato oblio solo negli anni Settanta a Londra e Belfast per poi ricomparire un ventennio più tardi in una registrazione di Opera Rara, è stata oggetto di una revisione critica sull’autografo a cura di Alberto Sonzogni per la Fondazione Donizetti di Bergamo ed è eseguita a Firenze per la prima volta in Italia in tempi moderni e sarà rappresentata in forma scenica a fine novembre proprio sul palcoscenico bergamasco in occasione del Festival dedicato al compositore. Nel capoluogo toscano si è potuto godere in anteprima della bellissima musica drammatica donizettiana ed è stato un grande successo sotto ogni punto di vista. L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino è in forma smagliante. Suoni puliti, saldi dove occorre, delicati nei momenti più patetici, precisi ad ogni attacco. Sul podio è Sebastiano Rolli, un affezionato del repertorio di Donizetti, di cui va premiato lo stile. Volendo cercare il pelo nell’uovo si sarebbe preferita qualche marcatura d’accento in più. Sempre eccellente il Coro preparato da Lorenzo Fratini, soprattutto nella pagina affidata al solo comparto maschile che precede il finale secondo: “Ecco gl’antichi platani”. Protagonista è Jessica Pratt, certamente una delle migliori interpreti del belcanto italiano di questo momento. La sua Rosmonda è speranzosa, poi disperata, affranta ed infine rassegnata. Le note sono deliziose, fino ai temibili sovracuti. La parte le sta a pennello e riprendendola tra poco più di un mese le permetterà di aggiungere ulteriori sfumature. Seconda donna, che in quest’opera ha il compito di concludere il dramma, è la Leonora di Eva Mei, regina nel personaggio e regina indiscussa del belcanto. Lo stile è raffinatissimo, la classe è impagabile, la linea di canto sempre uniforme, anche nei fraseggi più complessi dove forse si sarebbe preferita una vocalità più ampia e corposa. Ma a parte ciò la sua è una lezione di metodo e di dedizione allo studio. Michael Spyres è un Enrico II davvero efficacissimo. La sua vocalità da baritenore gli permette un’estensione che all’ascolto è davvero piacevole, poiché molto omogeneo anche nell’emissione, che non perde mai di volume nelle note basse, né necessita di essere spinta vero l’alto. È dunque fluido, limpido e squillante, in grado di produrre colori e pianissimi davvero emozionanti. Clifford è Nicola Ulivieri, altro grande interprete del belcanto italiano, che qui riconferma l’eleganza del suo stile, l’eloquenza del suo fraseggio, la capacità d’accento, l’ottimo uso dei cromatismi. Raffaella Lupinacci veste i panni di un Arturo servizievole e innamorato. Della sua vocalità, oltre al bel timbro, colpiscono i suoni sempre pulitissimi e la particolare uniformità della linea di canto. Grande successo per tutti al termine del concerto, con numerose e meritate chiamate alla ribalta.
I MASNADIERI [William Fratti] Busseto, 14 ottobre 2016.
L’efficacissimo spettacolo creato da Leo Muscato per il Festival del Bicentenario è riallestito nel piccolo Teatro Verdi di Busseto, ma non perde il suo romanticismo, né la sua ambientazione suggestiva. Dunque sempre d’effetto sono le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi, ma soprattutto ancora valido ed espressivo è il lavoro di regia svolto sui personaggi, dai solisti, al coro e ai mimi. Il talentuoso Simon Krecic è alla guida dell’Orchestra dell’Opera Italiana e dimostra mano salda e sicura, stile aggraziato, ma soprattutto ottima capacità d’espressione. Lo spartito è letto ed eseguito molto correttamente, coi giusti accenti e colori. L’orchestra lo segue con buon vigore, anche se in alcuni punti si notano dei piccoli errori commessi dai singoli strumentisti. Eccellente è la prova del Coro del Teatro Regio preparato da Martino Faggiani, sia nel canto, sia nell’interpretazione scenica. I solisti della produzione sono stati selezionati tra i finalisti del Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto e gli allievi della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna. Il giovane debuttante Giovanni Maria Palmia ha tutte le carte in regola per crescere e diventare un bravo tenore, un artista pieno, purché continui la sua preparazione e non venga affrettato da qualche agente privo di scrupoli. Appoggio e intonazione, centri e acuti squillanti, pastosità del timbro sono i suoi segni distintivi. Gli occorrono una maggior uniformità e gusto nel porsi. Accanto al suo Carlo è l’Amalia di Adriana Iozzia, voce interessantissima e particolarmente corposa in centro. È a tratti un poco disomogenea e in alto il suono è spesso acidulo, ma lavorando sulla morbidezza e sull’uso dei fiati per ciò che riguarda i piani, può certamente ottenere buoni risultati. Il ruolo di Francesco è interpretato da Leon Kim che appare un cantante già completo a tutti gli effetti. timbro brillante, vocalità squillante, fraseggio espressivo, buona capacità d’accento. In questa parte deve migliorare solo la pronuncia delle doppie. George Andguladze è solista in carriera, che a Parma e Busseto ha già cantato in diverse occasioni. Il suo Massimiliano dimostra grandi miglioramenti in termini di musicalità e di interpretazione, ma la vocalità resta pur sempre di poco spessore. Probabilmente l’età e la maturità gli daranno naturalmente ciò che gli occorre. Pietro Toscano è un Moser piuttosto inefficacie. Il suo giudizio dovrebbe sovrastare la disperazione di Francesco, sia vocalmente, sia scenicamente, mentre ne resta sempre al di sotto. Manuel Rodriguez Remiro è un Arminio abbastanza debole, mentre Jangmin Kong è un Rolla adeguato. Grandi applausi per tutti al termine della serata.
LA BOHÈME [Margherita Panarelli] Torino, 15 ottobre 2016.
Il Teatro Regio di Torino inaugura la Stagione 2016/17 con un nuovo allestimento de “La Bohème” di Giacomo Puccini, in occasione del 120° anniversario della prima esecuzione dell’amatissima opera del compositore lucchese. Il legame de “La Bohème” con il Teatro Regio è profondo e dura dal 1° febbraio 1896 poiché fu proprio il teatro torinese ad ospitarne la prima rappresentazione. Per celebrare l’anniversario a creare un nuovo allestimento è stato chiamato Àlex Ollé celebre regista de La Fura dels Baus il collettivo teatrale catalano che dal 1979 ha fatto irruzione nel mondo del teatro con la loro creatività e la ricerca costante di nuovi mezzi espressivi. Considerata infatti l’appartenenza del regista al gruppo e i precedenti lavori, le aspettative erano altissime ma la messa in scena è invece debole e nonostante alcuni interessanti espedienti non lascia il segno e non aggiunge nulla di nuovo nell’affollato panorama degli allestimenti di quest’opera. Unico vero pregio, oltre all’affascinante incastro delle scenografie di Alfons Flores, è l’aver avvicinato ulteriormente dal punto di vista emotivo la vicenda alla vita moderna. Ogni studente universitario di belle speranze e giovane artista precario si è potuto senza dubbio identificare maggiormente con i ragazzi protagonisti della vicenda che se la regia l’avesse ambientata all’epoca descritta nel libretto, e sicuramente il tremendo male di cui muore Mimì in questo allestimento è più conosciuto agli spettatori attuali della tisi. Questo approccio però rischia di far incontrare in maniera troppo ravvicinata la vita reale e la vicenda teatrale, che secondo i precetti dell’arte scenica deve sì emozionare per dare la possibilità di empatizzare con i personaggi e far riflettere, ma anche rappresentare una pausa, una diversione dalla realtà. Per chi scrive, questo elemento non è stato di disturbo, ma è indubbio che parte della cosiddetta “magia del teatro” venga meno in questo caso, in particolar modo visto che nonostante una veste estetica interessante questo allestimento risulta vuoto e perfino ordinario. Il tutto è ambientato in una periferia urbana, ricreata con un fitto reticolato metallico, che ricorda visivamente quella torinese, buia e senza vita, animata solo dai nostri protagonisti. Il secondo quadro si riempe di persone e colori e la gestione delle masse risulta dispersiva ma è l’atto più efficace dal punto di vista registico. Gli occhiolini all’attualità con i venditori ambulanti di colore e la Ritirata sostituita da banda e majorettes, diversificano e vivacizzano l’allestimento. Sul versante musicale, con il secondo cast di questa produzione, i risultati sono di gran lunga migliori. Erika Grimaldi, Mimì, ha timbro corposo e pastoso ma capace di luminosità in acuto quando necessario, con un’ottima padronanza dello strumento in tutti i registri, specialmente in occasione di pianissimi e messe di voce. A partire da “Si, mi chiamano Mimì” il soprano delizia e incanta e in “Donde lieta uscì” l’emissione omogenea, l’eccellente controllo del fiato e l’utilizzo calibrato di tutte le qualità del suo strumento conquistano e commuovono. Squisita anche la sua interpretazione di “Sono andati, fingevo di dormire”. Iván Ayón Rivas, giovane e molto promettente tenore peruviano, caratterizza inizialmente il suo Rodolfo con un canto guascone e sfacciato, che inizialmente contrasta con l’usuale ritratto da goffo e un po’ inetto sognatore cui siamo abituati. “Che gelida manina” risulta così sgraziata e quasi vanitosa, ma messa in prospettiva all’intera performance ecco che acquista un carattere più preciso, questo Rodolfo è semplicemente più realista. Vocalmente sicuro e dotato di un timbro di grande fascino, Rivas convince appieno nel ruolo e risulta particolarmente efficace nel terzo quadro dove lo squillo del suo strumento dal fascino naturale, si unisce ad un più competente uso dello stesso. Francesca Sassu è una Musetta spumeggiante e la sua performance vocale è altrettanto, se non più elettrizzante, di quella attoriale. Il suo timbro quasi pungente, cristallino, si adatta perfettamente agli aspetti graffianti del personaggio, e si presta anche ad effusioni più liriche quando richiesto. Simone Del Savio è un Marcello di tutto rispetto, l’emissione è solida e il timbro accattivante, le sue interazioni con la Musetta di Francesca Sassu peraltro riescono ottimamente. Buona ma non particolarmente memorabile l’interpretazione di Schaunard di Benjamin Cho, mentre dimostra ulteriormente il proprio valore Gabriele Sagona nei panni di Colline – eccellente il suo “Vecchia Zimarra”. Efficaci anche le interpretazioni di Matteo Peirone nei ruoli di Benoît e Alcindoro. Buoni anche i risultati raggiunti da Cullen Gandy, Marco Sportelli e Riccardo Mattiotto rispettivamente Parpignol e i due doganieri e sempre in splendida forma il Coro del Teatro Regio. Si riconoscono nella direzione di Gianandrea Noseda un totale asservimento al dramma, eccellente sostegno ai solisti e al coro, ed una grande attenzione agli effetti sonori ricreati da Puccini per raccontare Parigi, di cui questa partitura è disseminata. La solidità del gesto, poco propenso a facili melensaggini, in particolare in questo repertorio, che però non rifugge dall’abbandonarsi all’espressione delle emozioni raccontate, rendono la lettura di Noseda della partitura pucciniana particolarmente intensa e ricca di pathos. Qualità di cui del resto il direttore musicale del Teatro Regio ha ormai ampiamente dato prova. Applausi convinti per tutti gli interpreti da parte di un teatro quasi completamente gremito per una rappresentazione di eccellente qualità nonostante le carenze riscontrate.
IL MEDICO DEI PAZZI [Lukas Franceschini] Venezia, 23 ottobre 2016.
L’ultimo titolo della stagione d’opera del Teatro La Fenice è stato Il medico dei pazzi di Giorgio Battistelli, allestito al Teatro Malibran in una nuova produzione e in prima nazionale dopo il felice debutto all’Opéra National de Lorraine di Nancy il 20 giugno 2014. Giorgio Battistelli è il più famoso e probabilmente importante compositore italiano contemporaneo che vanta un catalogo operistico di quasi quaranta titoli. Il suo ultimo successo è Co2, composto su commissione del Teatro alla Scala lo scorso anno in occasione dell’Expo di Milano, del quale abbiamo dato resoconto su queste pagine.Il titolo dell’opera ci riporta inevitabilmente al celeberrimo film con il Principe De Curtis, Totò, il cui soggetto deriva dall’altrettanto famosa commedia di Eduardo Scarpetta. Classica commedia “napoletana” con tutti i luoghi comuni espressi dai personaggi, ma l’elemento principale è una sottile e bieca dimostrazione di quanto sia effimero il confine tra normalità e follia. Non credo serva raccontare la trama, conosciuta da tutti, prevale nella commedia un marchingegno perfetto per dimostrare che volendo si può far credere quello che non è. Infatti, il nipote Ciccillo fa credere allo zio medico 3Felice che una pensione-albergo è invece un manicomio. Arguta e fluente la riduzione in libretto curata dallo stesso autore musicale, il quale ha una frequenza prolifica con titoli cinematografici, uno degli ultimi visti “Divorzio all’italiana” a Bologna qualche anno fa. La scrittura musicale è vorticosa e incalzante facendo leva spesso sulle percussioni e imponendo ai cantanti uno stile molto diversificato che spazia dal declamato al puro lirismo vocale. È una musica brillante, piacevole, e con un gusto moderno senza abusare di linguaggi troppo “attuali” preferendo una scrittura di raffinata inventiva, il quale mi fa apprezzare Battistelli in molte sue opere. Il compositore con gusto istrionico fa il verso d’omaggio a capolavori del passato (Traviata, Otello, Falstaff). L’unico aspetto che ha destato perplessità è stato il timbro talvolta molto acceso a discapito delle voci, ma è forse opinione scaturita da un primo ascolto. Francesco Saponaro, regista e scenografo, firma una felicissima produzione. Una semplice ma funzionale scena fissa, che si sposa perfettamente con il ridotto palcoscenico, tiene il gioco della commedia incalzante e mai statica. La mano del regista è superlativa nel tracciare una recitazione brillante sulla vorticosa commedia, mai un momento fermo e tutto calibrato alla perfezionemedico 4 in una drammaturgia cronometrica. Un grande lavoro teatrale di sapiente genialità. Ambientazione stile commedia all’italiana anni ’50 spassosa, cui si aggiungono i meravigliosi costumi di Carlos Tieppo, al quale se messo a disposizione un giusto apporto e budget sa essere bravo artista. Altro artefice della riuscita di questo godibile spettacolo e stato Cesare Accetta, un disegnatore luci di grande professionalità. La parte musicale era condotta con mano sicura da Francesco Lanzillotta, coadiuvato dalla brava orchestra del Teatro La Fenice, in una lettura che teneva il passo al ritmo della partitura, sfoggiando ottimi tempi e una serrata conduzione drammaturgica. Ben preparto da Claudio Marino Moretti il Coro che offre una prova al di sopra di molte altre produzioni di repertorio. Efficace la compagnia scritturata per l’occasione, attenta ai dettami musicali con sicura e precisa professionalità ma ancor più straordinaria era la resa teatrale. Si sono distinti in particolare Marco Filippo Romano, Felice Scosciammocca, Filippo Fontana, Raffaele e Milena Storti, Amalia, ma tutti meritano un plauso per un lavoro di alta qualità: Damiana Mizzi (Rosina), Adriana medico 5Donadelli (Bettina/Carmela), Lorina Castellano (Concetta), Seggio Vitale (Ciccillo), Giuseppe Talamo (Michelino), Maurizio Pace (Errico), Mattero Ferrara (Luigi) e Clemente Antonio Daliotti (Carlo). Teatro con grande presenza di pubblico, cosa sovente rara per un’opera contemporanea, che al termine ha decretato un sincero trionfo, meritato, a tutta la compagnia.
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM [Marco Benetti] Como, 23 ottobre 2016
Un titolo inusuale è stato quest’anno inserito nella Stagione del Teatro Sociale di Como (Circuito OperaLombardia). L’anniversario shakespeariano che si sta celebrando un po’ ovunque ha certamente favorito la scelta, caduta su A Midsummer Night’s Dream di Benjamin Britten, dall’omonima commedia del Bardo. Per l’occasione è stata ripresa la storica regia ideata da Elio De Capitani per il Teatro Elfo- Puccini di Milano, mentre per la parte musicale ci si è affidati come di consueto all’Orchestra I Pomeriggi musicali, diretta da Francesco Cilluffo. La celebre commedia, che mescola al suo interno le vicende di due coppie di giovani nobili ateniesi, le trame ordite dalle magiche creature che di notte popolano i boschi nei dintorni della capitale greca e le maldestre prove di uno spettacolo teatrale da parte di un gruppo di artigiani, è stata ridotta a libretto dallo stesso Britten, con l’aiuto dall’amato compagno Peter Pears. Musicalmente i tre mondi vengono sapientemente caratterizzati da scelte timbriche accurate. Così le coppie di amanti sono spesso impegnate in recitativi accompagnati dalle sonorità degli archi e dei fiati, il mondo notturno e fatato è affidato alle voci acute, ad arpe e clavicembalo, mentre gli artigiani sono accompagnati da fagotti e ottoni. Il personaggio che fa da ponte fra i vari mondi, cioè lo spiritello Puck, interpretato da un attore acrobata, vede i suoi interventi parlati accompagnati da timpani e trombe. Come evidenziato anche da De Capitani nelle note di sala, le soluzioni adottate da Britten nella riduzione del libretto mostrano tuttavia qualche debolezza: va infatti persa quella simmetria con cui era concepito il lavoro originale, allungando anche, nell’ultimo atto, i dialoghi tra i sovrani di Atene. La scelta registica operata da Elio De Capitani, aiutato nell’impresa da Ferdinando Bruni, che cura anche i costumi, è stata quella di riadattare per l’opera la messa in scena teatrale che veniva utilizzata, negli stessi giorni in cui andava in scena l’opera a Como, per l’originale commedia di Shakespeare. Il palcoscenico è stato trasformato da Carlo Sala, curatore delle scene, nella soffitta del palazzo dei duchi di Atene, dove di notte, come in un sogno, vengono ad incontrarsi i personaggi fantastici con esseri umani. Il cast vocale si compone di cantanti davvero validi, non solo per essersi dovuti cimentare con un titolo poco frequentato dal repertorio, ma anche per il fatto che si tratti a tutti gli effetti di musica contemporanea (la prima risale al 11 giugno 1960), nonostante la tonalità allargata impiegata nella scrittura musicale. Raffaele Pe è un Oberon davvero talentuoso, raffinato ed elegante, che sa sfruttare tutta l’espressività richiesta dalla parte, affidata da Britten ad un controtenore. Il cast vocale si compone di cantanti davvero validi, non solo per essersi dovuti cimentare con un titolo poco frequentato dal repertorio, ma anche per il fatto che si tratti a tutti gli effetti di musica contemporanea (la prima risale al 11 giugno 1960), nonostante la tonalità allargata impiegata nella scrittura musicale. Raffaele Pe è un Oberon davvero talentuoso, raffinato ed elegante, che sa sfruttare tutta l’espressività richiesta dalla parte, affidata da Britten ad un controtenore. Altrettanto lodevole è la Tytania di Anna Maria Sarra. Il quartetto di amanti si rivela altrettanto preparato: Alex Tsilogiannis (Lysander), Paolo Ingrasciotta (Demetrius), Cecilia Bernini (Hermia) e Angela Nisi (Helena). Davvero sbalorditivi, per qualità della concertazione e per le capacità attoriali necessarie al ruolo, i sei artigiani ovvero Zachary Altman (Bottom), Nicholas Masters (Quince), Roberto Covatta (Flute), Rocco Cavalluzzi (Snug), Claudio Grasso (Snout) e Dario Shikhmiri (Starveling). Un doveroso complimento anche ai duchi di Atene, Federico Benetti (Theseus) e Arina Alexeeva (Hippolyta). La direzione di Francesco Cilluffo, che ha probabilmente approfondito il repertorio britteniano durante i sui studi londinesi, dimostra una buonissima conoscenza dell’opera, riuscendo attraverso la sua lettura ad evidenziale gli archi tensivi su cui essa è costruita. Ne risulta un fraseggio che sa essere elegante all’occorrenza ma anche sferzante, ad esempio nell’accompagnare il testo recitato da Puck (Simone Coppo). Lo spettacolo è di per sé una bellissima produzione che fa ben sperare sui futuri allestimenti di OperaLombardia e che incoraggia a far arrivare, anche sui palcoscenici di città un poco periferiche, autori spesso ingiustamente rari nei grandi teatri.
UN BALLO IN MASCHERA [SIMONE RICCI] Roma, 23 ottobre 2016.
Il Teatro Costanzi ha deciso di puntare su un nuovo allestimento in coproduzione con la Svezia, paese scelto anche per l’ambientazione della storia. Passeggiando sul Lungotevere romano in direzione del Centro ci si imbatte in una fontana non più funzionante con una scritta che ricorda, tra le altre, la prima rappresentazione di “Un ballo in maschera” a Roma nel 1859. Allora gli spettatori della Capitale dovevano recarsi allo scomparso Teatro Apollo per assistere agli spettacoli, mentre oggi il simbolo della lirica romana si trova a tre chilometri di distanza. Per concludere la stagione 2015-2016 il Teatro dell’Opera di Roma ha scelto proprio il melodramma di Giuseppe Verdi, puntando sull’ambientazione svedese della storia. Questa recensione si riferisce alla replica di domenica 23 ottobre 2016. La regia di Leo Muscato ha sfruttato un nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Malmö: dunque, niente Boston, niente Riccardo e niente Renato, ma spazio a quelle che erano le intenzioni originarie di Verdi con la Svezia di fine ‘700. Personalmente preferisco la versione americana di quest’opera, ma riscoprire di tanto in tanto il libretto bocciato dalle censure del XIX secolo non fa certo male. Si è cercato di riprodurre una sorta di favola incantata, ma dal finale tragico: durante il breve preludio sono state proiettate delle frasi tipicamente fiabesche (“C’era una volta un Re…”), poi si è dato spazio a una corte più buffa del solito, con personaggi stravaganti e dagli abiti bizzarri ancor prima del ballo. Le scene di Federica Parolini e i costumi di Silvia Aymonino non erano caratterizzati dall’ansia di riprodurre con eccessiva fedeltà storica la Svezia di oltre due secoli fa: spesso abbondavano il bianco e il nero tra i colori, ma non sono mancati i toni più vivaci e sfarzosi per non incupire troppo l’ambientazione. Il pubblico romano ha tributato grandi applausi ad Angelo Villari, a suo agio nel ruolo di Re Gustavo (Riccardo per chi è affezionato alla storia americana). Si tratta di uno dei ruoli più variegati e “ruvidi” dell’intera letteratura verdiana, ma il tenore messinese è riuscito a risolverlo ottimamente. La sua resa artistica ha puntato soprattutto sullo scavo della frase e la sua performance ha convinto anche riguardo alla nettezza e varietà di accenti. Ma se m’è forza perderti e il duetto d’amore con Amelia, in particolare, sono stati momenti piuttosto coinvolgenti. Meno brillante è stata Julianna Di Giacomo: nella sua Amelia si sono notate alcune imperfezioni relative al fraseggio e un acuto poco convincente e al limite della stonatura mentre si aggirava nell'”orrido campo”. Queste situazioni sono state comunque compensate dall’emissione ben proiettata nei centri e da un Morrò, ma prima in grazia di intensa drammaticità. Gli spettatori hanno tributato il giusto riconoscimento a Lucrezia Drei, un Oscar allegro, vitale e in grado di conferire il giusto brio al racconto. Il soprano milanese ha saputo sottolineare bene dal punto di vista visivo la spigliatezza e l’innocenza fanciullesca del personaggio. Inoltre, la sua voce si è fatta apprezzare per le interessanti aperture liriche, senza leziosità, ma sempre all’insegna della freschezza: tra l’altro, ha stupito il pubblico con due piroette perfette. Il Capitano Anckarström (Renato) di Juan Jesús Rodríguez è stato reso al meglio dal punto di vista scenico, con una immedesimazione adeguata nei tormenti interiori del migliore amico del Re: buoni, al limite dell’ottimo, alcuni cantabili, ha dimostrato di saper gestire al meglio la vocalità del tipico baritono verdiano. Sara Murphy, invece, era una indovina (Arvidson-Ulrica) capace di controllare con cura l’emissione, oltre a una attenta gestione del registro grave. Alessio Cacciamani (Conte Horn-Samuel) e Dario Russo (Conte Ribbing-Tom) avevano la giusta spavalderia e cupezza, anche se si sono confusi un po’ troppo nella folla del ballo nei momenti finali dell’opera. Le performance del resto del cast sono state precise e discrete, a partire da Gianfranco Montresor (Christian, un marinaio), di buona presenza scenica, senza dimenticare il giudice di Gianluca Floris e il servo di Amelia di Giordano Massaro. Jesús López Cobos ha diretto l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma cercando di non strafare con le accensioni fragorose tipiche di “Un ballo in maschera”. In questo modo, però, non sono stati gustati pienamente i momenti lirici del melodramma. La breve sinfonia ha fatto registrare qualche accelerazione di troppo, mentre è andata decisamente meglio con il finale del secondo atto. Il coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto come di consueto da Roberto Gabbiani, era visivamente e musicalmente sempre attento a sottolineare sia i momenti intensi che quelli più spensierati del libretto. Il pubblico romano ha dimostrato di aver gradito il risultato finale con lunghi e convinti applausi e sicuramente ora attenderà altri lavori di qualità per quel che riguarda la stagione 2016-2017 che inizierà tra un mese.
IL TROVATORE [Lukas Franceschini] Parma, 27 ottobre 2016.
Deludente nuova produzione de Il Trovatore al Verdi Festival di Parma, del quale non ci sono elementi da salvare o ricordare e speriamo che questa sia stata una parentesi accidentale. Il Trovatore è stata una delle opere più rappresentate al Festival sin dalla sua prima edizione nel 1990, gli esiti sono sempre stati positivi con picchi particolari in alcune edizioni, ma una discesa così indicativa come nell’attuale manifestazione non si ricordava. Il terribile spettacolo ideato da Elisabetta Courir, assieme allo scenografo Marco Rossi e alla costumista Marta Del Fabbro, ci ha lasciati così spiazzati che è difficile anche farne una cronaca. Non è possibile parlare di allestimento poiché le sole scure e spoglie tribune girevoli non possono essere considerate scenografia, anche se firmata, senza avere una benché minima logica o affinità con la vicenda; potevamo assistere a un titolo operistico qualunque. La regia della Courir era del tutto assente non trovando una drammaturgia non solo efficace ma almeno accettabile. Lei trova soluzioni che lasciano perplessi, per non dire infastiditi, utilizzando una serie di mini, peraltro bravi, ma che nulla hanno a che fare con l’opera. Verrebbe da pensare per mancanza d’idee. Leonora all’entrata del I atto era accompagnata da alcune ancelle, coperte da un velo nero, la cui visione portava subito a pensare a un burka. Nell’accampamento degli zingari quando Azucena canta “Stride la vampa” assistiamo a una coreografia statica con passaggio di pugnali, nel finale atto II i soldati del conte ipotizzano una violenza sessuale sulle suore del convento, a una sono strappati gli occhiali rendendola così “cieca” alla berlina dei sadici militari. All’inizio del terzo atto gli stessi soldati cantano “Squilli echeggi” andando a ritrovare i loro anfibi posti in fila sul proscenio. Mancava completamente un’idea plausibile in questo Trovatore, che è passato in una lunga e fastidiosa visione. I costumi erano tutti scuri, i soldati e il conte in grigio, anonimi e senza traccia, con alcune bizzarrie come la sciarpa rossa di Manrico annodata come si usa oggi. Luci tetre e non sempre azzeccate di Giuseppe Ruggiero, movimenti statici e per nulla accattivanti di Michele Merola. Da dimenticare. Massimo Zanetti, a capo della Filarmonica “A. Toscanini” non si stacca da una lettura tradizionale ma in molti punti sovente scivolata in sonorità troppo accese e tempi dilatati, questi ultimi forse necessari per soccorrere taluni cantanti. È doveroso rilevare che non avendo a disposizione un cast preciso e sicuro egli ha dovuto anche barattare compromessi, portando a termine una recita difficile ma onesta. Molto bravo il Coro del Teatro Regio, istruito da Martino Faggiani, che ha fornito non solo prova di ottima professionalità ma efficacia d’assieme e grande musicalità. Nel cast la sola Enkelejda Shkosa, Azucena, ha fornito una prova convincente per accento, colore e fraseggio sempre controllati e pertinenti, utilizzando un mezzo vocale di valore. Penalizzata dalla regia, come tutti gli altri, ha tuttavia abusato nei suoni di petto, pratica raramente da lei utilizzata. Il protagonista, il tenore Murat Karahan, ha nel suo carniere solo un facile utilizzo del registro acuto tanto da svettare nella pira, senza da capo, e prendersi un applauso scrosciante. Tutto il resto era sprecato in un canto aperto, senza sfumature e fraseggio, incapace di piegare uno strumento anche valido ma che necessita ancora di tanto studio. La Leonora di Dinara Alieva era risolta in una piatta correttezza. Il timbro è piuttosto aspro e poco seducente, tenta qualche fraseggio riuscito, ma l’incisività è quasi assente. Inoltre, durante il canto continua a muoversi come in una sorta di ballo, questa pratica porterebbe a pensare di scarsa attitudine tecnica e anche insicurezza. George Petean, Conte di Luna, avrebbe anche una bella voce, pastosa e rotonda ma piatta senza accenti e la sua prestazione passa nella classica banale routine. Senza traccia per un canto sfasato il Ferrando di Carlo Cigni, che credo non fosse stato in serata ottimale. Pertinenti gli altri artisti nelle parti minori: Carlotta Vichi (Ines), Cristiano Olivieri (Ruiz), Enrico Gaudino (vecchio zingaro) ed Enrico Paolillo (un messo). Teatro sold-out in ogni ordine di posto, con un pubblico molto molto generoso di applausi. Sono cambiati i tempi, ricordando il temibile loggione di Parma!
AIDA [William Fratti] Victoria, 27 ottobre 2016.
Nell’ambito del Festival Mediterranea di Gozo, il Teatru Astra di Victoria mette in scena Aida di Giuseppe Verdi con la regia di Enrico Stinchelli, la cui visione del grand-opéra verdiano non avviene attraverso scenografie imponenti, ma tramite le masse artistiche che, vestite di colorati e scintillanti costumi, popolano il palcoscenico in tutti i pezzi d’assieme. Efficacie anche la coreografia dorata durante il trionfo. Sul podio della Malta Philharmonic Orchestra siede Joseph Vella, che attacca il preludio col suo gesto lento e, inesorabilmente disattento a ciò che accade oltre la partitura poggiata sul suo leggio, procede incurante dell’enorme fatica che i solisti devono compiere nel prendere fiati lunghissimi o dove non sono previsti per sopravvivere allo scempio che sta compiendo sulla musica di Verdi. E allo stesso modo resta impassibile quando le diverse sezioni d’orchestra vanno per strade diverse, già dal preludio, o quando gli strumenti a fiato spezzano il suono per prendere aria, o quando i cori sono totalmente fuori tempo. Inascoltabili le trombe egizie della marcia trionfale. Insufficiente anche la prova del Teatru Astra Opera Chorus in collaborazione con il Coro Lirico Siciliano, soprattutto nella sezione femminile, guidati da Maria Frendo e Francesco Costa. Silvia Dalla Benetta, pur avendo alle spalle una carriera di oltre vent’anni, non è mai entrata nell’Olimpo seppur continui a dimostrare che, con una tecnica ferrata e uno stretto controllo dell’organo vocale, si possa fare del buon canto anche in repertori apparentemente dissimili, ma che la tradizione del Novecento ha voluto fortemente diversificare. In questi ultimi mesi è gradualmente passata dalle colorature di Meyerbeer e Auber al classicismo di Mozart e al belcanto del Bellini drammatico fino ad approdare al debutto in Aida. Considerandone la resa la si potrebbe definire un soprano assoluto. Il suo debutto nel ruolo verdiano è di grande effetto e soprattutto di intelligenza musicale: naturalmente non va a ricercare tinte o timbri che non possiede, ma gioca le carte dell’intonazione perfetta, del fraseggio elegante e del legato raffinatissimo, su una tavolozza di colori e sfumature dove il suono è sempre pulito e omogeneo, facendo uscire un personaggio diviso tra l’amore per l’uomo e l’amore per la patria, tra il timore per gli Dei e il timore per i Faraoni. Ma ciò che colpisce davvero è l’aver potuto ascoltare tutte le note, dalla prima all’ultima, anche quelle spesso omesse nei pezzi d’assieme, soprattutto nel finale secondo dove il soprano vicentino sovrasta continuamente i cori. La accompagna il valido Radames di Antonino Interisano, che possiede sempre acuti squillanti e ben posizionati in avanti. Ottima anche l’interpretazione di Sanja Anastasia, che rende una Amneris alquanto drammatica, arrivando alla grande scena del quarto atto con un impeto decisamente marcato che ne sottolinea la disperazione. La sua vocalità calza a pennello con questo tipo di ruoli, dove le tinte scure e brunite si devono sposare con un fraseggio particolarmente teatrale, per poi sfociare verso l’acuto col giusto vigore, il tutto impreziosito da una recitazione davvero emozionante. Volendo cercare il pelo nell’uovo, necessiterebbe solamente di maggior morbidezza nei momenti in cui esce dai suoni di petto. Devid Cecconi, che salvo errori debutta nel personaggio di Amonasro, esegue la parte con una perizia e un’energia davvero notevoli. Il bravo baritono aveva già dimostrato il suo smalto in recenti occasioni, tra cui Giovanna d’Arco sia al Festival Verdi di Parma, sia alla Scala. La sua sortita nel finale secondo già presagisce il nerbo di terzo atto, in cui mostra tutta la brillantezza e l’eloquenza che occorrono al breve ma importante ed intenso ruolo verdiano. Il duetto tra Dalla Benetta e Cecconi è indubbiamente la pagina migliore di tutta l’opera, in cui i due cantanti si prodigano in maniera vocalmente impeccabile. Carlo Colombara è un Ramfis autorevole; Petri Lindroos è un Re molto efficace; pure molto buona è la resa della Sacerdotessa di Georgina Stalbow e del messaggero di Frans Mangion.Scroscianti e calorosi applausi per tutti gli interpreti al termine di una lunghissima e quasi interminabile serata, con diverse acclamazioni per i quattro protagonisti.
OLIVO E PASQUALE [Lukas Franceschini] Bergamo, 28 ottobre 2016.
Il Donizetti Festival ha inaugurando alla grande, al Teatro Sociale, con una bellissima produzione di Olivo e Pasquale, opera del 1827, in nuovo allestimento ideato da Ugo Giacomazzi e Luigi di Gangi di OperaAlchemica e su una revisione sui materiali coevi a cura di Maria Chiara Bertieri per la Fondazione Donizetti. Nel 1826 Gaetano Donizetti e il librettista Jacopo Ferretti tornano a collaborare dopo tre anni dal felice esordio con L’Ajo nell’imbarazzo. Purtroppo non raggiungeranno i felici risultati precedenti poiché il libretto deriva da una commedia prolissa olivo 2che mette a confronto caratteri drammaturgici in contrasto. In assenza di un testo accattivante il compositore produsse una partitura solo a tratti geniale. Limitazioni al compositore vi furono anche in occasione della prima rappresentazione, Teatro Valle di Roma il 7 gennaio 1827, avendo a disposizione una compagnia non di prestigio, oltre a dover comporre il ruolo di Camillo, innamorato della primadonna, per un mezzosoprano. L’amoroso en-travesti era tipico dell’opera seria, basta pensare al Romeo dei Capuleti e Montecchi o ai paggi con parti anche rilevanti. Il pubblico romano trovò stridente la scelta, anche perché l’opera buffa si avvicinava in maniera incisiva alla vita realistica borghese. L’opera non fu un trionfo ma un successo di stima, anche se Donizetti non ne era olivo 3particolarmente soddisfatto. Quando l’opera fu rappresentata al Teatro Nuovo di Napoli il 1 settembre 1827, Donizetti rettificò la versione romana adattando il ruolo per tenore, e intervenne in alcuni punti dello spartito rimodellando parte della struttura ma soprattutto “napoletanizzando” l’opera, cioè dialoghi parlati in luogo dei recitativi cantati e almeno un ruolo “tradotto” in dialetto. Come riferito dalla curatrice della revisione, Maria Chiara Bertieri, per la ricostruzione di Olivo e Pasquale nelle due versioni romana e napoletana non ci si è potuto avvalere delle fonti autografe, tutt’oggi inesistenti. La versione partenopea è stata condotta su una delle partiture manoscritte che sono conservate, e la scelta è caduta su quella custodita presso il Conservatorio di Milano nella quale vi sono interventi a mano di Donizetti. Questo lavoro ha portato alla luce una partitura di qualità, che non potremo definire capolavoro, ma sicuramente piacevole e aggiunge un tassello importante nella conoscenza e nell’ascolto di uno dei massimi compositori dell’Ottocento. Donizetti è appena trentenne quando compone Olivo e Pasquale e già possiamo affermare che l’arte del mestiere la conosce, di lì a poco verranno capolavori sia comici sia drammatici di assoluta rilevanza nel corso del secolo. Nel nostro olivo 4caso i riferimenti rossiniani sono evidenti, ma con uno stile personale, che rasenta una comicità di commedia raffinata. In taluni momenti si percepiscono temi che saranno sviluppati poi, le due ore e mezzo di musica sono incalzanti e si ascoltano piacevolmente. Brillante e spassosissimo lo spettacolo creato dal duo Giacomazzi-Di Gangi, coadiuvati dal team Sara Sarzi Sartori, Daniela Bertuzzi e Arianna Delgado, per le scene e costumi. L’impronta è quella della commedia brillante con pochi oggetti ma che ben indentificano la drammaturgia. Una sena costellata da una cornice di banconote fa capire quanto il denaro sia importante per Olivo, astuto e rude commerciante, che vuole far sposare la figlia per interessi economici con Le Bross. Bellissimo l’ingresso del combinato fidanzato sulla prua di una nave. I costumi sono coloratissimi e molto curati, senza individuare un’epoca precisa ma la mano creativa e molto felice. I registi hanno curato con molta attenzione la recitazione, soprattutto i dialoghi parlati, i quali non sono mai caduti nella logora macchietta ma sono stati olivo 5realizzati con gusto teatrale e ritmo incalzante. Continue gags e guazzabugli tipici del dramma giocoso sono risolti con grande partecipazione dai cantanti e grande divertimento da parte del pubblico. Uno spettacolo divertente e godibile che speriamo non si fermi solo a Bergamo. Sul podio c’era Federico Maria Sardelli, una garanzia poiché musicista raffinato e ottimo concertatore. Fermamente convinto della genialità del compositore, valorizza con la sua direzione le diverse sfaccettature dello spartito imprimendo vivacità e leggerezza drammaturgica, minuziosa elegia nei passi romantici, perfetto rapporto tra buca e orchestra, sollecitando l’ottima Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala in una prova nitida e precisa e sempre contenuta nelle sonorità. Molto buono anche il contributo del Coro Donizetti Opera istruito da Fabio Tartari, che negli ultimi anni ha raggiunto una qualità encomiabile. La compagnia di canto era formata da alcuni artisti di lunga carriera affiancati da giovani artisti che ormai si sono affermati in importanti produzioni e che sicuramente in futuro avranno occasione di emergere ancor più. Le due voci gravi, i protagonisti Olivo e Pasquale, erano rispettivamente Bruno Taddia e Filippo Morace. Il primo dato prova di grande esperienza teatrale e buona tenuta vocale seppur non sempre precisa, ma lo stile e la musicalità erano rilevanti soprattuttoolivo 6 nell’istrionico fraseggio del rude ruolo. Anche il secondo ha reso una prestazione divertentissima, facendo sfoggio del “suo napoletano”, abbinato a un canto preciso e morbido oltre ad un raffinato accento e colore vocale. Laura Giordano, Isabella, tolto qualche incertezza nell’aria d’entrata, ha poi fornito una prova molto brillante trovando terreno particolarmente fertile in questo ruolo brillante e virtuoso accomunando anche una musicalità ferma che le permette di essere credibile nelle parti più patetiche. Ottima prova. Molto buona la prova dei due tenori principali. Pietro Adaini, Camillo, conferma in crescendo doti non comuni, affrontando un ruolo molto arduo, la prima aria è davvero terribile nel settore acuto, ma il tenore siciliano la affronta con impeto e grande tecnica, la quale gli permette di emergere anche nel secondo atto affrontando una parte per nulla facile ma con una padronanza di stile e musicalità davvero ammirevoli. Ottima prova anche per Matteo Macchioni, Le Bross, dotato di voce molto bella, chiara e di precisa intonazione e proiezione. Molto ben cantata l’aria d’ingresso, anche in questo caso non “un’arietta”, con una precisa esibizione delle agilità. Il terzo tenore, Edoardo Milletti, ha reso il ruolo del vanesio Columella con grane arte scenica accomunata a un canto preciso e brillante. Raramente anche in teatri più “grandi” si possono ascoltare tre tenori cosi bravi e la giovane età è un’aggiunta per un futuro che sarà sicuramente luminoso. Completavano il cast in ruoli minori come caratteristi Silvia Beltrami e Giovanni Romeo. Entrambi hanno fornito una prova maiuscola per brio musicale e precisa impostazione canora. A tutta la compagnia va inoltre attribuito un plauso particolare per l’ottima prova nella recitazione, priva di orpelli manierati, ma brillante e divertente grazie ad una regia pulita e molto attenta dalla giocosità del dramma. Infine, ma non per ultimo, va un plauso particolare al direttore artistico Francesco Micheli, che ha dato una svolta a un Festival che stava diventando monotono, offrendo novità e coraggio artistico che va applaudito per gli esiti raggiunti. Al termine dello spettacolo a tutta la compagnia è stato tributato un trionfo molto caloroso e meritato sotto tutti i punti di vista. La stagione del Donizetti Festival 2016 è dedicata al compianto M.o Gianandrea Gavazzeni nel ventennale della scomparsa.
DIE ZAUBERFLÖTE [Lukas Franceschini] Padova, 30 ottobre 2016.
La stagione lirica al Teatro “G. Verdi”, in collaborazione con il Teatro Sociale di Rovigo e Bassano Operafestival, si è aperta con una nuova produzione di Die Zauberflöte, curata da Federico Bertolani. Negli ultimi tempi ho assistito a diverse edizioni dell’opera mozartiana, e non sempre hanno convinto per non aver trovato il giusto equilibrio tra aspetto favolistico-fantastico e iniziazione morali e seri principi sociali, elementi imprescindibili che non possono essere ignorati. Altri percorsi troppo vicini alla psicoanalisi sovente si sono ingarbugliati autonomamente, anche se un approccio non banale e scontato nella pura narrazione fantastica è troppo limitato anche se rispettosamente identificativo. Il regista Federico Bertolani sceglie una lettura in chiave moderna, idea non nuova, ma su un parallelo di sogno o realtà. Infatti, all’inizio assistiamo alla scena dell’aggressione di Tamino in un quartiere periferico di una metropoli americana, il protagonista cade svenuto e inizia il sogno nel mondo delle dottrine positive che lo porterà ad affrontare le prove per la formazione della sua vita. Idea zau 3molto bella, ma non sufficientemente sviluppata. Non è chiaro perché Pamina si trova a soccorrere in un primo momento Tamino, la figura estrema del senza tetto Pagageno, più azzeccato il personaggio di Monostasos un poliziotto di quartiere, idea logora e abusata quella delle tre dame prostitute la cui Konig nel primo atto poteva essere loro maitresse. Il mondo di Sarastro, volutamente bianco, è ben rappresentato nella sua rettitudine identificato dal colore chiaro, come i pilastri posti ai lati della scena che potrebbero identificare la via maestra. La scena, piuttosto cruda e spoglia ma con cambi a vista attraverso pannelli apribili, è di Giulio Magnetto, il quale ha mano felice nella simmetria dell’allestimento, anche se i colori erano troppo monocromatici. Manierati e in tema con l’ambientazione i costumi di Manuel Pedretti. Resta lo spettacolo di Bertolani, che come predetto ha avuto un’idea originale (sogno) e avrebbe potuto funzionale benissimo se nel finale ci fosse stato un collante tra i due mondi, invece assistiamo al risveglio di Tamino che s’incammina con l’amata Pamina verso un mondo più consapevole e ordinato. A parte quest’impressione personale è uno spettacolo godibile, molto chiaro, che è stato molto apprezzato dal pubblico. Buona la prova dell’Orchestra di Padova e del Veneto, abbastanza precisa e con soddisfacente sonorità. La bacchetta di Giuliano Betta è stata molto attenta al rapporto buca-palcoscenico, imprimendo una lettura molto incalzante, ora di ampio respiro, ora solennemente drammatica, anche se ogni tanto si lasciato trasportare in sonorità eccessive, ma nel complesso la prova era positiva. Nel solco della routine, ma senza cadute rovinose, il Coro Lirico Veneto istruito da Sergio Balestracci. Anche il cast nel suo complesso era attendibile, pur con i diversi distinguo. Fabrizio Paesano, Tamino, è un tenore in possesso di buoni mezzi, soprattutto nella zona centrale attraverso la quale e con un buon fraseggio tratteggia un protagonista convincente. Molto brava Ekaterina Sadovnikova, Pamina, dotata di voce squisitamente lirica, ricca di accenti e sfumature che lei applica a un’interpretazione emozionante e di grande levatura. Wihelm Schwinghammer era un Sarastro solenne ma sfasato nei vari registri, pur possedendo una voce importante. La Regina della notte di Christina Poulitsi era sfavillante negli estremi acuti, fermi e ben timbrati, pertanto ha trionfato nella sua seconda aria, mentre nella prima, causa una zona centrale “vuota”, la fatica e le lacune erano evidenti. Il migliore del cast era John Chest, un Papageno mirabile sia per interpretazione scenica sia per un canto morbido, rifinito e assolutamente preciso. Validissima anche la Papagena di Teona Dvali, che sfoggiato un’ottima musicalità. Molto brave le tre dame, Alice Chinaglia, Cecilia Bagatin e Alice Marini, le quali hanno dimostrato un ottimo canto d’insieme, sempre intonato e preciso. Bravissimo Patrizio Saudelli, Monostatos, rifinito ed elegante cantante, impeccabile nei suoi interventi, un po’ spento l’oratore di Paolo Battaglia, professionali i sacerdoti-armigeri di Carlo Agostini e Luca Favaron. Una menzione particolare è necessaria per i tre fanciulli-geni Stella Capelli, Maria Gioia e Federico Fiorio, i quali hanno dimostrato una professionalità impressionante per aderenza stilistica e un canto uniforme e di gran classe. Non erano propriamente dei bambini ma ragazzi-cantanti in età matura, pertanto le due voci femminili presumo, avranno modo di svilupparsi in un futuro promettente, mentre il ragazzo già dimostra qualità canore non comuni e spero di avere occasione di riascoltarlo presto. Essi sono membri dell’Accademia d’Arte Musicale di Verona diretto da Elisabetta Zucca, alla quale va un plauso riconoscente. Alla recita domenicale alla quale ho assistito il teatro era gremito da un pubblico composto anche da molti bambini entusiasti, al termine tutta la compagnia ha ricevuto applauso prolungato, convinto e meritato.
LE NOZZE DI FIGARO [Lukas Franceschini] Milano, 2 novembre 2016.
Dopo trentacinque anni il Teatro alla Scala ha deciso di produrre un nuovo allestimento de Le nozze di Figaro, mandando in soffitta lo storico allestimento di Giorgio Strehler utilizzato per ben nove stagioni. Infatti, è scontato che anche il teatro deve evolversi e cambiare, tuttavia, considerato il risultato finale, non era proprio il caso. Il nuovo spettacolo di Frederic Wake-Walker, con scene e costumi di Antony McDonald, mi ha lasciato all’inizio perplesso, al termine un po’ irritato. A mio parere personale il regista ha sviluppato una lettura troppo “televisiva” a scapito della teatralità e da quanto contenuto, in tema di moralità, nel libretto. La prima rilevanza è che non esiste differenza sociale tra i Conti d’Almaviva e la giovane coppia di servi, errore grave, poiché siamo in un’epoca in cui tali differenze erano ben marcate. Tutto nell’insieme pareva una fiction, si può anche attualizzare ma non perdere il filo conduttore di ciò che si racconta. Durante l’overture si costruisce la scena, idea non nuova, ma fino al terzo atto ci poteva anche stare, pur trovandoci in un ambiente settecentesco patinato e stereotipato, poi gli stili si mescolano e la sala del terzo atto era arredata con elementi moderni che difficilmente erano concepibili. L’unico momento nozze 3veramente emozionante è stato l’apertura della scena del II atto, scena bellissima e onirica. La concezione registica del teatro nel teatro è superata da tempo, e sembra che il regista volesse trasformare l’opera in una recita fine sé stessa senza sviluppare i temi del librettista e della morale sociale, mi distacca notevolmente dall’approvazione. Inoltre vi sono molte situazioni incomprensibili, o almeno non chiare. Che significato aveva quel prototipo di vecchio suggeritore in proscenio al lato prima sinistro poi destro che imbeccava in un paio di occasioni il conte nel recitativo? Che cosa rappresentava? Poteva essere Andrea Da Ponte che controllava il suo lavoro poetico? E le continue apparizioni di comparse in tailleur nero? Ora costruttrici di scene, poi imbianchine al terzo atto? La grande scena del giardino al IV atto illuminata a giorno, quando invece è sera e buio, mentre Susanna sale su un lampadario per cantare la sua aria? Che senso ha? Ma è soprattutto il lavoro sui personaggi che resta incomprensibile, perché Figaro ogni volta che entra in scena, e anche durante nozze 4molti recitativi, deve fare salti che non hanno senso? L’intrigante combutta tra la contessa e Susanna è decisamente travisata come fosse un’intesa tra amiche, dimenticando i ruoli sociali. Anche la recitazione intrisa di troppe situazioni da commedia buffa era forzata e in parte stridente con quanto espresso da musicista e poeta. I costumi erano in stile settecentesco pur con delle bizzarre soluzioni per gli abiti della coppia nobile. Delude anche il versante musicale. Franz Welser-Most, che ascoltai proprio in Scala in un discutibile Fidelio qualche anno fa in una trasferta della Staatsoper di Vienna alla Scala, conferma anche in quest’occasione le sue ordinarie doti di concertatore. La sua lettura non ha lasciato tracce significative, poiché era impostata sulla più banale routine, slegata, lenta, e alterna in momenti nei quali non si comprende l’eccessiva sonorità o spento ritmo. Tali caratteristiche non hanno trovato corrispondenza né con la linea vocale degli interpreti né con l’azione teatrale. Inoltre, l’opera è stata eseguita con la soppressione delle due arie rispettivamente di Marcellina e Don Basilio, opinabile scelta, ma considerati gli esiti finali, poi non un gran male. Il coro del Teatro alla Scala, diretto da Bruno Casoni, ha dimostrato la consueta professionalità. Il cast era contraddistinto da un generale anonimato interpretativo, che ha fortemente condizionato la recita. Nel giovane e bravo protagonista Markus Werba, non ho rilevato il consueto talento, piuttosto una meccanica sequenza di recitativi e arie senza anima. Peccato, perché la voce è sempre bella e le intenzioni erano affiorate ma non sviluppate. Golda Schultz, Susanna, è una cantante precisa, di buona e spigliata musicalità, e ha reso il personaggio con una manierata verve sia vocale sia interpretativa. Lasciava perplessi Diana Damrau, Contessa, la quale era del tutto fuori luogo nel ruolo nobile, mancando di accento, fraseggio, e aulica introspezione malinconica. Penalizzata sicuramente da una regia fuorviante, non trovava una personale linea interpretativa ma si adagiava comodamene in schemi d’opera buffa del tutto estranea allo spartito mozartiano. Carlos Alvarez, nell’insolito ruolo del Conte, sfoggiava come di consueto la sua bella e rigogliosa vocalità, ma purtroppo era troppo legato ad altri repertori e aveva poca dimestichezza con un fraseggio “giocoso” e alle molteplici sfaccettature del ruolo. Anonima sia per voce sia per interpretazione il Cherubino di Marianne Crebassa, troppo sopra le righe e decisamente sfogato Andrea Concetti nel doppio ruolo di Bartolo e Antonio. Migliore e di molto la Marcellina di Anna Maria Chiuri, brillante e divertente in questi ruoli di carattere cui va sommata una dizione perfetta e un canto puntuale. Senza memoria la prestazione di Kresimir Spicer, Don Curzio e Basilio, sovente slegato e troppo artefatto nel canto. Molto nozze 6buona la prova di Teresa Zisser, Barbarina, e professionali le due contadine di Francesca Manzo e Kristìn Sveinsdòttir, provenienti dall’Accademia del Teatro alla Scala. Pubblico molto perplesso e immobile, il primo applauso dopo un assolo è stato al terzo atto, prima tutto era passato in assoluto silenzio, tranne due applausi alla fine degli atti e alcune isolate ma sonore contestazioni rivolte al regista, ma eravamo alla terza recita e gli autori non erano presenti. Al termine la compagnia ha ricevuto un soddisfacente applauso mentre il direttore è stato più pesantemente contestato.
LA BOHÈME [William Fratti] Piacenza, 4 novembre 2016.
Lo spettacolo ideato da Cristina Mazzavillani Muti per creare, disegnare e raccontare La Bohème di Giacomo Puccini si spoglia di verismo, di realismo, di tradizione e di concetti stereotipati a favore di una visione onirica e suggestiva. A tale scopo risulta molto efficace la scenografia quasi completamente spoglia su cui si proietta il bel lavoro di David Loom e Davide Broccoli che, come la musica di Puccini, porta inesorabilmente lo spettatore dalla tavolozza colorata di Marcello al grigiore della malattia di Mimì. A completamento dell’impianto sono le belle luci di Vincent Longuemare. Meno significativi i costumi di Alessandro Lai. Troppo vuoto il lavoro di regia, che è vincente nelle gestualità dei personaggi – tranne la poca raffinatezza con cui è raccontata Musetta – ma ci si sarebbe aspettato qualcosa di più nella scena del Momus e nel quarto atto, dove la protagonista – ingiustificatamente scalza – sembra morire sull’ara di un’opera a soggetto storico piuttosto che su un letto, un divano o una poltrona di una vecchia soffitta. Nicola Paszkowski alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che in precedenti occasioni non era risultato troppo convincente, apre l’opera in maniera poco aggraziata, cui gli risponde qualche bella stonatura in palcoscenico, ma dopo pochi minuti la situazione viene fortunatamente arginata. La mano del direttore non è passionale, né il suono orchestrale è particolarmente rifinito, ma la resa complessiva è abbastanza discreta, fatta eccezione per la mancanza di quei crescendo e quei caratteri maestosi che dovrebbero definire più chiaramente l’ardente vigore pucciniano. Benedetta Torre ha la giusta vocalità per eseguire con aderenza questo genere di ruoli lirici. La sua Mimì è molto efficace nel personaggio e lo sarebbe anche il canto se si superassero certi scogli che non le permettono di mantenere una linea di canto omogenea: la zona centrale è davvero molto interessante, ma gli acuti sono abbastanza stiracchiati e talvolta troppo fissi. La accompagna il Rodolfo di Alessandro Scotto di Luzio che sta compiendo passi da gigante nella prima parte di una carriera importante. La voce e le note giuste per interpretare questa parte, oltre al fascino e alla prestanza, ci sono tutte, ma non è sufficiente. Ciò che manca per amalgamare questi ingredienti necessari sono il legato, ora quasi assente, una miglior dizione e maggior eloquenza nel fraseggio. Piacevolissima la brillantezza del Marcello di Matias Tosi e squillantissimi gli acuti. Peccato che l’appoggio non sia dei migliori e talvolta risulti calante. Molto buona la recitazione. Lo affianca la simpatica Damiana Mizzi che dipinge una Musetta credibile sia vocalmente, sia scenicamente, anche se certi suoni risultano acerbi e alcuni gesti poco eleganti. Discreto il Colline di Luca Dall’Amico, che in questo ruolo dovrebbe ricercare maggior spessore nei fraseggi e soprattutto nella celebre aria. Particolarmente efficace lo Schaunard di Daniel Giulianini. Sempre bravo Giorgio Trucco, che qui è Benoît. Molto bene anche Graziano Dallavalle, Alcindoro e Sergente dei doganieri. Ottimo il Coro del Teatro Municipale di Piacenza guidato da Corrado Casati, come pure le Voci Bianche del Coro Farnesiano di Piacenza preparate da Mario Pigazzini.
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM [Mirko Gragnato] Brescia, 6 novembre 2016.
Contro il freddo novembrino il teatro Grande ospita il Midsummer Night’s Dream del Circuito Lirico Lombardo. Alla regia di Ferdinando Bruni ed Elio de Capitani si affianca l’orchestra de i Pomeriggi Musicali di Milano guidata dal Maestro Francesco Cilluffo. Una scelta coraggiosa quella del Circuito Lirico Lombardo, una delle realtà più virtuose in questi tempi di crisi e difficoltà per la cultura. I teatri della Lombardia e stavolta anche con la collaborazione del Valli di Reggio Emilia in un a rete di concordia organizzano uno spettacolo itinerante e condiviso, che senza badare all’ingombrante presenza scaligera propongono una stagione di rara qualità permettendo ai teatri delle città minori come Brescia, Como, Cremona, Pavia, che per acustica bellezza non hanno nulla da invidiare al Piermarini milanese, di proporre una preziosa attività culturale, alimentando la tradizione del teatro musicale. La scelta audace di non proporre i soliti titoli che di questi tempi affollano i cartelloni di tanti teatri ha evitato la strategia “squadra vincente non si cambia” che ha inaridito le stagioni di molti teatri svilendole di proposte originali e alternative. Audace la scelta del circolo lirico lombardo per il Midsummer Night’s Dream di Britten, la musica del novecento è percepita ancora come qualcosa di acerbo negli ambienti teatrali e quello che una volta era il contemporaneo fatica ad entrare nei gusti del grande pubblico. Tuttavia, la fortuna aiuta gli audaci, il pubblico ha risposto benissimo affollando le sale dei teatri, se non addirittura portando al tutto esaurito. Merito soprattutto delle maestranze coinvolte: artisti giovani e validi, armati di quella freschezza e vigore che ai grandi nomi incartapecoriti oggi manca. Uno spettacolo che ha trovato oltre alle ottime scelte di voci anche l’intesa perfetta tra regia, scene, luci e costumi. Nell’adattamento che Britten fa della commedia shakespeariana si pone il problema di, come scrive lui stesso “non comporre un’opera wagneriana di 5 ore” tant’è che gli atti dai 5 originali di Shakespeare passano a 3 rendendo così l’interccio narrativo più fluido e scorrevole. La scena resta abbastanza invariata e dall’iniziale dimensione salottiera: arredata in stile impero, si ha una trasformazione silvana, il bosco prende via via possesso del palcoscenico. Teleri di edera e di vegetazione prendono sempre più spazio sulle scene, trasfigurando una realtà di città ordinata e misurata in un sali e scendi di tendaggi silvestri. Le scene di Carlo Sala seguono la musica mostrando come le passioni dell’essere umano non si possono imbrigliare, ma come la natura trovano sempre la via per uscir fuori, i fiori che nascono sui comignoli o tra le tegole dei tetti. La regia di Ferdinando Bruni e Elio de Capitani assieme alle luci di Nando Frigerio trovano un’intesa perfetta, quasi come se le luci stesse diventassero un soprabito dei costumi seguendo tra ombre e riflessi lo status emotivo dei movimenti scenici, ispirati alla musica arricchendola di magia, luci d’incanto. In questo allestimento trava frutto la curiosa idea di alternare allo spettacolo di prosa quello operistico, scelta curiosa, che oltre a contrastare le spese assai gravosi di allestimento fornisce al pubblico un continuum teatrale, come se leggessimo il libro e andassimo a vedere l’adattamento cinematografico in giorni ravvicinati, permettendoci così un’immersione integrale tra testo, sviluppo e musica. Musica che la fa da protagonista, Britten affida all’orchestra non tanto il ruolo di mera accompagnatrice musicale, ma diventa vera e propria parte della scena, le sonorità che salgono dal golfo mistico ammantano i personaggi come una seconda pelle, si intrecciano con le luci. Per ottenere l’effeto della magia, Britten usa tutte le possibilità timbriche creando ogni tipo di sfummatura dalla tavolezza del compositore. In buca vi sono strumenti di ogni tipo e oltre ogni previsione, in quest’opera novecentesca, ricompare il clavicembalo, strumento dimenticato e che aveva lasciato le scene dell’opera da tempo immemore. Le sonorità dei pizzicati clavicembalistici con quelli delle arpe vanno ad amalgamarsi alle vibrazioni della celesta e dello xilofono. nell’intento di usare ogni possibilità sonora dell’orchestra, dà poi molto risalto alle parti gravi dei violini sulla quarta corda, o ai contrabbassi affida delicati colpi con la bacchetta dell’arco. Ampio è l’uso dei glissandi degli strumenti a corda, che condiscono la partitura di questo effetto onirico e instabile, seguendo così le apparizioni e sparizioni dei personaggi fantastici nell’intreccio del racconto. Così come l’incantevole ruolo del coro di voci bianche e le quattro fate, Britten mostra di riuscire a raccontare con la musica ispirando emozioni e percezioni sinestesiche. Tra la tessitura dei cantanti fa la sua comparsa una parte più che cantata recitata, ma che nelle abilità sceniche ha reso tantissimo, veramente ottimo Puk nell’interpretazione buffa e coinvolta di Simone Coppo. Anche la Tytania di Anna Maria Sarra mostra bel timbro e tenuta vocale oltre che ottime doti sceniche, resa nei costumi di Ferdinando Bruni come un personaggio uscito da un quadro preraffaellita. L’Oberon che Britten fa interpretare ad un controtenore nella prima del 1960 era riservato alla vocalità di Alfred Deller, mentre la parte di Lisander era affidata all’amato Peter Pers con i lquale aveva scritto a quattro mani il libretto. Qui la voce è di Raffaele Pe, che nei movimenti scenici risulta un po’ ingessata dimostra di riuscire bene nella tessitura che la partitura richiede, anche se alle volte un po’ fissata sulla dinamica del mezzo forte. Il vero ruolo preponderante si deve alla crew degli improbabili attori che vanno a mettere in scena il “Piramo e Tisbe” una vera e propria allegra combriccola che nei ruoli scenici e cantati ha trovato il match perfetto, alleggerendo ancor di più l’opera e facendo della vera commedia con le note di Britten. Nicholas Masters, Roberto Covatta, Rocco Cavalluzzi, Dario Shikmiri e Claudio Grasso danno uno slancio scenico creando una relazione con il pubblico tale da andare oltre alla lingua straniera, così come i film muti la mimica, e la gestualità permettono di trasmettere il messaggio attraverso il non verbale, scavalcando il limite linguistico. Il gruppo di questi curiosi “village people teatrali”, nell’idea dei costumi. Ferdinando Bruni, fanno satira delle maestranze tecniche del teatro tra tecnici luci, facchini, sarti, ed elettricisti ai quali si aggiunge Zachary Altman nel ruolo di Bottom, quasi un falstaf più dedito al fitness che però non manca nel suo ruolo di macchietta scenica in un’ ottima resa vocale. La bacchetta del giovane Francesco Cilluffo sul podio si è mostrata consapevole con una lettura della partitura approfondita, guidata da una gestualità misurata e senza fronzoli che va a celebrare le vere nozze, più che quelle del duca e la duchessa, quelle tra le molteplici visioni dell’opera: regia, scene, luci, costumi, direzione, orchestrazione e vocalità. Uno spettacolo ottimamente riuscito, che ha avuto il giusto riconoscimento, un teatro gremito con molti giovani tra le file della platea e dei palchi. Il circolo lirico lombardo si mostra realtà virtuosa e forse in questi tempi difficili, che vedono molti teatri in difficoltà, potrebbe ispirare gestioni più sagge e scelte assai più consapevoli senza venir meno alla missione artistica.
LA SCUOLA DE’ GELOSI [Lukas Franceschini] Legnago, 11 novembre 2016.
Nella città natale di Antonio Salieri è stata rappresentata la prima esecuzione in tempi moderni del suo maggior successo nel repertorio buffo La scuola de’ gelosi, realizzazione effettuata su iniziativa della Fondazione Culturale “A. Salieri” di Legnago. Caso assai strano la vicenda di questo dramma giocoso in due atti che fu rappresentato in prima assoluta al Teatro La Fenice di Venezia, per la stagione del carnevale, il 27 dicembre 1778. Salieri mentre studiava a Venezia fu “scoperto” da Florian Leopold Gassmann, compositore e maestro di Cappella all’Opera di Vienna, il quale lo portò con sé nella città asburgica e oltre a farsi compito della sua formazione musicale non mancò di promuoverlo sotto tutti punti di vista. Sotto le sue “cure” il giovane Salieri imparò a comporre opere di diversi generi, soprattutto buffo, ispirandosi al maestro. Fu nel 1772 che con La Fiera di Venezia, opera giocosa di stampo “goldoniano”, si affermò a Vienna. Morto Gassmann era logico che la carica di Kappellmeister passasse a Salieri, anche se in seguito l’Imperatore licenziò tutta la compagnia d’opera italiana favorendo una programmazione di netto stampo tedesco. Ecco perché pur continuando la sua attività in Austria il compositore si spostò anche nella capitale veneta, città di giovinezza e studi, ma soprattutto centro importante della vita musicale del tempo. Sono sconosciute le motivazioni della commissione di una nuova opera per il Teatro di San Moisé, forse fu anche in virtù della carica presso la corte degli Asburgo. A Venezia conobbe il poeta bellunese Caterino Mazzolà, librettista dell’opera in questione. Assieme composero il dramma buffo seguendo le mode del momento: una struttura in due atti, evitando la suddivisione in tre, come altrettanto fu per la sinfonia in un unico tempo. La sequenza musicale segue le regole già fissate, un’alternanza di arie e duetti, concertati e recitativi. Anche i motivi drammaturgici s’ispirano alla tradizione: la gelosia, la prova di fedeltà, gli amori intrecciati, la differenziazione tra le classi sociali. Con un efficace libretto e una musica brillante, che oscilla tra il divertente e il malinconico, fu confezionata un’opera scuola 2che conseguì un successo clamoroso. Non possiamo non rilevare che molte peculiarità de La scuola de’ gelosi è dunque antesignana di più celebri opere soprattutto mozartiane. Quanto alla musica, Salieri si conferma musicista di mirabile inventiva e raffinato linguaggio melodico e pur non essendo il genio assoluto (non addentriamoci nella diatriba mozartiana) si pone come il più autorevole artefice della musica del suo tempo a Vienna, musicista specializzato in un genere preferibilmente buffo ed eccellente maestro e ispiratore di compositori delle successive generazioni. Tali affermazioni possono essere confermate sia dalla lunga eccellente lista dei suoi allievi sia, nel nostro caso, dalla riproposta dell’opera in oggetto. Infatti, La scuola de’ gelosi ebbe ben cinquanta diverse produzioni, le quali non costituiscono solo un successo bensì un trionfo vero e proprio soprattutto nel ‘700, ove la novità era all’ordine del giorno e le riprese si contavano solo nell’arco di qualche stagione, invece qui siamo alla presenza di una continua riproposta in tanti teatri italiani ed esteri. Abbiamo pertanto molteplici versioni poiché una prassi del tempo era adattare la partitura (anche sostituendo le arie) alla compagnia di canto che si aveva a disposizione in quel momento, come confezionare appositamente un prodotto per ottenere il successo voluto. Per la realizzazione di questa proposta in tempi moderni dobbiamo rendere un doveroso encomio a Jacopo Cacco e Giovanni Battista Rigon. Essi si sono recati a Vienna all’Österreichische Nationalbibliothek ove è stata loro concessa la possibilità di accedere all’autografo originale, scelta più ovvia per una messa in scena brillante, dal quale hanno tratto l’indispensabile trascrizione. Sarebbe auspicabile che la Fondazione Salieri avesse le risorse e fosse in grado di produrre a cadenza fissa uno spartito del compositore veronese, del quale abbiamo avuto possibilità d’ascolto recente solo di Les Danaïdes, L’Europa riconosciuta, Falstaff e Il mondo alla rovescia. Sarebbe una grande gioia poter scrivere e raccontare frequentemente di nuove scoperte musicali e magari poter utilizzare il termine “Salieri-Renaissance”. Va meritatamente lodato lo spettacolo realizzato a Legnago, poiché è un’operazione di “buon teatro” realizzato in coproduzione con la Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno, la Fondazione Spontini di Jesi, il Teatro Ristori di Verona, il Teatro Marruccino di Chieti e la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, alla quale va sommata l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino per il cast. Tale larga partecipazione, molto auspicabile anche per altri progetti, farà sì che dopo le due recite veronesi ce ne saranno altre dodici nelle diverse città coinvolte con alcune rappresentazioni appositamente dedicate ai giovani delle scuole. Lo spettacolo è stato realizzato dal regista Italo Nunziata, assieme allo scenografo Andrea Belli e alla costumista Valeria Donata Bettella. Considerata la drammaturgia dell’opera, il regista ha voluto rendere lo spettacolo frizzante e leggero, senza ricorrere a linguaggi incomprensibili e troppo psicoanalitici. Gliene siamo molto grati. Assistere oggi a uno spettacolo d’opera è spesso difficile comprendere la tortuosa e talvolta incomprensibile comunicazione del linguaggio teatrale. Invece Nunziata si limita a spostare scuola 3la vicenda in un ‘900 fantasioso, molti sono i riferimenti liberty, ma soprattutto a far recitare un cast giovane con vivace frenesia e scioltezza dinamica davvero incalzante e divertente, senza mai premere il pedale su una giocosità troppo farsesca ma restando in perfetto equilibrio nella leggerezza musicale, nel gusto della commedia di “stampo goldoniano” che qualche tema morale contiene, rendendo lo spettatore partecipe delle vicende delle tre coppie di protagonisti. Su questa concezione, ottima l’idea di Andrea Belli di creare scene molto minimali e scorrevoli, che spostandosi creavano l’ambiente necessario sul momento, con piacevole visione e colorata partecipazione. Divertentissime le teste di cervo con grandi corna che calavano dalla graticcia, il cui significato era più che ovvio. La costumista Bettella ha aggiunto la sua preziosa mano realizzando dei costumi molto ricercati e coloratissimi, che davano quel gusto retrò anche settecentesco, e ben messi in luce, come tutta la drammaturgia cangiante, dalla professionalità di Marco Giusti, ideatore del disegno luci. Giovanni Battista Rigon, oltre a curare la trascrizione, è stato il vero deus ex machina di quest’operazione, concertando una lettura precisa, raffinata e molto briosa. La sua esperta mano, soprattutto in questo repertorio, ha saputo cogliere appieno il linguaggio musicale di Salieri, una commedia brillante ma non troppo comica, calibrando con grande gusto armonico e narrativo sia ricercate sfumature delle diverse arie, sia coesione delle dinamiche strumentali, non perdendo mai il senso narrativo e realizzando un ottimo equilibrio tra buca e palcoscenico. In tutto questo era coadiuvato dall’ottima Orchestra de I Virtuosi Italiani, capeggiati dal loro primo violino Alberto Martini, una garanzia già in partenza. Inoltre, mi preme rilevare l’ottima realizzazione del quintetto del secondo atto, un gioiello musicale in un tessuto dorato. La compagnia di canto era formata da elementi dell’Accademia di Canto del Maggio Musicale Fiorentino e forniva una prova complessiva efficace seppur con dei distinguo. Si metteva in luce il baritono Benjamin Cho, Blasio, dotato di voce molto duttile e ben amministrata accompagnata da un sapiente uso del fraseggio e verve teatrale. Francesca Longari era una Contessa poetica dal canto forbito e preciso. Eleonora Bellocci, Ernestina, moglie sospettata che offriva una briosa e furbesca interpretazione con scuola 4una voce brillante e molto musicale. Molto dotata vocalmente la Carlotta di Ana Victoria Pitts, voce brunita e ottimamene amministrata che sarebbe interessante sentire anche in altri repertori. Meno duttile e forbito, anche se molto musicale, il Conte di Patrick Kabongo, il quale necessita ancora una formazione di finimento in arte scenica e dosaggio dei fiati. Simpatico e brillante il servitore Lumaca di Qianming Dou, e bravissimo il Tenente di Manuel Amati, che sfodera una vocalità elegante e ben amministrata, il giovanissimo tenore pare, e speriamo, dovrebbe avere un avvenire luminoso. Il Teatro “Salieri” era esaurito in ogni ordine di posto, la cittadinanza locale, e non solo, è accorsa in massa per ascoltare il celebre concittadino, e al termine successo entusiasta con numerose chiamate. Considerazione personale: spesso si raccolgono più soddisfazioni nei teatri di provincia rispetto a più blasonate istituzioni.
AQUGRANDA [Lukas Franceschini] Venezia, 13 novembre 2016.
Il Teatro La Fenice inaugura la Stagione Lirica e Balletto 2016-2017 con una nuova opera commissionata per 50° anniversario dell’alluvione del 4 novembre 1966: Aquagranda su libretto Roberto Bianchin e Luigi Cerantola (tratto da libro Acqua Granda. Il romanzo dell’alluvione di R. Bianchin) con musica di Filippo Perocco. Operazione certamente encomiabile e coraggiosa, legata significativamente alla città per un fatto tragico quanto devastante. Un lavoro di cultura che è radicato in Venezia e a livello storico dieci lustri sono relativamente pochi, infatti, l’avvenimento è tuttora molto vivo negli abitanti lagunari. Il Sovrintendete e Direttore artistico hanno voluto che gli autori dello spettacolo fossero tutti veneziani, non per campanilismo ma perché legati alla città e certi che avrebbero potuto restituire una rievocazione più realistica rispetto ad altre scelte. Una volta deciso di ispirarsi per il libretto al libro di Bianchin, si è affidata la stesura allo stesso autore e a Luigi Cerantola. Anche Filippo Perocco è veneziano di nascita e formazione, anche se ora la sua carriera di compositore è a livello internazionale nei circuiti della musica contemporanea. Terzo elemento artistico il regista Damiano Micheletto sempre nativo della città veneta che anche in quest’occasione collabora con i suoi abituali artisti Paolo Fantin, scenografo, e Carla Teti, costumi. L’opera è ambientata nell’isola di Pellestrina, che fu invasa per prima dall’ondata dell’acqua. Pochi i personaggi, capeggiati dal pescatore Fortunato che è il solo a rendersi conto di quanto di lì a poco succederà. La musica di Perocco è anti-teatrale e anti-retorica come un flusso di suono che si abbina all’onda acquatica che rompe le mura (“murazzi” in veneziano) e invade tutto. Grande rilevanza, o forse protagonista assoluto, è il coro cioè “la voce della laguna” che esegue dei canti lagunari in forma tonale, ma di grande effetto è l’enfasi che suscita drammaturgicamente. Bisogna rilevare che il canto dei solisti, in dialetto locale, non è punto di riferimento per il compositore, piuttosto siamo di fronte ad una musica che utilizza il canto come sensazione d’effetto incentrata su sonorità che s’intersecano con uno storpiamento del suono creando un flusso di linguaggio musicale personale quasi astratto. Anche il canto, che potrebbe ispirarsi al madrigale, è trattato in maniera parallela alla musica, distaccato e declamatorio. Un aspetto che ha destato perplessità è stato quello della continua ripetizione della frase o della parola, ma probabilmente al compositore non interessava rendere evidente questa peculiarità, tanto da suscitare nello spettatore l’idea che il suo lavoro potrebbe essere un “oratorio” in chiave moderna. L’orchestra accompagna la tragedia con un linguaggio antimelodico, ma di grande effetto basta ascoltare le prime battute forti e sorde, come in una tragedia di antica memoria. Non siamo di fronte al capolavoro moderno, ma sicuramente a un dramma per musica (suddiviso in dodici scene) della durata complessiva di ottanta minuti che s’identifica sui sentimenti, le paure di fronte ad un evento indomabile. È la forza tragica e drammaturgica che colpisce, non certo la parola e le azioni umane. L’effetto sonoro in continua fibrillazione arriva al momento in cui la marea si ferma, causa il cambio del vento, e la maestria del contrappunto sta nel trovare un finale che in me ha evocato elementi dalla “Pastorale” di Beethoven, il finale sviluppa il poter respirare per una tragedia che avrebbe potuto essere più grande. In questa concezione è funzionale lo spettacolo ove prevale la grande scena di Paolo Fantin sulla regia di Damiano Michieletto. Il coro è aqua 4collocato in due tribune ai lati dei primi palchi di proscenio, al centro una grande vasca a parete che sin dall’inizio inizia a riempirsi di acqua vera e inondare poi il palcoscenico, un momento teatrale di grande impatto, e anche se era prevedibile perché si poteva immaginare, la visione toglie il fiato. Io che sono nato in terra ferma e non conosco queste situazioni mi sono immedesimato per un attimo nell’impotenza degli uomini di allora e ho provato un senso di sgomento. Credo che anche il regista non abbia voluto imprimere una lettura troppo personale ma lasciare all’elemento acqua realizzare quello che gesta o parole non possono realizzare. L’effetto c’è stato. Lo spettacolo era supportato dai pertinenti costumi di Carla Teti, artista che si conferma sempre all’altezza del compito, e a video originali d’epoca, magistralmente ideati da Carmen Zimmermann e Roland Howart, che impressionavano alla sola visione, non immagino come fosse stata la realtà. Di notevole qualità la direzione di Marco Angius, un esperto encomiabile in questo repertorio, perfetto calibratore di sonorità e abile interprete nel parallelismo tra buca e orchestra. Non si poteva avere maestro migliore. Ottima anche la compagnia di canto, che solitamente è impegnata in repertori classici, ma qui si è ben adattata a una nuova scrittura vocale, peraltro molto difficile. Primeggia Andrea Mastroni, Fortunato il pescatore, che s’impone per una resa scenica di grande impatto accomunata a una voce importante, morbida e ben amministrata nel fraseggio. Non meno brava la Lilli di Giulia Bolcato, alla quale è riservata una bellissima aria molto virtuosa e impegnativa che lei risolve con grande disinvoltura e precisa esecuzione acuta. Mirko Guadagnini, Ernesto, è impegnato con partecipazione, anche se la scrittura è talvolta ardua per la sua vocalità. Silvia Regazzo è una brava Leda, Vincenzo Nizzardo, Nane, sfoggia accenti meritevoli di nota e ottima identificazione nel personaggio. Marcello Nardis era un eccellente Cester, ricco di sfumature e intenti drammatici, William Corrò, Luciano, confermava la brillante professionalità di sempre. Un elogio particolare va riservato al Coro del Teatro La Fenice, diretto da Claudio Marino Moretti, che si è esibito in una parte di ardua difficoltà dimostrando non solo professionalità ma una peculiare duttilità di repertorio. Bravissimo! Anche all’ultima replica, a teatro tutto esaurito, il successo è stato trionfale.
LA BOHÈME [Renata Fantoni e William Fratti] Firenze, 17 novembre 2016.
In occasione del centoventesimo anniversario della prima rappresentazione, anche l’Opera di Firenze rende omaggio al massimo capolavoro di Giacomo Puccini. Per l’occorrenza è scelto l’allestimento minimalista del Teatro Comunale di Bologna per la regia di Lorenzo Mariani, con scene e costumi di William Orlandi. Spettacolo intelligente, efficace, opportuno, adeguato, con tutti gli elementi necessari e senza orpelli non richiesti. Solisti e masse sempre in movimento, sensato e con gusto. Luci di Christian Pinaud suggestive, movimenti coreografici di Anna Maria Bruzzese in perfetto coordinamento con tutta l’ambientazione. Purtroppo, da un punto di vista meramente sonoro, non è allestimento adatto per quell’enorme palazzetto dalla pessima acustica che è l’Opera di Firenze, poiché le quinte in PVC non aiutano a rifrangere il suono verso la platea. Sul podio della sempre eccellente Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino è Daniel Oren, che sembra essere arrivato a ridosso della rappresentazione. Già non aveva brillato nel recente Don Carlo parmigiano, ora appare lento e noioso, come se non volesse rischiare un andamento non preparato. In certi punti i cantanti lo anticipano, in altri sono costretti a prendere qualche fiato in più, in altri ancora arrivano al limite del respiro alla fine della frase. Del carismatico Maestro di un tempo restano solo i vigorosi brontolii, che mal supportati da una musicalità non più intensa, servono solo a disturbare l’ascolto. Jessica Nuccio, che non aveva propriamente convinto nei ruoli verdiani, è una Mimì deliziosa, ben centrata nella vocalità e nel personaggio. Ottimi i legati di certe frasi. Raffinati i piani. Da riascoltare assolutamente, con una direzione più consona e su un palcoscenico dalla migliore acustica. Fabio Sartori è sempre Fabio Sartori. Squillante, brillante, nobile fraseggiatore, abile cromatista. Il suo è un Rodolfo che lascia il segno. Marcello è Simone Piazzola, che continua ad essere un bravo cantante, ma sembra avere perso parte del suo bel timbro e della sua gradevole luminosità. Mentre prima aveva tutte le carte del fuoriclasse, ora le sue recenti prove restano nella media. Pure nella media è la Musetta di Alessandra Marianelli, efficace e adeguata, ma non entusiasmante. Gianluca Buratto non risplende per chiarore e lucentezza, poiché la sua vocalità è forse fin troppo pastosa, ma sa cantare molto bene, con buona tecnica ed interpretazione. Pure appropriato è lo Schaunard di Fabio Previati. Completano le opportune parti di contorno di Salvatore Selvaggio nei panni di Benoît e Alcindoro, Carlo Messeri in quelli di Parpignol, Vito Luciano Roberti come Sergente dei doganieri, Antonio Cobisiero come doganiere, Leonardo Sgroi come venditore ambulante.
RIGOLETTO [Lukas Franceschini] Bologna, 17 novembre 2016.
È stata la mano di Alessio Pizzech ad affrontare una lettura molto cruda e forte della celebre opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, in programma al Teatro Comunale quale penultimo titolo della stagione 2016. Durante il preludio del I atto c’è un uomo, Rigoletto, con mantello che scruta un affresco (riproduzione de “La caduta dei Giganti” dall’originale in Palazzo Te a Mantova) nel quale si vedono volti stralunati e occhi diabolici, bocche che addentano corpi. Un uomo solo, piangente e disperato nel suo senso di colpa. Ecco Rigoletto! Il buffone di corte, una corte corrotta e totalmente amorale dedita alla lussuria, è vittima del suo padrone dovendo assistere a questa visione ma ancora più rilevante è il suo essere di buffone che deve servire il duca per sopravvivenza. Inoltre, è vittima del suo corpo che deve esibire per il divertimento altrui, ma è anche il suo essere umano, il suo modo di vivere sbagliato e orrendo. L’effetto forte è che il buffone di corte si spoglia delle vesti da “lavoro” e vediamo che indossa delle calze a rete, un giubbotto di pelle nero, scarpe da donna con tacco a spillo, il suo corpo è umiliato e deriso, non solo per la gobba, ma come essere umano da una corte infame. È una violenza al maschile su cui punta il regista, le cortigiane sono alla mercé del potere degli uomini indotte a selvagge orge e meri oggetti. Ecco perché Rigoletto in abiti borghesi con tanto di soprabito e valigia da lavoro si reca nella sua abitazione ove “costudisce” Gilda, sua figlia, rinchiusa come una bambola in una vetrina di oggetti preziosi. Trattasi del secondo dramma del protagonista, una figlia adorata, troppo, tanto da essere rinchiusa in una claustrofobica quanto gioiellata scatola. Il padre nasconde con cura il suo essere, a lei ha dato tutto quello che poteva, ma soprattutto l’ha tenuta isolata dalla realtà del mondo che lui stesso conosce e giudica violento, ma la ragazza ormai è insofferente per non dire esausta di questo isolamento e la prima occasione sarà quella fatale. Attraverso questa drammaturgia chiara, Pizzech realizza un lavoro di grande fattura, scava negli animi dei singoli personaggi e trova non nuova ma diversa luce senza andare contro quanto narrato nel libretto. Ovvio che a molti puristi un linguaggio così forte non piaccia, ma pur nel rispetto dei gusti se per un attimo analizzassero con occhio diverso quello che si sta raccontando converrebbero che è la storia ispirata dal dramma di Victor Hugo. Dai bagliori accecanti della corte, capeggiata dal lascivo Duca, si passa al cupo e beffardo finale, davanti a un battello casa di malaffare dei loschi fratello e sorella Sparafucile e Maddalena, la maledizione piomba sul protagonista ancora più drammatica perché isolata nelle nebbie del Mincio tanto fosche quanto discontinua, non accettata e forse inadeguata era quella di Rigoletto. A questa lettura interessante ma di buon teatro psicologico hanno contribuito con rilevanza Davide Amadei, scenografo, che disegna elementi chiari ed essenziali, e Claudia Ricciotti, costumista, che cerca attraverso colori sgargianti per la corte, ma neri per gli uomini di potere, un’atemporalità della vicenda che giustamente si adopera in ogni epoca. Alla recita da me ascoltata e vista ci sono state delle variazioni rispetto la locandina prevista. Il baritono Vladimir Stoyanov sostituiva l’indisposto Marco Caria e in Rigoletto, e Giuseppe Iori subentrava ad Antonio di Matteo nel ruolo di Sparafucile. Tuttavia, già dall’inizio dell’atto Stoyanov era notevolmente sottotono rispetto alle sue qualità e durante il duetto con Gilda ha dovuto interrompere, chiedendo scusa al direttore e al pubblico voleva abbandonare il palcoscenico. Ha tentato di terminare la parte ma poi è stato sostituito in corsa, dal II atto, da David Cecconi, il quale la sera prima aveva cantato la sua recita. Su Stoyanov non è possibile esprimere giudizi, anche se nel giro di un mese due incidenti analoghi dovrebbero fare riflettere. Quanto a Cecconi devo rilevare che ha un ottimo strumento vocale, musicale, sufficientemente omogeneo e calibrato nel colore. È un po’ carente nell’accento e in qualche acuto, ma considerata la situazione credo non si posso più di tanto rimarcare e comunque avrà modo di rodare ancora il personaggio in seguito. Molto brava Irina Lungu nel ruolo di Gilda, alla quale dona uno spessore drammatico incisivo in virtù di una vocalità piena e precisa nel virtuosismo, senza scivolare nella meccanicità di taluni sopranini di coloratura. Il Duca di Mantova di Celso Albelo svettava vocalmente solo nel settore acuto, fermo raggiante e preciso. Perché tagliare il da capo della cabaletta? La zona centrale è invece sempre limitata e sovente gli attacchi, anche a mezzavoce, artefatti o poco nitida. Inoltre, scenicamente il personaggio è piuttosto carente. Era invece in ottima forma Enrico Iori, che non ascoltavo da qualche tempo. Bel timbro pastoso, preciso nell’emissione e ben caratterizzato nel truce personaggio. Meno significativa la Maddalena di Rossana Rinaldi, la quale possiede una voce interessante ma in quest’occasione poco incisiva poiché appariva solo se forzava nel grave. Professionale il Monterone di Andra Patucelli anche se non proprio scolpito l’accento. Molto bravi gli altri interpreti, a cominciare dal Marullo di Raffaele Pisani e poi in sequenza Pietro Picone (Matteo Borsa), Beste Kalender (Giovanna), Hupo Laporte (Conte di Ceprano) e Marinna Mennitti (Contessa di Ceprano e Paggio). La direzione di Renato Palumbo era alterna con momenti di grande drammaticità e tempi vivi con altri troppo lenti e una sommaria slegatura tra buca e palcoscenico. Tuttavia per la situazione sopra descritta ha saputo portare a termine la recita con molto onore. Il Coro del Comunale, istruito da Andrea Faidutti, ha reso una valente apporto come spesso dimostrato nel corso della stagione. Lunghi e calorosi applausi al termine a tutti gli interpreti.
AURA [Lukas Franceschini] Treviso, 18 novembre 2016.
Al teatro Comunale “Mario Del Monaco” un altra prima assoluta Aura del compositore milanese Luca Mosca, il quale collabora sovente per il libretto, con la moglie Pilar Garcia. Commissione di Teatri e Umanesimo Latino SpA. Il soggetto è originale e non ispirato a nessun testo ma frutto dell’inventiva della signora Pilar. Uno squarcio di vita “giovanile” di oggi, forse bohémienne, di una giovane coppia d’innamorati, nella quale è lei ad aver carattere e ingegna una trappola per tirare fuori dai guai Paolo. Questi, infatti, si è indebitato con il pusher del quartiere, il quale a sua volta ha come mira Aura, la fidanzata. aura 2Sarà lei a offrirsi fisicamente a Kapu, il malavitoso, con un espediente di sostanza stupefacente che la renderà come morta per qualche ora. Attorno a questo dramma si svolgono anche le vicende degli altri coprotagonisti: le amiche di Aura, i due fidi “assistenti” di Kapu, un poeta in erba, e uno stuolo di ragazze briose che fanno da contorno con le loro piccole storie. Sulla copertina del libretto di sala Aura è denominata opera comica in un atto (circa novanta minuti). Personalmente non riesco a capire cosa ci sia di comico in questo soggetto, che trovo molto interessante e attuale anche se non del tutto originale. I protagonisti, Aura, Paolo e Kapu sono ben tracciati, mi permetto di rilevare che il numeroso contorno di personaggi poteva essere sfoltito. Infatti, il libretto, non cosi raffinato come in altre occasioni, consente limitata drammaturgia a tutti senza mostrare personalità parallele ai protagonisti. Anche in quest’occasione, l’originalità di scrittura ripetitiva non aiuta una vicenda che se scolpita nei temi drammatici avrebbe sicuramente avuto più effetto. La musica di Mosca è molto apprezzabile poiché adotta una soluzione senza archi prediligendo tastiere e chitarre elettriche. Non possiamo affermare che manchi di melodia, anzi le pagine solistiche riservate alla protagonista sono molto tipiche anche se drammatiche, ma nel suo insieme lo spartito contiene differenti aspetti che sovente si contrastano. Come affermato dall’autore, forse il comune denominatore è il colore, il quale è offerto dagli strumenti in chiave diversa, legni, percussioni e strumenti a fiato, rendendo il tutto molto incisivo e ritmico, ma rilevo anche in questo caso con nessun riferimento comico. Il regista Alvise Zambon, ispirandosi a un progetto drammaturgico di Francesco Bellotto, ambienta la vicenda in una periferia di metropoli, una sorta di dismessa officina, forse oggi adibita a centro sociale. Perfettamente lineare con la vicenda di storie di quartiere, spaccio, malaffare, lavori saltuari, amicizie e amori giovanili. Calca un po’ la mano sulla recitazione di alcuni stereotipi odierni e passati, ma lo fa sempre con gusto. Semmai avrebbe dovuto osare di più nella scena in cui Aura si concede al boss, il ricatto con tematica sessuale era gelido e sarebbe potuto essere rappresentato con più concitazione. Resta comunque uno spettacolo molto lineare, ben scolpito, drammaturgicamente efficace e godibile. Molto apprezzabile l’esecuzione musicale guidata dalla bacchetta esperta e sicura di Giovanni Mancuso, il quale ha saputo realizzare una lettura incalzante districandosi con grande abilità nella difficile realizzazione di sonorità contrastanti. Molto brava orchestra del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che anche in quest’occasione conferma professionalità abbinata a una duttile capacità esecutiva. La compagnia di canto ha fornito un’ottima prova nel suo complesso. Emergono sia vocalmente sia scenicamente i due protagonisti Fernanda Girardini e Dario Giorgelè, la prima sensuale interprete dotata di voce omogenea e ben amministrata, particolarmente brava nel suo intervento solistico; il baritono ha confermato doti non comuni in una resa teatrale eccelsa accomunata con varietà d’accento vocale di grande fascino. Puntuale e sciatto quanto conviene il Paolo di Francesco Basso, ottimamente realizzata la coppia di assistenti del boss, Andrea Biscontin, Bisco, ed Elena De Simone, Ria, e prezioso l’intervento di Asako Watenabe nel ruolo di Asako. Tutti gli altri interpreti pur nei loro brevi momenti sono stati di ottima professionalità e ammirevole arte teatrale. Li cito in ordine di locandina: Erika Tanaka (Giulia), Kalliopi Petrou, Popi, Marijana Pantelic, Mira, Safà Korkmaz, Safà, Claudia Graziadei, Grazia, Federica Corrò, Fede, Valentina Corò, Vale, Serena Bozzo, Erba, Ludovica Marcuzzi, Ludo. È immaginabile che questi personaggi siano stati creati sugli stessi cantanti già in fase di struttura di libretto. Alla prima assoluta il teatro pur registrando qualche vuoto nei palchi ha avuto un’ottima risposta di pubblico, considerando l’opera contemporanea. Buon successo con numerose chiamate al termine.
SANCTA SUSANNA/ SUOR ANGELICA/ GIANNI SCHICCCI [Stefano Solaster] Pisa. 19 novembre 2016.
“Finché c’è opera c’è speranza” …così sosteneva, Alberto Mattioli, nella sua autobiografia di un “portatore sano” di mal d’opera. Dopo aver visto la prima del “Trittico” pisano aggiungerei “finchè ci sono Direttori Artistici coraggiosi” come il M° Lippi (Dir. Artistico del Teatro Verdi di Pisa) che con gli esigui mezzi di un Teatro di provincia centra un ambizioso doppio obiettivo: mettere in scena un “Trittico” (operazione questa raramente visibile in provincia per i notevoli costi che comporta produrre tre opere nella stessa serata) convincente ed emozionante e dare fiducia, e quindi possibilità, a giovani talenti di debuttare ruoli importanti. Nonostante l’opera di apertura di questo inedito “Trittico” portasse in dote epiteti come “blasfema” e “scabrosa”, una giustificata diffidenza per un’opera in lingua, fosse sconosciuta al grosso pubblico, Sancta Susanna si è conquistata lo scettro di trionfatrice della serata a cui il pubblico pisano ha avuto la fortuna di assistere. Le ragioni di questo successo del capolavoro di Paul Hindemit sono innanzitutto da cercarsi nell’allestimento curato da Lorenzo Maria Mucci e nelle interpreti principali: Mucci ha giocato sul filo di una recitazione fatta di movimenti dilatati e pose plastiche che denotavano un meticoloso lavoro registico atto a far sì che i personaggi potessero esprimere una loro identità ben precisa; la scena agile e funzionale, realizzata da Emanuele Sinisi, incorniciava un unico spazio scenico, che rappresentava il fil rouge di questo Trittico, dipinta perfettamente dalle luci di Michele Dalla Mea. Per quanto riguarda le interpreti l’autentica trionfatrice di quest’opera, ed oserei dire dell’intera serata, è stato il giovane talento sardo Elisabetta Farris (già ammirata qui a Pisa nei panni di Elena nella recente produzione di Mefistofele). La crescita di questo soprano è esponenziale: affronta le difficili pagine del suo personaggio con una maturità espressionistica che raramente si vedono in interpreti di pari età. La Farris, sorretta da una vocalità ben salda, da acuti squillanti e da un’espressività drammatica solitamente tipica di attrici ormai collaudate, vince la sfida di debuttare, nell’arco della stessa serata, due ruoli così impegnativi come Sancta Susanna e Suor Angelica prova ne siano i copiosi applausi al termine di entrambi gli allestimenti. La voce del mezzosoprano giapponese Sumie Fukuhara non è di pasta particolarmente interessante ma interpreta con sicurezza ed efficacia il difficile ruolo di Suor Klementia; recita in perfetta coordinazione con la Farris, si guadagna appieno gli applausi finali ed è anche merito suo se Sancta Susanna è la trionfatrice della serata. Da sottolineare la prova della valente Maria Candirri nei panni sella Suora Anziana e della prorompente giovane serva incarnata da Giulia De Blasis. Corretto il garzone di Marco Voleri e il gruppo delle Suore composto da: Margherita Tani, Emanuela Grassi, Noema Erba, Elena Bakanova, Helga Sergio, Sonia Baussano, Claudia Muntean, Takako Izumi, Domitilla Lai e Candida Guida. Nella Suor Angelica, seconda messa in scena della serata, mentre la Farris, confermado quanto di buono scritto precedentemente per la Sancta Susanna, emoziona e strappa calorosi applausi a scena aperta dopo l’aria “senza mamma”; tradisce le aspettative il mezzosoprano Sumie Fukuhara che non risulta in sintonia col ruolo della perfida e vecchia Zia Principessa: se pur dotata di bastone la sua camminata non denota né anzianità né fierezza e, purtroppo, l’interpretazione è macchiata da una dizione non propriamente esemplare. Il perfetto lavoro di identificazione dei personaggi fatto dal regista nella Sancta Susanna qui viene a mancare e così zelatrici, infermiere, novizie e converse perdono le loro peculiarità, le dinamiche dei dialoghi si affievoliscono e il mare di interventi che caratterizza il convento pucciniano, col passare dei minuti, tende più ad assomigliare ad una triste ed uniforme palude da cui riescono ad emergere solo la prima e la seconda sorella cercatrice interpretate rispettivamente dalla brava Elena Bakanova e dalla efficace Takako Izumi; da segnalare altresì l’austera maestra delle novizie interpretata da Emanuela Grassi. Nell’ultimo “atto” del Trittico il lavoro registico di cesellatura dei personaggi torna a farsi sentire. Il baritono Sergio Bologna tratteggia un Gianni Schicchi con le sfumature e i differenti accenti richiesti dal ruolo grazie a un’innata verve e ad una voce salda e sicura. A mio avviso è protagonista di una recita corretta dalla prima all’ultima nota ma in modalità leggermente routinier: vince ma non stravince in una serata che sembrava fatta apposta per lui. Ottima anche la prova del soprano Giulia De Blasis che ha tratteggiato una Lauretta convincente sia sul lato interpretativo sia sul lato vocale nonostante un leggero fastidioso vibrato. Lo stuolo dei comprimari è sicuramente cappeggiato dall’efficace e spassosa Zita impersonata dal valente contralto Candida Guida. Hanno saputo farsi notare anche l’eclettico Giovanni Di Mare autore di un’ottima caratterizzazione del personaggio del Maestro Spinelloccio, Marco Innamorati che ha interpretato un Simone con eccellente presenza scenica e dotato di voce dal timbro tornito e, infine, un convincente Daniele Piscopo – Betto (che conferma i successi già riscossi nelle precedenti apparizioni sul palcoscenico del Verdi). Più di qualche perplessità sul Rinuccio di Andrea Giovannini che macchia la sua prestazione con due “scivolate” nel registro acuto in “Firenze è come un albero fiorito”, la partenza ad handicap lo porta probabilmente a “strafare” nel tentativo, purtroppo vano, di recuperare non riuscendo mai ad essere totalmente convincente né sul piano interpretativo né sul piano vocale. Completano il cast, partecipi anch’essi del successo del Gianni Schicchi, Marco Voleri, Takako Izumi, Marco Iannattoni, Emilio Marcucci, Maria Candirri, Alessandro Martini, Franco Bocci, Massimo Dolfi. La concertazione è affidata al Maestro Daniele Agiman che dirige in modo efficace e puntuale con ampiezza di gesto e attenzione al palcoscenico trovando altresì un’ottima risposta nell’ Orchestra Arché. Piccola nota a margine: da segnalare la presenza di infiltrati maschili nel coro della Suor Angelica diretto dal M° Marco Bargagna.
SANSONE E DALILA [William Fratti] Torino, 20 novembre 2016.
Cultura di alta qualità. Altissima. È ciò che contraddistingue l’affascinantissimo spettacolo andato in scena al Teatro Regio di Torino in coproduzione con China National Centre for the Performing Arts di Pechino. Non è la prima volta che Hugo de Ana si cimenta col dramma di Camille Saint-Saëns, dunque non solo consegna al pubblico una regia particolarmente centrata, densamente minuziosa, fluida e perfetta in ogni momento, ma sa anche rinnovarsi rispetto alle prove precedenti. Piacevolissimo è l’adattamento all’orientale, in omaggio al palcoscenico su cui è stato costruito l’intenso lavoro, che non è riconducibile soltanto alla grandeur delle belle scene o allo splendore dei preziosi costumi, ma soprattutto trova completamento nei gesti, negli sguardi, nei movimenti, in ogni minima posa o azione compiuti da coro, ballerini, mimi e cantanti solisti. Hanno contribuito al valore e al successo dello spettacolo anche le luci suggestive di Vinicio Cheli, le attraenti proiezioni di Sergio Metalli e l’ottima coreografia nello stile contemporaneo di Leda Lojodice. Superlativa la direzione musicale di Pinchas Steinberg, tanto precisa da potersi definire matematica. Lodevoli i momenti in cui attende i fiati e i fraseggi dei protagonisti. Emozionantissime e struggenti le pagine corali, raffinatissimi l’incontro tra Samson e Dalila e la scena della prigione. Eccellente oltre ogni misura il suono prodotto dall’Orchestra del Teatro Regio di Torino, cui fa eco l’altrettanto esemplare Coro guidato da Claudio Fenoglio. Daniela Barcellona nel repertorio francese si trova particolarmente a suo agio, pertanto rende una Dalila sensuale e suadente attraverso le tinte e le sfumature della sua voce. Molto apprezzabile il fatto che non esageri mai negli accenti drammatici, restando morbida e soprattutto mantenendo i suoni sempre piacevoli. La affianca l’encomiabile Samson di Gregory Kunde che, come già detto più volte, in questa fase della sua carriera trova terreno decisamente fertile in questo genere di ruoli. Non avrà la freschezza vocale del tenore trentenne, ma l’esperienza copre la lacuna, anzi, rende un fraseggio e un’interpretazione sinceramente insuperabili. Inoltre lo squillo che l’ha sempre contraddistinto continua ad essere brillantissimo. Encomiabile il sommo sacerdote di Dagon di Claudio Sgura. Voce piena e ben timbrata, canto eloquente e ricco d’intenzioni, accenti ben posizionati ed espressi. Il suo duetto con Dalila è certamente la pagina più intensa della rappresentazione. Molto buona la prova di Sulkhan Jaiani nei panni del vecchio ebreo. Accettabile l’Abimelech di Andrea Comelli. Adeguate le parti di contorno di Roberto Guenno, Cullen Gandy e Lorenzo Battagion come filistei. Scroscianti e intensi applausi oltre a tante acclamazioni per i protagonisti e il direttore. Meritatissimi.
SANSONE E DALILA [Margherita Panarelli] Torino, 20 novembre 2016.
Avvince e conduce in un oriente magico e fiabesco l’allestimento di Hugo de Ana di Sansone e Dalila di Camille Saint-Saëns. Stravaganti copricapi, cuscini damascati e tende sono affiancate da strutture monumentali che trasportano efficacemente all’interno della vicenda. Uniche pecche nella messa in scena di grande eleganza di Hugo de Ana, la coreografia della sortita di Dalila e delle fanciulle nel primo atto, davvero poco originale e l’onnipresenza delle proiezioni che a tratti rendono quasi difficoltoso seguire quanto avviene in scena. Al contrario le danze rituali del secondo quadro del terzo atto riescono perfettamente e il risultato complessivo è raffinato ed affascinante. Altrettanto elegante è la direzione di Pinchas Steinberg alla guida dell’orchestra e del coro del Teatro Regio, comme d’habitude preparato a puntino da Claudio Fenoglio. L’attenzione ai colori e alle dinamiche, senza che mai l’interpretazione risulti “fredda” e calcolata, è massima ed encomiabile, fondamentale per rendere giustizia alla incantevola partitura del compositore francese. L’accompagnamento ai solisti è sempre puntuale e il dialogo tra buca e palcoscenico esemplare. In scena un cast eccellente in una interpretazione elettrizzante del capolavoro di Saint-Saëns: Daniela Barcellona nei panni della celeberrima femme fatale infonde alla sua Dalila grande dolcezza nei momenti di seduzione e il suo timbro è naturalmente suadente, sorprendono infatti gli slanci di risoluto desiderio di vendetta quando il mezzosoprano triestino abbandona l’amabilità del suo timbro vellutato per una più pungente veemenza e vigore. Trascurabile di fronte a tale prova, e ad alla cura posta anche nella recitazione, l’occasionale comparsa di un vibrato troppo percepibile; il repertorio francese è sicuramente terreno fertile per la cantante. Si sente dire che lo smalto della voce di Gregory Kunde sia stato ormai intaccato dall’inevitabile scorrere del tempo e tale affermazione sembra difficile da contraddire, ma la sua prova in questo Sansone e Dalila accerta semmai quanto invece l’ottima tecnica del tenore statunitense contribuisca a mantenere elastica ed in salute la sua voce. La meticolosità nello studio del testo e della partitura traspaiono in ogni sua interpretazione e risaltano qui come in altre occasioni eppure a fare la differenza nella ricezione di ogni sua esecuzione è la genuina carica emotiva che instilla nei suoi personaggi. Prestanza vocale e fisica contraddistinguono il sommo sacerdote di Claudio Sgura, dall’emissione solida e dall’ottimo fraseggio. Non risulta invece all’altezza l’Abimélech di Andrea Comelli che manca di squillo e imperiosità. Eccellente Sulkhan Jaiani nei panni del vecchio ebreo, i sui avvertimenti a Sansone sono minacciosi al punto giusto. Efficaci ed adeguati ai loro ruoli sono Roberto Guenno, il messaggero filisteo, Cullen Gandy e Lorenzo Battagion, gli altri due filistei. Calorosi gli applausi dal numeroso pubblico in sala, che tributa meritate ovazioni all’intero cast.
PORGY AND BESS [Lukas Franceschini] Milano, 23 novembre 2016.
L’opera Porgy and Bess ha un destino felice al Teatro alla Scala. Infatti, esclusa l’edizione del 1955 (cui non ero presente), sia l’edizione del 1996 sia l’odierna riproposta, hanno avuto un esito trionfale. Porgy and Bess fu musicata da George Gershwin, su libretto di DuBose e Dorothy Heyward, e testi di Ira Gershwin. La storia è basata sul romanzo di Heyward Porgy, che descrive la vita degli afroamericani nell’immaginaria strada di Catfish Row a Charleston all’inizio degli anni trenta. Fu rappresentata in prima assoluta al Colonia Theatre di Boston il 30 settembre, 1935, con cast di cantanti afro-americani di formazione classica, una scelta artistica audace al tempo. Gershwin lesse il romanzo nel 1926 e in seguito propose subito all’autore di collaborare al progetto. Il musicista volle comporre un’opera popolare, e per sua stessa ammissione, non volle utilizzare musica folk ma compose spirituals e canti popolari originali perché la sua idea era quella dell’opera popolare senza agganci con elementi musicali precedenti. La prima versione dell’opera (un’esecuzione di quattro ore, contando i due intervalli) fu eseguita privatamente in forma di concerto alla Carnegie Hall, nell’autunno del 1935. Durante le prove di Boston, Gershwin fece molti tagli e perfezionamenti per abbreviare il tempo d’esecuzione e stringere l’azione drammatica, in previsione del debutto a Broadway, cui seguì una tournée che toccò molte città dell’est americano. Fin dall’inizio, l’opera ha attirato molte polemiche razziali, tali aspetti si sono in parte palcati, forse del tutto scomparsi solo negli anni ’70 del secolo scorso. Gershwin ricevette grande ammirazione musicale da parte di Duke Ellington, anche se polemizzava per l’aspetto drammaturgico dei personaggi di colore. Infatti, molti dei membri del cast originale, dichiarano in seguito che temevano che i loro personaggi potessero indentificare lo stereotipo degli afro-americani, i quali vivevano in povertà, usavano droga e risolvevano le loro diatribe solo con i pugni, identificando Porgy and Bess come un’opera razzista nei confronti dello stile di vita delle persone di colore. In tale ottica, molte rappresentazioni furono cancellate o sospese per la protesta della comunità nera. Dobbiamo dunque considerare che anche la musica talvolta ha aspetti politici e sociali, anche se questo non era nelle idee dell’autore. La convinzione che Porgy and Bess fosse razzista si è rafforzata nel corso del Movimento dei Diritti Civili Americani degli anni 1950, 1960 e 1970, che videro l’opera sempre “fuori moda”. Esemplare fu la dichiarazione di Harold Cruse, critico sociale ed educatore afro-americano: “… Porgy and Bess è un contradditorio simbolo culturale, il più incongruo mai creato nel porgy 3mondo occidentale”. L’opera all-black è stata impopolare per alcuni celebri artisti neri. Harry Belafonte rifiutò la parte nella versione cinematografica fine anni ’50 (il ruolo fu interpretato da Sidney Poitier). Grace Bumbry, la quale trionfò come Bess nella produzione 1985 al Metropolitan Opera (primo allestimento bel teatro newyorkese), dichiarò “…ho pensato che avevo lavorato molto per realizzare quest’opera ed eravamo arrivati nel momento di capire che il 1935 era lontano e le cose erano cambiate. Considero l’opera come un vero pezzo di America di quei tempi, possa piacere o no, ma io ero lì al Met a cantare Bess!” Col tempo l’opera ha guadagnato l’accettazione da parte della comunità afro-americana, anche se non per tutti, e va comunque considerato che lo spartito è particolarmente adatto a cantanti lirici neri, proprio per le peculiari caratteristiche vocali com’era intenzione dell’autore, il non avrebbe immaginato una presa di posizione sociale così contradditoria. La musica riflette le radici jazz di New York, ma richiama anche alle tradizioni dei canti del sud. Gershwin rimodellò le canzoni popolari di sua conoscenza in blues, preghiere, grida di strada, canti di lavoro, e spirituals, i quali si fondono con arie e recitativi. Non mancano anche riferimenti musicali alla liturgia ebraica. È presente anche una serie di leitmotifs, che rappresentano singoli caratteri e sviluppano temi conduttori al fine di riflettere l’azione sul palco. Indicativi in questo senso sono le riprese di “Bess, you is my woman now”, “I got plenty o’ nuttin” e il celeberrimo “Summertime”. La nuova produzione del Teatro alla Scala era un’esecuzione in forma semiscenica per il coro non di colore che non poteva, secondo le disposizioni del compositore, fondere il timbro tipico delle voci di colore. Aspetto opinabile ma accettiamo l’imposizione. Ci troviamo di fronte ad una pedana a scalinata, come quella utilizzata per i concerti, sulla quale si pone il coro, sul palcoscenico agiscono i solisti, sullo porgy 4sfondo dei bellissimi video, che rievocano un’antica Charleston, di Max Kaufmann ed Eva Grun. Philipp Harnoncourt (figlio del direttore Nikolaus) agisce con grande pudore nella difficile drammaturgia con effetti strabilianti, tanto che lo spettacolo è godibilissimo come fosse una vera e propria messa in scena. Tutti i personaggi hanno la loro giusta luce, necessaria per comprendere le differenti sfaccettature. Contribuisce, con esito più che lusinghiero, Elisabeth Ahsef, costumista raffinata e mai banale. Il settore musicale deve iniziare definendo strepitosa la prova del coro, diretto da Bruno Casoni, il quale anche se non “originale” ha saputo fornire una prova maiuscola esprimendo una grandissima professionalità abbinata a una malleabilità in colore e accento davvero encomiabile. La direzione avrebbe dovuto essere affidata al recentemente scomparso Nikolaus Harnoncourt, che amava e aveva studiato molto bene la partitura e sarebbe stato un gradito ritorno scaligero. Alan Gilbert ha ereditato la concertazione, e ha assolto il suo compito con impeccabile stile. L’esotismo sinfonico era il suo tratto più significativo, non mancando neppure l’aspetto folkloristico sempre calibratissimo ma di grande effetto musicale. Magnifica la concertazione delle voci, e del coro, spesso protagonisti assoluti, i quali non sono mai stati “coperti” dall’orchestra ed erano sempre impeccabili. L’orchestra assecondava con grande bravura una lettura d’efficace impatto sonoro con precisione assoluta. Una particolare menzione per Davide Laura, solista al banjo. Nel cast primeggiava il Porgy di Morris Robinson dalla struttura corporea gigantesca, per la quale utilizzava una stampella in luogo del solito carrettino, il quale sfoggiava una voce brunita e affascinante sempre calibrata e di rilevante fraseggio. Meno incisiva la Bess di Kristin Lewis, forse debuttante nel ruolo, alla quale mancava il pathos vocale adatto e talune peculiarità espressive. Bravissimo Lister Lynch, Crown di forte irruenza e stilisticamente perfetto Chauncey Packer, Sportin Life di simpatica caratura. Mary Elisabeth Williams era una straordinaria Serena, timbro e vocalità ammirevoli, e Angel Blue, Clara (cui è riservato il brano più famoso “Summertime”), ha fornito una prova convincente. Ma tutto il cast è da lodare per la grande prova vocale dimostrata: Tichina Vaughn (Maria/donna delle fragole/Annie/Lily), Donovan Singletary (Jake/Fraizer/impresario/coroner), Cameo Humes (Mingo/Robbins/Peter/uomo dei granchi), Stefano Guizzi (Archdale/detective/poliziotto), Massimo Pagano (Jim), Massimiliano Di Fino (Nelson) ed Elhadji Mbodji (Scipio). Teatro esaurito in ogni ordine di posto, pubblico all’inizio perplesso ma in seguito entusiasta dell’esecuzione che è stata premiata con lunghissimi e calorosissimi applausi. Un grande successo!
ROSMONDA D’INGHILTERRA [Lukas Franceschini] Bergamo, 25 novembre 2016.
Dopo i buoni esiti della scorsa e rinnovata stagione, anche quest’anno la Fonazione Donizetti ce la mette tutta per mantenere alto il livello qualitativo delle proposte, di cui Rosmonda d’Inghilterra rappresenta l’apice. Il secondo titolo al Festival Donizetti 2016 è stato Rosmonda d’Inghilterra nella sua prima realizzazione scenica in tempi moderni. Opera seria in due atti, seconda in ordine cronologico che il compositore scrisse per la compagnia di Lanari al Teatro alla Pergola di Firenze per la Stagione di Carnevale del 1834. Composta solo due mesi dopo Lucrezia Borgia, per la prima vantava un cast superlativo: Fanny ros 2Tacchinardi-Persiani (protagonista, suo primo ruolo donizettiano), Anna Del Sere (Leonora), Gilbert Duprez (Enrico II), Carlo Porto (Clifford) e Giuseppina Merola (Arturo). La vicenda, su libretto di Felice Romani, narra le vicende alla corte d’Inghilterra nel XII secolo dell’amore extraconiugale tra il Re Enrico II e la giovane Rosamon Clifford, il quale provocò la vendetta della potente Regina Eleonora d’Aquitania. Le vicende storiche non si conclusero come nell’opera, anche se Leonora fu acerrima nemica del marito sia politicamente sia per la sua relazione, ormai palese a tutti, con la giovane Clifford. In origine il libretto fu scritto per Calo Coccia (1829), poi quando fu musicato da Donizetti, Romani apportò alcune modifiche. A nessun’altra opera del bergamasco di questo periodo toccò sorte così limitata, dopo Firenze vi fu una sola ripresa nel 1845 a Livorno. Nel secolo XX la riscoperta per una appena nata Opera-Rara a Londra in forma di concerto, un’incisione discografica negli anni ’90, senza tralasciare due memorabili e forse insuperate incisioni dell’aria di sortita di Rosmonda interpretate da Joan Sutherland e Beverly Sills. Qualche musicologo ha rilevato che Rosmonda rappresenta un affievolimento dell’energia creativa di Donizetti e pur sfoderando la consueta padronanza di mestiere e un’incisiva scioltezza di rado riesce a commuovere lo spettatore. Inoltre, sul piano drammaturgico musicale non mette bene a fuoco i personaggi. Personalmente mi dissocio dal primo punto poiché qui troviamo un Donizetti che sperimenta e attua nuove forme di spettacolo: riprende un tema a lui caro la rivalità tra due primedonne, ma lascia perplessi per un finale veramente drammatico ma poco usuale, che finisce con una chiusura “tronca” dopo l’assassinio della protagonista. Non mancano pagine di altissimo valore, concertati raffinati e duetti di forte tensione teatrale (come quello del II atto tra Enrico e Leonora), anche se l’autore avrebbe potuto scolpire con maggior enfasi alcune caratteristiche dei protagonisti. Resta indubbia la solida mano del musicista e una musica che forse non rapirà l’ascoltatore ma è di elevata fattura. L’aspetto del finale “deludente” fu ripensato dallo stesso compositore nel 1837 quando utilizzò la musica per un parziale rifacimento, intitolato Eleonora di Gujenna, per la quale aggiunse un ensemble e una cabaletta in stile ottocentesco per la Regina d’Inghilterra, però l’opera non fu mai rappresentata. Non lascia segno efficace l’allestimento ideato da Paola Rota assieme Nicolas Bovey, scenografo e disegno luci. Ambiente lugubre e spoglio, arredi quasi inesistenti. La corte inglese non era particolarmente fiorita al tempo ma qui si eccede. Ci sono due pareti mobili appese in graticcia, che sono spostate a vista da mini creando una scena piuttosto banale. Tolto l’aspetto visivo, che forse voleva rappresentare il torbido momento storico, Rosmonda rinchiusa in un castello e la drammatica tensione tra i coniugi reali, quello che manca è una precisa e indicativa linea drammaturgica sui personaggi. La protagonista relegata in una gestualità da bambola in custodia, il re per niente regale e autorevole, Clifford un padre in bilico tra il sentimentale e il pietismo, la regina austera e regale, messa in evidenza più dall’arte della cantante che dalla regista, il coro ridotto a comparsa di entrata e uscita. I costumi di Massimo Cantini Parrini erano invece tutti di grande fattura e classe, ma si distinguevano in particolare quelli di Eleonora. Sebastiano Rolli, direttore e concertatore, a capo dell’Orchestra Donizetti Festival ha imposto una lettura molto rilevante sia nel ritmo sia nella sequenza drammatica delle variegate sonorità, sempre controllate e molto raffinate. Attento e preciso nel rapporto con il palcoscenico mantiene un equilibrio teatrale molto efficace, sovente aiutando i singoli, e creando un’atmosfera tersa e di grande effetto. Ottima la prova dell’Orchestra, la quale ha avuto un notevole miglioramento rispetto a edizioni passate. Rilevante anche l’esibizione del Coro Donizetti Opera, istruito da Fabio Tartari, che già da qualche tempo assicura prestazioni di altro profilo. Jessica Pratt, la protagonista, riconferma le sue peculiari doti vocali di belcantista, tuttavia, dobbiamo rilevare una sommaria piattezza nell’aria di sortita e un fraseggio poco incisivo, sempre preoccupata a far risaltare la zona acuta a scapito delle sezioni centrali. Il personaggio, nella prima parte, era abbozzato e quasi inerme, diversamente nel secondo atto ha reso il ruolo con più carattere e maggiore accento canoro essendo nell’insieme credibile ma non uniforme nell’intera opera. Al contrario Eva Mei, Leonora, ha offerto una prova sbalorditiva in un ruolo di forte drammaticità e impegnando lo strumento vocale in zona centrale-grave da lei non abitualmente frequentata. Bravissima nella modulazione dei colori, fraseggio eloquente, dinamiche negli accenti davvero ragguardevoli, cui bisogna sommare, e non è da meno, una presenza scenica stupefacente, una vera donna forte e risoluta. Una prova da lodare appieno. Dario Schmunck, Enrico II, doveva affrontare una parte molto ardua (scritta per il citato Duprez) dovendo cantare in una zona acuta da tipico tenore belcantista assieme a un centro non meno indicativo per accento e pastosità di timbro. Dobbiamo affermare che le alternative a questo ruolo non erano molte, anzi poche a dire il vero, e Schmunck ha fatto il possibile con le sue capacità, ma era l’anello debole della produzione. Non dotato di timbro affascinante, ha reso con sufficienza nel settore acuto, molto al limite, a scapito della sezione grave spesso afona e dimostrando spesso una certa fatica sostenere il ruolo, anche se si deve ammirare l’impegno e l’enfasi dimostrata pur non raggiungendo vertici eguali alle colleghe. Molto buona la prova di Nicola Ulivieri, Clifford, al cui ruolo non sarebbe guastata un’aria, ma il cantante trentino ha reso con grande carisma il nobile padre guerriero e risoluto nell’imporre i suoi voleri alla figlia. Bravissimo sotto il profilo vocale con un canto morbido, rotondo sempre controllato e ricco di accenti affascinanti. Altrettanto possiamo affermare per Raffaella Lupinacci, Arturo, una cantante in continua ascesa che anche in quest’occasione ha avuto modo di mettere in luce le sue buone qualità di mezzosoprano assieme ad un rigoglioso settore acuto e un personaggio ben interpretato. Per questa prima esecuzione scenica il Teatro Donizetti era esaurito in ogni ordine di posto, e questo era un bel vedere. Il pubblico ha promosso con calorosi applausi tutti i cantanti e direttore, meno soddisfatto della parte visiva si sono registrati non isolati dissensi all’uscita del team tecnico-artistico.
ROSMONDA D’INGHILTERRA [William Fratti] Bergamo, 25 novembre 2016.
Come già scritto a ottobre in occasione delle recite fiorentine il melodramma, che è stato riesumato dal suo lungo e ingiustificato oblio solo negli anni Settanta a Londra e Belfast per poi ricomparire un ventennio più tardi in una registrazione di Opera Rara, è stata oggetto di una revisione critica sull’autografo a cura di Alberto Sonzogni per la Fondazione Donizetti di Bergamo. Eseguita in forma di concerto all’Opera di Firenze per la prima volta in Italia in tempi moderni è ora allestita sul palcoscenico bergamasco in uno spettacolo ideato da Paola Rota, con scene e luci di Nicolas Bovey e costumi di Massimo Cantini Parrini. L’impianto semplice, minimalista e suggestivo lascerebbe spazio allo sviluppo psicologico dei personaggi se non fosse per il grande vuoto che crea noia e monotonia. La gestualità degli interpreti è spesso assimilabile al solo estro degli artisti; le controscene che dovrebbero riempire, spiegare, sottolineare, anticipare, sono davvero troppo poche. Non si può dire che lo spettacolo non sia riuscito, ma lo si potrebbe definire soltanto un abbozzo. Discreta la prova dell’Orchestra Donizetti Opera e del Coro diretto da Fabio Tartari, entrambi composti da ottimi professionisti, ma che per funzionare al meglio avrebbero bisogno di maggior compattezza. Così come a Firenze la bacchetta è nelle mani di Sebastiano Rolli, sempre eccellente nello stile, ma ancora avaro d’accenti. Protagonista è sempre Jessica Pratt, una delle migliori interpreti del belcanto italiano che, rispetto alle esecuzioni concertistiche, perde un poco di cristallo nei sovracuti. Ottimi i colori e le sfumature del personaggio. Si riconferma raffinatissima maestra di eleganza la Leonora di Eva Mei, che addirittura riesce a migliorare nei fraseggi e nelle tinte drammatiche, mantenute sempre uniformi alla linea di canto, con suoni bassi sempre misti, mai di petto, onde preservare l’impeccabile stile belcantista, reso con gusto e classe impareggiabile. Dario Schmunck è un Enrico II efficace solo a tratti. La vocalità è talvolta brillante e squillante, talaltra stimbrata, non riuscendo dunque a trasmettere un senso di continuità. Nicola Ulivieri è un Clifford sempre elegante, abile fraseggiatore, ottimo interprete nella vocalità, nelle sfumature, nello stile e nella recitazione. Ancora una volta perfetto è l’Arturo di Raffaella Lupinacci, che trova terreno particolarmente fertile in questo tipo di ruoli di cui abbonda il romanticismo italiano, con la speranza di riascoltarla presto.
A CHRISTMAS CAROL [Lukas Franceschini] Trento, 2 dicembre 2016.
“Tutti abbiamo la possibilità di migliorarci. Possiamo iniziare nuovamente da zero e cambiare in meglio. Non è mai troppo tardi per considerare le conseguenze derivanti dai nostri comportamenti. In fin dei conti potremmo tutti cercare di essere più generosi nei confronti del prossimo”. Questo in sintesi il messaggio più importante dell’opera A Christmas Carol del compositore inglese Iain Bell. La Stagione “OperA 20-21” dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, sottotitolata “Love and other cruelties”, prosegue la programmazione concarol 2 un altro titolo contemporaneo, rappresentato in prima assoluta nel 2014 alla Houston Grand Opera, tratta dall’omonima novella di Charles Dickens, su libretto di Simon Callow. A Christmas Carol è una celebre novella natalizia dello scrittore anglosassone, la quale è una feroce critica alla società basata, in sintesi, sull’arricchimento di pochi a discapito di tanti. Dickens la scrisse nel 1843 raccontando la storia di un uomo d’affari avaro ed egoista, Ebenezer Scrooge. La storia si svolge la notte della viglia di Natale e narra l’inquietudine del protagonista. Infastidito di tutto e soprattutto della prossima festività, Scrooge individua tra la neve il volto del defunto socio in affari, una visione che gli desta turbamento. La notte sarà ancora più travagliata con la visita di tre spiriti che carol 3rappresentano il Natale passato, presente e futuro, questi porteranno Scrooge a pentirsi dei propri atti egoistici e suggerire un cambio interiore. Il protagonista, lasciando sorpresi tutti, decide di diventare un uomo diverso: una seria riflessione e l’imminenza del Natale faranno di lui un uomo nuovo che da un altro valore alla sua vita. Non è mai troppo tardi sia per cambiare sia per iniziare una nuova esistenza. Il musicista ha precisato nel programma di sala che questa non è la consueta novella natalizia ma contiene un messaggio molto più profondo: Scrooge è destinato alla dannazione, ma il destino gli offre una seconda e ultima possibilità, la quale è raccolta proprio nel periodo di Natale. Denominata One Singer Opera, poiché è interpretata da un solo cantante, è un’idea che Bell ebbe dopo la sua prima opera lirica, nella quale era impegnato un organico molto consistente, inoltre, drammaturgicamente si è rifatto alla prassi che lo stesso Dickens carol 4durante la promozione del suo scritto era solito impersonare i diversi personaggi del racconto. Questa rappresentazione segna il debutto italiano di Iain Bell, il quale si definisce un “vecchio compositore” londinese che ama l’armonia audace portando l’ascoltatore verso inedite e inaspettate melodie. In tale ottica l’ispirazione è tratta da Claude Debussy, Alban Berg e Gyorgy Ligeti, ma è soprattutto l’influenza di Benjamin Britten, dal quale è ispirato per melodie forse violente ma che evocano oscurità e situazioni cupe, che caratterizzano i suoi spartiti. In quest’opera egli ha dovuto tenere in considerazione molteplici aspetti vocali oltre alla “resistenza” dell’unico cantante presente. Il compositore in questo suo secondo spartito operistico, che sarebbe più corretto chiamare commedia in musica, accompagna carol 5prevalentemente il libretto con una musica cristallina, ponendo l’accento su timbri crudi alternati a una melodia molto rilevante, come predetto Britten ispira ma non è copiato, e l’orchestrazione è particolarmente forbita con soluzioni che ricordano più il classicismo che la modernità. Una musica che si ascolta con piacere e segna una vena artistica di assoluto talento. Il librettista Simon Callow sceglie un solo personaggio, il quale è trasformato in narratore e rasenta la figura del racconto d’appendice. Testo accuratissimo e ben sintetizzato nella drammaturgia del racconto. Di grande livello la prova dell’Orchestra Haydn guidata dal giovanissimo James Southall, il quale esegue una lettura di forte impatto drammatico narrativo scavando nella non facile partitura, e rilevando attraverso tempi sostenuti e ritmo incalzante squarci sonori di grande carol 6effetto. Straordinaria la prova del tenore Mark Le Brocq, il quale accomuna una recitazione da manuale con un canto forbito, equilibrando testo e musica attraverso la duttilità della sua arte vocale. Tali peculiarità hanno contribuito in modo efficace a rendere chiaro e di forte tensione il racconto di Dickens, anche in considerazione della tenuta vocale per due atti di circa quarantacinque minuti di assolo. Lo spettacolo, che proveniva dalla Welsh National Opera, era realizzato da Polly Graham, la quale crea una drammaturgia emozionante in un ambiente unico, un po’ astratto ma con evidenti riferimenti natalizi, calibrando una perfetta recitazione. Lei aggiunge un personaggio recitato, l’assistente del narratore, impersonato dalla bravissima Veronica Risatti. Nate Gibson, scenografo e costumista, ambienta la vicenda in pieno stile ottocentesco, tocco personale per la scena con tavolo mastodontico e pochi oggetti, elemento principale il libro che tiene sempre in mano il protagonista, realizzazione accuratissima per il costume in clima romanzo d’appendice. Non meno efficaci le luci di Ceri James che realizza un ambiente molto affascinante. Il Teatro Sociale di Trento era molto affollato di pubblico, giovane e meno, cosa piuttosto rara per un’opera contemporanea in prima per l’Italia, ma il lavoro è piaciuto e ha convinto sia gli spettatori sia chi scrive. Applausi convinti, prolungati e meritati al termine.
ATTILA [Lukas Franceschini] Venezia, 9 dicembre 2016.
Attila, dramma lirico di Giuseppe Verdi, torna a essere rappresentato per cinque recite nel teatro in cui nacque il 17 marzo 1846. Opera del primo periodo i cosiddetti “anni di galera”, ha conosciuto un oblio fino alla seconda metà del secolo scorso, poi una continua riscoperta tanto che oggi possiamo considerarla opera di repertorio, tanti i cantanti che si sono cimentati nei quattro ruoli principali, ardui, att 2scolpiti musicalmente e di grande spessore drammatico. Lo spettacolo presentato a Venezia è la ripresa dell’inaugurazione del Teatro Comunale di Bologna 2016, con quale era coprodotto assieme al Teatro Massimo di Palermo. Sulla concezione registica di Daniele Abbado, Gianni Carluccio (scene, costumi, disegno luci), Daniela Cernigliano (costumi) e Simona Bucci (movimenti coreografici) in sostanza restano le impressioni non entusiastiche espresse nella recensione di Bologna. La narrazione è sommariamente banale e senza particolari focalizzazioni sui personaggi, movimenti convenzionali e carenza di spessore sui personaggi di Attila e Odabella, che avrebbero meritato più attenzione. Molte scene opinabili con figuranti accosciati dei quali non ho capito il senso, e l’assurdità dell’assassinio di Attila prima appeso a funi calate dall’alto. Tutto scorre senza grande disturbo, ma resta tutto dimenticabile. Il palcoscenico veneziano, più ristretto di quello di Bologna, dava un senso più raccolto alla visione e in parte era un’aggiunta positiva. Costumi senza stile, d’impronta principale erano lunghi cappotti senza stile, scena stilizzata ma senza riferimenti storici, non spettacolare ma passabile. Sul podio abbiamo avuto Riccardo Frizza, il quale pur confermando le sue doti di concertatore a mio avviso firma una delle sue migliori direzioni da me udite in teatro. Complice anche una precisa e attenta orchestra, egli concerta con grande dinamismo, sfoggiando sonorità molto belle nei momenti lirici, introduzione atto I, ma anche battaglieri e con ritmo sostenuto nei passi concitati. Una bellissima prova stilistica del primo Verdi. Molto buona la performance del coro, diretto da Claudio Marino Moretti, il quale conferma anche in quest’occasione il rilevante livello raggiunto negli ultimi anni. Protagonista era il basso Roberto Tagliavini, il quale ha fornito prova d’ottima interpretazione accomunata a un canto rifinito, ben delineato nei registi e di forbito timbro. Rispetto alla sua esibizione veronese di qualche anno fa, ha notevolmente migliorato sia l’interpretazione sia lo stile del canto, cui si deve rendere un sincero plauso. Diversamente l’Odabella di Vittoria Yeo ha avuto qualche difficoltà nell’ardua parte vocale. La voce della cantante coreana è molto bella ma non è un drammatico d’agilità, pertanto le difficoltà sono state soprattutto nel registro grave, totalmente afono, per far fronte alle impegnative volate nel settore acuto. A mio parere la cantante sta osando un po’ troppo nella scelta del repertorio, troppo oneroso per i suoi mezzi, e non vorrei che questo compromettesse una voce di assoluto rilievo che però andrebbe amministrata diversamene. Bisogna riconoscerle che rispetto alla recente “piatta” Giovanna d’Arco di Parma, ora abbiamo ascoltato un accento e un fraseggio più incisivo e pertinente. Molto bravo Julian Lim, Ezio, che esibisce una linea di canto di gran classe, rifinita e molto omogenea anche se non particolarmente raffinato nell’accento, ma nel complesso una prova molto apprezzabile. Il Foresto di Stefan Pop era impegnato a mostrare muscoli vocali e acuti sparati, in uno stile decisamente ormai sorpassato. Peccato perché il tenore possiede dei mezzi non comuni, i quali se fossero amministrati diversamente avremo risultati di altro stampo. Per questo dovrebbe impegnarsi curando il fraseggio, il colore modulato e cantare anche in piano e non tutto forte. Speriamo in futuro in occasioni migliori. Bravissimo Mattia Denti, Leone, timbro scuro ed espressivo nel canto, tutto lineare e con ampio sfoggio di colori, al suo pari anche l’Uldino di Antonello Ceron, che in questi ruoli si riconferma interprete e cantante di riferimento. Teatro esaurito in ogni ordine e pieno successo al termine.
RIGOLETTO [Simone Ricci] Roma, 10 dicembre 2016.
Una regia e delle scene rispettose: i tre atti di Giuseppe Verdi hanno convinto il pubblico romano, conquistato dalla semplicità e giovinezza dell’opera. Giovin, giocondo, sì possente, bello: Rigoletto descrive in questa maniera il suo padrone, il Duca di Mantova, dopo aver incontrato per la prima volta Sparafucile. Sono gli stessi aggettivi che si possono usare per parlare del lavoro scelto quest’anno dal Teatro dell’Opera di Roma per il progetto “Fabbrica-Young Artist Program”. L’iniziativa permette ai nuovi talenti, già formati presso conservatori e accademie, di inserirsi nel mondo dello spettacolo, quindi nel cast dell’opera verdiana figuravano molte promesse interessanti della lirica. Questa recensione si riferisce alla replica finale, quella di sabato 10 dicembre 2016. L’allestimento del Costanzi è stato molto rispettoso del libretto e della trama: la regia di Leo Muscato ha puntato sul sicuro con una regia collaudata e sui chiaroscuri del mondo astratto suggerito da Verdi e Piave. Le grandi insegne luminose indicavano allo spettatore che ci si trovava di fronte al palazzo del Duca e all’osteria: il perimetro delle stanze era rappresentato da semplici e trasparenti tende, mentre era decisamente evocativo il paesaggio notturno del terzo atto e si poteva intuire la presenza minacciosa del Mincio. Le scene di Federica Parolini e i costumi di Silvia Aymonino erano ugualmente poco propensi all’esagerazione. I cortigiani in frac (con tanto di maschere da maiale) potevano far pensare a un’epoca diversa rispetto al ‘600, ma non disturbavano la vista. Il pubblico ha tributato lunghi applausi al cast vocale, con picchi di entusiasmo al termine delle arie più celebri. Luca Salsi, ancora fresco di successi per il “Nabucco” alle Terme di Caracalla della scorsa estate, ha vestito la maschera del buffone come una seconda pelle. L’esecuzione è stata intensa e ben calata nella psicologia di un personaggio tanto complesso: ha stupito il pubblico romano con la mezzavoce e il piano, caratterizzando bene la vigoria di Pari siamo e l’amarezza rabbiosa dei Cortigiani. Lisette Oropesa ha dimostrato di essere a suo agio nei panni di Gilda: la voce ha brillato negli acuti, senza dimenticare la capacità di saper commuovere con suoni visionari e trasognati fino al leggerissimo sospiro delle note finali. Caro nome ha ricevuto giustamente l’applauso più scrosciante della serata e la voce del soprano americano ha impreziosito lo splendido quartetto Bella figlia dell’amore. Piero Pretti ha affrontato con grande proprietà di mezzi il ruolo del Duca, anche se non sarebbero stati fuori luogo due pizzichi in più di spavalderia e incisività: la vocalità fresca e ben strutturata ha comunque convinto. La Maddalena di Erika Beretti, una delle artiste del progetto “Fabbrica”, era ben caratterizzata dal punto di vista scenico: non c’è stata traccia di emozione nel difficile e già citato quartetto, in poche parole una buona impressione. Il cast era completato dal lugubre (dunque in questo caso azzeccato) e preciso Sparafucile di Dario Russo, l’appropriato e intenso Monterone di Fabrizio Beggi, altri tre artisti del progetto – Reut Ventorero (una Giovanna delicata e mai sopra le righe), Timofei Baranov (uno spavaldo Marullo), Aleandro Mariani (Matteo Borsa) e Sara Rocchi (Contessa di Ceprano) – oltre a Leo Paul Chiarot (Conte di Ceprano), Fabio Tinalli (usciere di corte) e Claudia Farneti (paggio della Duchessa). La direzione d’orchestra è stata affidata al giovane Michele Gamba, il quale vanta un importante debutto alla Scala datato pochi mesi fa: con i suoi 33 anni ha trasmesso tanta energia e vigore alla partitura verdiana, senza tralasciare i momenti intensi e drammatici. Personalmente non avrei accelerato in modo eccessivo come ha fatto con la scena in cui Rigoletto finge di fischiettare dopo che ha scoperto il rapimento della figlia, ma potrebbe essere il classico pelo nell’uovo. L’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma si è mostrata sicura e minuziosa, oltre che capace di assecondare la volontà di virtuosismo dei vari personaggi. In un’opera come “Rigoletto” non si può non citare la prova del coro. Roberto Gabbiani ha dato come di consueto indicazioni molto precise e gli applausi finali sono stati forse un po’ tiepidi rispetto ai reali meriti: lo Zitti, zitti è stato ben tratteggiato, mentre l’accompagnamento a bocca chiusa durante la “notte di mistero” del terzo atto era minaccioso al punto giusto. In diverse occasioni il loggione ha sottolineato la bravura del cast, in particolare Gilda e il Duca: ora con l’ultima recita di “Tristan und Isolde” di Wagner di questa sera si concluderà il 2016 del Teatro dell’Opera di Roma.
LA TRAVIATA [William Fratti] Genova, 15 dicembre 2016.
Dopo la forzata cancellazione della nuova produzione de La rondine di Giacomo Puccini, il Teatro Carlo Felice di Genova inaugura la Stagione 2016-2017 con La traviata di Giuseppe Verdi nel nuovo spettacolo firmato da Giorgio Gallione. Mettere in scena l’opera che più di tutte, nel corso degli ultimi trenta anni, è stata oggetto delle più svariate interpretazioni e trasposizioni non è affare semplice. Tutt’altro. È tanto difficile costruire nuove idee, come superare gli allestimenti classici dei grandi registi del passato. Gallione riesce a realizzare un dramma godibile, poiché conosce bene il suo lavoro, pertanto sul palcoscenico succede sempre qualcosa che mantiene viva l’attenzione del pubblico. Ma lo fa mescolando tra loro vecchie idee già viste e rivisitate: Violetta che muore nel preludio e rivive la vicenda come una sorta di flashback; il simbolismo dell’arbusto di camelia sfiorito e senza foglie; le mele rosse; lo specchio infranto; il coro alla Magritte e altre ancora. Ottima la realizzazione delle scene e dei costumi di Guido Fiorato, di buona fattura e pertinenti ai concetti sviluppati. Eccellenti e suggestive le luci di Luciano Novelli. Meno interessante la coreografia di Giovanni Di Cicco, poiché totalmente avulsa dall’elegante stile utilizzato per il resto del racconto. Massimo Zanetti è sul podio della brava e precisa Orchestra del Teatro Carlo Felice. La sua lettura della partitura non dà particolari spunti interpretativi, ma compie un buon lavoro di guida e accompagnamento. Molto positiva è anche la prova del Coro diretto da Franco Sebastiani, ma è da segnalare un breve fuori tempo nella pagina dei mattadori e successivamente in “Oh, infamia orribile”. Se è complesso mettere in scena una Traviata originale, ancora più complicata è la scelta della giusta protagonista. Occorre innanzitutto partire dal presupposto che la parte di Violetta sarebbe scritta per soprano drammatico di agilità, ma che negli ultimi venti anni i teatri di tutto il mondo l’hanno quasi sempre affidata a soprani più leggeri, favorendo soprattutto la riuscita di “Follie… Sempre libera” con i suoi do sopracuti e il mi bemolle finale, ma andando a perdere lo spessore delle numerosissime note basse che, anche se fossero emesse correttamente – ma dai più sono generalmente eseguite con suoni distorti o schiacciati o poco sostenuti – perdono comunque di intensità. Detto ciò, all’interno di una lunga serie di protagoniste di coloratura, Desirée Rancatore è in assoluto una delle migliori interpreti di questo ruolo, poiché il fraseggio, gli accenti, l’uso dei colori, ma soprattutto la parola scenica, provengono dal suo animo più profondo. “Addio del passato” è un momento sinceramente sentito e davvero toccante, al termine del quale il soprano riceve un meritatissimo successo personale. Giuseppe Filianoti, pur possedendo ancora una bellissima voce, limpida e allo stesso tempo pastosa, presenta qualche problema in appoggio e il suo Alfredo, in alcuni punti, non è perfettamente intonato. Si riscontra poi una difficoltà in acuto durante l’aria e pare essere solo un momento; ma ciò accade ancora durante la cabaletta e il finale secondo e prima dell’inizio del terzo atto il tenore è annunciato indisposto e sostituito da William Davenport che conclude l’opera. Vladimir Stoyanov è Germont e finalmente lo si riascolta col vigore e la brillantezza di un tempo. Di primo livello il duetto con Rancatore, eccellente “Di Provenza” dove il baritono esprime tutta la sua capacità di fraseggio, impreziosito di colori e sfumature toccanti. Daniela Mazzucato è un’Annina di lusso; Marta Leung è una Flora soddisfacente; Didier Pieri è un Gastone accettabile seppur con alcune riserve; Manrico Signorini pare indisposto poiché sembra un Dottor Grenvil dalla voce traballante e usurata; Paolo Orecchia è un Barone passabile; Stefano Marchisio è un ottimo Marchese. Completano i non troppo efficaci Giuseppe di Maurizio Raffa, domestico di Alessio Bianchini e commissionario di Matteo Armanino. Grande successo per una prima emozionante, soprattutto per Desirée Rancatore e Vladimir Stoyanov. Qualche dissenso per la squadra creativa dello spettacolo.
MADAMA BUTTERFLY [Lukas Franceschini] Milano, 16 dicembre 2016.
Per la prima volta la Stagione d’Opera del Teatro alla Scala di Milano è stata inaugurata dall’opera di Giacomo Puccini Madama Butterfly, per l’occasione nella versione della prima assoluta del 17 febbraio 1904. È stata precisa volontà del maestro Riccardo Chailly proporre la partitura originale dell’opera che ebbe una sola rappresentazione poiché il compositore dopo il fiasco della prima ritirò lo saprtito e di conseguenza furono cancellate tutte le recite previste. Oggi, il lavoro di ricostruzione della partitura è opera di Julian Smith. Inutile ripercorrere la genesi di come nacque una delle più famose e mad 2rappresentate opere liriche, è cosa abbastanza risaputa. Vorrei piuttosto rilevare talune differenze tra l’edizione solitamente eseguita e l’originale. Nell’atto I, prima della scena del matrimonio, Cio-Cio-San si dilunga a vario modo presentando tutto il suo stuolo di parenti al futuro marito, fra questi lo zio Yakusidé, uomo molto propenso al bere. Goro, il sensale, si dilunga in convenevoli con gli ufficiali giapponesi, e la stessa protagonista argomenta sulle differenze religiose tra oriente e occidente. Lo zio, ormai ubriaco, canta una canzoncina ma fatica ad intonarla, tra la derisione degli invitati e il disprezzo di Pinkerton che usa anche parole poco gentili anche nei confronti dei servitori. Nel duetto finale atto primo vi è una pausa di riflessione di Butterfly che racconta al marito i diversi rifiuti di matrimonio precedenti, musicalmente lo stile amoroso pucciniano prosegue in forma parallela tra sentimento ed emozione. Il secondo atto (che diventa un blocco unico) la vicenda si trasforma prima in una commedia statica per svilupparsi solo nel finale nella vera e propria tragedia. Nella prima parte è indicativo che il brano “che tua madre” non raggiunga un vertice di tragicità, ma resta ancorato alla melodia e ai modi giapponesi, come poi in seguito la canzone stile ninna-nanna “È Roje un bimbo biondo” e quella più tragica intonata a Suzuki “Ei venne alle sue porte”. Memorabile invece il terzetto Pinkerton-Suzuki-Sharpless all’interno della casa nel finale che in parte sostituisce l’aria “Addio fiorito asili” non presente nella prima versione. Anche la figura di Kate assume una rilevanza drammaturgica più concreta, nel volere il bimbo, considerato lo scambio di battute con Cio-Cio-San. I coniugi americani, Pinkerton e Kate, assumono in questa prima esecuzione luci diverse e molto più drammatiche. Il primo dimostrando la sua vera codardia di uomo cinico ed egoista, la seconda come in parte suddetto, pur essendo “causa innocente di sciagura” (parole pronunciate da Sharpless nella versione di Brescia) non si fa scrupolo di chiedere il bimbo con forza alla madre. L’’assenza dell’aria “Addio fiorito asil”, marca tali caratteristiche, e rende la vicenda più drammatica, è plausibile che fu introdotta per offrire un assolo al tenore. Curiosità a margine nella prima versione il capitano di marina americano si chiama Sir Francis Blummy Pinkerton. È risaputo che la prima esecuzione fu fischiata dal pubblico perché in parte non capita ma soprattutto per un ordito complotto nei confronti di Puccini, il quale probabilmente prese lo schiaffo più sonoro di tutta la sua carriera, riscattato in seguito con il trionfo di Brescia qualche mese più tardi che ripristina l’abituale edizione da noi sempre ascoltata. Doveroso ricordare che vi furono dei lievi ritocchi di partitura anche per l’edizione parigina del 1906 e quella di Milano al Teatro Carcano 1920. Alla Scala l’oblio perdurò per quasi un ventennio, fu Arturo Toscanini nel 1925 a mettere in cartellone Madama Butterfly con l’autorevole presenza di una cantante del calibro di Rosetta Pampanini. Riprendo al pari le parole di Riccardo Chailly: “La nostra decisione di eseguire alla Scala la prima versione di Madama Butterfly vuole essere una possibilità in più di ascolto, confronto e conoscenza”. A queste parole non c’è nulla da aggiungere, sintetiche e precise esprimono quello che deve essere sia il ruolo di chi esegue musica lirica sia di chi ascolta, pur nella preferenza della versione, ma per tutti deve prevalere la sete di curiosità e per questo non possiamo che ringraziare il direttore musicale della Scala per le scelte effettuate nel corso di questi anni nel repertorio pucciniano. La regia era affidata ad Alvis Hermanis che sceglie una via incentrata sul teatro gestuale del kabuki, il quale dovrebbe offrire attraverso una retorica fisica e gustale la pertinente drammaticità della vicenda. Tale peculiarità forse va abbinata a testi orientali, mentre qui siamo alla presenza di uno spartito di Puccini che ha nel sentimento e nell’emozione il suo fulcro principale. Il disegno registico, seppur elegante e senza sbavature, non trova “anima”, non crea effetti, emozioni, fremiti, si limita a raccontare molto delicatamente e in maniera stilizzata la triste vicenda. Più rasente al tradizionale che all’innovativo, peraltro non da disprezzare, non crea danni e il mondo giapponese è rappresentato a tutti gli effetti. Molto belle e di meccanica laboriosità le scene a “sipario” sempre dello stesso regista e Leila Fteita, con bellissime riproduzioni di Nagasaki dei primi anni del secolo scorso. Difficile trovare parole per elogiare i magnifici costumi di Kristine Jurjane, preziosi e con splendidi ricami che forse la visione teatrale non rende sufficiente giustizia. Buona la visione drammaturgica di Olivier Lexa e bellissime le luci di Gleb Filshtinsky. Il principale artefice di questo successo è indiscutibilmente il maestro Riccardo Chailly. La sua concertazione è stata esemplare sotto tutti i punti di vista, ma in particolare colpisce il senso narrativo, nel quale ha impresso colori e sfumature di grande effetto. Sempre in perfetto equilibrio tra momenti molto lirici e drammatici ha sviscerato quanto di meglio è possibile ascoltare dalla musica di Puccini e in particolare in questo per noi “nuovo” ascolto tutte le sfaccettature de caso, rilevante nella passione come nel canto di conversazione sempre contenuto ma retto sul filo della tensione drammatica, con giusti agganci sinfonici, per arrivare all’esplosione tragica finale da mozzare il fiato. Una prova di assoluto rilievo del direttore milanese cui dobbiamo un grazie sincero per questa nuova proposta. Da par suo l’orchestra segue il “suo” direttore non solo con la consueta professionalità ma anche con un entusiasmo di realizzazione che possiamo affermare di altissimo valore. Il coro diretto da Bruno Casoni, anche se in una contenuta esecuzione, conferma la sua mirabile professionalità in un emozionante coro a bocca chiusa. Protagonista doveva essere il soprano Maria José Siri ma alla nostra recita abbiamo trovato Liana Aleksanyan che probabilmente sostituiva la indisposta. La signora Aleksanya ha cantato con onesta professionalità e voce omogenea e di bel tratto lirico, purtroppo le mancava la parte essenziale per essere una Butterfly di rilievo: il fraseggio e il colore. Infatti, tutta la sua performance era limitata a una sommaria interpretazione e duttilità vocale, non riuscendo a trovare i necessari accenti per interpretare prima la bambina poi la donna Cio-Cio-San. Adagiatasi sulla blanda ruotine, talvolta anche stantia, non è caduta in grossolani errori ma siamo ben lontani dalle intenzioni del direttore, dal quale ha avuto un aiuto non indifferente. Il Pinkerton di Bryan Hymel difettava per una mancanza sostanziale nel settore centrale, caratteristica che in quest’opera lo metteva in disagio nel canto di conversazione. Più abituato a ruoli acuti era sovente coperto dai colleghi e talvolta anche dall’orchestra, difettando per scansione e fraseggio non curatissimi. Molto superiore alla precedente prova scaligera Carlos Alvarez, Sharpless, che in questo ruolo trova conferma del grande artista che sappiamo. Calibratissimo nel canto, manierato ed elegante nell’accento, ha messo in rilievo una preziosa corda vocale in un personaggio calzato magnificamente. Chi si è ritagliato un successo del tutto personale è stato Carlo Bosi, Goro, che ha interpretato e cantato un sensale di riferimento nel panorama attuale. Voce squillante e limpida, fraseggio e accento bellissimi, accomunati da una recitazione teatrale di forte impatto, impersonando il subdolo e viscido affarista in modo esemplare. Molto brava anche la Suzuki di Annalisa Stroppa, ben delineata nel canto e di forte impatto emotivo. In questa produzione abbiamo avuto un cast nei ruoli minori di accurata scelta e grande professionalità che raramente si può riscontrare in altremad 6 produzioni. Costantino Finucci era un bravissimo Yamadori, Abramo Rosalem un inferocito ma contenuto Zio Bonzo, Leonardo Galeazzi un simpatico e brillante Yakusidé, incisivi Gabriele Sagona e Romano Dal Zovo rispettivamente Commissario Imperiale e Ufficiale del registro. Bellissima ed elegante la Kate di Nicole Brandolino, e perfetto il terzetto dei parenti Marzia Castellini (madre di Cio-Cio-San), Maria Miccoli (la zia) e Roberta Salvati (cugina). Il teatro era sold-out in ogni ordine di posto, come non si vedeva da qualche tempo. Pubblico molto attento alla “nuova” versione che è stata molto apprezzata decretando un autentico successo per tutti gli interpreti, con un trionfo, meritatissimo, all’uscita del maestro Chailly.
MADAMA BUTTERFLY [William Fratti] Milano, 13 dicembre 2016.
È assolutamente strepitoso e culturalmente vincente che Riccardo Chailly voglia eseguire l’integrale pucciniano attraverso una ricerca così minuziosa all’interno dell’animo del compositore. Oggi nessuno può affermare con certezza quali siano i tagli di Butterfly sui quali Puccini non ha mai avuto ripensamenti. Detto ciò non è fondamentale stabilire quale fosse il suo volere definitivo, pressoché impossibile, ma capire da dove sia partito il suo tragico pensiero appassionato, che poi ha portato l’opera ad entrare in una tradizione esecutiva che l’ha mantenuta nella Top Ten per un secolo. Che piaccia o meno, questa prima versione descrive il mondo di Cio-Cio-San e le persone a lei accanto in maniera più puntuale, non solo nelle ambientazioni di primo atto, ma anche negli accadimenti del secondo, soprattutto attraverso lo scambio di battute con Kate, che copre l’imbarazzante assenza di Pinkerton. Resti o meno in repertorio, è un capolavoro a cui assistere, almeno una volta nella vita. Occorre poi considerare la precisione millimetrica con cui Riccardo Chailly si muove sulle partiture pucciniane. Accuratezza scrupolosa che non si ferma solo alla matematica delle note, ma che cerca all’interno di esse le passioni, i sentimenti e i tormenti che sono espressi attraverso colori e sfumature davvero impareggiabili. L’Orchestra del Teatro alla Scala fraseggia come se fosse un solo interprete, con un solo cuore e in diversi momenti riesce a catturare l’attenzione distogliendola dal palcoscenico. Alvis Hermanis, che in Italia ha avuto grande successo con Die Soldaten e Jenufa, mentre non è piaciuto per I due Foscari, in questa occasione crea uno spettacolo davvero ben costruito, dove ogni singolo gesto, sguardo, movimento, azione, è studiato e non lasciato al caso. Per l’ambientazione, curatissima, coadiuvato alle scene dalla bravissima Leila Fteita, si mantiene alle didascalie del libretto, non osa, lasciando che la musica di Puccini resti il solo e vero protagonista. Interessanti le proiezioni nello stile dell’acquerello di Ineta Sipunova. Più che eccellenti i preziosissimi costumi di Kristine Jurjane, completati da un trucco davvero magistrale. Ottime anche le luci di Gleb Filshtinsky e la coreografia di Alla Sigalova, che in alcune parti ricorda quella di Jenufa. Maria José Siri, annunciata indisposta, è una Madama Buterfly egregiamente costruita nella parte visiva personaggio, soprattutto se ne apprezza la gestualità. Lo stesso vale per la precisa resa vocale, come se fosse uno strumento integrante dell’Orchestra, fatta eccezione per il primo interno e un paio di passaggi in “Un bel dì vedremo”. Squisito il finale, a partire da “Tu? Piccolo Iddio!”. Purtroppo tutto ciò resta ancorato alla superficie, come già riscontrato in precedenti occasioni: Siri è una brava cantante, ma sembra che non entri mai nell’animo del ruolo e il suo fraseggio rimane freddo e poco emozionante. Molto buona la resa del Pinkerton di Bryan Hymel. Vocalità limpida, acuti ben impostati, forse un poco leggero per lo spessore orchestrale di certe pagine, personaggio giustamente sempliciotto. Eccellente lo Sharpless di Carlos Alvarez, che sa strappare al pubblico ben più di una lacrima durante la lettura della lettera. Annalisa Stroppa riceve un meritato successo personale, poiché la sua Suzuki è deliziosa, seppur perfettibile nello spessore occorrente nell’apertura del secondo atto. Carlo Bosi è Goro e non serve aggiungere altre critiche ed elogi rispetto alla performance della scorsa primavera ne La fanciulla del west, poiché come già detto il tenore è il migliore della sua categoria; c’è solo da sperare che intervenga in tutto l’integrale pucciniano. Nicole Brandolino presenta la sua Kate Pinkerton con una sorprendente vocalità vellutata e il suo scambio di battute con Cio-Cio-San lascia il segno. Leonardo Galeazzi è un ottimo Yakusidé, pure efficacissimi sono Costantino Finucci come Yamadori e Abramo Rosalen nei panni dello zio Bonzo. Bravi gli altri interpreti delle parti di contorno: Gabriele Sagona è il commissario imperiale, Romano Dal Zovo è l’ufficiale del registro, Marzia Castellini è la madre, Maria Miccoli è la zia e Roberta Salvati è la cugina. Sempre eccellente è il Coro diretto da Bruno Casoni. Applausi brevi e lievi, con un successo particolare per Riccardo Chailly e Annalisa Stroppa.
LA BELLA ADDORMENTATA [Mirko Gragnato e Camilla Lippa] Torino, 17 dicembre 2016.
Unica tappa italiana dello Staats Ballet di Berlino, sulle musiche di Tchajkovskij il Regio di Torino ospita La Bella Addormentata. L’orchestra è guidata dal M° Pedro Alcalde; mentre i movimenti dei ballerini portano la firma di Nacho Duato e le scene e i costumi quella di Angelina Atlagic. Un teatro gremito, popolato da un pubblico vario che va dai bambini, agli adolescenti, sino agli anziani. Ecco la magia di una favola, che unisce grandi e piccini, la scelta della Disney di riadattare le musiche di Tchajkovskij per il lungometraggio di animazione creato nel 1959, costruisce un classico che lega questo balletto a ricordi di infanzia, rievocando negli spettatori più adulti il ricordo di una fanciullezza andata, portando adulti e piccini ad una emotività condivisa. Che se vogliamo è il segreto dello spirito del Natale. Tantissime le date per questo balletto e ricchissime le fila del Berlin Staats Ballet che tra recite serali e pomeridiane garantiscono 7 rappresentazioni in 5 giorni con ben tre cast che si alternano. Con l’aprirsi del sipario le scene di Angelina Atlagic lasciano stupiti e i costumi incantano per la cura del dettaglio senza però sacrificare l’agilità dei ballerini; con colori pastello e scene a teleri dal sapore ottocentesco grazie alle tinte tenui si dà l’impressione dell’antico, di un qualcosa che è passato attraverso le sabbie del tempo. Le musiche di Tchajkovskij non mancano di emozionare per il loro sapore tutt’altro che didascalico ma riccamente sinfonico, divenendo parte principe in pieno legame con il balletto senza dare minimamente l’impressione di una musica asservita totalmente ai passi di danza. Ma, anzi proprio la sorellanza tra Tersicore ed Euterpe vede la nascita di questo balletto, compositore e coreografo: Tchaikovskij e Petipa, a partire dal 1866 lavorano di concordia componendo un team ideale per la creazione di passi di danza e musica come l’intreccio di un ricamo. Musica e passi si seguono reciprocamente aderendo l’uno all’altro e calzandosi come un abito di sartoria. Nacho Duato a cui si deve l’ideazione delle coreografie, firmata nel 2015 proprio per lo Staats Ballet di Berlino, crea una coreografia diversa che si distacca dal classicissimo Petipa, senza però snaturare la trama del balletto, certo si può dire non siano le variazioni di repertorio che tutti conosciamo ma la capacità del coreografo qui è stata il proporre qualcosa di diverso, una visione altra, che però ha voluto comunque non mancare di caratterizzare i personaggi. Così come Tchajkovskij usa dei leit motiv, Nacho Duato pone dei movimenti che divengono quasi epiteti danzanti tipici di ogni personaggio, soprattutto nel definire la natura delle fate. Il maestro Pedro Alcalde si mostra un valido direttore dal gesto pulito, congeniale alla linearità compositiva della musica per balletto. Unica pecca forse una fretta nel proseguire e nel dare continuità alla musica, non lasciando molto spazio agli applausi del pubblico dopo i virtuosismi dei ballerini. Di gran pregio le variazioni delle fate, che diventano qualcosa di più della solita fatina svolazzante in tutù, incarnando qualcosa di più umano e passionale. Ekaterina Petina, Weronika Frodyma, Aurora Dickie, Iana Balova, Luciana Voltolini, ed Elena Pris mostrano, anche se nel secondo cast, la valenza dello Staats Ballet di Berlino, le fate riempiono con una leggerezza vigorosa lo spazio del palcoscenico attirando l’applauso del pubblico. Prima fra tutte Julia Golitsina nell’interpretazione della fata dei Lillà. Abilissimi i cavalieri Alexej Olenco, Kevin Pouzou, Federico Spallita, Olaf Kollmannsperger e Nikolay Korypaev, che nel sostenere i passi delle fate hanno reso con prese e passaggi la sensazione del volo, facendo levitare con delicatezza le ballerine a mezz’aria, non lasciando trasparire il minimo accenno di fatica dando proprio l’impressione delle fatine come creature impalpabili e leggiadre. Aurora e il principe Desirè restano ruoli chiave, però un po’ limitati ai passi sulle punte senza essere sufficientemente caratterizzati nonostante l’abilità tecnica di Ksenia Ovsyanik e di Dinu Tamazlacaru. Nell’alternarsi delle favoleggianti scene di Angelina Atlagic, durante l’incantesimo della fata dei Lillà, maestralmente il palcoscenico si trasfigura in un fitto bosco che quasi per magia si arricchisce di boccioli di rosa nel momento del bacio con il quale il principe spezza il maleficio della fata Carabossa. La fata cattiva resta però il personaggio più apprezzato, coreografia e costumi la caraterizzano e la rendono un personaggio profondamente cattivo accompagnata da uno stuolo di ballerini in tuta nera che sin dalla sua comparsa dietro le balze di un lungo telo ne fanno i diabolici cortigiani. Ballerini dai movimenti nervosi e scalpitanti, mostri arricchiti da quell’eleganza e attrazione tipiche del male. Male incarnato alla perfezione nel far interpretare ad un uomo, Michael Banzhaf, la rappresentazione di questa cattiva. Ottima performance che oltre ai passi di danza veniva arricchita dalla gestualità, dalla mimica facciale e da uno sguardo penetrante degno di gelare il sangue anche al bimbo più vivace. A Carabossa van gli applausi più fragorosi, ma soprattutto a questo corpo di ballo che è stato capace di emozionare in questi giorni pre natalizi il folto pubblico del teatro Regio con la musica di una favola. Le scellerate scelte delle istituzioni nel ridurre i contributi ad uno dei massimi teatri italiani impoverirebbe i cittadini di Torino e i molti visitatori di questa splendida città di un’offerta valida, capace di arricchire e di trasmettere emozioni, legandole saldamente ai ricordi di grandi e piccini, infatti prima dello spettacolo la rappresentaza sindacale ha preso la parola per ricordare con un breve messaggio il ruolo e l’importanza del teatro e delle sue maestranze per una città speciale come Torino.
RIGOLETTO [Lukas Franceschini] Rovigo, 18 dicembre 2016.
Prima della pausa natalizia al Teatro Sociale è stata rappresentata l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, allestimento di qualche anno addietro in coproduzione con il Teatro Verdi di Pisa. Il titolo verdiano mancava da qualche anno nella città del basso veneto, la ripresa odierna s’inserisce nell’ambito delle produzioni in comune che da qualche tempo Rovigo ha attivato con Pisa, peccato solo che a oggi non sia ancora stata inserita in cartellone l’opera Mefistofele di Arrigo Boito già eseguita in Toscana. L’allestimento del regista Federico Bertolani potremo definirlo volenteroso ed efficace solo nell’ottica degli scarsi budget che dispongono oggigiorno i teatri. Una scena spoglia con quinte nere ai lati, solo qualche oggetto, una sedia nella scena del primo atto, un divano quadrato nel secondo (stile Frau), una parete mobile fissata in graticcia, con porta e finestra, determina l’interno della casa di Rigoletto. La stessa sarà poi utilizzata per la locanda del III atto. Lo scenografo Giulio Magnetto sa fare molto di meglio e ne abbiamo avuta prova in altre produzioni, qui come predetto, si doveva andare al risparmio. Non colpiscono i costumi moderni di Mirella Magagnini, la quale tuttavia trova una certa linea nel definire lo stato sociale dei personaggi. C’è la mano di Bertolani e questa si fa vedere, anche se con poco traccia una drammaturgia credibile, mai sopra le righe, perfettamente comprensibile e incisiva. Rigoletto è il buffone di corte che si traveste in scena per adottare una tenuta borghese quando incontra l’adorata figlia. È un uomo combattuto e avvilito nell’animo, deve fare il buffone per mantenere il suo unico prezioso bene, quel bene che sarà messo alla berlina dalla spietata e amorale corte mantovana. Una corte forse volutamente tutta in nero per imprimere una sorta di sinistra lussuria. Tutti gli altri personaggi si collocano pur nelle loro differenze in questo solco narrativo al quale nulla c’è da obiettare, e fortunatamente non calca la mano nella scena di Maddalena del III atto, che spesso è ridotta a macchietta. La visione è credibile anche se non proprio affascinante. Sul podio abbiamo trovato la valida bacchetta di Gianna Fratta, che reduce al mattino del Concerto di Natale al Senato della Repubblica, è giunta in tempo perfetto alle ore 16 per salire sul podio. La sua direzione è stata molto precisa e soprattutto abile nel tenere assieme un cast talvolta impreciso. Abbiamo apprezzato la grande tecnica di vera concertatrice, imprimendo tempi sostenuti e la perfetta sicurezza nell’attacco. Peculiarità che le hanno permesso di portare a termine l’opera cui va riservato un plauso avendo a disposizione un’orchestra, la Regionale Filirmonia Veneta, la quale non brillava per precisione. Molto buona la prova del Coro Lirico Veneto diretto da Flavia Bernardi. Protagonista era Elia Fabbian, che abbiamo sentito in prove molto migliori. Presumo che il cantante non fosse in perfette condizioni fisiche poiché spesso la voce dava segni di cedimento con stonature e imperfezioni. Sarebbe stato il caso di farci annunciare. Tuttavia, restano inalterate le qualità interpretative e le intenzioni drammaturgiche. Pablo Karaman era un Duca di Mantova esuberante e di bella voce, purtroppo problemi tecnici nel passaggio rendevano tutta la zona acuta forzata e in parte limitata. È un vero peccato perché le qualità ci sono e se fossero superati questi limiti saremo di fronte ad un cantante che potrebbe regalarci prestazioni sicuramente apprezzabili. La migliore era la giovane Venera Prostasova, una Gilda con voce molto ben rifinita, omogenea e preparata tecnicamente. Interpretativamente si distaccava da arcaici bamboleggiamenti trovando accendi sia drammatici sia patetici di grande effetto. Francesco Palmieri era un poco raffinato Sparafucile, mentre risultava migliore la Maddalena di Antonella Carpenito, precisa e professionale. Abbastanza buona la lunga schiera nei ruoli minori a cominciare dal Matteo Borsa di Luca Favaron e del Marullo di Romano Franci. Ivan Marino era un tonante ma sfogato Monterone, Elena Rosolin una corretta Giovanna, Paolo Bergo un buon conte di Ceprano. Completavano la locandina Simonetta Baldin (Contessa Ceprano), Riccardo Ambrosi (usciere) e Nicoletta Baldin (paggio). Buon successo al termine della rappresentazione anche se duole costatare la scarsa presenza di pubblico a una recita pomeridiana, per un titolo di grande repertorio, in Teatro storico che un tempo era sempre molto affollato di pubblico proveniente anche dalle città limitrofe.
IL CAMPANELLO/ IL GIOVEDÌ GRASSO [Lukas Franceschini] Treviso, 19 dicembre 2016.
Interessante proposta al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di due farse di Gaetano Donizetti: Il campanello e Il giovedì grasso. Due tra i più riusciti spartiti del compositore bergamasco in questo genere, allestiti in collaborazione con il progetto Opera Studio del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Il Campanello di notte è una farsa con recitativi che fu rappresentata la prima volta a Napoli al Teatro cam 2Nuovo il 1 giugno 1936. Donizetti adattò un vaudeville francese ambientandolo a Napoli, in quell’estate del ’36 piena di tensione politica e con un solo teatro aperto in città. Non ci si deve stupire se il musicista musicò un soggetto comico proprio nei mesi in cui la moglie partorì una bimba morta e scomparvero entrambi i genitori. L’attività teatrale-compositiva era per Donizetti il modo migliore per mantenere il suo equilibrio umano. In quest’opera egli crea un ruolo comico, di bravura Enrico, per il baritono Giorgio Ronconi, che in seguito sarà cam 3sia il suo primo Chevreuse (Maria di Rohan) e interprete di altri grandi ruoli del primo Verdi. La farsa lascia un po’ di maro in bocca e racchiude più di un tratto crudele della satira. Infatti, sarà Enrico amante respinto a “rovinare“ la prima notte di nozze di Don Annibale con Serafina. Vi sono anche dei riferimenti ad altre opere precedenti, la canzone del gondoliere da “Marin Faliero” utilizzata come parodia sui vocalizzi dei cantanti. Al Campanello manca quel tocco poetico, quel calore umano che ad esempio troviamo in L’elisir e Don Pasquale, ma resta un’opera d’ilarità spassosa con recitativi spiritosi, in napoletano talvolta. La musica è fluida, geniale e mordace, in cui prevalgono i duetti tra i due cantanti maschili, ma anche il duetto tra Enrico e Serafina è fiorito nel canto, e il terzetto finale è di una serrata fluidità ammirevole. Il giovedì grasso o Il nuovo Pourcegnac è anch’essa farsa in un atto tratta dal vaudeville omonima di Scribe e Delestre-Poirson, rappresentata a Napoli al Teatro del Fondo il 26 febbraio 1829, e tra gli interpreti c’erano nientemeno che Giovanni Battista Rubini e Luigi Lablache. È una tra le migliori commedie romantiche in un atto, la quale anche in tempi moderni ha conosciuto diverse proposte. Anche in questo caso molti recitativi sono in dialetto napoletano, nella cui lingua culmina l’aria di Sigismondo, composta per Lablache, che è cam 5ispirata alla celebre tarantella locale. La vis comica è imperante, il soggetto del travestimento confermato come in quasi tutte le farse e opere buffe, e il linguaggio musicale è fluido e di chiaro stampo donizettiano, pertanto non delude mai. Donizetti aveva una certa predilezione per questo spartito, e molti celebri cantanti la interpretarono con entusiasmo, infatti, in seguito il compositore scrisse un’aria alternativa per il ruolo di Sigismondo, “Che prego per riuscita”, in sostituzione della tarantella dialettale per Antonio Tamburini. Il progetto di Treviso, che racchiude anche la partecipazione dell’Opera da Camera di Ginevra e il Dipartimento di Studi Umanistici di Ferrara, è molto lodevole nel suo intento, e considerato il prodotto di apprezzabile riuscita. Convince appieno la regia Francesco Bellotto che crea una drammaturgia brillante e di scorrevole narrazione, ripescando modi e usi tipici della commedia buffa ma senza eccedere in vezzi e stereotipi che oggi sono sorpassati. Brillantezza, grande ritmo ed eleganza sono il denominatore della sua impostazione che chi scrive ha molto apprezzato divertendosi. Non meno è l’apporto di Angelo Sala, scenografo, per ambienti di raffinata signorilità, e la bravissima mano sartoriale di Alfredo Corno che disegna costumi bellissimi, cromatici in pieno stile tardo cam 7ottocentesco. Delizioso spettacolo e molto godibile. Sul podio Franco Trinca realizza una concertazione sostenuta nel ritmo, variegata nelle dinamiche e d’indubbia teatralità. Purtroppo questa volta abbiamo trovato l’Orchestra del Consorzio tra i Conservatori del Veneto leggermente svogliata e non così precisa come in altre occasioni. Nel cast la parte del mattatore è di Filippo Morace nel doppio ruolo di Don Annibale (Campanello) e Sigismondo (Giovedì grasso). Il cantante campano conferma in indiscusse qualità canore, che con voce pastosa, uniforme nei registri, ci regala due personaggi di assoluto rilievo, cui bisogna aggiungere una recitazione spassosissima, raffinata e mai sopra le righe; quanto al dialetto napoletano… beh gioca in casa e i risultati sono eccellenti. Nel Campanello abbiamo avuto la gradevole presenza di Mara Gaudenzi, una Serafina delicata e molto musicale, e un Enrico, di Dario Shikhmiri, molto valido come interprete ma da raffinare come cantante soprattutto nei volumi e nel fraseggio. Spassose la Rosa di Francesca Gerbassi e il Cola di Antonio Cappetta. Molto bravi anche gli invitati alla festa, i quali formano in piccolo coretto ma interloquiscono anche singolarmente: Kallopi Petrou, Mary Rosada, Valeria Girardello, Diego Rossetto, Alvise Zambon, Francesco Basso. Nel Giovedì grasso Andrea Biscontin era un Ernesto piuttosto forzato e con una voce ancora acerba, anche se il personaggio era ammirevole, e Valeria Girardello, Nina, apprezzabile soprano di spiccata musicalità e buon uso dei suoi messi. Diego Rossetto era un apprezzabile e preciso Teodoro, Mara Gaudenzi, Camilla, si conferma anche in questo atto unico cantante di buona impostazione. Apprezzabili gli interpreti: Francesco Basso era un colonnello preciso, Francesca Gerbasssi una spassosa Rosa, Antonio Cappetta un simpatico Cola, Alvise Zambon un bravo Giulio (ruolo aggiunto). Completavano la locandina Kalliopi Petrou (una cameriera) e Mary Rosada (moglie del colonnello). Al termine a tutte le compagnie è stato riservato un caloroso e sincero successo, unico rammarico era vedere il teatro mezzo vuoto. Forse quattro recite (compresa un’anteprima) sono eccessive per una città quale Treviso?
WERTHER [Lukas Franceschini] Bologna, 15 dicembre 2016.
Werther, il celebre dramma lirico di Jules Massenet, torna al Comunale di Bologna dopo venticinque anni (esclusa la parentesi Bocelli del 2004), con attrattiva principale la presenza del tenore Juan Diego Florez alla sua prima italiana nel ruolo in titolo. Curioso che la prima dell’opera sia andata in scena all’Hofoper di Vienna in lingua tedesca nel 1892, l’anno seguente la consacrazione sarà all’Opéra-Comique di Parigi in lingua originale, in un clima musicale in piena voga verista. Tratto dal romanzo “Die Leiden des jungen Werther” di Wolfgang Goethe, possiamo affermare che l’opera è un unico grande duetto, suddiviso in dialoghi e monologhi fra il protagonista e Charlotte, mentre gli altri ruoli sono figure di contorno, in parte sommesse, a una vicenda tagica, fatale e inesorabile. Il destino degli infelici amanti, in pratica “non amanti”, è un’esistenza infelice ma inesorabile, ove il volere umano non è in grado di mutare gli eventi e il fato. Massenet provoca nello spettatore tensione, sentimento, palpitazioni, ma enuncia sin dall’inizio con il delicatissimo “claire de lune” il tragico destino, inconfutabile, che con accenti crudeli scuote non solo l’anima. Tali aspetti sono descritti musicalmente, come in quasi tutte le opere di Massenet, attraverso una scrittura lirica e appassionata, tenera e sensuale rasente il tremore nella quale il canto è accompagnato da eleganti soluzioni sinfoniche di leggera e ispirata maestria romantica. Interessante il nuovo spettacolo ideato da Rosetta Cucchi, la quale pone Werther al centro della scena come in un sogno o una vita desiderata. Infatti, il protagonista è sempre in scena seduto su una poltrona a sinistra ed è artefice di una drammaturgia che vorrebbe in un modo, la vita serena famigliare con la donna amata, e il destino dal quale non riesce a svincolarsi. Una regia molto azzeccata, soprattutto perché fa capire, attraverso brevissimi tableau vivant ideati da bravi attori, un’idea psicologica che sicuramente attraversa lo stato d’animo del protagonista senza irrompere in maniera pesante su un racconto intimo e pennellato con bravura di scelte oniriche, ma anche crude, sempre in equilibrio con la melodiosa musica. Perfettamente credibile trovare sempre il ritratto della mamma defunta di Charlotte, il giuramento che la figlia fece è imperante nel corso della vicenda. Unica perplessità il pic-nic del secondo atto davanti alla chiesa, la cui scena poteva essere risolta con altra inventiva, ma è solo un gusto personale di chi scrive. Ambientazione moderna ma con stile, nella quale si apprezza in particolare la mano di Tiziano Santi, scenografo, che non dimentica il tema della natura contrassegnato da trochi di tiglio, e realizza la bellissima casa borghese de Le Bailli, ove non sfuggono allo sguardo i numerosi libri. Più contenuti i costumi, seppur apprezzabili, di Claudia Pernigotti, funzionali le luci di Daniele Naldi, anche se in qualche caso più colore non sarebbe guastato. Spettacolo godibile e giustamente applaudito al termine. Molto positiva prova del direttore Michele Mariotti, salvo errori di chi scrive, debuttante nel titolo. Mariotti ha imposto una lettura molto teatrale e forbita teatralmente, scavando nella complessa partitura quelle giuste e affascinanti tinte sinfoniche, mettendo in evidenza timbri sonori di ottima fattura (nei preludi e interludi in specie), ma non dimenticando mai la tensione e i tormenti dei due protagonisti. Pertanto abbiamo avuto una direzione impostata in una chiave lirica ma con sprazzi di forte accento sinfonico che non ha mai messo in discussione, o prevaricato, il canto sul palcoscenico. Pregevoli sono state le sfumature, la ricchezza dei timbri e il tessuto narrativo, forse talvolta focalizzato su singoli elementi o frammenti romanzeschi, ma d’indubbio effetto teatrale. Una direzione che merita un plauso anche perché nel canto di conversazione cerca di accompagnare un preciso vigore accorato che rende giustizia alle intenzioni del compositore. L’orchestra del Comunale era più precisa di altre volte e mai sopra le righe contribuendo alla realizzazione di una prova musicale ragguardevole, rendendo Mariotti non solo un direttore rossiniano, nel cui campo ha fornito prove anche ragguardevoli, ma è un direttore che nella sua maturazione sta affrontando anche altri repertori con esiti molti distinti. Juan Diego Florez è cantante preciso e preparato, tutte le note sono cantate con una certa facilità, ma non siamo di fronte al fuoriclasse cui siamo abituati, poiché la sua voce proiettata soprattutto in acuto non possiede le caratteristiche per il ruolo, dimostrando inoltre che con il passare degli anni la zona centrale non ha avuto un’evoluzione nello spessore. A questo va aggiunto un fraseggio poco variegato, un accento e un colore che spesso rasentavano la piattezza e il monotono. Dunque, a mio avviso, è solo questione di ruolo non adatto e questo è confermato anche da una sostanziale stanchezza nel finale, anche se ci troviamo di fronte al tenore più preparato del panorama internazionale. Anche questo tentativo di allargare il repertorio non piò dirsi totalmente riuscito. Piuttosto anonima la Charlotte di Isabel Leonard, poco espressiva nel canto, e forzata in acuto seppur disinvolta scenicamente, nell’ordinarietà l’Albert di Jean-François Lapointe dal quale mi sarei aspettato più morbidezza nel canto. Molto piacevole al giovane e brillante Sophie di Ruth Iniesta, dal canto cristallino e molto sonoro. Molto buona la schiera di cantanti nei ruoli minori a cominciare da Le Bailli di Luca Gallo, Alessandro Luciano nella parte di Schmidt, e Lorenzo Malagola Barbieri che interpretava Johann. Una menzione particolare al Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna, istruiti da Alhambra Soperchi, che interpretavano i fratelli e sorelle di Charlotte dimostrando grande musicalità e canto preciso. Stranamente il Teatro non era esaurito, anzi si registravano parecchi vuoti, e il pubblico delle prime è stato in assoluto silenzio fino alla grande aria di Werther del III atto, alla quale è scaturito un applauso trionfale, finendo al termine con un convinto successo per tutti ma con ovazioni per Florez e Mariotti.
WERTHER [William Fratti] Bologna, 21 dicembre 2016.
La Stagione 2016 del Teatro Comunale di Bologna si conclude con un nuovo allestimento di Werther di Jules Massenet curato da Rosetta Cucchi. La regista pesarese si avvale della bravura di Tiziano Santi per creare delle ambientazioni molto semplici, presumibilmente poco costose ma molto efficaci, il cui fascino è sapientemente sottolineato dalle belle luci di Daniele Naldi. Ma soprattutto è il lavoro sui personaggi, attraverso gesti e movimenti, che crea un adeguato e opportuno svolgersi della vicenda, dove l’uso di scene sovrapposte e controscene aiuta ad immedesimarsi e a mantenere viva l’attenzione in ogni momento dell’azione. Perfettamente in linea i costumi di Claudia Pernigotti. Decisamente ottima la direzione dell’elegantissimo Michele Mariotti, che se primeggia in Rossini e nel belcanto in generale, dimostra di sapere farsi valere anche nel repertorio francese, poiché la passione e il dolore di Massenet si mantengono lineari per tutto il tempo, come nel tranquillo scorrere di un fiume composto di note e di suoni, riccamente cromatizzati, sapientemente sfumati, con una bravissima orchestra che lo segue come se fossero un tutt’uno. Juan Diego Florez forse non avrà il tipico slancio romantico che tradizionalmente ci si aspetta dal ruolo di Werther, ma canta meglio di una divinità e di questo bisogna rendergliene atto. il modo in cui porge i suoni, con dei legati e delle sfumature deliziosi, la maniera in cui articola le parole, con fraseggi e colori raffinatissimi, la bravura con cui scende nelle note basse con suoni misti, l’eccellenza con cui timbra i pianissimi senza usare i falsetti, sono tutti segni distintivi del suo altissimo valore artistico. Il tenore è poi letteralmente costretto dal pubblico a concedere il bis della celebre “Pourquoi me réveiller” e, se possibile, la seconda volta è addirittura meglio. Lo affianca l’ottima Charlotte di Isabel Leonard, morbida ed omogenea su tutta la linea di canto, elegantissima, sapientemente misurata, ma allo stesso tempo mai trattenuta, in grado di portare la purezza di un bel suono anche nell’accento più drammatico. Decisamente in parte la Sophie di Ruth Iniesta, ben centrata nel personaggio, dotata di voce piena e rotonda seppur leggera, oltreché molto musicale. Efficace Jean-François Lapointe nel ruolo di Albert, anche se non particolarmente intenso o provvisto di spessore. Simpaticissimi e musicalissimi Alessandro Luciano e Lorenzo Malagola Barbieri nelle vesta di Schmidt e Johann. Più che eccellenti le voci dei bambini: Susanna Boninsegni, Carlo Alberto Brunelli, Irene Cavalieri, Diego Bolognesi, Pietro Bolognini, Marco Conti. Completano Brühlmann e Kätchen: Tommaso Caramia e Aloisa Aisemberg. Grandissimo successo per tutti i protagonisti, con un pubblico festoso che non vuole abbandonare la sala.
TURANDOT [Lukas Franceschini] Verona, 22 dicembre 2016.
L’attività della Fondazione Arena è fortunatamente ripresa inaugurando la stagione Invernale al Teatro Filarmonico con Turandot di Giacomo Puccini. Dopo la chiusura forzata per due mesi e la nomina del nuovo sovrintendente, il dott. Giuliano Polo, è da augurarsi che l’attività culturale-musicale della città non avrà ulteriori pause e prosegue il suo compito nel contesto dei luoghi e della programmazione cui siamo abituati da anni e resta un punto di riferimento non solo per i veronesi. Lo spettacolo presentato a Verona è una produzione della Slovene National Opera di Maribor ideata da Filippo Tonon, regia, scene e disegno luci. Il regista realizza una storia che contiene le molteplici possibilità di soluzione drammaturgica dell’opera, non tralascia il fiabesco, ma segna marcatamente anche il conflitto sociale tra la reggia di Altoum e l’inavvicinabile principessa attorniata da guardie e ancelle. Tre grandi cubi posti su differenti livelli scorrono orizzontalmente sul palcoscenico creando velocemente la scena che rapidamente si dissolve in un’altra. È la maestria del regista a trovare soluzioni agili e narrative di ampio respiro drammaturgico, con un tocco di esotismo misterioso, complice un effetto luci notturno di grande efficacia. Ogni personaggio pare essere affiancato da un colore, ma oltre la spettacolare Turandot, sono i tre ministri a colpire per l’ampio cromatismo. La brava costumista Cristina Aceti adoperando una mano molto creativa non delude rievocando un oriente fantasioso ma curatissimo negli accostamenti. L’ingegnoso spostamento, sia di solisti sia masse, è veramente elegante e fluido, il tutto rapisce lo spettatore come in un romanzo d’appendice. Molto bravo il direttore Jader Bignamini che concerta con innata duttilità, ampio respiro di suono, colori accesi ed enfasi teatrale. Guida con mano sicura il palcoscenico essendo punto di riferimento nell’equilibrio voci e suono, anche se in taluni momenti si lascia prendere a mano e le sonorità gli sfuggono coprendo i solisti, ma nel complesso una prova molto positiva. Bravissimo il coro, istruito da Vito Lombardi, mai sopra le righe, e in perfetto equilibrio con l’orchestra. Teresa Romano, Turandot, non sembra abbia realizzato il suo ruolo più congeniale, poiché il settore acuto è forzato e limitato, l’accento sommario e la dizione molto precaria. L’abbiamo preferita in altre parti. La grande sorpresa della serata è stato il tenore Martin Muehle, Calaf, dal timbro brunito ma squillante, sicurissimo in tutti i registri, puntuale ed emozionante nei momenti a lui riservati, come nella celebre aria, nella quale ha avuto molte richieste di bis, purtroppo non concesso. Rocio Ignacio è stata una Liù che possiamo collocare nell’ordinarietà, l’accento non è squisitamente lirico e il fraseggio monotono, anche se nel III atto era molto più pertinente rispetto il primo. Rilevante la presenza di Carlo Cigni, Timur, in questo caso anche bravissimo nel fraseggio, cui va sommato un colore vocale di forte emozione, pertanto la performance di Parma di ottobre è da considerare un piccolo incidente di percorso poiché abbiamo trovato il cantante che conosciamo. Molto musicali, bravi e precisi nella loro grande scena del II atto i tre ministri Federico Longhi (Ping), Luca Casalin (Pang) e Massimiliano Chiarolla (Pong), cui va riconosciuta una buona pulizia vocale e un tono molto elegiaco preferibile al sovente farsesco. Di grande professionalità glia altri interpreti in locandina: Murat Can Guven (Altoum), Nicolò Ceriani (Mandarino) e Angel Harkatz Kaufmann (Principe di Persia). Teatro quasi esaurito e tanti applausi al termine, con ovazioni per il tenore Muehle.
LA BOHÈME [Mirko Gragnato] Padova 29 dicembre.
Un teatro Verdi gremito per le due recite de La Bohème di Giacomo Puccini, che chiudono la stagione operistica del 2016 nella città patavina. La bacchetta di Eduardo Strausser guida la Filarmonia Veneta nel cast le stelle Maija Kovalevska e Micaela Marcu, che interpretano i due ruoli femminili di Mimì e Musetta. Brilla il baritono albanese Gezim Myshketa nel ruolo di Marcello, assieme alle vivaci voci bianche del coro Cesare Pollini. Il tutto nella regia, scene, luci e costumi dell’allievo di Stefano Poda, Paolo Giani. Bohème è un’opera che si colloca perfettamente nel periodo natalizio, il libretto e spesso le scene ci trasportano in una Parigi invernale, in un luogo imbiancato dalla neve, dal sapore romantico: nell’intimità di una soffitta e dal clamore dei cafè e delle terraces parisienne, ingredienti che si sposano benissimo con il clima natalizio di dicembre, non è un caso che siano molti i teatri che in questo periodo hanno deciso di allestire quest’opera pucciniana. Chi però si immagina un allestimento tradizionale con questa produzione disattende queste aspettative; quello che si scopre è più un percorso personale, un’analisi dei caratteri dei personaggi che Paolo Giani cerca di esporre con introspezione. La soffitta dei 4 amici, sempre uniti come i 4 moschettieri di Dumas diventa una dimensione monocromatica che ricorda certi loft in odore di desing, una dimensione un po’ underground, fatta di oggetti di reimpiego, trasformando il pittore, il filosofo, il poeta e il musicista più in giovani artisti, membri della Parigi bene, perdendo quel fascino di entusiasmo e ristrettezze da “studente povero” alla Gualtier Maldè. Si esce insomma un po’ dal seminato tradizionale, ma la musica di Puccini e il libretto, scritto a quattro mani, di Illica e Giacosa incanalano così bene l’intreccio lasciando in ogni caso che la narrazione proceda fluida, senza snaturarsi. Il Baritono albanese Gezim Myshketa nel ruolo di Marcello si mostra come la voce maschile più solida di questo cast un po’ azzoppato da una bronchite che colpisce il tenore Giorgio Berrugi nel ruolo di Rodolfo. La scena de “mi si è spento il lume” perde un po’ quel tocco di magia nel loft dalle tinte lucidate di blu, ideato da Giani Cei. Anche se Berruggi tenta con molto sforzo di portare avanti il ruolo, resta alle volte più un mimo senza voce, disertando vocalmente la scena e lasciando però specialmente il pubblico degli ultimi ordini di palchi e della galleria a bearsi della bellissima orchestrazione pucciniana, nel farsi rapire scrutando il golfo mistico. Orchestrazione magica che in Bohème è il vento che gonfia le vele dell’intreccio, con i bellissimi ingressi di viole e l’abile uso degli strumenti a fiato. Quella voluta dal Maestro Eduardo Strausser è una disposizione orchestrale molto curiosa: archi tutti a sinistra, viole, violini, celli e contrabbassi, rigorosamente dietro ai violini primi; a destra tutti i fiati e le percussioni, in una sistemazione da banda, davanti oboi e flauti, dietro clarinetti e fagotti e in fondo gli ottoni con i timpani. Il Maestro Eduardo Strausser piccino di statura e giovane di età ha comunque saputo dare un sapore sinfonico alla partitura pucciniana guidando, seppur con una disposizione atipica ma molto funzionale, l’orchestra della Filarmonia Veneta. Un maestro, che nonostante non vada oltre i trenta, dal 2014 è direttore residente e vicedirettore del Theatro Municipal de Sao Paulo in Brasile. Per quanto riguarda i nostri protagonisti il non pervenuto Rodolfo, ha destato scalpore nelle file della platea, nel chiedersi come non fosse disponibile un sostituto in serata, e a poco sono valse le premure del regista Giani durante un cambio scena per chiedere la comprensione e il sostegno del pubblico del teatro Verdi. Mentre la nostra Mimì, il soprano lettone, Maija Kovalevska ha retto benissimo il palco, seppure lasciata pressoché da sola, riempiendo con una voce piena i vuoti di un Rodolfo infortunato, si è dimostrata capace di ottime abilità sceniche, non lasciandosi intimidire nemmeno dal duetto “O soave fanciulla” cantato praticamente a solo. La Kovalevska ha tenuto la tensione emotiva dell’opera sino alla fine, conducendo da sé, una vera cantante senza un tentennamento, che sicuramente continuerà la sua scalata di successo nel panorama internazionale, una donna che solca senza timore e senza paure il palcoscenico nonostante gli imprevisti. Altra voce femminile di pregio: il soprano rumeno Michaela Marcu, dalle movenze sensuali che riesce ottimamente nel ruolo di Musetta, ma della cui voce forse ci si aspettava qualcosina di più, sembra non dare tutta la qualità vocale di cui è capace. Peccato che il secondo quadro sia stato trasformato in un party da jet set, perdendo la magia delle rue parisienne e del cafè Momus qui evocato da una insegna al neon un po’ sterile. Nel clamore del party il coro di voci bianche “Cesare Pollini” impersonando i bambini nella febbrile attesa del giocattolaio Parpignol, un personaggio dai contorni molto natalizi si potrebbe dire, danno ottima prova vocale e timbrica, nel ” vo la tromba, il cavallin” si mostra che il coro ha una preparazione solida e non si svilisce nella caotica resa scenica, nella quale si perde purtroppo molto della magia del libretto dove il Coro Lirico Veneto fa fatica ad emergere nel tran tran delle scene… cosa ci faranno mai dei bambini ad un party con lap dance e open bar? Qui il regista Giani fa un bel scivolone. Recuperando però nei restanti due quadri con una Parigi resa glaciale e spettrale da un deserto di umanità, ritornado per l’ultimo quadro alla soffita dove i letti dei “quattro moschettieri” hanno ai loro piedi le panoplie del mestiere: chi cumuli di scartoffie, bozze e appunti, chi strumenti musicali, chi pesanti volumi di filosofia e chi invece cornici e pennelli. Una visione molto favolistica, riecheggiando forse i lettini dei bambini, con i giochi in fondo al letto, quasi un invito a ritornare fanciulli, semplici e genuini senza le ubbie dell’età adulta che nel libretto assediano i pensieri di Rodolfo spingendolo ad allontanarsi da Mimì con sciocche scuse per evitarle una vita di rinunce, nel difficile decorso della malattia che la sconvolge nel corpo. Nel quarto quadro il basso Gabriele Sagona nel ruolo di Colline, da prodezzza del suo registro grave in ” Vecchia zimarra” dicendo addio al vecchio e affezionato soprabito per raggranellare qualche soldo e fornire qualche cordiale alla giovane Mimì, oramai infreddolita dal gelo e dalla vita che la sta lasciando. A conclusione del dramma ampi applausi a tutto il cast e a questo spettacolo; applausi fragorosi per Myshketa, Marcu e ovviamente Kovalevska. Anche il regista Giani prende sonori applausi di apprezzamento, così come il M° Strausser. Un allestimento promosso dall’Assessorato alla Cultura del comune di Padova a realizzata grazie al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al sostegno di Regione Veneto in scena anche la notte di San Silvestro, dove Berruggi sarà sostituito dal tenore Giordano Lucà, per poi lasciare il teatro Verdi ed essere replicata il 21 e 22 gennaio 2017 al teatro Sociale di Rovigo con il quale è stato co-reallizzato.