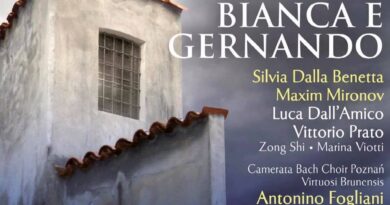Spettacoli 2017
GINA [Lukas Franceschini] Venezia, 10 gennaio 2017.
Al Tetro Malibran, per la stagione d’opera della Fenice, è stata messa in scena Gina, melodramma idilliaco di Francesco Cilea, suo primo lavoro operistico composto come saggio finale al Conservatorio di Napoli nel 1889.
Gina è certamente un’opera minore, pertanto le sue rappresentazioni sono state molto limitate: la prima al Teatrino del Conservatorio San Pietro a Majella il 9 febbraio 1889, alcune recite nel 2000 al Teatro Rendano di Cosenza poi riprese a Roma nel 2001. La Fenice dopo tre lustri, e a centotrent’anni dalla prima, colma un vuoto sulla musica del compositore calabrese, e vorrei rilevare che l’operazione è molto interessante nella programmazione di una Fondazione, la quale ha il dovere far conoscere ogni tanto anche opere secondarie e desuete.
La vicenda è ambientata in epoca napoleonica in un paesino francese non identificato, e sul tessuto di una drammaturgia idilliaca, in parte campestre, agiscono cinque personaggi, Uberto, che dovrebbe arruolarsi e lasciare temporaneamente la fidanzata Lilla, e Gina, sua sorella. Quest’ultima utilizzando un monile d’oro di famiglia, giura che sposerà chiunque vorrà sostituire il fratello alla campagna di guerra. Si offre Giulio, di lei innamorato, anche e il fratello deve ugualmente partire. Due anni dopo Uberto rientra assieme a un compagno d’armi, tra lui e Gina nasce un sentimento, non riconoscendosi subito. Giulio si dichiara affermando di essere il misterioso personaggio che si è sostituito al fratello. L’incertezza di Gina è palese, sarà il sergente Flamberge a mostrare il monile, rivelando che Giulio lo consegnò a lui in punto di morte (poi salvandosi) e pertanto la giovane coppia può felicemente sposarsi.
La musica dell’opera si distacca fortemente dalla vena veristica che in seguito porterà al successo internazionale Francesco Cilea. In particolare sarà Adriana Lecouvreur il titolo per antonomasia e mai uscito dal repertorio, assieme a L’Arlesiana che ebbe nella prima parte del XX secolo assidue rappresentazioni. In Gina troviamo invece un’elevata vena melodica lirica che si distingue in momenti amorevoli e patetici. Il compositore si avvicina nello stile più al vaudeville francese che all’onda della scapigliatura, della giovane scuola e del verismo che impereranno per decenni. Una delicata overture, che riprende i temi successivi, apre un racconto idilliaco ispirato all’invenzione melodica semplice ma accorata, caratterizzata da pezzi chiusi sufficientemente collegati e un manierismo che getta le basi di future altre creazioni. Infatti, fu proprio grazie a Gina che Cilea fu notato dall’editore Sonzogno che pubblicò tutte le sue opere, garantendo anche il successo. Non bisogna liquidare questo spartito con dozzinale sufficienza, è auspicabile invece un’onesta conoscenza di un autore che ha fortemente influenzato il ‘900 italiano e rilevare che sarebbe stato improbabile che un giovane neo diplomato potesse essere innovatore al suo primo lavoro, che è caratterizzato nella tradizione di arie, duetti, concertati. In particolare sono molto rilevanti le arie solistiche di Gina, Lilla e Uberto e il quartetto del II atto.
L’allestimento presentato a Venezia porta la firma di Bepi Morassi, colonna portante della Fenice, che sviluppa uno spettacolo semplice ma di piacevole narrazione, del resto il tessuto drammaturgico non consente invenzioni particolari. Il tratto delicato nel descrivere situazioni e personaggi sono pertinenti e manierati proprio nello stile dell’opera. Francesco Cocco è un bravo e giovane scenografo che disegna una scena vaudeville di agile funzionalità, inserendo tutti gli elementi perfino grandi bandiere francesi che scendono dai palchi laterali, e Francesca Maniscalchi crea costumi d’epoca di raffinata fattura. Dobbiamo lodare l’impegno della Fenice per il progetto di collaborazione con la Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia per realizzare ogni anno uno spettacolo con i giovani allievi.
Principale artefice del successo di Gina è il direttore Francesco Lanzillotta, che si adopera in una lettura piacevole e ricca di sfumature e colori, senza stravolgere il clima idilliaco, rilevante la narrazione di forte impatto teatrale.
Professionale il Coro della Fenice nei brevi interventi, diretto da Ulisse Trabacchin.
Efficace la compagnia di canto capitanata dalla protagonista Arianna Venditelli, delicata sensibile interprete e cantante di forbita musicalità, anche se alcuni passi nel settore acuto non sono ancora del tutto calibrati. Armando Gabba interpreta un Uberto molto valido per linea di canto e sensibilità nel fraseggio. Alessandro Scotto di Luzio, Giulio, ha voce lirica bellissima utilizzata con dovizia, peccato che il fraseggio e l’accento siano sovente monotoni.
Molto brava Valeria Girardello, Lilla, che nell’aria del II atto ha il suo momento per emergere in un canto fluido e raffinato. Meno significativo il Flamberge di Claudio Levantino, corretto cantante ma povero di volume.
Al termine a tutta la compagnia è stata riservata una calorosa accoglienza, giustamente meritata!
ANNA BOLENA [Lukas Franceschini] Parma, 12 gennaio 2017.
Il primo titolo serio di Gaetano Donizetti a trionfare fu Anna Bolena nel 1830 al Teatro Carcano di Milano. L’opera mancava dal Teatro Regio di Parma da ben quarant’anni e prima si contano due sole edizioni nell’Ottocento. Tale lacuna è colmata, in parte, con l’inaugurazione della stagione 2017 nella nuova produzione ideata da Alfonso Antoniozzi.
Anna Bolena appartiene al cosiddetto filone inglese della produzione del bergamasco, la trilogia Tudor, e fu composta in un mese quando il musicista era ospite di Giuditta Pasta nella sua villa sul Lago di Como. Il libretto di Felice Romani narra la triste vicenda della seconda moglie di Enrico VIII, e madre della futura Elisabetta I, che fu mandata al patibolo dal marito per convolare a nuove nozze con Jane Seymour. Pur basandosi su un fatto realmente accaduto, lo stesso librettista scrive sul frontespizio che non è appurato che Anna Bolena, accusata di tradimento coniugale, fosse realmente colpevole, ma per esigenze drammaturgiche teatrali si vuole considerare la tesi dell’innocenza creando una situazione certamente d’effetto nel grandioso finale. Oggi, documentazioni alla mano, l’incertezza di tale reato è ancora palese, è accertato invece che tutta la famiglia Boleyn fu accusata di cospirare contro la corona e anche questo fu un motivo per cui la regina fu decapitata nel giardino della Torre di Londra. Strutturando l’opera su un dramma così concepito Donizetti e Romani trovano un terreno facile per caratterizzare soprattutto le due primedonne che hanno ruoli bellissimi e memorabili, compreso il duetto del secondo atto, senza dimenticare la grande presenza di Enrico, violento e crudo marito, e del giovane innamorato Percy che segue il destino del suo giovanile amore. Una struttura classica e lo stile ci riportano a un romanticismo musicale con frange di passato, anche se il belcanto, con la grande scena della pazzia, è di un’imponente e indimenticabile teatralità con furie di dramma storico, cui si aggiunge la presenza di un paggio che avrà ruolo non di contorno nella vicenda.
Il nuovo allestimento di Parma, coprodotto con il Teatro Carlo Felice di Genova, è uno spettacolo in linea con le casse non certo floride dei teatri italiani, realizzato non dico “al risparmio” ma certamente con risorse limitate. Ciò non toglie che il regista Alfonso Antoniozzi non abbia delle buone idee e cerchi di ideare una drammaturgia plausibile anche se nel complesso non è una delle sue migliori realizzazioni e non passerà alla cronaca come spettacolo indimenticabile. Ci sono dei punti che mi trovano in netto disaccordo con la sua concezione. Il primo è quello di ambientare l’opera negli anni ’40 del secolo scorso perché come lui scrive è un momento storico di grandi cambiamenti. Mi pare superfluo dire che nei quasi cinque secoli addietro periodi di cambiamento ce ne sono stati molti altri e spostare le vicende in epoca “moderna” non ha giovato al dramma. Il quale dramma è pur sempre storico anche se come predetto c’è un forte distacco dai fatti reali. Anzi, se vogliamo essere precisi il grande fatto di cambiamento alla corte inglese non fu certo la decapitazione di Anna Bolena, piuttosto il divorzio dalla prima moglie di Enrico VIII, Caterina d’Aragona. La conseguenza di questa impostazione ha avuto la conseguenza che i costumi non lasciano segno particolare: la goffa pelliccia del re, il paggio Smeton abbigliato da donna equivoca, il coro maschile in frac, la Seymour che pareva una cameriera del serial “Downton Abbey” e la non sontuosità regale della protagonista, spiazzavano non poco. Peccato perché l’autore, Gianluca Falaschi, è creatore ben superiore di quanto visto a Parma e artista di rango affermato. La scena, di Monica Manganelli è pressoché fissa, un praticabile sul quale si svolge l’intricata vicenda ai cui lati sottostanti è posto un coro sempre immobile e statico, forse spettatore inerme delle dispute reali. La gabbia carcere della scena finale stride con il rango della regina che mai e in nessun caso sarebbe stata messa in una cella in qualsiasi epoca. Bellissimi i video proiettati sul fondo, che sono stati di grande impatto. Convince invece un aspetto della drammaturgia e precisamente lo scontro tra le due donne, seconda e terza conserte Tudor, qui Antoniozzi azzecca un aspetto sia storico sia drammaturgico di grande spessore mettendo a confronto due “regine” in una spietata guerra di amore e potere nel quale tuttavia prevale anche la rassegnazione dell’una capendo la sua sconfitta. Altro elemento incisivo la freddezza e crudeltà di Enrico disegnato quasi immobile e senza sentimenti, i suoi voleri sono ordini e questo basti. D’effetto il trono fragile di Anna, costituito da mini, che all’occasione accolgono la regina ormai conscia della sua instabilità, come efficace la maschera che usa prima Bolena e poi Giovanna nuova consorte, la quale appare dopo la decapitazione in pieno titolo regale, meno pertinente il coro che assiste alla follia e all’esecuzione della protagonista con un flûte di spumante in mano. Molti aspetti di questa regia erano appropriati e convincenti, molti altri, a gusto di chi scrive, sicuramente no, tuttavia dobbiamo riconoscere ad Alfonso Antoniozzi la chiarezza di quello che ha voluto esprimere, tolto le superflue mine che girovagano in alcune scene.
La parte musicale vedeva Fabrizio Maria Carminati sul podio dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, il quale ha il pregio di operare pochissimi tagli e reggere la lunga opera con onesta professionalità. Avrei preferito una scansione più vigorosa di alcune scene, in particolare terzetto e finale atto primo, e in generale mi parso che la sua direzione non abbia trovato una lettura incisiva e una drammaturgia precisa adagiandosi su un accompagnamento talvolta lento e slegato che personalmente non riconosco in Carminati.
L’orchestra era di buon livello e piuttosto precisa, molto preparato il Coro del Teatro Regio di Parma che si ritaglia una performance di grande stile, sempre diretto da Martino Faggiani.
Mettere insieme il cast per un’opera come Anna Bolena è compito assai arduo, e senza rievocare un recente passato piuttosto pensando alla peculiarità vocale dei cantanti per cui fu scritta l’opera.
Parma ha tentato di raggruppare un cast che sulla carta doveva essere vincente, poi il diavolo, come suol dirsi, ci ha messo la coda. Escono vittoriose le due antagoniste Anna e Giovanna. Yolanda Auyanet, Anna Bolena, credo al debutto nel ruolo, affronta la difficile parte con grande impeto e una ricchezza di colori vocali davvero impressionanti, coinvolgendo il pubblico più sull’aspetto drammatico che sul virtuoso, realizzando un fraseggio di gran classe e una recitazione vocale di forte teatralità. Dotata di voce molto bella, risolve la parte virtuosistica con perizia e stile senza però svettare ma esegue il tutto con grande musicalità, peccato che il registro acuto non sia così lucente come la zona centrale, ma siamo di fronte ad una prova sicuramente positiva.
Sonia Ganassi, Seymour, era in ottima forma e propone una Giovanna di gran classe, cantata con spavalda sicurezza e introspettiva recitazione, puntuale in tutti gli ardui momenti dello spartito e valida belcantista di cui serbiamo memoria.
Marco Spotti, Enrico VIII, è un basso con voce molto importante e buoni mezzi ma in questo ruolo non trova gli esiti di altre occasioni. Il fraseggio e l’accento erano monotoni e non riusciva a imporsi come il re cui ogni desiderio è ordine. Forse non aiutato dalla regia, la sua interpretazione era distaccata e poco incisiva.
Percy doveva essere Maxim Mironov, di cui ricordiamo una pregevole performance a Bergamo, purtroppo un’improvvisa indisposizione l’ha messo fuori gioco e all’ultimo è arrivato a Parma, proprio il giorno della prima, Giulio Pelligra. Considerati gli eventi, non sarebbe corretto esprimere un giudizio sulla prestazione, tuttavia è lecito rilevare che a mio avviso la parte è troppo onerosa, in particolare nel settore acuto, per una voce tutto sommato piccola ma molto educata e musicale ma bisogna lodare la disponibilità del cantante a salvare la recita.
Molto brava Martina Belli, Smeton, mezzosoprano scuro di ottima voce, precisa tecnica e buona caratterizzazione del personaggio.
Completavano la locandina i professionali Alessandro Viola, Harvey e Paolo Battaglia, Rochefort.
Finale un po’ turbolento con applausi calorosi a tutto il cast, molto convinti per Auyanet e Ganassi, qualche disappunto al direttore e una più pesante contestazione all’uscita del regista, scenografa e costumista.
ANNA BOLENA [William Fratti] Parma, 12 gennaio 2017.
Il Teatro Regio di Parma inaugura la sua breve Stagione Lirica 2017 con un nuovo allestimento di Anna Bolena, in un progetto con il Teatro Carlo Felice di Genova che coinvolge anche gli altri titoli del ciclo Tudor di Gaetano Donizetti.
Sul podio dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna è Fabrizio Maria Carminati, direttore generalmente molto capace e particolarmente adatto al grande repertorio, ma che in questa occasione appare inadeguato e piuttosto grossolano, con tempi poco comprensibili e nessuna chiara intenzione, con assenza di colori e sfumature. La versione scelta prevede solo alcuni dei tagli di tradizione ed è un’occasione sprecata non averne approfittato per eseguire l’integrale, utilizzando l’edizione critica pubblicata lo scorso anno dalla Fondazione Donizetti.
Lo spettacolo di Alfonso Antoniozzi, con scene e video design di Monica Manganelli, si avvale del medesimo impianto fisso del Devereux genovese, ma qui ambientato nei moderni anni Quaranta. Si tratta di un allestimento molto semplice, ma abbastanza fotogenico e funzionale; purtroppo gi spazi sono spesso vuoti e la magia dell’effetto cartolina lascia il passo alla noia. Sicuramente il libretto di Romani non aiuta, rivolto più ai sentimenti che non all’azione, ma qualche gesto in più, qualche controscena, un po’ di cambi negli effetti video, probabilmente avrebbero reso questa Bolena meno monotona. Le idee ci sono, interessanti, anche piuttosto comprensibili, ma poco sviluppate lungo il procedere della vicenda. Pure i costumi di Gianluca Falaschi non sono azzeccatissimi: se ne riconosce la pregevole fattura, ma inseriti in questo contesto fanno sembrare Anna una bella signora qualunque, Giovanna la sua governante ed Enrico un pappone, già sufficientemente mortificato da una regia che lo impone così distaccato da mostrare solo altra immobilità.
Yolanda Auyanet, inizialmente un poco tesa, si è dimostrata molto volenterosa e col suo consueto fare morbido ed omogeneo si è impegnata in una recita in crescendo, arrivando ben concentrata al drammatico finale reso col giusto effetto, buona intenzione e ottima intonazione. La sua tecnica le permette di domare la difficile parte di Anna, ma non trasmette quell’incanto che dovrebbe traspirare dalla luminosità della voce e non fa trattenere il fiato quando è impegnata nel virtuosismo.
Sonia Ganassi veste i panni di Giovanna con estrema disinvoltura e il suo agio lo si percepisce per tutto il tempo. L’esperienza nel ruolo e l’ottima tecnica di base le hanno permesso di ottenere un buon risultato, pur con qualche difficoltà nella cavatina e altri brevissimi momenti un poco stimbrati.
Giulio Pelligra sostituisce all’ultimo minuto l’indisposto Maxim Mironov e l’impaccio è chiaramente visibile – ma perdonabile – cui si aggiungono qualche stonatura e diverse parole inventate. Tutto sommato riesce a portare a casa un Percy dignitoso.
Marco Spotti è il bravo cantante di sempre, ma il suo bel timbro cavernoso, il suo volume molto importante e il suo stile personale male si amalgamano al belcanto di Auyanet e Ganassi. Indubbiamente il suo Enrico VIII sarebbe stato perfetto se affiancato a due protagoniste dalla vocalità più scura e drammatica, mentre così riesce ad esprimere il suo consueto carattere solo durante i pezzi d’assieme.
Martina Belli è un ottimo Smeton, dotata di buona musicalità, linea di canto omogenea, belle note basse e altrettanto piacevole nelle colorature.
Efficaci, pur con qualche neo, il Rochefort di Paolo Battaglia e Hervey di Alessandro Viola che sostituisce Pietro Picone.
Finalmente il Coro del Teatro Regio diretto da Martino Faggiani ritorna nel pieno del suo splendore: suoni eccellenti, fraseggi eloquentissimi, accenti ben marcati, sussurrati emozionanti, ma soprattutto encomiabile l’uso della parola scenica che dà vita a delle pagine che sono perlopiù un resoconto narrativo.
Buon successo per tutti gli interpreti, con ovazioni per Auyanet, Ganassi e Spotti. Diversi dissensi per il direttore, come pure per tutta la squadra creatrice dello spettacolo. Contrariamente a quanto si possa pensare, i loggionisti hanno riferito che non hanno protestato lo spettacolo perché non realizzato in epoca rinascimentale, ma principalmente a causa della noia, complice la direzione d’orchestra.
PAGLIACCI [William Fratti] Torino, 17 gennaio 2017.
Il vero protagonista di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, andato in scena al Teatro Regio di Torino senza alcun abbinamento in dittico con altri titoli, è indubbiamente Nicola Luisotti.
La sua lettura della partitura è straordinariamente ricca di colori, soprattutto ricca di emozioni, riuscendo a dipingere in musica ciò che sentono i personaggi e che è descritto nelle loro parole e nelle loro azioni. Altrettanto eccellente sono l’Orchestra, che si prodiga in suoni pulitissimi, in legati dolcissimi, in fraseggi intensissimi, e l’ottimo Coro guidato da Claudio Fenoglio, sia sotto il profilo vocale e musicale, sia per ciò che riguarda la recitazione nella complessa mise-en-scène, che lo vuole componente viva e attiva per tutto il tempo.
A tale proposito lodevole è il lavoro di Gabriele Lavia, che studia gesti, sguardi, movimenti, azioni, primi e secondi piani, controscene, in tutto e per tutto, in un continuo flusso che non permette neppure di mettere a fuoco tutto quanto, proprio così, come avviene nella vita di tutti i giorni. Molto ben realizzate la scenografia e i costumi di Paolo Ventura, che crea abilmente il clima del secondo dopoguerra, il tutto arricchito dalle luci efficacissime di Andrea Anfossi.
Francesco Anile, subentrato nel ruolo di Canio già da qualche recita in sostituzione degli altri tenori indisposti, si prodiga come suo consueto in una emissione in acuto molto luminosa e ben impostata in avanti, ma sotto tende spesso al parlato e talvolta manca l’appoggio.
È invece sempre intonatissima e con uno stile di canto perfettamente lineare il soprano Erika Grimaldi, che nella parte di Nedda dimostra anche ottime doti di fraseggio e recitazione, ma si nota una certa debolezza nei passaggi più bassi.
Il prologo di Roberto Frontali vale da solo il viaggio a Torino: liricissimo, musicalissimo e brillantissimo; entusiasmante, struggente e intensamente cinico. Inoltre esprime ogni frase pronunciata da Tonio con un fraseggio che va ben oltre il verismo e la parola scenica: la sua è una prova di livello irraggiungibile. E la conclusione “La commedia è finita!” fa letteralmente rimbalzare il cuore e raggelare il sangue nelle vene.
Molto buona anche la prova dell’Arlecchino di Juan José de Léon, ma con un vibrato un poco prepotente. Piacevolmente morbido e musicale il Silvio di Andrzej Filonczyk. Ben adeguati i contadini di Vladimir Jurlin e Sabino Gaita. Eccellenti mimi, trampolieri e giocolieri.
TANNHÄUSER [Lukas Franceschini] Venezia, 20 gennaio 2017.
Era molto attesa la prima produzione 2017 del Teatro La Fenice: Tannhäuser di Richard Wagner, che sommava il debutto nel titolo del direttore Omer Meir Wellber e il ritorno del regista, talvolta “dissacratore”, Calixto Bieito.
L’opera romantica Tannhäuser fu rappresentata per la prima volta a Dresda il 19 ottobre 1845 e poi in una seconda versione a Parigi il 13 marzo 1861. E’ pratica comune, pur essendoci anche altre modifiche, considerare prevalentemente le versioni tedesca e francese, anche se quella di Dresda non corrisponde in realtà alla prima rappresentazione, bensì a un rimaneggiamento di due anni successivi, che modifica il finale. La versione di Parigi è un’elaborazione successiva di circa tre lustri. I cambiamenti riguardano in particolare l’Overture, conclusa non più a brano se stante, ma come “introduzione” per poi svilupparsi nella musica del Venusberg, con diversa orchestrazione e il balletto del Baccanale. Mutano la parte di Venus, più morbida e per mezzosoprano, e anche altri ritocchi orchestrali con la semplificazione negli atti II e III. Tuttavia i cambiamenti essenziali riguardano in particolare il Venusberg e il personaggio di Venus, che non possiamo considerare dei compromessi con il gusto francese, piuttosto di sostanziali miglioramenti nel disegno musicale e nella drammaturgia, poiché alcuni ritengono anacronistiche e insostenibili le proposte di Dresda. Il maggior problema è focalizzato nella tessitura del protagonista, un chiaro esempio (come sostenuto da molti musicologi) di come un compositore scriva inseguendo una sua linea personale non valutando quanto possa essere realizzata nella pratica teatrale, cioè avendo a disposizione un cantante capace di superare l’ardua impresa. Nel nostro caso la tessitura non è molto acuta ma è molto discontinua e in aggiunta scomoda per le molteplici frasi collocate sul passaggio di registro. Una partitura che necessita di un cantante molto controllato nell’emissione e di forte partecipazione come interprete. Se in molti passi primeggia il tenore eroico nel declamato e nel cantare sopra l’orchestra e sulle altre voci, nel racconto del III atto la tessitura si abbassa notevolmente, chiudendo l’opera in un canto morbido di stampo lirico, il quale è caratterizzato da morbidezze.
Tutto quanto espresso sopra mancava completamente a Stefan Vinke, il tenore protagonista a Venezia, il cui canto era una continua mancanza d’intonazione, stentoreo nello stile, poco credibile nell’accento e fraseggio contraddistinto dalla monotonia. Un vero peccato perché Tannhäuser è difficile immaginarlo senza protagonista. Ancora più incomprensibile è che la direzione artistica durante le prove non abbia rimediato una tempestiva sostituzione.
Di buona professionalità l’Elisabeth di Liene Kinca, una cantante di buona impostazione canora con timbro lirico e omogeneo nei registri. Avesse avuto qualche slancio espressivo più sostenuto, nella prima aria, avrebbe fatto una gran figura, nella preghiera del III atto ha dato il meglio di se e le va riconosciuta una buona interpretazione scenica.
Non convince la Venus di Ausrine Stundyte, cantante con voce ingolata e poco espressiva, anche se i mezzi sarebbero interessanti, ma necessiterebbero di diverse e ulteriori cure. Nella concezione registica il personaggio era molto azzeccato e di forte impatto teatrale.
Il migliore del cast era Christoph Pohl, Wolfram, giovane baritono di ottime qualità vocali, contrassegnato da un canto morbido, forbito nel colore e di sostanziale espressione nel fraseggio.
Pavlo Balakin, il langravio Hermann, ha iniziato con qualche sfasatura poi rientrata e posandosi sul piano della buona recitazione e decorosa prova vocale.
Molto bravo il Walter interpretato da Cameron Becker, tenore di squisita musicalità, cui si aggiungono le prove azzeccate e musicalmente precise di Alessio Cacciamani, Biterolf, Paolo Antognetti, Heinrich, e Mattia Denti, Reinmar.
Un particolare plauso per il giovane pastore interpretato da Chiara Cattelan, e molto bravi e precisi i quattro nobili giovani: Gianluca Nordio, Veronica Mielli, Emma Formenti e Sebastiano Roson, tutti solisti del Koble Children’s Choir del Centro Culturale p.M.Kolbe di Mestre (Venezia).
Sul podio la presenza di Omer Meir Wellber è stata una piacevole sorpresa. Il direttore, che come predetto debuttava nel titolo, aveva a disposizione un’ottima orchestra, particolarmente partecipe e come di rado precisa nel suono, pur con lievi sbavature degli ottoni che si perdonano con stima. La sua lettura è stata molto precisa e teatrale, azzeccando tempi e dinamiche di ottimo effetto e pastosa sonorità. Secondo chi scrive, ha privilegiato l’aspetto narrativo vigoroso, a scapito di tratti romantici e morbidezze che avrei apprezzato maggiormente, ma resta sempre una direzione di ampio respiro e molto calibrata musicalmente, una delle migliori prove di Wellber da me ascoltate in teatro. Il direttore ha optato per l’esecuzione del primo atto nella versione di Parigi, il secondo e il terzo nella versione di Dresda.
Bellissima la prova del coro istruito da Claudio Marino Moretti, che proprio nel finale ci regala un momento musicale emozionante.
Resta infine lo spettacolo di Calixto Bieito, che delude non tanto per l’impostazione generale, poco romantica, ma per i superflui inserimenti fuori luogo e talvolta fastidiosi. Per lui, come scritto nelle note, l’opera si svolge nel conflitto tra due donne di diversa concezione ed estrazione sociale. Pertanto bellissima la scena del primo atto con un Venusberg astratto con piante appese in graticcia e in questo giardino si aggira Venus seducente e avvinghiata nel suo amore profano. Non sarebbe servito un esplicito amplesso tra lei e Tannhäuser, con lui che posa le mani e la testa tra le sue gambe. Non per bigotteria, tutt’altro, ma fin lì ci si arriva. La contrapposizione tra amore sacro e amore profano, trova una logica nella sua concezione registica, e anche teatrale, ma poi scivola su terreni fragili come il tentativo di stupro che subisce Elisabeth, e il “bondage” che tenta Wolfram quando capisce che non pensa a lui ma prega per il ritorno di Tannhäuser. Elementi dei quali non sentivamo il bisogno. Venus donna libera e solitaria, Elisabeth donna schiacciata e vittima di una società maschile arcaica e primitiva, concetti in parte presenti nella drammaturgia ma molto opinabili. L’ambientazione è moderna senza stile o riferimenti, un banale ambiente borghese che non lascia traccia come i costumi comuni di Ingo Krügler, il quale “veste” le due donne in sottoveste. Rebecca Ringst, la scenografa, azzecca il primo atto con belle soluzioni, si adagia nella ruotine negli altri, anche se la bianca sala dei cantori è stilizzata, ma sembra il giardino d’inverno di una ricca villa. Il coro, ovvero i pellegrini, sono collocati sullo sfondo, come una cosa lontana irraggiungibile, anche se dobbiamo rilevare che la scena finale è molto teatrale, poiché appare sul proscenico come anime che tentano e vogliono l’assoluzione divina, lasciando nel dubbio lo spettatore se questa ci sarà. Molto belle le luci di Michael Bauer, speculari e sempre focalizzate sui singoli. Taluni riferimenti sarebbero anche pertinenti, come il feticismo di Wolfram, il patto di sangue dei cantori amici di Tannhäuser, ma sono sempre sviluppati in un contesto quasi morboso e molto accentuati, quando sarebbe stato opportuno molto meno e più eleganza.
Al termine molti applausi a cantanti e direttore, anche se qualche distinguo non sarebbe stato scorretto, una lieve contestazione all’uscita del regista.
LA STRANIERA [Natalia Di Bartolo] Catania 21 gennaio 2017.
Capolavoro non facile La Straniera di Bellini, sia sotto l’aspetto musicale, riguardo all’esecuzione e pure all’ascolto, certo difficile anche nella messa in scena.
Al Teatro Massimo “Bellini” di Catania, il 21 gennaio 2017, l’opera si è dimostrata non facile anche per altri motivi: sostituzione a monte del direttore d’orchestra con il M° Sebastiano Rolli; Daniela Schillaci, Alaide al debutto nel ruolo, sostituita per un’indisposizione improvvisa da Francesca Tiburzi, titolare del secondo cast; sostituzione in extremis per il personaggio di Isoletta con Sonia Fortunato al posto di altre titolari che avevano dato forfait…
Il tutto in un clima di grande aspettativa che si era voluto creare attorno a questa messa in scena d’inaugurazione della Stagione Lirica 2017. Infatti l’opera è stata rappresentata nella versione originale del debutto del 1828, secondo la revisione critica curata da Marco Uvietta; il che l’ha resa un evento atteso ma, in tali condizioni di precarietà, certamente rischioso per gli interpreti.
Leit motiv della produzione, in un nuovo allestimento, l’acqua, scelta dal regista Andrea Cigni, con la scenografia di Dario Gessati e i costumi di Tommaso Lagattola, come elemento liquido di multiforme aspetto di riflessione e di paesaggio, sotto le luci di Fiammetta Baldisseri. Atmosfere essenziali, anche sottolineate da alcune proiezioni.
Indubbiamente non a proprio agio gli interpreti in questa particolare messa in scena, che pure ha avuto i suoi pregi, perché lineare e senza fronzoli, ma in cui l’acqua è stata determinante anche dal punto di vista sonoro in alcuni punti, poiché gli interpreti vi erano immersi fin oltre le caviglie e vi camminavano dentro.
Nelle scene d’insieme gran rumoreggiare d’acqua, interpreti messi a dura prova dall’umidità, costumi inzuppati, primadonna in accappatoio agli applausi finali. Insomma: l’acqua in scena può andar bene, ma est modus in rebus.
Musicalmente parlando, però, ciò che è balzato all’orecchio è stata la discontinuità, quasi la frammentarietà, della resa complessiva.
Il M° Sebastiano Rolli, al debutto nella direzione dell’opera, ha inteso dare un piglio brillante alle proprie dinamiche e ai tempi. Positivo il dato, visto che ne La Sonnambula dello scorso maggio 2016 aveva mostrato ispirarsi a storiche lentezze, ma ha creato a volte una barriera tra gli interpreti e il pubblico, soprattutto quello in platea, per il quale la scena soprelevata a causa dell’enorme vasca certo non era d’aiuto nella ricezione corretta delle voci dal palcoscenico. Un maggior supporto agli interpreti e al coro, un piglio più esperiente e robusto nei confronti dell’orchestra stessa, tutti a volte spiazzati e incerti, avrebbero giovato e ciò dichiarava apertamente anche una carenza di prove adeguate, acuita dal disagio delle improvvise sostituzioni e di altri numerosi intoppi che avevano ostacolato la debita preparazione dell’opera.
La protagonista Alaide, Francesca Tiburzi, titolare del secondo cast, è stata la sostituta della tanto attesa Daniela Schillaci, che canterà comunque le altre recite. La Tiburzi ha avuto una bella gatta da pelare, nonostante il bel colore scuro che ne caratterizza la vocalità, soprattutto a causa della tendenza ad avere qualche problema d’intonazione. Il celeberrimo vocalizzare dietro le quinte al primo atto che introduce Alaide, per esempio, ha dimostrato un attacco ed un prosieguo alquanto incerti, sia pur considerando che si tratti di una partenza a freddo di improba difficoltà. Il soprano è andata avanti, comunque, con piglio drammatico ed ha delineato, scenicamente, un personaggio robusto, ma si è mostrata anche carente nella zona acuta, stirando una voce che non è perfettamente adatta alla parte e che in toto, probabilmente, non è una voce adatta a cantare Bellini o, almeno, “questo” Bellini.
Il tenore Emanuele D’Aguanno, al debutto nel ruolo di Arturo, alle prese pure con l’acqua che ha saputo gestire con abilità scenica, ha dispiegato una voce dall’emissione fluida, dotata di un bel legato e di facilità ai sovracuti. Anch’egli ha avuto un bel da fare per far funzionare i duetti, dove l’evidente carenza di prove di cui sopra ha avuto il proprio peso specifico alquanto elevato, ma, in conclusione, se l’è cavata egregiamente, dando di Arturo una versione credibile e sentita, oltreché coraggiosa, nella quale ha anche dato prova di professionalità e di carattere.
Dell’Isoletta di Sonia Fortunato non si può che dir bene, perché si è accennato all’inizio come fosse un’interprete last minute. Gravoso compito, dal golfo mistico, quello di dar voce alla controfigura/mimo Nicol Oddo senza aver studiato l’opera per andare in scena. Era successo a chi scrive di assistere ad un episodio simile, ma in corso d’opera in un Don Carlo a Vienna, per l’improvvisa indisposizione del basso che impersonava Filippo II, divenuto afono durante la recita. Nel teatro austriaco, il sostituto, però, era comparso in palcoscenico, lateralmente, con tanto di leggio, e aveva dato voce all’interprete in persona, con un vero e proprio playback. A questo punto, meglio la finzione dal golfo mistico; ma il buon impasto vocale da mezzosoprano della Fortunato sarà tutto da ascoltare in scena.
A parte il gradevole Valdeburgo di Enrico Marrucci, le voci del signore di Montolino, Alessandro Vargetto, del priore degli Spedalieri, Maurizio Muscolino, e di Osburgo, Riccardo Palazzo, non brillavano né per proiezione né per espressione. Altrettanto il Coro, istruito però questa volta con una certa cura da Ross Craigmile, ma intimorito dai tempi della direzione.
Una serata da cui si è usciti con un po’ d’amaro in bocca, al pensiero di ciò che è stato e di ciò che avrebbe, per molti motivi, potuto essere.
Serata affollata, anche confusionaria tra il pubblico plaudente con qualche eccesso da claque, ma Bellini, per fortuna e per quei miracoli che spesso si riesce a compiere in scena grazie alla potenza dell’Arte, ne esce comunque indenne e questo è il dato di fatto più rilevante. Chi scrive, però, non si priverà di un’altra recita e la consiglia.
COSÌ FAN TUTTE [Simone Ricci] Roma, 21 gennaio 2017.
La prima opera del nuovo anno del Costanzi è il capolavoro che conclude la trilogia dapontiana di Mozart, in questo caso all’insegna della stravaganza e del fanciullesco.
Il 2017 del Teatro dell’Opera di Roma è cominciato con il capolavoro conclusivo della trilogia dapontiana di Mozart, “Così fan tutte”. Proprio come il librettista, il regista di questo nuovo allestimento per il Costanzi, il britannico Graham Vick, si è innamorato perdutamente del sottotitolo dell’opera buffa, “La scuola degli amanti”. Mozart non lo amava molto e temeva che potesse confondersi con un lavoro di Antonio Salieri, “La scuola de’ gelosi”. Vick ha invece deciso di prenderlo alla lettera, eliminando il Golfo di Napoli e dando spazio all’aula di una scuola stravagante e colorata. Non tutto il pubblico ha apprezzato la scelta e alla fine della rappresentazione è partito qualche verso di disapprovazione, il quale ha coinvolto anche i costumi.
Questa recensione si riferisce alla replica di sabato 21 gennaio. “Così fan tutte” funziona benissimo da sola come opera e anche una regia particolare non toglie nulla alla bellezza della partitura. Vick ha trasformato Don Alfonso in un insegnante, mentre Gugliemo e Ferrando sono diventati due alunni scanzonati e spavaldi. La nave disegnata al pc e proiettata sulla parete poteva piacere a un pubblico di età non superiore ai 10 anni, mentre Despina nelle vesti di una donna delle pulizie, con tanto di ciabatte, strappava qualche sorriso in più. Le due coppie di amanti, inoltre, vestivano abiti dai colori a dir poco appariscenti, in particolare Fiordiligi e Dorabella.
A onore del vero ci sono state regie più “azzardate” di questa: nonostante qualche elemento fanciullesco, l’ambientazione poteva funzionare e il cast vocale è riuscito a rendere credibile e divertente ogni azione. Sono stati proprio i cantanti a far dimenticare le stravaganze registiche e costumistiche. I sei protagonisti hanno brillato senza dubbio per l’allegria che sapevano trasmettere, in particolare hanno fatto capire al pubblico romano di essersi immedesimati perfettamente e di divertirsi parecchio: il sorriso di un cantante è sempre contagioso e gli spettatori hanno mostrato di gradire.
Gli applausi convinti sono andati a tutto il cast, si è comunque intuita qualche ovazione in più per Federica Lombardi, una Fiordiligi dalla voce fresca e dalla regione centrale sontuosa e intensa. Il giovane soprano ha scolpito molto bene le frasi con rotonde vibrazioni e un registro acuto che è apparso discretamente omogeneo, come si è avuto modo di ascoltare in Come scoglio. Nei duetti dal tipico sapore belcantistico, la sua voce si è sposata in maniera naturale con quella di Paola Gardina, una Dorabella che ha convinto per quel che riguarda l’intensa musicalità e la forte partecipazione.
Le espressioni civettuole e il suono pieno nella seconda aria (È amore un ladroncello) sono stati i suoi punti di forza, senza dimenticare la chiarezza della dizione. Mattia Olivieri è stato invece un Guglielmo vivace. La foga giovanile di Donne mie, la fate a tanti è stata resa con una voce dal timbro bello e consistente, il quale è stato ascoltato senza difficoltà: la presenza scenica e le espressioni divertite del viso hanno fatto diventare ancora più interessante la sua performance. Antonio Poli era un Ferrando dall’evidente smalto lirico, mai affaticato e in grado di affrontare con il giusto equilibrio anche il “piano”, uno degli ostacoli di questo ruolo tenorile.
Il Don Alfonso di Paolo Bordogna è stato caratterizzato da voce fluida e da un fraseggio mai banale, costantemente alla ricerca di un effetto a metà tra l’austero e il buffo e senza mai sprecare una battuta o un accento. Molto apprezzata è stata anche Daniela Pini nel ruolo di Despina, abile nel camuffarsi in medico e notaio, senza dimenticare In uomini, in soldati che ha convinto per volume e timbro educato. Speranza Scappucci ha accompagnato con garbo le voci, alternando bacchetta e fortepiano: non era semplice assecondare il gioco e il fraseggio mutevole dell’opera di Mozart, ma non ha sfigurato e l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma si è disimpegnata con buona professionalità.
Il ruolo del coro (come di consueto ben addestrato da Roberto Gabbiani) può sembrare marginale in “Così fan tutte”, ma anche Bella vita militar merita di essere eseguito con la giusta esperienza vocale e in questo caso il risultato è stato di buona fattura. Vick ha voluto dare spazio soprattutto alla scuola e quindi sono inevitabili le pagelle: per il regista inglese e le scene e i costumi di Samal Blak non si può parlare di una bocciatura senza appello, ma di una insufficienza non grave e che può essere migliorata. I cantanti e il direttore d’orchestra hanno invece meritato voti più lusinghieri.
FAUST [Lukas Franceschini] Firenze, 22 gennaio 2017.
Una delle più celebri opere del repertorio francese, Faust di Charles Gounod, ha avuto pochissime rappresentazioni al Teatro Comunale di Firenze, infatti, prima di questa produzione 2017 si registrano solo altre due allestimenti: nel 1948 in versione italiana e nel 1985 in lingua originale.
22 gennaio 2017. Faust, dramma lirico in cinque atti, subì cambiamenti, aggiunte e trasposizioni dal suo esordio al Théâtre Lyrique nel 1859 fino all’allestimento definitivo all’Opéra del 1869 per il quale fu aggiunto il balletto della “Notte di Valpurga” e la preferenza dei recitativi al posto degli originali parlati. Il soggetto, una riduzione da Goethe, è indicativo per l’epoca e riflette inoltre, secondo alcuni, la problematica del compositore, disgiunto tra timori religiosi e tentazioni del desiderio. Gounod, raffinato e soprattutto accomodante, forgia questo contrasto fondendoli in una melodia dolce e cavillosa, con armonie aperte e solenni, il valzer è spesso presente in maniera semplice.
Nel colmare una non frequente proposta l’Opera di Firenze ha avuto l’azzeccata idea di riallestire il bel spettacolo di David McVicar creato per il Covent Garden nel 2004. Il regista scozzese firma un bellissimo e tra i più interessanti spettacoli d’opera degli anni recenti. Innovatore ma senza stravolgere, tra i più moderni, il quale firma una regia molto potente e ricca di elementi innovativi. La vicenda è trasportata in pieno ‘800 all’epoca della guerra franco-prussiana, dalle cui battaglie torneranno i soldati feriti nel IV atto. Il vero protagonista dell’opera è Mèphistophélès, istrionico illusionista con baule al seguito, nel quale trova tutte le sue magie da vendere a cominciare dalla “giovinezza” per Faust ma anche i gioielli per incantare Margherita e che la porteranno all’inesorabile destino. Mirabile e impressionante la scena fissa laterale nella quale a destra si erge un organo di chiesa a sinistra i palchi di Palais Garnier. Il centro scena è variabile secondo l’azione, abbiamo una perfetta ricostruzione del quartiere dove vive Margherita, la taverna, e un cabaret nel quale il demonio fa incontrare i due giovani. Meravigliose e azzeccate alcune soluzioni registiche: far sgorgare vino da un crocefisso durante “Le veau d’or”, la grande scena della chiesa al IV atto dove Mefistofele dapprima statua si trasforma in umano stringendo Margherita nell’abbraccio mortale. Altro memorabile momento è il Sabba che prende idea dalla parodia di un balletto con la “regia” del Diavolo abbigliato come una matronale tenutaria di bordello e il balletto che allude a un turbine di baccanti che si conclude in un’orgia molto castigata. Sul finale, impressiona la grande grata della prigione e la piccola bara del bimbo con uno spettacolare ritorno all’inizio, a quel baule che porta tutto all’indietro. Una drammaturgia forte ma coerente e compatta che posso affermare inchioda lo spettatore alla sedia per le oltre tre ore di spettacolo, che definire magnifico è superfluo. Assieme al regista hanno contribuito in maniera straordinaria lo scenografo Charles Edwards, la costumista Brigitte Reiffenstuel, il coreografo Michael Keegan-Dolan e il light-designer Paule Constable, tutti perfetti nel loro compito. Una produzione assolutamente da non perdere, anche se già utilizzata in molteplici riprese.
Non da meno la parte musicale a cominciare dalla direzione di Juraj Valčuha. Coadiuvato da una brillantissima Orchestra del Maggio Musicale, ha saputo reggere le redini di una partitura complessa e variegata con una tensione drammatica di altro livello. I tempi serrati o lirici erano ricchi di colori e sfumature, e mai ha ceduto in minima parte alla narrazione romanzesca sempre tenuta nel vivo mordente dell’impulso demoniaco. Una grande prova di concertazione.
Tra i solisti emerge con preponderanza il Mèphistophélès di Paul Gay, basso con voce imponente e morbida, avvezzo al canto delicato ricco di sfumature e accenti, cui va sommata una presenza scenica affasciante di forte impatto teatrale.
Wookyung Kim è un tenore con bellissima voce, calda e abbastanza educata. È carente il gusto d’interpretare e qualche raffinatezza, inoltre l’intonazione non sempre controllata e il registro acuto non particolarmente rifinito.
Carmela Remigio, Margherita, è cantante molto musicale e di grande bravura nel fraseggio, ma il settore acuto è limitato, il grave poco incisivo. Emerge nelle scene liriche ma come cantante virtuosa è appena accettabile e nella parte drammatica manca di temperamento e spessore.
Serban Vasile è un Valentin di corretta impostazione e buona resa vocale, brillante e disinvolto il Sibel di Laura Verrecchia, la quale si ritaglia un momento di plauso nella sua aria. Gabriella Sborgi è una simpatica e bravissima Martha, Karl Huml un Wagner di ottima professionalità. Brillantissima la prova del coro del Maggio Musicale diretto da Lorenzo Fratini.
Alla recita domenicale lo spettacolo, integro dopo lo sciopero della prima, ha ottenuto un clamoroso successo decretato da un pubblico festante e numeroso che riempiva quasi completamente il grande Teatro dell’Opera di Firenze.
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL [William Fratti] Bologna, 24 gennaio 2017.
Ad accompagnare l’inaugurazione della Stagione d’Opera 2017 del Teatro Comunale di Bologna è stato un insistente parlottare, scrivere, comunicare, annunciare, soprattutto sui social network, qualcosa di scottante in merito all’allestimento, per l’occasione coprodotto con Festival d’Aix-en-Provence e Musikfest Bremen, che ha addirittura previsto l’adattamento dei dialoghi – a cura di Martin Kušej e Albert Ostermaier – all’attualizzazione dell’azione, con l’aggiunta di controlli e perquisizioni all’ingresso da parte delle forze dell’ordine.
Sfortunatamente la grande aspettativa di ciò che pareva essere lo spettacolo più innovativo degli ultimi tempi ha prodotto soltanto un aggravarsi del sintomo della disattesa. L’idea di Martin Kušej di trasporre la vicenda ai principi delle dispute e delle guerre per l’oro nero è assolutamente vincente, soprattutto perché riesce nell’intento di evidenziare i caratteri drammatici voluti da Mozart e abilmente nascosti dietro le caratteristiche della commedia. Purtroppo la novità tanto reclamizzata si ferma qui, poiché la scena unica ambientata nella desolazione del deserto, il procedere lentissimo dell’azione, l’assenza di controscene ed effetti, fanno di questo spettacolo un noiosissimo procedere di vuoto e di nulla. Il fatto che sia coerente e filologico non lo salva: monotono, lento e pesante resta. Solo i pochi secondi del coup-de-théâtre finale svegliano i più assopiti: Osmino, insoddisfatto dell’inaspettato perdono di Selim, decide di tagliare la testa ai quattro sventurati. Scena, tra l’altro, scortata da una lunga serie di disapprovazioni da parte del pubblico.
Per fortuna a mantenere alto il livello di attenzione ci pensa l’abile bacchetta di Nikolaj Znaider, che giustamente abbandona le tinte più leggere a carattere buffo a favore di accenti drammatici, patetici e cinici, in perfetto stile mozartiano e comunque molto aderente al tipo di spettacolo montato da Kušej. L’Orchestra del Comunale è dipinta da una miriade di colori sgargianti ed eccelle particolarmente nel preludio di “Martern aller Arten”. Ottimo il Coro preparato da Andrea Faidutti, purtroppo costretto all’interno del golfo mistico.
Cornelia Götz è una Konstanze particolarmente intonata e aderente allo stile, ma eccezion fatta per l’intenso canto patetico, il resto non è così brillante e luminoso, oltre a eseguire i picchettati in pianissimo e a difettare di accento drammatico.
Bernard Berchtold è un Belmonte corretto, ma nulla di più, poiché non esprime quell’intensità d’amore che già la scrittura elegante della parte possederebbe.
Lo stesso vale per la Blonde di Julia Bauer, che mostra una linea di canto pulita, ma priva di sapore. Pure insipido il Pedrillo di Johannes Chum.
È invece più che ottimo l’Osmino di Mika Kares, che si prodiga in un fraseggio di un’eloquenza magistrale, arricchito da una miriade di sfumature che palesano ogni stato d’animo del guardiano. Il canto è raffinato, i suoni sono perfetti, pure le numerose note gravi e i gradevolissimi acuti. Kares rende un personaggio davvero interessante, poiché il cinismo bonario celato nei suoi primi cantabili già preannuncia l’insolito finale.
Buona la parte recitante del Selim di Karl-Heinz Macek.
Durante gli applausi diverse acclamazioni sono riservate a Nikolaj Znaider e Mika Kares, mentre alcune disapprovazioni sono rivolte all’assente squadra responsabile dell’allestimento.
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL [Lukas Franceschini] Bologna, 26 gennaio 2017.
La stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna è stata inaugurata da una discutibile edizione di Die Entführung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart, importata dal Festival di Aix-en-Provence (2015) dove anche là ebbe numerose critiche e contestazioni.
Il perché di questa scelta è strana, considerando che trattasi di uno spettacolo decisamente non bello, e le perplessità sono fondate sulla riscrittura del libretto e del finale per opera del drammaturgo Albert Ostermaier, collaboratore del regista Martin Kusej.
L’azione è trasportata ai giorni odierni nel pieno scontro bellico con l’esercito jihadista. Il mondo fiabesco mozartiano, non privo di confronto tra mondo occidentale e arabo, è totalmente stravolto. Dunque regista e drammaturgo non ritenevano il libretto e le volontà di Mozart ancora attuali o proponibili oggi? Difficile dare una risposta, certamente quest’adattamento dei dialoghi, seppur giustificato nel programma di sala da un’argomentata motivazione, è un arbitrio insensato che non lascia traccia. Sono completamente stravolte alcune figure, in particolare Osmin che è ridotto a mero carnefice attuale, mentre nell’originale è un basso buffo con accenti comici. L’opera è un singspiel tratto da un vaudeville, genere in voga a fine ‘700, con marcati elementi al mondo islamico, cambiarla in tragedia a tutti gli effetti, per chi scrive, è un errore grossolano, che può ascriversi solamente al protagonismo degli autori. Oltre al libretto è cambiato anche il finale, nel quale si assiste a un vero controsenso poiché Osmin decapita le teste dei quattro ostaggi, in precedenza perdonati e lasciati liberi da Selim, e gettate ai piedi di questi contravvenendo ai suoi voleri, o forse era complice tale massacro. Inoltre bisogna rilevare che i dialoghi erano molto articolati e di una lunghezza insopportabile, quando oggi, anche nei teatri tedeschi, si tende a ridurre al minimo la recitazione tranne quella di Selim.
Oltre a queste arbitrarie trasposizioni non abbiamo avuto uno spettacolo degno di memoria e neppure della classica routine, ma probabilmente solo da dimenticare. Una scena, creata da Annette Marschetz, pressoché fissa con sabbia vera, un fondale che funge da deserto e sulla sinistra una tenda nera che potrebbe essere la residenza di Selim ma anche il quartier generale dell’esercito Isis. Non cambia nulla per tutto lo spettacolo, se non qualche effetto luce non sempre azzeccato di Reinhard Traud. Costumi banali e moderni di Heide Kastler. Regia statica e monotona, con scelte coerenti ma logore nella visione come la foto dei quattro prigionieri con bandiera nera, che purtroppo tante volte abbiamo visto nei telegiornali su fatti di vera cronaca. I guerriglieri, dei mini, che incitano alla decapitazione dei prigionieri senza mai eseguirla ma solo per incutere terrore. Ogni riferimento al comico e al brillante è ovviamente cancellato, vengono cosi penalizzati soprattutto Osmin, Blonde e Pedrillo (il quale è messo sotto la sabbia lasciando fuori solo la testa), e naturalmente tutto va in contrasto con il libretto cantato. Inoltre il coro era collocato in buca, e questo la dice lunga della scarsità d’idee. Come già detto da dimenticare, e credo non sarà cosi difficile.
Non ha brillato neppure la parte musicale, soprattutto perché il cast era molto mediocre, e vi sono stati ben due cambi all’ultimo minuto, presumibilmente dovuti al tipo di spettacolo.
Nicolaj Znaider è un celeberrimo e bravissimo violinista, per la prima volta in Italia in veste di direttore d’opera. Egli si adegua all’impostazione generale dello spettacolo con una direzione lenta e molto manierata, talvolta tendente al noioso. Tuttavia, bisogna costatare che il suono era molto bello, le dinamiche e i colori rilevanti, e la nitidezza esemplare. Complice in questo un’orchestra del Comunale in ottima forma veramente da lodare. Peccato che l’incontro con questo musicista sul podio sia stato con questo spettacolo e con un cast molto mediocre. Speriamo in occasione migliore in futuro.
Molto buona la prova, seppur limitata nello spartito, del coro diretto da Andrea Faidutti.
I due elementi migliori del cast sono stati Mika Kares, Osmin, e Jlia Bauer, Blonde. Il basso Kares ha voce molto profonda e ben timbrata, anche se talune note gravi non erano udibili, tali limiti vanno ad ascriversi in una propensione più in acuto che nel grave di una voce importante ma limitata per un ruolo come Osmin. Comunque trattasi di una prova positiva di un cantante con buone doti, magari da raffinare, e una presenza scenica maiuscola, sarebbe auspicabile ascoltarlo in altra occasione. Il soprano Bauer ha una voce ben impostata, seppur con dei limiti in acuto, ma è molto musicale e degna di note positive.
Cosa che non si può dire per il Belmonte di Bernard Berchtold che oltre a rendere evidente drammatici limiti vocali, non possiede nemmeno un timbro suggestivo, e parlare di correttezza è già un complimento.
Cornelia Gotz, Konstanze, fa quello che può con una parte che va oltre il limite delle sue possibilità. Limitata come soprano d’agilità, riesce solo nel canto centrale, il grave è afono, e nel complesso fa quello che può, e non avremo potuto aspettarci altro già dalla prima aria eseguita con monotonia.
Più efficace il Pedrillo di Johannes Chum, che sostituiva un altro tenore turco previsto e ovviamente fuggito da questa produzione. Voce non particolarmente brillante ma di buona impostazione e sicuro, tende a forzare e stridere nel settore acuto ma nel complesso è stato un personaggio accettabile.
Molto bravo l’attore Karl-Heinz Macek, Selim, ottima la recitazione e la presenza scenica.
Pubblico piuttosto spiazzato dallo spettacolo, convinto però dal reparto musicale cui ha concesso al termine delle oltre tre ore di esecuzione un convito applauso, con accesi consensi solo per Mika Kares.
Un’ultima nota. Considerato questo tipo di allestimento, la prefettura temendo potessero esserci delle contestazioni non tipicamente teatrali, ha ordinato un servizio d’ordine rafforzato attorno al Comunale con controllo al metal-detector per tutti gli spettatori che entravano. Purtroppo dobbiamo arrivare a questo punto per andare all’opera. Mah!
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL [Lukas Franceschini] Treviso, 27 gennaio 2017.
Interessante assistere in due giorni a due produzioni di Die Entführung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart e metterle a confronto. È quanto mi è accaduto con Bologna e Treviso.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una trasposizione temporale dell’opera. Infatti, il regista Robert Driver sceglie di ambientare il singspiel negli anni ’20 del secolo scorso, subito dopo la fine del primo conflitto mondiale. Per il personaggio di Selim si è ispirato, molto liberamente, ad Ataturk il presidente della Repubblica Turca, indimenticato statista, che volle imprimere pur nel rispetto delle tradizioni una concezione di stato laico attingendo in parte alle moderne democrazie europee, delle quali era particolarmente ammiratore. La vicenda della storia dei quattro “prigionieri” europei è vissuta attraverso un bizzarro ma piacevole rifermento al cinema hollywoodiano del tempo, nel quale Konstanze è un alter ego di Mata Hari, una spia occidentale (ricordiamoci che la Turchia al tempo era di nuovo in guerra), Belmonte è il suo spavaldo e romantico amore spagnolo, Blonde donna libera della borghesia, Pedrillo il giovane sempliciotto innamorato di Blonde capace di trovare sorprendentemente la soluzione al problema, Osmin il fedele scudiero del Pascià, più “can che abbaia non morde” e non certo di raffinato intelletto, Selim-Ataturk il politico molto saggio di forte carattere, il quale pur ammirando l’occidente da buon turco non comprende come la condizione femminile possa essere così “libera”. Ecco espresso in breve il filo drammaturgico di Driver, il quale a differenza del collega bolognese coglie tutti gli spunti che il libretto di Johann Gottlieb Stephanie e la musica di Mozart vogliono esprimere, anzi lancia un ponte forse traballante tra Europa e mondo islamico, ma quello che è certo non sono soppressi i caratteri sfaccettati dei personaggi: l’amore e il sentimentalismo tra le due coppie, la drammaticità e risolutezza di Konstanze, le ire furibonde di Osmin ma anche il suo lato comico, la saggezza del Pascià e la lezione sul perdono.
Uno spettacolo molto curato e ben disegnato drammaturgicamente, una regia piacevole allo stesso tempo tradizionale ma innovativa, potendo attingere a filmati cinematografici dell’epoca, un’idea piacevole. Un lavoro riuscito e ben congeniato, anche se alcune scene solo recitate sono state tagliate. Unico neo è stato quello di eseguire i parlati in lingua italiana. Non saprei dire chi ha avuto tale idea non brillante, poiché dopo aver ascoltato arie, duetti, quartetti, in tedesco era un pugno nello stomaco la recitazione in italiano. Inoltre, a parte la filologia che oggi è rispettata più di ieri, i parlati erano sintetici e con l’ausilio della traduzione nei sopratitoli non sarebbe stato tanto difficile seguire la vicenda anche per chi non conosce affatto il tedesco.
Molto belle le sene arabesche, di Guia Buzzi, che si aprono a soffietto, semplici ma stilizzate. La stessa Buzzi è autrice di costumi di altro tratto sartoriale e in stile con l’epoca scelta. Una menzione speciale per Roberto Gritti validissimo e raffinato ideatore delle luci e Lorenzo Curone per le belle proiezioni di spezzoni di vecchi film e vedute di Istanbul.
Sul versante musicale al primo posto dobbiamo mettere il direttore e maestro concertatore Francesco Ommassini. Innanzitutto il direttore ha avuto la geniale soluzione di alzare la buca dell’orchestra, con ciò abbiamo apprezzato un suono più incisivo e molto vicino a quanto era nell’originale del ‘700. Per problemi di spazio alcune percussioni e qualche ottone sono stati collocati nei palchi di prim’ordine di proscenio ma anche in questo caso il calibro era ben rifinito. La sua concertazione è stata molto incisiva e briosa, mantenendo sempre un ritmo molto incalzante e soprattutto teatrale. Abbiamo ammirato in particolare la precisone, la chiarezza di suono e la duttilità dell’interprete d’indiscusso valore. Ovviamente l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta non regge il confronto con quella del Comunale di Bologna, che con qualche imperfezione si colloca su un livello di buona routine ma che potrebbe migliorare nel corso delle recite.
Diversamente il Coro del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, diretto da Francesco Erle, ha fornito prova di ottima professionalità e supera notevolmente il coro utilizzato in precedenti occasioni a Treviso.
Per quanto riguarda il cast vocale, potremo citare il proverbio “Se Atene piange, Sparta non ride”, il quale evidenzia oggigiorno l’immensa difficoltà nel riunire una serie di cantanti adatti alle difficoltà dei ruoli. Se dobbiamo fare un paragone è giusto rilevare che le risorse di Bologna, poiché fondazione, sono ben diverse di quelle di Treviso, il cui teatro giustamente deve trovale delle collaborazioni e coprodurre i propri allestimenti.
Anche in questo caso i migliori sono stati l’Osmin di Manfred Hemm e la Blonde di Daniela Cappiello. Il signor Hemm ha voce di vero basso profondo, sostanzialmente ben amministrata e capace di eseguire la difficile parte con buona resa canora e ottime intenzioni espressive, cui si somma una vivacità teatrale equilibrata e non troppo caricata. La signora Cappiello ha voce squillante e ben amministrata, briosa e con una punta di civetteria adatta al personaggio, forbita nel registro acuto quanto in un gusto canoro cui va solo il plauso.
Ben diverse le note per la coppia principale d’innamorati, Konstanze e Belmonte. Jannette Vecchione-Donatti ha mostrato parecchie lacune tecniche soprattutto nella zona di passaggio e ne registro acuto. Non è dotata di una voce adatta al ruolo, la quale è sovente stridula e la zona grave è piuttosto afona. Martin Piskorski possiede una voce anche rilevante che non è in grado di amministrate cantando sempre sul mezzo forte-forte, poco espressivo e con limiti tecnici, tuttavia è riuscito a portare in fondo la recita.
Di buona professionalità il Pedrillo di Marc Sala, tenore leggero di oneste doti che non ha sfigurato nel suo compito.
Selim Pascià non era interpretato da un attore ma da un cantante di fama come Bruno Praticò. Egli ha messo tutto il suo impegno in una parte di non sua comune frequentazione, ma le doti di recitazione erano un po’ limitate.
Il teatro “Mario Del Monaco” di Treviso era molto gremito di pubblico, una bella visione se paragonata a certe assenze in spettacoli precedenti, il quale ha tributato al termine a tutta la compagnia un caloroso successo.
DON CARLO [Lukas Franceschini] Milano, 1 febbraio 2017.
Ritorna al Teatro alla Scala l’opera Don Carlo di Giuseppe Verdi in nuovo allestimento di Peter Stein, creato al Festival di Salisburgo nel 2013 e recentemente acquistato dal teatro milanese, mettendo probabilmente “in cantina” il precedente spettacolo (2008), non particolarmente entusiasmante, di Stéphane Braunschweig.
Don Carlos, questo il titolo originale, fu composto per l’Opéra di Parigi e rappresentato l’11 marzo 1867, è da considerarsi il capolavoro operistico assoluto di Verdi o da collocarsi nel ristretto elenco del vertice creativo. Sgombriamo subito e sinteticamente un aspetto importante. Tutti i soggetti dell’opera sono personaggi storici realmente esistiti, la vicenda però è stratta dal dramma storico di Schiller, il quale non è fedele agli eventi reali, il romanzo s’ispira alla storia per cerare un racconto molto affascinante. Anche Verdi e librettisti non si sono posti il problema della veridicità storica, perché giustamente hanno trovato più coinvolgente il romanzo per la stesura della drammaturgia.
Sarebbe prolisso elencare le diverse e molteplici versioni e edizioni dell’opera, la quale come predetto fu composta in versione grand-opéra in cinque atti con libretto in francese. La prassi vuole che per le riprese in altri paesi il testo fosse tradotto nella lingua locale. Inoltre, Verdi ritornò sullo spartito con ripensamenti, tagli, riduzioni e rielaborazioni per le diverse riprese in città italiane. L’edizione scelta dal Teatro alla Scala per l’odierna rappresentazione si riferisce alla prima parigina del 1867, nella traduzione ritmica italiana di Achille De Lauzières e Angelo Zanardini e senza balletto del III atto, e si rifà alla prima esecuzione italiana di questa versione rappresentata a Bologna il 27 ottobre 1867.
Lo spettacolo, con la regia di Peter Stein, è soprattutto sviluppato sulla definizione dei personaggi nel loro più intimo animo a scapito del ruolo sociale. L’idea trova soluzioni molto azzeccate affiancate ad altre più banali, e solo quanto c’è la presenza di un cantante-attore di rango le idee del regista trovano significativa espressione. Accade sovente con un Filippo II statuario e corroso dal dubbio, e un’Elisabetta rassegnata. Cito come esempio: la gestualità da manuale di Furlanetto nel monologo e successivo duetto con il Grande Inquisitore, o la scena successiva quando la regina sviene ed Eboli si precipita a soccorrerla ma è prontamente fermata dal re, sarà lui stesso a sollevarle il capo accarezzandolo. L’autodafé mancava di solennità sinistra, ed era discutibile il corteo delle delegazioni delle colonie dell’impero. Di forte impatto drammatico erano invece la scenda del carcere e tutto l’atto V, con rilevante drammaturgia. Il tallone d’Achille dell’allestimento era l’inizio dell’atto II con la scena dello scambio della maschera tra Eboli ed Elisabetta e successivo terzetto, ambientato in un illogico giardino con tendone e piccole passatoie, che invece di rendere cupo e drammatico il momento parafrasavano il farsesco.
Ferdinand Wogerbauer, scenografo, ha mano lieta alterna firmando una pertinente e austera corte all’Escorial, un primo atto “nebbioso” di Fontainebleau, scivolando in altri punti, atto III e gabinetto di Filippo, sempre di maniera ma con poca attendibilità. Bellissimi i costumi d’epoca di Anna Maria Heinreich, cromatici e di forte impatto visivo, pertinenti le luci Joachim Barth.
Moto rilevante la prova di Myung-Whun Chung, maestro concertatore, che sceglie una lettura impostata sul romantico, ponendo l’accento sul dramma intimo dei singoli piuttosto che sulla cornice storica. Una lettura in crescendo, che trova negli ultimi due atti una fusione buca-palcoscenico di ottimo rendimento, non mancando un controllo su colore e dinamiche. Sarebbe stato più consono qualche slancio più accentuato nella canzone del velo e nell’autodafé, ma sono piccoli dettagli. L’orchestra era in piena sintonia con il direttore e in ottima forma, e vorrei sottolineare l’assolo degli ottoni, passo difficilissimo, perfettamente calibrato e meraviglioso. Altrettanto si può affermare per la prestazione del coro, diretto da Bruno Casoni, sempre puntuale e di grande musicalità.
Il cast scritturato per l’occasione era composto di nomi molto celebri, ma con qualche distinguo.
5Francesco Meli, Don Carlo, ha sfoggiato la sua consueta voce squillante e molta bella. Molto convincente nel fraseggio e nell’accento, ha dimostrato qualche lieve problema nel settore acuto, e il suo canto è sempre “aperto” come negli ultimi tempi usa a fare, ma nel complesso una prova positiva.
Di tutt’altra impostazione la prova di Ferruccio Furlanetto, un Filippo II veramente vissuto, variegato nell’interpretazione, austero e altezzoso alternato a momenti di sofferenza e umanità. La voce è sempre importante, anche se dopo anni d’illustre carriera qualche attacco non è sempre pulito, ma l’accento è superbo e l’esecuzione del monologo è stato uno dei momenti più altri della serata.
Note meno positive per Simone Pizzola, Roderigo, il quale mi ha lasciato letteralmente sbigottito nel costatare il ridimensionamento del volume. La voce del cantante era troppo esigua e di difficile ascolto in molti suoi momenti, e la perplessità è resa ancor più evidente nel confronto con sue occasioni nel recente passato. Spero trattasi di caso isolato poiché il giovane baritono è una delle promesse più interessanti di questi ultimi anni. Inoltre, il canto è raffinato, molto curato nel fraseggio e con grandi proprietà d’accento.
Eric Hafvarson, Gande Inquisitore, sostituiva il previsto Orlin Anastassov e nel complesso era accettabile anche se la sua voce risulta oggi piuttosto logora e greve mentre il personaggio è perfettamente riuscito.
L’Elisabetta di Krassimira Stoyanova è interpretata con grande regalità e la voce, dal timbro bellissimo, sempre precisa e usata con grande musicalità e finezza interpretativa. Sicura in tutte zone sia gravi sia acute avrebbe potuto trovare qualche accento interpretativo più vigoroso piuttosto che appoggiarsi a un canto sempre corretto ma insolitamente manierato.
Non convince la principessa Eboli di Ekaterina Semenchuk per caratura vocale che al confronto con la Stoyanova era addirittura più leggera. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un soprano corto e non particolarmente forbito nelle agilità, oltrepassare il campo del mezzosoprano. Dobbiamo riconoscerle un’interpretazione con esiti convincenti ma molto inferiori alle attese quelli vocali.
Brava Theresa Zisser nel ruolo del brillante Tebaldo, molto professionali il Frate di Martin Summer, il Conte di Lerma e araldo di Azer Zada e la voce dal cielo di Céline Mellon.
Una menzione particolare merita il gruppo dei Deputati Fiamminghi, Solisti dell’accademia della Scala, per l’omogeneità espressa nel loro intervento e la raffinata compostezza di esecuzione. In ordine di locandina erano: Gustavo Castillo, Rocco Cavalluzzi, Dongho Kim, Viktor Sporyshev, Paolo Ingrasciotta e Chen Lingjie, quest’ultimo allievo del Conservatorio Verdi.
Unico neo dello spettacolo i troppi intervalli che hanno determinato una durata di oltre cinque ore. Al termine non sono mancati applausi convinti a tutta la compagnia e un’ovazione all’uscita del maestro Chung.
DON CARLO [William Fratti] Milano, 1 febbraio 2017.
L’efficace spettacolo di Peter Stein è ricco di pregi e difetti. I pregi risiedono sicuramente nel lavoro di regia dello stesso Stein, poiché solisti e coristi hanno sempre un movimento caratterizzato, uno sguardo significativo, un gesto ragionato, impreziosito di controscene che rendono l’azione più fluida e coinvolgente. Particolarmente degni di nota sono il duetto di secondo atto tra Carlo ed Elisabetta e il quartetto in quarto atto. L’allestimento minimalista entro cui si articola la regia di Stein è un ambiente ideale, ma poco bello da vedere. Gli ambienti spogli ideati da Ferdinand Wögerbauer sono perfetti in termini di disegno architettonico, ma i materiali usati fanno pensare ad una scenografia low cost. E lo stesso vale per i costumi di Anna Maria Heinreich, validi nello stile – storicamente non precisissimi, ma teatralmente efficaci – che sembrano confezionati con stoffe di basso livello. Pure le luci di Joachim Barth mantengono un importante livello di suggestione, ma non portano mai lo spettatore a concentrarsi emotivamente su di un singolo accadimento.
Altrettanto vale per la direzione di Myung-Whun Chung alla guida dell’Orchestra del Teatro alla Scala – che perde qualche colpo in più di una circostanza durante la serata – che appare elegante e raffinata, molto fluida ed omogenea, ma mai spicca il volo, mai riluce come un diamante ed è un po’ scollata nel terzetto Carlo-Eboli-Rodrigo. Detto ciò, sia Peter Stein, sia Myung-Whun Chung riescono a tenere alto il livello di attenzione per tutte le oltre cinque ore del lungo spettacolo.
Per l’occasione si sceglie la versione in cinque atti, con l’aggiunta – rispetto alla più conosciuta versione Modena – del Coro dei Boscaioli in primo e la scena dello scambio delle maschere in terzo. La locandina recita “Edizione integrale della versione in 5 atti, a cura di U. Günter e L. Petazzoni” ma è un peccato che non si siano ripristinati anche il balletto, l’arioso di Filippo “Chi rende a me quell’uom?” e il Coro conclusivo dell’opera. Poteva essere una buona opportunità culturale, sia di studio, sia di semplice ascolto, magari eliminando una pausa per non prolungarne ulteriormente la durata – considerando che il Teatro alla Scala possiede gli impianti e le tecnologie per effettuare i cambi in pochi minuti – ma soprattutto serbando emotivamente l’intensità del dramma nella sua complessità.
Francesco Meli ha la vocalità perfetta per interpretare il ruolo del protagonista ai massimi livelli, possedendo tinte eroiche e passionali che poggiano su di una base che tende sempre al lirico leggero, tale da non appesantire mai la parte. Ottimi gli slanci, davvero vivi e sentiti. Purtroppo in alcuni punti sembra perdere un poco l’intonazione e ciò è presumibilmente dovuto all’abuso del falsetto perpetrato fino a poco tempo fa. Qui i piani sono emessi correttamente, pertanto il problema dovrebbe essere arginato e risolvibile.
Krassimira Stoyanova possiede una vocalità naturalmente vellutata talmente bella che la sua Elisabetta spicca in ogni momento, elegante e raffinata, con una perfezione tecnica che ha poche eguali. Detto ciò non è chiaro come mai abbia deciso di prediligere la risonanza di petto nelle note basse, quando in passato la si era sentita emettere ottimi suoni misti, mescolando così tale cattivo gusto alla sua classe innata.
Ancora eccellente, nonostante l’età e qualche pecca perdonabilissima, il Filippo II di Ferruccio Furlanetto. Il suo fraseggio non ha paragoni e la sua intensità è vibrante in ogni momento, rendendo un personaggio che difficilmente può essere superato.
Ekaterina Semenchuk non convince nel ruolo di Eboli. La tecnica di canto e l’interpretazione non sono malvagie, ma sembra piuttosto corta in acuto e abbastanza leggera nei centri.
Simone Piazzola è sempre ottimo interprete dotato di buona presenza scenica, linea di canto omogenea, eccellente intonazione e fraseggio ben rifinito, ma la sua voce, come già notato in precedenti performance, appare stimbrata e mal proiettata, tanto da non sentirsi per buona parte dell’opera. Fortunatamente le arie affidate a Rodrigo sono abbastanza scoperte e riesce ad ottenere comunque un buon successo.
Eric Halfvarson è un Grande Inquisitore scenicamente molto efficacie, ma con parecchie difficoltà vocali nelle note più estreme, sia in alto, sia in basso. Martin Summer è un Frate piuttosto approssimativo.
Theresa Zisser è un efficacie Tebaldo, Azer Zeda un Conte di Lerma accettabile, mentre Céline Mellon è una Voce dal cielo poco corretta.
Buona la prova dei deputati fiamminghi ed eccellente quella del Coro preparato dall’intramontabile Bruno Casoni.
PAGLIACCI [Lukas Franceschini] Verona, 2 febbraio 2017.
L’opera breve Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, un prologo e due atti, settanta minuti complessivi, è il secondo titolo proposto dalla Fondazione Arena per la Stagione Lirica al Teatro Filarmonico.
La stagione è iniziata ancora a dicembre con Turandot, dopo due mesi di sospensione e il nuovo sovrintendente. I problemi economici non sono risolti ma si cerca una via che sarà lunga e faticosa, il tutto nell’indifferenza totale della città e della società civile considerando che il corpo di ballo è stato definitivamente liquidato e abolito. Fa più notizia il progetto di copertura dell’anfiteatro sponsorizzato per centoventimila euro da una nota azienda veronese internazionale, senza malafede il finanziamento offre più visibilità commerciale all’azienda che un’utilità vera e la possibile realizzazione.
In tale momento di ristrettezza economica Pagliacci “fa serata”, come si usa dire, senza abbinamento ad altra opera breve. Se non era possibile programmare un dittico, si sarebbe potuto ad esempio eseguire brani sinfonici nella prima parte o altre soluzioni, poiché i biglietti non erano a prezzo ridotto.
Lo spettacolo era quello già presentato a Verona qualche anno fa e firmato da Franco Zeffirelli, regia e scene, il quale soprattutto nella sua ultima parte della carriera ha usato un eccesso di comparse figuranti in tutte le sue creazioni. L’ambientazione è ideale: una periferia degradata di una qualsiasi città di provincia, ma si scontra con il senso della vicenda ambientata in un paesino. Abbiamo pertanto uno schizofrenico inserimento di personaggi che infastidiscono non poco: popolani, bambini, ragazzi, prostitute, travestiti, imbianchini, forze dell’ordine, giocolieri, equilibristi e chi ne ha più ne metta. Decisamente troppo, tanto da creare un senso di smarrimento nello spettatore. L’arrivo della compagnia di circensi-protagonisti assomiglia l’arrivo di un Circo Orfei al massimo splendore, quando invece sarebbero quattro saltimbanchi che girovagano per piazze di terza categoria. Tutto questo toglie in maniera decisiva l’aspetto drammatico dell’opera, che vede il maturo Canio, uomo in fondo buono ma accecato dalla gelosia, che si trasforma in assassino. La ripresa curata da Stefano Trespidi pare abbia calcato ancor più la mano su questi eccessi, e i costumi di Raimonda Caetani contribuiscono non poco a un clima eccessivo e fuori luogo, che nel complesso disturba e distoglie l’attenzione non solo dalla musica. Poche idee drammaturgiche, tanta confusione, uno spettacolo che può benissimo andare in soffitta.
Il direttore Valerio Galli, che ascoltavo per la prima volta, è stata un’interessante e piacevole conoscenza. I tempi sono tenuti su un ottimo equilibrio di sonorità, molto variegato nelle sfumature e nei colori dei quali sa cogliere il netto significato nei diversi momenti dell’opera. Buon concertatore nel tenere assieme la massa corale, solisti e orchestra, la quale risponde in maniera molto puntuale e dimostrando la professionalità che conosciamo. Una bacchetta che mi auguro di risentire presto anche in altri repertori.
Il coro dell’Arena di Verona, istruito da Vito Lombardi, si è ritagliato un particolare successo meritato per precisione e sicurezza, un plauso va anche al coro di Voci bianche A.Li.Ve diretto da Paolo Facincani per l’ottima professionalità e verve teatrale dimostrata.
Molto soddisfacente anche il cast. Rubens Pelizzari ha messo in luce una solida preparazione e abbiamo avuto un Canio molto generoso e interprete, magari con qualche accesa teatralità, la linea vocale è sufficientemente rifinita e supera tutti gli ostacoli con buona musicalità.
Ottima la Nedda di Valeria Sepe, un soprano che oltre la bellissima figura teatrale sfoggia una voce lirica molto rifinita, preziosa nell’accento e nel fraseggio e con un registro acuto rilevante.
Elia Fabbian, Tonio, offre una prestazione molto ben realizzata nelle intenzioni e nell’interpretazione, talvolta tenta di esagerare e potrebbe farne a meno, perché il suo fraseggio è eloquente, anche se in alcuni passi non è sempre preciso.
Molto bravo Alessio Verna, Silvio l’amante di Nedda, particolarmente efficace nel canto lirico, nel duetto d’amore sfoggia sensualità attraverso una voce ben impostata e morbida, con bei colori.
Bravo anche Francesco Pittari, Beppe, molto preciso nella parte e rifinito vocalmente che ha il suo momento glorioso nella celebre serenata del II atto.
Lo spettacolo è molto piaciuto al pubblico, numeroso anche all’ultima recita cui abbiamo assistito, che oltre a gradire tutta la confusione sul palcoscenico ha tributato un caloroso e successo a tutta la compagnia.
FAUST [Renata Fantoni e William Fratti] Firenze, 3 febbraio 2017.
Il celebre spettacolo di David McVicar prodotto a Londra nel 2004 arriva a Firenze rispondendo positivamente alle numerose aspettative, soprattutto perché di questi tempi è difficile assistere in Italia a spettacoli così grandiosi se non in rare eccezioni.
Nonostante l’allestimento sia molto classico e tradizionale, con le scene imponenti di Charles Edwards e i preziosi costumi di Brigitte Reiffenstuel ripresi da Anna Watkins, resta efficacissimo grazie al minuzioso lavoro di regia che prevede movimenti, gesti, sguardi, anche intere azioni da parte dei numerosi attori – cantanti solisti, cori, danzatori e figuranti speciali – in ogni momento della lunga partitura. Eccellenti le coreografie di Michael Keegan-Dolan riprese da Rachel Poirier che fondono classico e contemporaneo in un amalgama perfetto con la musica di Gounod e la visione di McVicar. Più deboli le luci di Paule Constable riprese da John Percox, apparentemente più orientate alla mera illuminazione che non alla creazione di suggestione.
Ottima la direzione di Juraj Valčuha che sa mantenere sempre molto compatta l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, attento al suono e alla raffinatezza del gusto francese, pur non prediligendo colori passionali – se non in quinto atto – tali da far decollare la recita con grande slancio. Eccellente il Coro preparato da Lorenzo Fratini.
Wookyung Kim è un Faust dotato di bella voce squillante dal colore suadente e timbro luminoso, ma spesso impreciso, con qualche acuto scricchiolante – soprattutto negli attesi “Je t’aime” e in quelli di “Demeure chaste et pure” – e qualche perdita d’appoggio – non solo per il cantante, ma anche per gli archi che lo accompagnano alla fine della celebe aria.
Carmela Remigio ridona finalmente il giusto colore al ruolo di Marguerite, troppo spesso affidato a vocalità leggere che fanno perdere l’accento drammatico in quarto e quinto atto, oltre che nella canzone del “Roi de Thulé”, ma non riesce a brillare come si deve nell’aria dei gioielli.
Paul Gay interpreta un ottimo Méphistophélès, soprattutto per il fraseggio ben rifinito oltreché molto intenso. Il canto è altresì molto corretto anche se si sarebbero preferiti certi acuti più luminosi.
Serban Vasile è un Valentin piuttosto efficacie, molto più a suo agio con le tinte drammatiche di atto quarto che non con il lirismo e la lucentezza necessari a rendere al meglio le pagine del secondo.
Laura Verrecchia è un appropriato Siebel, Gabriella Sborgi una buona Marthe e Karl Huml un adeguato Wagner.
Successo strepitoso per tutti al termine dell’ultima recita in cartellone.
IL TROVATORE [Natalia Di Bartolo] Vienna, 5 febbraio 2017.
Ci sono serate in cui un imponderabile quid di energia che non pare cosa di questa terra sembra convogliarsi tutto in un punto del globo. E’ accaduto a Vienna, dove il 5 febbraio 2017 è andato in scena Il Trovatore di Giuseppe Verdi in una nuova produzione del Wiener Staatsoper.
Opera tremenda per difficoltà, per canoni da rispettare, per lo spessore che richiede alle voci, per l’importanza che riveste quale capolavoro nella produzione verdiana, per un miliardo di altri motivi su cui si potrebbero scrivere volumi, Il Trovatore. Ma quando si crea lo stato di grazia, è lì che i capolavori rivivono. A Vienna, è successo questo, in una serata decisamente fuori dall’ordinario.
Basta iniziare dalla direzione d’orchestra del M° Marco Armiliato: la perfezione. Non una sbavatura, non un cedimento, tempi serrati, polso fermo e volitivo, dinamiche italiane a tutto spiano, con una competenza veramente rara e con a disposizione un materiale egregio da plasmare in buca, con l’orchestra del Wiener Staatsoper, e da dirigere e supportare in scena.
Grandiosi il suono, la profondità, lo spessore, il rigore dell’intera esecuzione. Anche il volume: quando si hanno grandi voci sul palcoscenico, ci si può permettere di non frenare. Il tutto da manuale, a Vienna, dove, ultimamente, s’erano sentite direzioni poco attinenti a ciò che veniva eseguito. Una gioia per chi ascolta e per gli interpreti, che hanno goduto di un sostegno di questa potenza e autorevolezza.
E gli interpreti hanno dato il massimo. Un cast da capogiro, da edizione storica: una serata imperdibile per i melomani, gli appassionati ed anche i fans di quattro dei più grandi cantanti al momento sulle scene mondiali.
Il Trovatore, Manrico, di Roberto Alagna è stato, come sempre, un meraviglioso rebus. Come possa una voce di questa limpidezza e qualità lirica impegnarsi nei ruoli eroici e uscirne vittoriosa resta un mistero, attribuibile solo alla grandezza dell’interprete. Per il tenore italo francese, dalla freschezza vocale meravigliosamente cristallina, dopo 30 anni di carriera ancora all’altezza di un Roméo o di un Werther, essere un Manrico autorevole e vincente è di per sé un portento. Il quarto atto, poi, che dà agio alla vocalità di Alagna di dispiegarsi più agevolmente e gli dà modo di dar corpo al personaggio anche scenicamente, è stato un unico brivido. Roberto Alagna sa fare della propria voce ciò che vuole, soprattutto modellarla sui sentimenti, in particolare nei momenti di massima tensione emotiva. È qui che viene fuori tutta la sua maestria: pieno centro non tanto nelle perigliose note della pira, pur risolte egregiamente, bensì in quell’”Infame!” cantato, ma quasi declamato, con un’inflessione che per chi scrive, sua conterranea in terra di Sicilia, risuona anche familiare e fa rabbrividire ancor più, di meraviglia. Chapeau alla professionalità sconfinata di questo magnifico artista.
Passare a parlare di Anna Netrebko, Leonora, vista ed ascoltata accanto ad Alagna negli anni trascorsi in molte produzioni, è un rebus parimenti meraviglioso. Come abbia potuto il celebre soprano trasformare la propria vocalità, scurendola senza appesantirla, anche questo resta un mistero, decisamente glorioso. Magnifici i gravi, che si sente come l’artista stia curando sempre di più, voltasi a repertorio vocalmente più “pesante”; ottima la zona centrale, ma quel che è il meglio è il suo aver mantenuto la zona acuta, con filati raffinatissimi ed acuti di tutto rispetto anche come corposità. Ancora il tutto un po’ da amalgamare, in una vocalità pur sempre in evoluzione, con qualche incertezza nell’intonazione nei momenti in cui l’orchestra non è di sostegno, momenti difficilissimi, trappola infernale per molte Leonore. Per il resto, applausi a non finire, anche a scena aperta. Una potenza vocale, oltretutto, capace d’imporsi senza problemi e che volge a mietere altri allori in ruoli futuri.
Ludovic Tézier Conte di Luna? Una forza della Natura! Imbrigliare quella voce, non propriamente “verdiana”, anche perché adusa ad un repertorio variegato e multilingue, non è cosa facile. Un paio d’inciampi negli accenti letterario/musicali, ma voce grandissima, incontenibile, corposa ed autorevole. Recitazione adeguata, l’imporsi sul palco indiscutibile: grande Conte di Luna!
Azucena, l’esperiente Luciana D’Intino, gran voce anche lei, proiezione che gareggiava adeguatamente con le potenze dei colleghi in scena: gravi profondi e scavati, acuti lievemente stimbrati ma nel complesso raffinata, credibile e scenicamente apprezzabile. Una Azucena di scuola italiana è l’Azucena ideale, di solito. Eccone una, infatti.
Solitamente si parla poco di Ferrando, ma Jongmin Park, merita una menzione, così come la Ines di Simina Ivan. Adeguati gli altri interpreti. Allo stesso modo, il Coro del teatro austriaco ha brillato, sia pure dopo qualche esitazione al primo atto. Non è la prima volta che negli ultimi tempi lo si sente tendere a qualche fuori tempo e ci si augura che si tratti solo di intralci momentanei.
La messa in scena del regista Daniele Abbado trasponeva l’azione negli anni ’30 del secolo scorso, in una Spagna franchista di militari e partigiani. Déjà vu, in verità: non si sa (o, meglio, forse si immagina) perché quest’epoca ispiri tanto i registi di qualsivoglia opera, non solo di quella in questione. Ad ogni modo, le pistole non giovano a Il Trovatore, che è di sua natura epico e cavalleresco.
Però ben venga, comunque, una buona regia, animata, assai ben curata, contenuta nella ricca e articolata scenografia di Graziano Gregori, ravvivata dai costumi di Carla Teti e illuminata dalle luci di Alessandro Carletti.
I dissensi del pubblico agli applausi finali non erano del tutto giustificati, visto che non si compivano eccessi o stranezze particolari. Anzi, il complesso dei movimenti scenici dei ribelli, dei militari, delle suore era ben studiato e molto ben seguito ed il posizionarsi degli interpreti a favore d’acustica era particolarmente accurato, perfino nel far cantare di spalle la Netrebko senza problemi, grazie agli accorgimenti previsti dalla scenografia.
Applausi finali da mandare in tilt gli orologi, oltre che le orecchie e le mani degli spettatori plaudenti e dei fans candidati all’afonia dopo le grida. Scandito e pienamente meritato un “bravissimo!” a Tézier, di suo già superlativo.
Una serata che è stata una vera gioia per le orecchie, per gli occhi, ma soprattutto per l’anima, all’altezza delle grandi produzioni che hanno sempre caratterizzato il meraviglioso teatro austriaco.
ATTILA [Natalia Di Bartolo] Modena, 7 febbraio 2017.
Attila di Giuseppe Verdi è un’opera spesso considerata “minore”, poco rappresentata e un po’ trascurata. I melomani peppiniani si chiedono il perché, i critici e gli storici forniscono le più variegate risposte. Ovviamente me lo sono chiesto anch’io, che sono una melomane peppiniana a tutti gli effetti.
Ascoltando l’opera a Modena, andata in scena al teatro Comunale Pavarotti il 2, il 5 e il 7 febbraio 2017, mi sono data una risposta personale: perché di Attila veramente grandi ce ne sono stati e ce ne sono pochi. La parte di Attila contiene momenti di virtuosismo per un protagonista che ha la vocalità del basso; momenti che pretendono l’assoluta padronanza del palcoscenico, non solo della propria voce.
A Modena Attila era Carlo Colombara. Avevo già ascoltato, recensito e intervistato proprio lui a Catania per la stessa opera, nel dicembre 2014, e l’ho trovato assolutamente grande anche nella città emiliana. La voce brunita, la precisione dell’esecuzione, il fraseggio mirabile, la chiarezza della dizione, la potenza e la correttezza dell’emissione fanno, a mio parere e non solo, di Carlo Colombara il miglior Attila sulle scene di oggi.
La fisicità, inoltre, conta, in quest’opera e al Colombara, trent’anni di carriera da festeggiare quest’anno, non mancano la presenza scenica e il portamento regale, che applica ai suoi personaggi, i quali, per forza di cose, si trovano ad essere spesso dei re o degli imperatori, come il suo amatissimo Filippo II dal Don Carlo e il suo zar Boris Godunov, ultimamente debuttato a Varna con grande successo.
Tornando alla messa in scena modenese, è d’obbligo passare in rassegna le altre voci e dunque veniamo ad un punto specifico in cui il melomane peppiniano s’impunta ascoltando l’Attila: il baritono Ezio e i suoi staccati; li aspetta al varco ancor più di quelli di Attila stesso. E se Ezio non li esegue, il melomane ne esce malissimo: è una questione di principio (ed anche di avere nelle orecchie l’esecuzione storica Ramey-Zancanaro-Muti alla Scala, 1991, che come termine di paragone farebbe tremare le ginocchia a chiunque).
Il baritono in scena deve essere un gigante anch’egli, come Attila. A parte aria e cabaletta che Verdi gli ha affibbiato, Ezio ha a che fare con un re barbaro, a cui l’autore ha affidato una parte vocalmente molto incisiva e potente ed il baritono è quasi costretto a gareggiare con il basso o rischia di esserne coperto e annientato.
Accostare ad un grande Attila una voce baritonale degna è un obbligo. E a Modena il baritono Vladimir Stoyanov ha dato il meglio. A parte l’emissione e la proiezione notevoli entrambe, quanto agli staccati di cui sopra, lo Stoyanov ha avuto la correttezza di eseguirli tutti. Dunque lode anche a lui. Mica facile, poi, tener testa a Carlo Colombara, che, a sua volta i propri staccati non li esegue soltanto, li cesella!
Dunque la qui presente melomane peppiniana a Modena è rimasta soddisfattissima: il duetto Attila-Ezio ha funzionato come un orologio. Gli staccati c’erano tutti, la potenza e l’amalgama delle due voci altrettanto.
La Odabella di Svetlana Kasyan, invece, era acerba ancora, in questa parte, necessitava di una maggiore precisione nelle agilità, di un fraseggio più accurato, di maggiore cura nei passaggi, di una messa a punto vocale complessiva del personaggio, nonostante la bella presenza scenica.
Foresto, Sergio Escobar, a sua volta, voce potenzialmente molto valida, soffriva di qualche problema d’appoggio e non solo, nonostante la fisicità imponente.
Corretti gli altri interpreti e il coro, diretto da Stefano Colò.
Il tutto sotto la bacchetta del M° Aldo Sisillo, alla guida dell’Orchestra dell’Opera italiana, il quale, sinceramente, avrebbe dovuto aggiungere un po’ di propellente al proprio entusiasmo verdiano e soprattutto infondere maggiore energia agli orchestrali. Tempi lasciati un po’ a se stessi, con qualche decelerazione, dinamiche da approfondire, ma nel complesso un buon sostegno per i grossi calibri sul palcoscenico, che affrontavano, tra l’altro, l’edizione integrale dell’opera, priva di tagli.
Gradevole la messa in scena di Enrico Stinchelli, che ha curato forse più il versante “romano” che quello “barbaro”, ma che ha ottenuto momenti godibili anche dal punto di vista visivo, con le proprie luci e con le scene e i costumi di Pier Paolo Bisleri dell’allestimento della Fondazione del teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste, nonché usufruendo di alcune suggestive proiezioni.
Da questa produzione della Fondazione del teatro Comunale di Modena verrà tratto un CD e il melomane peppiniano attende di riascoltare l’opera in registrazione… I famosi staccati, ovviamente, prima di tutto.
IL BARBIERE DI SIVIGLIA [Mauro Bonato] Trieste, 10 febbraio 2017.
Al teatro Verdi di Trieste successo per l’opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Grandi applausi per il “barbiere” più famoso del mondo. È andata in scena la prima del “Barbiere di Siviglia” con lunghi applausi da parte del pubblico e tra gli interpreti, Figaro ha saputo convincere in maniera piena e ricevere lunghe ovazioni. Il buon livello del cast ha come da copione rispettato il successo di pubblico, previsto e annunciato per l’opera buffa, la quale normalmente riempie ogni teatro. Anche a Trieste l’opera ha incontrato un’indiscussa approvazione, comprovata dai lunghi applausi a scena aperta e dalla calorosa approvazione a fine spettacolo.
Il Figaro, Mario Cassi, un basso coinvolgente ha saputo conquistarsi il pubblico fin dall’inizio. Nella cavatina “Largo al factotum” ha raccolto lunghi applausi per la bravura nella sua interpretazione. Sul palcoscenico, Mario Cassi con la sua voce chiara e con il suo elegante fraseggio, ha saputo emozionare, non solo come da copione e per il ruolo di Figaro, ma per essersi calato nella parte in maniera eccellente, anche nel più importante palcoscenico triestino.
La maliziosa Rosina interpretata da Aya Wakizono, al suo debutto a Verdi di Trieste, è stata convincente. Con la sua interpretazione ha dimostrato di avere un talento ottimale per il repertorio rossiniano. La Wakizono con la sua perfetta “tecnica italiana” e grazie alla sua agilità canora, dopo aver conquistato il pubblico di molti teatri italiani, ha saputo coinvolgere in maniera appassionante anche la platea tergestina.
Giorgio Giuseppini, è stato applaudito calorosamente nella sua interpretazione quasi perfetta del subdolo Basilio. Nel suo personaggio divertente, è doveroso rilevare come sia intervenuto in maniera eccellente ne “La calunnia è un venticello”. Ha saputo interpretare in modo pieno il suo ruolo nell’universo rossiniano.
Domenico Balzani che interpretava il Don Bartolo, con una voce piena ha saputo conquistare il pubblico specie nell’aria “A un dottor della mia sorte”.
Il tenore Giorgio Misseri nel ruolo non facile del Conte d’Almaviva, ha convinto il pubblico, in un crescendo che ha saputo conquistarsi gli applausi soprattutto nel secondo atto dell’opera. Forse la sua giovane età non gli ha consentito una brillante interpretazione nel primo atto. E a questo ha saputo porre rimedio in modo soddisfacente con le arie del secondo atto. Si può dire che dopo una partenza lenta ha ben saputo riprendersi la scena.
È stata apprezzata dal pubblico, la scelta della regia di Giulio Ciabatti e delle scene di Aurelio Barbato, di non cedere a tentazioni moderniste, presentando un allestimento classico. La scelta tradizionale ha dato al “barbiere”, una naturalezza che l’ha resa viva e fruibile. Gli scorci di Siviglia hanno dato il senso della grandezza, con un’accentuazione anche dei piccoli dettagli. Allestimento che era già stato apprezzato, nell’estate del 2016, anche sul palcoscenico di Dubai proprio grazie al teatro lirico del Verdi.
Qualche appunto si deve fare al maestro Francesco Quadrocchi, che non sempre ha saputo dimostrare appieno quell’energia che Gioacchino Rossini voleva per una delle sue più famose opere. Forse si potrebbe parlare di una sorta di debolezza nei crescenti rossiniani; ma in complesso la sua direzione è stata buona.
FALSTAFF [Lukas Franceschini] Milano, 15 febbraio 2017.
Un nuovo Falstaff, ultima opera di Giuseppe Verdi, è allestito alla Scala quale terzo titolo della stagione 2016-2017.
L’allestimento proviene da Salisburgo (2013) e fu acquistato “in saldo” dalla Scala assieme ad altri spettacoli, Don Carlo già rappresentato e i prossimi Maestri Cantori. L’unica domanda e senza polemica è: che fine ha fatto il recente spettacolo di Robert Carsen, coproduzione Scala? Oltre ad essere un allestimento bellissimo, che pubblico e critica hanno lodato e applaudito, sarebbe un gran peccato non poterlo rivedere, anche se nella sala del Piermarini è già stato rappresentato in due edizioni.
Il Falstaff visto e ascoltato oggi si avvale della regia di Damiano Michieletto, le scene di Paolo Fantin e i costumi di Carla Teti, nuovi e più attuali rispetto a Salisburgo (così dicono i meglio informati). La concezione del regista è decadente, infatti, in questo Falstaff si sogna tornando indietro nel tempo, quando il protagonista, oggi ospite della dimora di riposo “Casa Verdi”, era in carriera e trionfava sui palcoscenici. Un ritorno alla giovinezza. Idea originale e bella, che trova spazio in un Verdi sempre presente, dal quadro appeso alle pareti, ai brani suonati al pianoforte all’inizio dell’opera, nello squarcio di vita quotidiana dentro la casa di riposo. Il protagonista è disegnato in maniera infantile, un vecchio buono e sognatore che passa le giornate sul divano sorseggiando vino e sfogliando l’album dei ricordi. Tutti gli altri personaggi entrano dalla finestra come dei folletti che ruotano intorno a lui, e ripercorrono o pagine vissute o giocano nel sogno idilliaco ma amaro. Qualche scena è veramente azzeccata. Quando Falstaff dice “Vado a farmi bello” porta in scena un vecchio baule con dentro i suoi costumi, è solo attraverso il passato, la giovinezza che trova il senso del piacere, oggi monotono e senza stimoli. Oppure, quanto intona la cantilena “…tutto declina… Va’ vecchio John…” ha in mano il celebre ritratto di Verdi staccato dalla parete. Non meno suggestive alcune scene del “sogno”, cioè l’opera stessa, che si fonde con la vita quotidiana della casa di riposo. Commuovente che durante il duetto Fenton-Nannetta, si renda concreto visivamente la stessa scena tra due anziani innamorati. Un limite di questo spettacolo è dover immaginare quello che non c’è, il parco di Windsor, la taverna, la caduta nel Tamigi, è una molteplice situazione di citazioni che si addice poco quando è il teatro a porre la marcia. Non ultima il video sulla fuga finale, mi è parso disturbasse un momento musicale elevatissimo. Aspetti anche opinabili, ma sicuramente Michieletto con questo Falstaff si riscatta enormemente dal più discutibile Un ballo in maschera di qualche anno fa. Elegante, precisa e minuziosa alla perfezione la scena di Paolo Fantin, elegante e rifiniti i costumi di Carla Teti, affascinanti le luci di Alessandro Carletti, bellissimi i video di Roland Howart.
Chi trionfa e sorprende in questa produzione è il maestro Zubin Mehta. Le sue ultime salite sul podio, specie a Firenze, furono contraddistinte da una sommaria routine e rilassata concertazione. Qui alla Scala abbiamo ritrovato il Mehta dei vecchi tempi, autorevolissimo direttore, raffinato interprete, magnifico coordinatore. Coadiuvato da un’orchestra in splendida forma, anche se ridotta nell’organico, esegue una lettura elegante, ricca di colori e sfaccettature armoniche, ma sempre con attenzione alla sobrietà degli accenti, e senza mai eccedere in smisurati eccessi. Un effetto quasi cameristico, un Falstaff da salotto, una delizia.
Il protagonista era Ambrogio Maestri, il Falstaff per antonomasia degli ultimi tre lustri, che qui ritroviamo ancora istrione e sfaccettato nell’interpretazione, quasi da manuale con l’aggiunta del physique du rôle, ma meno efficace nel canto che stranamente era spento, poco ricercato nel colore e sovente risolto con il parlato.
Più valente il Ford di Massimo Cavalletti, rifinito nel fraseggio ed espresso con voce intensa e ben amministrata. Francesco Demuro, Fenton, evidenziava lacune tecniche che determinavano un’esibizione precaria e sfuocata, pur avendo a disposizione una voce rilevante.
Nel settore femminile primeggiava Yvonne Naef, una Mrs. Quickly dirompente e simpatica mai sopra le righe, assieme alla Nannetta di Giulia Semenzato, cantante molto diligente musicalmente ma senza particolari abbandoni vocali. Carmen Giannattasio, Mrs. Alice Ford, è ottima interprete, anche se la voce manca di peculiare spessore, molto professionale la Meg di Annalisa Stroppa.
Ottime le altri parti, a cominciare da Gabriele Sagona e Francesco Castoro, rispettivamente Pistola e Bardolfo, che si distinguevano per un ottimo equilibrio interpretativo e vocale, e infine, ma non ultimo, lo strepitoso Dott. Cajus di Carlo Bosi, il quale forniva eccellente caratterizzazione scenica e vocale, limpida e precisa, di un personaggio irresistibile e in questo caso onorato con gloria. Nell’insieme è doveroso rilevare che tutto il cast era particolarmente ispirato dal disegno registico fornendo un’ottima resa teatrale.
Bravissimo il Coro del teatro alla Scala diretto da Bruno Casoni.
Pubblico non particolarmente vivace negli applausi, tolto una sincera accoglienza al termine per il M° Mehta, ma attento e compiaciuto nell’insieme per tributare un convinto successo alla produzione.
LA WALLY [William Fratti] Piacenza, 17 febbraio 2017.
Dopo il successo dello scorso anno con la produzione de L’amico Fritz nell’ambito del progetto di formazione guidato da Leo Nucci, anche il questa stagione il Teatro Municipale di Piacenza propone un titolo poco rappresentato di quel periodo culturale che generalmente, anche se non sempre a proposito, viene identificato col movimento del verismo.
La Wally di Alfredo Catalani manca dai cartelloni italiani da troppo tempo e il direttore artistico Cristina Ferrari, capitanando una coproduzione che vede coinvolti i teatri di Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Lucca, riesce a mettere insieme una squadra di professionisti di ottimo livello, inserendo anche alcuni nomi dei più importanti panorami internazionali.
Nicola Berloffa crea uno spettacolo molto piacevole e pure particolarmente efficacie, dove c’è sempre azione e movimento, riuscendo a rendere ottimamente anche certi difficili passaggi come la caduta di Hagenbach nel burrone, la calata di Wally con la corda e la valanga. Purtroppo ci sono anche alcuni momenti deludenti, come la taverna di Afra troppo piccola per fare danzare tutti, i protagonisti che non muovono un solo passo di valzer e poi si scambiano un vistoso bacio finto, il continuo lancio di sciarpe e altri abiti tra terzo e quarto atto. A parte ciò la resa complessiva è davvero buona, impreziosita dalle scene funzionali di Fabio Cherstich e dai bei costumi di Valeria Donata Bettella. Pure le luci di Marco Giusti sono efficaci, anche se si sarebbe preferito qualche effetto più marcato al momento della valanga finale.
Francesco Ivan Ciampa si immerge nella difficile partitura di Catalani sortendone una direzione molto lineare, sempre omogenea, sempre al servizio del canto e dei sentimenti voluti dal compositore attraverso una scelta adeguata di fraseggi e sfumature. Molto buona la prova degli archi dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, mentre è piuttosto mediocre quella dei fiati. Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati si riconferma eccellente.
Saioa Hernandez è un’ottima protagonista, ben centrata nel personaggio e vocalmente molto sicura, dotata di un timbro morbido e pastoso tipicamente lirico, che riesce a piegare lungo le insidie della parte. Gradevoli anche le note basse, che pur risuonando di petto non ne modificano il colore, ma forse ne abusa un po’ troppo durante la recita, poiché nell’ultimo atto gli acuti non sono particolarmente eccezionali. Hernandez è anche piuttosto parca nell’uso del legato, che invece avrebbe potuto impreziosire e raffinare la performance, come pure una certa avidità di sfumature, presentando un canto molto simile anche nei vari cambi di stato d’animo. Detto ciò la prestazione complessiva è di alto livello e sarà certamente un piacere poterla riascoltare.
Zoran Todorovich porta a casa il ruolo di Hagenbach con i suoi pregi e difetti. Il tenore è indubbiamente dotato di buono squillo, ma che talvolta appare spinto e forzato. Qualche nota calante qua e là non va fortunatamente a precludere l’esecuzione. Inoltre si sarebbe preferita qualche tinta romantica in più nel quarto atto.
Claudio Sgura è un Gellner davvero eccellente e si riafferma, per l’ennesima volta, interprete di riferimento per questo genere di ruoli. È sempre omogeneo, dal pianissimo al fortissimo, dalla nota più grave a quella più acuta, con un suono chiaro e ben impostato in maschera, arricchito di tinte drammatiche mai eccessive e di un fraseggio molto ben rifinito. Il duetto con Stromminger e quelli con Wally sono indubbiamente le pagine migliori della serata.
Altrettanto magnifica è Serena Gamberoni nei panni di un Walter di extra lusso. Il ruolo lirico leggero le calza a pennello, tanto da far traboccare di validissimi cromatismi l’aria di apertura, mantenendo sempre in primo piano un suono limpido e cristallino.
Molto bene anche per Giovanni Battista Parodi che si cimenta nella breve ma complessa parte del vecchio Stromminger. Efficacissima l’Afra di Carlotta Vichi. Ben riuscito il Pedone di Mattia Denti.
Grandissimo e meritatissimo successo per tutti. E già si vocifera nei corridoi che la prossima stagione vedrà risorgere un altro titolo molto interessante.
KÁT’A KABANOVÁ [William Fratti] Torino, 21 febbraio 2017.
Il progetto Janáček-Carsen è indubbiamente uno dei più interessanti programmi di cartellone messi in atto negli ultimi anni, permettendo al pubblico italiano di assistere a più capolavori del grandissimo compositore ceco, soprattutto attraverso un’unica chiave stilistica. Il lungo catalogo dell’opera contiene migliaia e migliaia di titoli e accanto al grande repertorio, quando i dirigenti scelgono di proporre un diverso tipo di offerta, dovrebbero seguire l’esempio e farlo attraverso progetti, fili conduttori, che portino spettacolo e cultura contestualizzata e non perla sporadica.
Originariamente creato per l’Opera di Anversa, poi rappresentato anche alla Scala di Milano, l’allestimento altamente suggestivo di Kát’a Kabanová approda sul palcoscenico di Torino incantando letteralmente tutti gli spettatori. Il lento scorrere dell’immenso Volga lo si percepisce chiaramente nella musica di Janáček, qui ulteriormente sottolineato, forse addirittura amplificato da Robert Carsen che sceglie di rappresentare tutta la vicenda sull’acqua, usando solo alcune passerelle per creare gli ambienti. Il lavoro di regia, qui ripreso da Maria Lamont, giocato su sguardi e piccoli gesti è davvero toccante, preciso nota per nota, come un orologio svizzero. Suggestivi oltre ogni misura sono anche gli effetti luci disegnati dallo stesso Carsen e da Peter Van Praet. Efficacissimi i costumi di Patrick Kinmonth coi quali contribuisce ulteriormente a dipingere la società provinciale in cui Kát’a si sente eccessivamente costretta e imprigionata. Davvero lodevoli le numerose ballerine, con la coreografia di Philippe Giraudeau, che a tratti sembrano rappresentare l’anima del fiume, a momenti paiono suggerire lo spirito di tante altre donne che hanno vissuto il medesimo destino della protagonista.
Eccellente la direzione di Marco Angius che, oltre alla precisione, alla puntualità, alla purezza del suono dell’Orchestra del Teatro Regio, sembra possedere l’anima del compositore, riuscendo a trasmettere una miriade di cromatismi attraverso cui scaturisce l’angosciosa vicenda della povera Kát’a, interpretata dalla bravissima Andrea Dankova.
Il soprano slovacco è una specialista del ruolo e lo si nota chiaramente in ogni sfaccettatura dell’interpretazione. Già applaudita in Italia in Jenůfa a Bologna e Palermo, anche a Torino riceve un meritatissimo successo personale, poiché oltre alla sicurezza vocale, riesce a portare in scena tutte le emozioni che sovrastano e poi travolgono la protagonista.
È affiancata da una bravissima Lena Belkina, Varvara, sognatrice limpida e innocente, e da una malvagia Rebecca de Pont Davies, Kabanicha, che si sarebbe preferita più drammatica da un punto di vista puramente vocale.
Molto buona la resa dei tenori, a partire dal rassegnato Tichon di Štefan Margita, seguito dal sognatore Boris di Misha Didyk e dal candido e semplice Kudrjáš di Enrico Casari. Ottimo anche Oliver Zwarg nei panni del burbero Dikoj.
Efficenti anche le parti di contorno: Lukáš Zeman è Kuligin, Lorena Scarlata è Gláša, Sofia Koberidze è Fekluša, Roberta Garelli è una donna tra la folla. Benissimo anche il piccolo intervento del Coro diretto da Claudio Fenoglio.
Successo sentito per tutti gli artisti, in particolar modo per Dankova e Angius.
I CAPULETI E I MONTECCHI [Lukas Franceschini] Verona, 21 febbraio 2017.
E’ stata riproposta al Teatro Filarmonico l’opera I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini nell’allestimento ideato da Arnaud Bernard, a suo tempo coprodotto con il Teatro La Fenice di Venezia.
L’opera non è tra le maggiori del compositore catanese, ed è superfluo insistere sui motivi, i quali non sono nella musica, peraltro molto bella, semmai su uno sgangherato libretto di Romani, il quale si rifà alla tragedia shakespeariana in modo molto superfluo e riducendo al minimo i personaggi. La mano romantica di Bellini colma molte lacune, soprattutto per l’utilizzo del coro, cha ha parte rilevante, e il canto espresso in lunghe melodie accompagnate spesso da strumenti a legno, di candida e melanconica espressione musicale. Il ruolo di Romeo en travesti è la singolare invenzione de I Capuleti, Bellini con tale scelta volle avvicinare il destino dei due amanti nel somigliante, per non dire identico, timbro e registro, coniugando una candida esperienza la tragica passione adolescente e sincerità di sentimenti, oltrepassando il limite storico di violente battaglie e interessi famigliari.
Come ebbi occasione di scrivere per le recite precedenti sia veneziane sia veronesi, lo spettacolo non è sicuramente dei più funzionali e rasenta spesso la noia. L’idea di ambientare la vicenda in un museo in allestimento e ispirarsi alle storiche pitture per creare la scena, in tableaux vivant è idea ormai obsoleta e logora. Tuttavia, con alcuni accorgimento poteva anche starci, mancava piuttosto uno sviluppo drammaturgico più ricercato e graffiante sui personaggi, i quali erano molto stereotipati nell’attendibilità e nell’espressione. Infastidiva invece l’andirivieni di tecnici, operai, personale delle pulizie in continuo muoversi durante le pause canore, come se la musica non fosse sufficiente a creare un’atmosfera, quando invece i lunghi preludi di Bellini esprimono una bellezza abbagliante, e inoltre il gesto scenico era di una banalità dozzinale.
Bellissimi i costumi di Carla Ricotti, in stile con la tragedia del bardo piuttosto che con le vicende locali, ma ripeto di gran classe. Le scene di Alessandro Camera sono funzionali e molto suggestive, ma non utilizzate al meglio poiché viste solo come fondo. Un po’ urtante l’utilizzo multiplo di un sipario scorrevole per il cambio scena, che poteva essere sviluppato con altre soluzioni.
Il direttore Fabrizio Maria Carminati si è impegnato in una direzione sicura e molto calibrata, particolarmente attento alle dinamiche e ai colori, accompagnando i solisti con esperta mano narrativa e un senso drammaturgico a effetto, anche se in taluni momenti ha preferito una lettura molto cesellata ma lenta.
Nella compagnia di canto svetta sicuramente Alessia Nadin, la quale ci offre un giovane Romeo di baldanzosa e animata irruenza, accomunato con un canto molto controllato e rifinito attraverso una voce equilibrata in tutti i registri, morbida, appassionata, stilisticamente agguerrita e con buona tecnica. Un ruolo che dovrebbe in futuro aprire ulteriori spazi alla brava cantante friulana.
Brava anche Rosanna Savoia, Giulietta, dalla voce cristallina e contenuta nel volume ma capace di ottimo fraseggio e intensità espressiva, puntuale nel settore acuto e di estrema musicalità.
Molto brillante la prova di Matteo Falcier, Tebaldo, artista che non conoscevo ma ascoltato in un concerto recentemente. Il tenore veneto ha messo in luce una voce molto preziosa, ben amministrata, sicuro nel registro acuto e buona scansione di colori.
Altrettanto lodevole il Lorenzo di Romano Dal Zovo, il basso veronese passo dopo passo ha intrapreso una carriera che porterà frutti rilevanti nel prossimo futuro. La sua performance al Filarmonico ha evidenziato un mezzo vocale molto prezioso, di bellissimo timbro e fraseggio ammirevole.
Meno significativo il Capellio di Luiz-Ottavio Faria, segnato da una ruvidità vocale e un timbro sovente nasale.
Ottima la prova del Coro della Fondazione Arena, diretto da Vito Lombardi.
Serata particolarmente felice musicalmente, la quale al termine è stata premiata da un sentito e partecipe successo da parte del numeroso pubblico che gremiva il Teatro Filarmonico.
NORMA [Natalia Di Bartolo] Palermo, 22 febbraio 2017.
I miti dell’opera devono rimanere tali. Soprattutto se ancora in carriera. Ci sono miti come quello di Mariella Devia, che escono sempre vincenti da ogni sfida. Le qualità della sua voce, la limpidezza, la tecnica sopraffina, le capacità d’emissione e di proiezione sembrano essere rimaste intatte fino ad oggi. Oggi che il grande soprano ha superato da tempo le sessanta primavere. Dunque, sia lode a chi, come Mariella Devia, possedendo uno strumento unico, abbia saputo conservarlo con tanta perizia nel tempo.
I miti dell’opera devono rimanere tali. Soprattutto se ancora in carriera. Ci sono miti come quello di Mariella Devia, che escono sempre vincenti da ogni sfida. Le qualità della sua voce, la limpidezza, la tecnica sopraffina, le capacità d’emissione e di proiezione sembrano essere rimaste intatte fino ad oggi. Oggi che il grande soprano ha superato da tempo le sessanta primavere. Dunque, sia lode a chi, come Mariella Devia, possedendo uno strumento unico, abbia saputo conservarlo con tanta perizia nel tempo. È ovvio, però, che un segreto in questa longevità ci deve essere per forza. Lo strumento voce è delicatissimo e bisogna saperlo usare, fin dall’inizio. L’uso accorto e cosciente dei propri mezzi, la capacità di non forzare mai, di cantare sul fiato e non di fibra e molto, molto altro, che non si sta qui a sottolineare, aiutano a conservare nel tempo la freschezza di una voce. Ma quel che conta moltissimo è anche il repertorio. E infatti, nel caso della nostra diva, la capacità di non strafare, di contenere la qualità ed il numero dei ruoli affrontati in tutto l’arco della carriera, la prudenza, l’intelligenza vocale hanno vinto.
Ed ecco, dunque, da qualche anno, che Mariella Devia può permettersi di essere anche Norma di Vincenzo Bellini. A Palermo, il 22 febbraio 2017 una grande Casta Diva ha risuonato tra i velluti storici del Teatro Massimo: un capolavoro. La finezza, gli attacchi, la delicatezza, le sfaccettature, la coscienza assoluta delle proprie capacità e dei propri limiti, hanno fatto della sua cavatina un gioiello di cui fregiarsi oggi e sempre.
Si parla della celeberrima Casta Diva, però. E Norma non è solo quella. Questo è un punto nodale: molti identificano Norma solo con questa cavatina al primo atto. Ma ci sono ore di canto, dopo Casta diva. E qui le cantanti hanno spesso vita difficile. L’ascoltatore, però, spesso soggiace al fascino del personaggio ed alla sua fama e, nel caso di Casta Diva a Palermo, non rileva che, se il brano celeberrimo può aver suscitato corale entusiasmo, ci sono stati momenti in cui tale entusiasmo ha corso il rischio di essere prossimo a spegnersi. Perfino per una grandissima come la Devia, infatti, qualche ostacolo si frappone tra l’intenzione e la perfezione. Ci sono frasi musicali nella zona grave in questa parte che per determinate vocalità sono pressoché impossibili. La Devia le ha affrontate e superate esclusivamente con la tecnica. Ora, se valga la pena di esporsi in un ruolo del genere facendo appello fino in fondo solo alle capacità tecniche è evidentemente un quesito a cui il celebre soprano stesso, con la propria performance palermitana, ha risposto. E certamente avrà tenuto conto come nell’insieme entrino in gioco altre componenti: la presenza di colleghi non adatti al ruolo, per esempio, può pregiudicare intere parti dell’opera.
Infatti sempre qui si cade, purtroppo, sull’inconsistenza della Adalgisa di Carmela Remigio, una sorta di contadinella svolazzante ed inespressiva, dalla vocalità discutibile, accanto ad una colonna del bel canto…Colonna che, però, a sua volta, nei duetti, avrebbe necessitato di avere a fianco ben altra colonna sopranile.
Non ci si può sottrarre, a questo punto, dal rilevare come sembrava a momenti di assistere non ai duetti Norma Adalgisa, ma ad inediti duetti Giulietta Capuleti-Amina. La Devia appoggiava la Remigio più vocalmente che scenicamente e la Remigio avrebbe avuto bisogno di entrambe gli appoggi; a sua volta non forniva alla Devia lo spunto per forzare un tantino in quel pathos un po’ violento, anche scenico, che è insito nel capolavoro belliniano e che la grande cantante a tratti non ha colto.
Ma dov’era la regia in questi momenti? Più che far avvolgere e svolgere lacci ad entrambe, i registi Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi non hanno saputo fare. Una sorta di danza nel duetto. Anche le dive vanno dirette in palcoscenico e non solo dal punto di vista “coreografico”.
Così come è accaduto che Norma, la quale in questa produzione si volge ad uccidere i figli soffocandoli con una fascia di stoffa, poi si trovasse, nella scena decima del secondo atto, in contraddizione diretta col Romani alla frase: “Non sai tu che ai figli in core/questo ferro…/(…) /Sì, sovr’essi alzai la punta…/Vedi… vedi… a che son giunta!…/Non ferii, ma tosto… adesso/ consumar poss’io l’eccesso…”. Quale ferro?
I registi hanno letto il libretto? O hanno pensato un po’ troppo ai riti ancestrali della Sardegna evocati da Maria Lai, con le sue fate ed i riti sciamanici ad esse collegati? Troppo insistito il tema di questi lacci, all’interno delle scene chiassose e volutamente “evento artistico” di Federica Parolini nel nuovo allestimento del Teatro Massimo in coproduzione con Arena Sferisterio di Macerata, e i costumi apprezzabili di Daniela Cernigliaro. Il tutto sotto le luci suggestive di Luigi Biondi.
Onde per cui, se i registi non dirigevano a dovere la Devia, a maggior ragione ci si sarebbe aspettati che non dirigessero John Osborn, Pollione. E, invece, lo dirigevano anche troppo, facendo del proconsole di Roma nelle Gallie una specie di primate che s’arrampicava, che si volgeva all’amico Flavio, l’ottimo Manuel Pierattelli, con atteggiamenti da nonnismo, e che era costretto ad emettere i sovracuti, di cui è lodevolmente dotato, dall’alto di un trespolo di pali dalla dubbia connotazione, data l’assenza in scena sia della quercia druidica che dello scudo d’Irminsul.
Oroveso, Luca Tittoto, dalla vocalità tutta da valorizzare, gli altri interpreti, il Coro, diretto da Piero Monti, erano soggiogati dall’andazzo complessivo. Il Coro, nella fattispecie, a volte ridotto a movenze primitive, era pure costretto a dare fondo alle proprie capacità vocali di legato/portamento, fatto salvo, per fortuna, almeno il celeberrimo “Guerra, Guerra!”.
Su tutti, infatti, imperava il M° Gabriele Ferro e l’ottima orchestra del teatro palermitano era costretta a tempi di tale lentezza, che lo stesso mito d’oltreoceano negli anni ’70 del secolo scorso forse non avrebbe osato raggiungere per favorire le coniugali corde.
E se i tempi si ritrovavano ad essere stirati fino allo sfinimento come i lacci sulla scena, le dinamiche erano uniformate ad una triste piattezza in sordina, certamente messa in atto anche per non coprire il palcoscenico: il Maestro Ferro aveva per giunta fatto sopraelevare il fondo del golfo mistico, facendo emergere l’orchestra a livello poco più basso del proscenio.
Il risultato di tutto ciò, è apparso anche come l’impensabile ricerca complessiva di un lirismo belliniano che in quest’opera non esiste. Quel lirismo, invece, che caratterizza proprio altre opere di Bellini in cui la Devia è stata eccelsa in ogni senso e che inevitabilmente tendeva ad emergere anche nel canto di Norma. Dunque?
Dunque l’evento Devia a Palermo sembra aver sovrastato l’evento Norma. E’ impensabile che il M° Ferro non abbia agito appositamente ed a ragion veduta in un intervento agogico così pregnante e vistoso.
E allora, per concludere, visto che a volte anche l’Universale è ridotto a piegarsi al contingente, si spera che Bellini, al momento, almeno a tratti, fosse distratto da altri angelici canti, lassù, dall’alto di quel dell’Empireo dove si trova assiso.
PRINCE IGOR [Mirko Gragnato] Amsterdam, 23 febbraio 2017.
L’Opera Nationale & Ballet vincitrice dell’Opera Award ad un secolo dalla rivoluzione d’ottobre, in collaborazione con il Metropolitan Theater di New York, porta in scena “Il Pricipe Igor” nell’allestimento di Dmitri Tcherniakov. La direzione affidata a Stanislav Kochanovsky e nel ruolo del protagonista il basso Ildar Abdrazakov.
L’opera di Alexander Borodin, il Principe Igor è un capolavoro musicale di rara bellezza e altrettanto raro è poterla trovare nei cartelloni delle stagioni teatrali fuori dalla Russia. Un’opera dalla costruzione tormentata e punteggiata di interruzioni, Borodin era non solo musicista: violoncellista e compositore, ma soprattutto chimico e medico. Allievo di Mendeliev, ideatore della tavola periodica degli elementi, faceva della ricerca in campo scientifico la sua prima attività e del suo straordinario talento musicale si serviva solo durante i ritagli di tempo per scrivere musica. “Borodin è un professore cinquantenne di chimica all’Accademia di Medicina. Ancora un talento, perfino grande, ma perduto per colpa della mancanza di nozioni e di un destino cieco che l’ha condotto alla cattedra di chimica invece che a una vivace attività musicale”. Così scriveva Cajkovskij intorno al 1880.
Il libretto scritto da Valdimir Stasov era pensato esattamente su Borodin lo stesso Stasov scriveva che «corrispondeva al suo talento e alla sua natura artistica: motivi epici di ampio respiro, elementi nazionali, molteplici personaggi, passione, drammaticità e l’Oriente con i suoi aspetti multicolori». L’intreccio del libretto si sviluppa intorno alla storia di Igor Sviatoslavic, il principe che nel 1185 si armò contro l’armata polovesiana che avanzava contro le terre dell’antica Russia. Un racconto patriottico che unisce fedeltà e amor patrio, debolezza e infedeltà, il peso delle responsabilità del potere. Iniziato ad essere scritto nel 1869 a 10 anni di distanza non aveva ancora raggiunto la sua completezza, mancando di molte parti, e restandone molte solo abbozzate. E alla morte del compositore nel 1887 il manoscritto non era molto più sviluppato.
Dobbiamo infatti a Rimsky-Korsakov, che in Borodin aveva visto la luce della genialità, se i temi scritti per pianoforte da Borodin sono stati elaborati e orchestrati, mentre ad Alexander Glazunov dobbiamo l’ouverture che conosceva a memoria per le tante volte l’aveva sentita eseguire da Borodin al pianoforte. Dobbiamo a questi due compositore la possibilità di poter ascoltare oggi un’opera così forte per musica e intreccio narrativo.
Nell’allestimento in collaborazione col Metropolitan di New York ideato da Dmitri Tcherniakov l’opera è divisa solo da due intervalli, il racconto prosegue fluido e continuo, la battaglia che avviene fuori le scene e i cui avvenimenti non sono musicati, vengono presentate grazie a dei ben congegnati video in bianco e nero, dove fortissimi e drammatici primi piani mostrano le sofferenze, le profonde paure e lo scoramento dei soldati condotti da Igor nella disastrosa battaglia contro i polovesiani. Dopo la disfatta tutta la vicenda avviene in questa lettura di Tcvherniakov in un mondo onirico, l’inconscio di Igor è un campo fiorito, un’enorme distesa di papaveri rossi, una dimensione sognate che ricorda il campo di papaveri del mago di Oz. Le corolle dei fiori rossi sono tutte realizzate in seta rompendo la monocromia del bianco e nero, del dramma della guerra, il color rosso sangue di cui i fiori sembrano essersi nutriti, diventa il terreno dove Igor fa i conti con sé stesso, il sé stesso umano, dissociato però dalle vicende che lo circondano. Egli come un fantasma assiste all’amore del figlio Vladimir per la figlia del Khan capo dei polovesiani, Končakovna, e a come il mondo cambi e si trasformi durante la sua assenza. In questo prato in fiore è allestito forse il pezzo più famoso dell’opera “Le danze polovesiane”, musiche conosciute dai più anche perché hanno fatto da colonna sonora per la cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali di Sochi. Igor si ritrova in questa parte circondato dai ballerini che con la danza trasportano nei movimenti del corpo le emozioni delle parole del coro, con toni gioiosi ma furiosamente barbarici.
All’Opera Nationale & Ballet il coro è posizionato su delle quinte di proscenio, una sorta di palchetti laterali nascosti, che si mimetizzano nel nero del boccascena con delle apertura a scomparsa, creando così uno straordinario effetto stereo fonico. La storia procede e si Ritorna poi nella sala del consiglio della città di Putivi, dove il cognato del principe Igor sta cercando di ottenere, con l’appoggio dei suoi, il potere, scalzando il consiglio dei boiari e la principessa Yaroslavna. L’arrivo dell’orda polovesiana che aveva sfiancato le difese dell’armata guidata da Igor raggiunge la città di Putivi e la distruzione della città viene evocata da fortissime esplosioni che hanno fatto sussultare il pubblico nella sala.
Ecco che nell’ultimo atto sul palcoscenico è rappresentata la distruzione, la sala del consiglio disfatta, le solide travi che ne sostenevano il soffitto sono crollate, le porte della sala divelte, un set che rievoca il disastro delle torri gemelli. Qui Tcherniakov propone un’intuizione scenica molto coinvolgente, il principe ritornato a Putivi assorto se ne sta appartato in un punto defilato della scena quando i due disertori Skula e Ovlur litigando tra di loro per avere del vino riconoscono il principe, uno dei due afferrato un bastone lo sbatte e fa risuonare un ‘enorme trave d’acciaio a penzoloni come una campana, tutti accorrono, increduli gli danno dell’ubriacone perché è impossibile che il principe sia tornato. Quando tutti si rendono conto che il principe è tra loro, gioiscono, Igor sembra ritornare dalla trance in cui era assorto, gli viene portata una brocca d’acqua con la quale si dilava, quasi un rito di purificazione.
Nel silenzio, sotto gli occhi di tutti, cerca di raddrizzare un portale divelto e buttato a terra, alcuni iniziano ad aiutarlo, poi prende una trave e così via, il resto della popolazione segue il suo principe e inizia a trarre dalle rovine della città, pietra dopo pietra, pezzo dopo pezzo, le basi per iniziare a ricostruire. Un afflato di speranza, un finale reso scenicamente con una forza emotiva strabiliante, lasciando un pubblico commosso, mentre sul palcoscenico un’anziana comparsa scoppia in un pianto a dirotto sino a che le luci in sale si spengono non appena l’ultimo accordo viene eseguito, lasciando la sala nel silenzio e al buio.
Un cast di validissimi artisti, molti di origine russa, Ovlur interpretato da Vasily Efimov, e Skula da Vladimir Ognovenko seppur con ottima pronuncia della lingua russa non danno un’esibizione di alto livello nel ruolo, restando in disparte non solo per il carattere del personaggio interpretato ma anche per le qualità vocali, sempre un po’ tirati, con i suoni dell’acuto espressi con un po’ di affanno. Kokavna interpretata da Aguna Kulaeva mostra un bel timbro ma con qualche fragilità sull’acuto, Vladimir, Pavel Cernoch, ottima resa scenica e abili capacità canore.
Dmitri Ulianov, nei panni del principe Galitsky, fantastico per capacità sceniche e vocali, un cattivo che si fa veramente odiare, tanto è convincente nel ruolo, ottimo nel difficile e spiccato dell’aria “Greshno tait, ya skuki ne lyublyu”.
Accanto alle grandi abilità di Ulianov si affiancano Oksana Dyka, Yaroslavna, e Ildar abradzakov, Igor, entrambi abilissimi nel rendere il ruolo drammatico con una vocalità profonda e matura.
L’intera opera è stata guidata da un gestualità raffinata, dosata ma con molta enfasi dalle mani di Stanislav Khocanovsky.
LA WALLY [Lukas Franceschini] Modena, 24 febbraio 2017.
Il Teatro Comunale “L. Pavarotti” di Modena ha il grande merito di offrire al pubblico un’opera purtroppo dimenticata: La Wally di Alfredo Catalani, una coproduzione con Piacenza, Reggio Emilia e Lucca (città natale dell’autore).
Bizzarro caso quello de La Wally, tutti conoscono la celebre aria, peraltro bellissima, “Ebben ne andrò lontana”, spesso inserita nei programmi dei concerti e nelle incisioni discografiche dei soprani, ma negli ultimi anni l’opera ha subito una trascuratezza nelle scelte dei cartelloni che potremo definire assurda. Salvo errori l’ultima esecuzione italiana risale alla fine degli anni ’80.
Catalani iniziò la stesura della sua ultima opera nel 1889 (morirà di tisi nel ’93) tratta da un racconto di Wilhelmine von Hillern, su suggerimento di Arrigo Boito, assieme al librettista Luigi Illica. Il 20 gennaio 1892, La Wally andò in scena al Teatro alla Scala con la foto17022017042653 2direzione di Edoardo Mascheroni, protagonista Hariclea Darclée (futura prima Tosca), e un esito molto buono, ebbe tredici repliche. In seguito fu allestita in altre città italiane ed estere, quando arrivò ad Amburgo, dove fu diretta da Gustav Mahler, questi affermò che era la migliore opera italiana che aveva eseguito. Per l’edizione al Teatro Regio di Torino (1894) il compositore modificò il finale rendendolo ancora più drammatico, purtroppo non poté assistere all’ennesimo successo. L’opera è stata sempre considerata come la migliore della produzione di Catalani, sia per la bellezza della musica sia per la coerente tenuta drammaturgica. L’autore frequentava la corrente degli “scapigliati”, fu qualificato come wagneriano e sembra avesse pure dichiarato di non amare Verdi, ricambiato anche se in seguito il Giuseppe ebbe a ricredersi. A tutti gli effetti un compositore anomalo ben lontano dalle correnti veriste e più a suo agio con i temi fantastici delle opere nordiche. Catalani usa il cosiddetto leitmotiv, la melodia della celebre romanza è un filo conduttore per tutta l’opera, ma non mancano pagine strumentali di grande fattura come i preludi, un terzo atto con colpo di teatro, e un quarto di autorevolissima fattura, drammatico e di grande ispirazione. In quest’opera è il paesaggio, la neve e il Tirolo, che appare come condizione musicale essenziale, personaggi e avvenimenti sono circoscritti in quell’ambiente, e lo stesso ambiente determina il colore drammatico o lirico della musica e del lavoro teatrale. Non mancarono forti riserve della critica ma l’opera ebbe ampia diffusione arrivando anche in America, grazie ad Arturo Toscanini, amico e sincero ammiratore di Catalani, che la dirigerà più volte, ai propri figli darà addirittura il nome di Wally e di Walter. Si ricorda un’inaugurazione Scala proprio con Wally nel 1953, protagonista una superba Renata Tebaldi, la quale in seguito realizzò la prima incisione discografica. Qualche sparuta riproposta, poi l’oblio. Pertanto non possiamo che lodare la programmazione di questi teatri che hanno fornito l’occasione di ascoltare se non un capolavoro, un’opera molto interessante nell’evoluzione musicale di fine ottocento, e sarebbe auspicabile una riscoperta di Catalani attraverso le altre sue opere.
L’allestimento con scene di Fabio Cherstich è abbastanza funzionale creando un ambiente innevato, un ghiacciaio permanente, che segna tutta la drammaticità della vicenda, nella quale l’ambiente ha una rilevante impronta. Bisogna ammettere che è molto difficile realizzare una scena montana e innevata come richiede l’opera, lo scenografo c’è riuscito con mano felice ma non troppo coreografica, ideando anche delle scale seminascoste che funzionano per entrate e uscite valide, puntando soprattutto sulla freddezza dell’ambiente e la crudeltà della vicenda. Riuscitissima la regia di Nicola Berloffa che traccia una lettura tutta focalizzata sulla femme fatal in noir, con la sua crudeltà e sentimenti, che trova soluzione solo nel suicidio finale. Gli altri personaggi ruotano intorno a lei ma sono ben tracciati nelle loro peculiarità, sfaccettature, senza mai ricorrere stereotipati linguaggi ma realizzando con senso della sobrietà accenti acri e molto teatrali. Belli i costumi di Valeria Donata Bettella, che non scivola sul tipico costume tirolese.
Il direttore Francesco Ivan Ciampa ha realizzato una direzione di grande spessore e spiccata musicalità, trovando un perfetto equilibrio tra i diversi stili insiti nella partitura, la quale è stata realizzata con enfasi e colori davvero ammirevoli, mettendo in luce quanto di meglio in essa contenuta.
Nel complesso molto valido il cast radunato al quale non sono riservate parti facili. Saioa Hernandez è un protagonista convincente sia sotto l’aspetto drammatico sia lirico. Possiede una voce imponente e talentuosa che utilizza con tecnica e grande sfoggio di fraseggio. Non meno valido il Gellner di Claudio Sgura, il quale in un ruolo cosi rude e di villan trova accenti teatrali e vocali di forte intensità, probabilmente la sua migliore prova da me ascoltata.
Più contenuto Zoran Todorovich, Giuseppe, che affronta un ruolo molto astio con impeto e grande volontà, anche se non sempre perfettamente calibrato. Serena Gamberoni si ritaglia un personale successo nel ruolo Walter per spiccata baldanza e puntuale esecuzione.
Molto bravo Giovanni Battista Parodi, uno Stromminger dal canto levigato e scolpito, al quale si aggiungono la professionale Carlotta Vichi, Afra, e il perfetto Pedone cantato da Mattia Denti.
Il teatro Comunale era quasi esaurito per questa rarità, e al termine il folto pubblico ha tributato un meritato e autentico successo a tutta la compagnia.
THE RAVEN [Lukas Franceschini] Bolzano, 3 marzo 2017.
Al Teatro Studio, sala inferiore del più imponente Teatro Comunale, è stata rappresentata, in prima esecuzione italiana, l’opera The Raven di Toshio Hosokawa su testo dall’omonima poesia di Edgard Allan Poe.
Più che un’opera lirica vera e propria, seppur contemporanea (prima esecuzione a La Raffinerie Ars Musica di Bruxelles il 17 marzo 2012), trattasi di un monodramma per voce sola di mezzosoprano e orchestra, molto ridotta nell’organico. Il compositore giapponese ha scelto un testo molto lontano dalla sua cultura e poetica musicale. Infatti, The Raven (Il Corvo) di Poe è una lunga poesia sviluppata in diciotto strofe, densa di rime e ripetizioni a cadenza come un rituale di morte. In essa si narra di un uomo, lacerato dalla morte della sua donna, Leonore, ricevere a mezzanotte la visita di un corvo. Egli pone numerose e dilanianti domande all’animale, ricevendo però sempre la stessa risposta: “Nevermore”, mai più. Hosokawa afferma che quando lesse per la prima volta il testo di Poe gli sovvenne il teatro Nō giapponese, poiché la visione del mondo in tale forma non è antropocentrica. Alcuni protagonisti sono animali o piante, altri spiriti soprannaturali. Considerando che Poe descrive il cedimento del mondo odierno quale conseguenza dell’invasione di strani magici volatiti che provengono da un altro mondo, è stato per lui naturale considerare la poesia una storia di Nō e trasformarla in monodramma. Nelle opere di Hosokawa è molto presente l”influenza del Teatro Nō. Tale forma è un’antica arte nipponica nata nel XIV secolo, nella quale sono unite poesia, recitazione, musica, danza, attraverso trame oniriche, ruoli fissi e movimenti essenziali. L’idea di integrare la tradizione dell’opera con il Teatro Nō era già stata sperimentata da autori molto diversi tra loro come Kurt Weill e Benjamin Britten, ma in un compositore giapponese trova uno sviluppo più autentico e rigoroso. Hosokawa ha saputo fondere i modelli musicali dell’avanguardia europea con le antiche tradizioni del suo paese d’origine, in particolare studiando gli stili dell’antica musica di corte del sol levante, ritornando alle proprie radici culturali, immergendosi nel buddismo, il canto liturgico dei monaci e imparando addirittura a suonare l’organo a bocca, lo sho.
Nell’opera di Hosokawa è messo in evidenza uno stato psicologico all’eccesso, invertendo anche i ruoli, nel tentativo di comunicare con un mondo sconosciuto, il quale è in parte oscuro e inesplicabile. Ciò avviene anche per la contrapposizione tra mondo animale e umano, nel quale il corvo potrebbe essere il fantasma della donna deceduta, ma potrebbe essere interpretato come un’allucinazione, un’immaginazione dell’uomo. Nel monodramma in oggetto è una donna, con registro di mezzosoprano, a esprimere le proprie angosce attraverso un grande recitativo che intensifica le angosce, gli stati emotivi, forse allucinati, la depressione e quel dialogo sordo con il corvo. La linea vocale è un misto tra parlato, sussurrato, spreachgesang, canto spiegato, attraverso una musica che segue di pari passo i turbamenti della protagonista, armonie statiche alternate ad auree timbriche di alta impronta teatrale, ovattate situazioni riflessive contrapposte a improvvise sonorità sferzanti, leggeri sussurri a un lirismo estatico.
Lo spettacolo può essere iscritto al teatro minimalista, infatti, è rappresentato nel piccolo Teatro Studio di Bolzano, uno spazio ottimale per una performance che comprende solo pochi strumenti, una cantante è una ballerina. Regia e coreografia sono di Luca Veggetti, il quale ha orientato i suoi lavori odierni nel trovare nuovi sviluppi per la musica contemporanea, preferendo una forma mista nella quale danzatori, cantanti e musicisti sono racchiusi nello stesso spazio. La protagonista è sdoppiata con il ruolo della danzatrice-attrice, una proiezione drammatica del suo mondo intimo e di esaltazione del gesto. Assieme, creano un universo di gesti sequenziali e sotto taluni aspetti comparabili. Una drammaturgia totalmente coreografata mettendo in strettissima relazione gesto, canto, e musica. Il richiamo al teatro Nō è espressivo nella rappresentazione su una pedana quadrata con il richiamo del teatro nel teatro, però con l’intenzione di ideare uno spazio instabile poiché la piattaforma è rialzata e inclinata. Un lavoro molto efficace e ponderato nei particolari, di forte ispirazione asiatica, fortemente drammatico e penetrante. Essenziale la scena e bellissime le luci di Clifton Taylor, non indimenticabili i costumi di Kathrin Dorigo.
Veggetti ha avuto a disposizione due bravissime artiste, che con lui hanno trovato il giusto equilibrio narrativo della lirica di Poe. La giovane danzatrice trentina Alice Raffaelli, imprime una pertinente tensione, fascino e drammaticità in una movenza statica e molto espressiva, la quale è realizzata attraverso una tecnica forbita.
Ancor più esaltante la prova del mezzosoprano Abigail Fischer, cantante dotata di strumento prezioso, il quale le permette di esprimere i molteplici stati d’animo in un’ottima calibrazione di colore e fraseggio, accumunata anche da una rilevante recitazione.
Straordinaria la direzione di Yoichi Sugiyama che guida i non meno validi solisti dell’Orchestra Haydn, due violini, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, tromba, trombone, timpani, sassofono e pianoforte. In questa composizione è indicativo il puro linguaggio singolo ma anche d’assieme. Questo è realizzato dal concertatore con un gesto di estrema precisione, suoni accurati, scansioni timbriche perfette e una collaborazione totale tra gli strumentisti di rara fattura. Una prova maiuscola, la quale porterebbe a pensare che questo spartito potrebbe essere realizzato con altrettanto successo anche in sede concertistica, poiché denominarlo opera è leggermente azzardato.
La rappresentazione di The Raven è stata preceduta da “Atem-Lied” per flauto basso dello stesso Hosokava. Un brano che esprime un onirico esempio di naturalismo musicale, il quale anteposto all’opera ha perfetta ragione di essere poiché crea un ambiente etereo e forma continuità con l’altro spartito. Il flauto basso è sinonimo di suoni della natura, con l’aggiunta di suoni di respirazione dell’esecutore che formalizza anche in questo piccolo gioiello un mondo teatrale che rasenta il Nō, attraverso rumori di rara voluttuosità. Interprete eccezionale Manuel Zurria, musicista di straordinaria tecnica e interprete considerevole, specializzato in musica contemporanea.
Al termine della performance, circa sessanta minuti, il folto pubblico del Teatro ha tributato un giusto e meritato applauso di gradimento a tutti i componenti musicali e artistici dell’opera.
LA TRAVIATA [Lukas Franceschini] Milano, 5 marzo 2017.
Dopo qualche anno d’assenza il Teatro alla Scala ha riallestito La Traviata di Giuseppe Verdi nello storico allestimento di Liliana Cavani del 1990.
Sarebbe stato più ovvio che fosse riutilizzato l’allestimento di Dmitri Tcherniakov che fu prodotto per l’inaugurazione della stagione 2013-2014 e mai ripreso in seguito. Infatti, è stata una sorpresa ritrovare il nome della Cavani in locandina, quando pareva che lo spettacolo, diretto da Muti in moltissime occasioni, doveva essere pensionato. Voci di corridoio, non verificate se attendibili, affermano che è stata precisa scelta della sig.ra Anna Netrebko, protagonista nelle ultime tre repliche, a voler interpretare l’eroina verdiana in questo spettacolo.
Dopo anni l’allestimento di Liliana Cavani si rivede con piacere, poiché è nel segno della tradizione, ben impostato, con una regia efficace, anche se non indimenticabile, tratti di buon teatro e precisa impostazione drammaturgica. Non è il caso di voler cercare chissà quale filosofica o psicoanalitica concezione, sulle vicende dell’agiata cortigiana Valéry. Alcuni potrebbero affermare che non è immediata la comprensione dello stile di vita, o meglio, professione della protagonista, ma penso che non sia ignoto a nessuno poiché il titolo dell’opera è indicativo. Ancora strabilianti e sfarzosi i costumi di Gabriella Pescucci, e lo splendore delle scene di Dante Ferretti che completano una visione piacevole e di grande fascino. Unico neo la lunghezza degli intervalli per i cambi scena, la rappresentazione supera le tre ore e mezzo. La “versione” Tcherniakov, oltre ad alcuni scivoloni che non è il caso di mettere a confronto, aveva il pregio di suddividere l’opera in due parti. Tuttavia, sarebbe auspicabile che La Scala avendo a disposizione due allestimenti diversi dello stesso titolo programmasse in futuro un’alternanza, La Traviata è un titolo sempre apprezzato e riempie senza fatica il teatro.
Sul podio c’è un maestro concertatore come Nello Santi (classe 1931), una tra le più longeve bacchette del teatro d’opera e tra i veterani in campo direttoriale. Rapporto strano quello tra Santi e il Teatro alla Scala, dopo una presenza nel 1971 (Madama Butterfly con Gabriella Tucci), fu richiamato un paio di stagioni addietro per L’elisir d’amore, che però fu cancellato dal direttore, per ritornare nella stagione odierna con due titoli, a novembre dirigerà Nabucco. Santi non è, o è stato, una bacchetta assoluta del XX secolo, ma è stato senza dubbio uno dei più solidi e rilevanti direttori del teatro di tradizione, con buone caratteristiche musicale e abile concertatore operistico. La sua carriera parla da sola. In questo ritorno alla Scala è confermata la professionalità e il carisma, anche se i tempi del primo atto sono spaventosamente lenti. Si riscontra una caratura differente nel secondo atto, tempi più sostenuti e incisivo spessore drammatico, per poi rallentarsi nuovamente nel terzo in particolare nel duetto “Parigi o cara”, che mette pure in difficoltà i cantanti. Santi non smentisce la sua ottima formazione ma i tagli di tradizione sono più che evidenti, nessun daccapo nelle cabalette e qualche sforbiciata in generale. Tuttavia non mancano momenti bellissimi, il duettone del II atto e il concertato finale della festa di Flora. L’orchestra risponde con perfetta sintona, adagiandosi anche alle lentezze, ma sempre con suono pulito e delicato senza mai una forzatura.
Il Coro, diretto da Bruno Casoni, è impeccabile e di alta levatura musicale, anche in questo caso al passo con il maestro, perciò il brindisi era poco frizzante.
Protagonista era il soprano americano, ma di origine messicana, Ailyn Pérez, la quale ha mostrato una voce molto educata di soprano lirico, buona musicalità e interpretazione scenica. Una prova positiva anche se nell’aria finale atto I, le agilità non sono il suo forte, ma nel secondo tra 5atto trova un terreno molto più verde e fertile, bellissimo ad esempio l’attacco “Dite alla giovine”, e anche nel terzo, tolta la dizione della lettera, esegue un “Addio del passato” molto commuovente e ben cantato.
Francesco Meli, Alfredo, è notevolmente più in parte rispetto al Don Carlo del mese scorso. Il suo Alfredo è giovane, brillante, emotivo. La voce è bellissima, come si sa da sempre, il canto anche se tendente sempre ad essere aperto, è più rifinito, incisivo e il fraseggio molto accurato. Un ruolo che dovrebbe frequentare con maggior frequenza.
Leo Nucci, Germont padre, conferma la classe e la maestria dell’artista. Le qualità sceniche e l’immedesimazione nel personaggio sono altissime, la voce qualche volta tende all’uso del naso, ma l’espressività e il fraseggio sono da manuale, soprattutto nel duetto del II atto. La potenza e la fermezza del settore acuto sono impressionanti e un applauso a un cantante che sorpassati i settanta riesce ancora a essere un personaggio così credibile è doveroso.
Di grande levatura tutti i cantanti nelle altre parti, a cominciare dal Marchese di Abramo Rosalen, raffinato e preciso interprete e al bravissimo Oreste Cosimo, Gastone, il quale ha reso evidente una voce molto bella e ben utilizzata che farebbe sperare in un futuro luminoso.
Chiara Isotton è una sfarzosa Flora e Chiara Tirotta un’Annina delicata e precisa. Costantino Finucci un autorevole Douphol, Alessandro Spina un puntuale Grenvil. Molto professionali il Giuseppe di Jérémie Schutz e Gustavo Castillo, domestico e commissionario. E’ doveroso rilevare che raramente si trova una compagnia così ben assortita e affiatata.
Teatro esaurito in ogni ordine di posto, tanti applausi sia durante l’esecuzione sia al termine, con particolari punte per i tre protagonisti e ovazioni per il maestro Santi.
TURANDOT [Natalia Di Bartolo] Vienna, 8 marzo 2017.
La Turandot di Giacomo Puccini è a prova di bomba. Nulla la scalfisce…basta, ogni tanto, chiudere gli occhi, specie se la messa in scena è quella di Marco Arturo Marelli, nuovamente in auge al Wiener Staatsoper nella presente stagione 2016-2017. Ma proprio perché il capolavoro è a prova di bomba, l’importante è che abbia musica e voci al proprio posto. E a Vienna, nella recita dell’8 marzo 2017 c’erano proprio tutte.
Non so se sia una mia impressione, ma l’orchestra del teatro viennese, probabilmente complice anche l’acustica del teatro, ritrova in Puccini delle sonorità che forse con altri autori non vengono fuori. La profondità dei suoni, l’affondo degli archi, il meraviglioso colore…certo è che ho avuto spesso la stessa sensazione, in particolare con una Tosca, un paio d’anni fa. Mai sentita un’orchestra così in Puccini, in nessun altro teatro. Ovviamente il pugno di ferro direttoriale non guasta, anche se i meravigliosi professori austriaci probabilmente andrebbero anche da soli.
Nel caso del M° Paolo Carignani hanno trovato pane per i loro denti e viceversa: magnifico! Una direzione espressiva e sentita, dinamiche da brivido, soprattutto al primo atto…la capacità di rendere godibile anche il finale di Alfano. Una coesione tra buca e palcoscenico che è propria solo dei grandi professionisti nei grandi teatri. Dunque, se dal golfo mistico salivano perfette sonorità pucciniane, il bello è stato che in palcoscenico le voci avrebbero dato del filo da torcere perfino a qualche aureo cast dei bei tempi.
Impeccabili vocalmente tutti gli artisti in scena. A cominciare dai magnifici tre, Ping Gabriel Bermudez, Pang Carlos Osuna e Pong Norbert Ernst, come una persona sola. Peccato che Il Marelli ammannisse per loro scenette di genere un po’ tra l’obitorio e l’ufficio del catasto con gli impiegati in mezze maniche, ma vocalmente e anche scenicamente erano davvero perfetti.
Avendo iniziato dai tre ministri dell’impero, si sale via via, incontrando il monumentale basso americano Ryan Speedo Green, visto e ascoltato già a Vienna e personalmente recensito due volte, come Don Basilio e come Angelotti. Il Green ha un’aura da ragazzone tutto USA che dovrebbe mettere un po’ da parte, dedicandosi invece a migliorare tecnicamente la bella voce che possiede, dotandola di un legato migliore. Il Bel canto rossiniano è una cosa, quello pucciniano decisamente un’altra: qui mancano le agilità e la caratterizzazione, che evidentemente lo divertono di più. Scenicamente disinvolto, oltre che vocalmente, il Green, infatti, come Don Basilio si trova decisamente meglio che come Timur, oltre che come Angelotti…a parte il fatto che il Marelli ogni tanto dimentica che il vecchio padre sia cieco e che quindi Liù abbia la primiera funzione di fargli da guida…Quindi si augura a questo valido, giovane interprete di trovare presto la giusta identità ad una voce interessante.
Si sale ancora: Liù: grande Anita Hartig, con la sua voce dal vibrato stretto e magnificamente governato. Una Liù così espressiva anche scenicamente da essere stata capace di travalicare le paturnie registiche del Marelli, creandosi una propria bolla scenica, in cui ha dato vita ad una sorta di messa a fuoco del personaggio, rispetto alla concezione registica. Una fuoriclasse, vocalmente e scenicamente, già una Micaela di prim’ordine anche a Vienna, accanto a Roberto Alagna. Il che, ovviamente, depone a favore di una vocalità interessantissima e di un temperamento da attenzionare sempre di più sui palcoscenici internazionali.
Proseguiamo la salita e arriviamo a Calaf, il tenore italiano Stefano La Colla. Voce brunita come non se ne sentono da tempo sui palcoscenici per parti eroiche: questo tenore può cantare di tutto, da Puccini, a Verdi a Mascagni e via discorrendo. L’importante è che chiuda la “u” (che non è “o”) nella dizione, che curi l’eleganza complessiva del fraseggio, che non si lasci tentare dallo stimbrare i piano (sta diventando una moda?) e che si sciolga scenicamente, muovendosi con maggiore dimestichezza e disinvoltura e perdendo quell’aura da Del Monaco con barbetta tenorile che non gli giova. Per il resto, non solo nel Nessun dorma, che ha suscitato applausi a scena aperta, ma anche in una variazione acuta poco consueta sull’”ardente” nella frase “Principessa altera ti voglio (tutta) ardente d’amore” il tenore ha raggiunto vertici sonori di tutto rispetto.
Ed eccoci giunti in cima, alla protagonista, la Turandot di Elena Pankratova, ottima voce, pasta d’acciaio per la principessa. Penalizzata dalla regia, dalle scene, dai costumi, in cui la sua fisicità robusta non era valorizzata per nulla, la cantante era davvero da ascoltare: una gioia, con quello squillo che si ritrova e con una proiezione da tempi d’oro.
Senza dimenticare le buone prove dell’imperatore Altoum di Heinz Zednik, costretto dal Marelli sulla sedia a rotelle, e del resto del cast, del Coro del Wiener Staatsoper lanciato da Thomas Lang a tutto volume, corre l’obbligo di stendere una nota di lode per i bambini: delizia pura, un coretto splendido, di una morbidezza sonora e di una dizione da manuale.
Insomma: si può dire di aver passato una gran bella serata di musica pucciniana a Vienna, per la quale si stendono queste brevi note sulle sole note. Per il resto, infatti, avendo trascorso la serata spesso ad occhi chiusi, si è guadagnato tanto in ascolto quanto assai poco si è perso in visione.
Mi viene da pensare che se si desse una messa in scena adeguata a questo cast si farebbero faville. Ma già la resa sonora ha appagato l’orecchio da melomane e a Vienna è sempre una gioia trovarsi seduti in una di quelle poltroncine di velluto rosso bordate di legno…se solo i traduttori simultanei sullo schienale del posto davanti, in platea, si potessero spegnere del tutto, in tutti i posti a sedere…Ma siamo quasi in primavera: le sciarpe delle signore adagiate sugli schienali, a Vienna, servono anche a questo.
IL TURCO IN ITALIA [Lukas Franceschini] Bologna, 10 marzo 2017.
Una velata malinconia ha contraddistinto la prima bolognese de’ Il Turco in Italia di Gioachino Rossini, poiché qualche giorno prima si è saputo della scomparsa del maestro Alberto Zedda, il quale avrebbe dovuto in origine dirigere questa produzione.
Alberto Zedda oltre ad essere stato direttore d’orchestra e artistico di prestigiose istituzioni, preminente è stata la sua attività di studioso musicologo soprattutto sugli spartiti rossiniani. Infatti, fu il primo a firmare le revisioni critiche de Il Barbiere di Siviglia e La Cenerentola ancora alla fine degli anni ’60 (cui seguirono altri spartiti), fu membro del Comitato editoriale della Fondazione Rossini e per molti anni direttore Artistico del Rossini Opera Festival. Il suo contributo alla rivalutazione, riscoperta, riallestimento di molti titoli rossiniani fu determinante, tanto che oggi molti di questi non sono più rarità ma opere di repertorio.
È significativo che nel programma di sala per l’edizione bolognese ci sia proprio un suo ridotto saggio che mette in relazione Il Turco con L’italiana in Algeri. Zedda definisce che la vena comica di Rossini si rivela nell’ascolto e nell’esecuzione tutt’altro che omogena e rileva un’ambiguità che rende difficile definire la natura della sua produzione buffa. Ogni sua opera giocosa, escluse le farse, presenta un codice espressivo definito e marcatamente vario, che eleva Rossini a compositore innovativo rispetto i suoi colleghi precedenti e coevi. Nella fattispecie il Turco, melodramma giocoso con sviluppi da commedia di carattere, è opera di svolta per comprendere l’atteggiamento del compositore nei confronti dell’opera comica, e si distacca fortemente dall’antagonista Italiana in Algeri, spesso erroneamente accostata come alternazione drammaturgica. Nel Turco in Italia si evidenziano persone vere e la comicità non si limita a parafrasare i tratti della commedia ma critica la filosofia del piacere nella quale non è difficile riconoscerci. Sono gli attori stessi a determinare la drammaturgia dell’opera attraverso un meccanismo di doppia storia, la quale è raccontata e tessuta con arguzia e stile dal poeta, che si colloca all’esterno dell’intreccio, e le bizzarre e comiche “turcherie” sono ben lontane da questo dramma giocoso borghese.
Lo spettacolo presentato al Comunale era di Davide Livermore già presentato al ROF la scorsa estate, e le perplessità di alloraturco 4 (recensione del 6 agosto ndr) non sono cambiate. Brillante l’idea di base, individuando in Prosdocimo, il Guido di 8 ½, famosissimo film di Federico Fellini. Tutta la vicenda prende le misure con il cinema del grande riminese, inserendo e confezionando un tessuto drammaturgico essenziale e vivace, ma troppo caricato nei riferimenti e nelle allusioni per giustificare una scelta che a mio avviso poteva essere sviluppata con più leggerezza ed eleganza. Pertanto ci sta bene Fiorilla che fa verso a Claudia Cardinale, e qualche accenno alla lunga carrellata di personaggi emblema dei lavori di Fellini, ma quando queste semplici comparse insistono con la loro presenza per tutta l’opera, alla fine un po’ di noia era evidente. Tuttavia è vero che la comicità del Turco è molto sottile e attinge alla commedia della vita e dell’arte, e Fellini fu uno che ha raccontato a modo suo la società del suo tempo, con un pizzico di stravagante originalità, la quale poteva essere allusiva e non copiata.
Poco da dire sulla scena piuttosto spoglia per non dire nuda, nella quale di volta in volta calavano dall’alto candide tende bianche. Molto più raffinato il lavoro di Gianluca Falaschi che ricrea costumi bellissimi per Fiorilla, ma anche per glia altri interpreti a cominciare da Selim che non era difficile affiancare all’Alberto Sordi dello Sceicco Bianco.
Sul podio in sostituzione di Alberto Zedda c’era Christopher Franklin, una bacchetta che conferma una precisa e professionale direzione, coniugando buca e palcoscenico in buon equilibrio. Peccato non avesse anche quella mano personale per rendere più briosa la lettura, che sovente si accomodava in lente e languide sonorità, perché dall’ottima Orchestra del Teatro Comunale si poteva chiedere e ottenere molto di più. Molto buona la prova del coro, diretto da Andra Faidutti, che conferma non solo la professionalità necessaria ma anche duttilità del repertorio e l’incisiva compattezza.
Il cast ha dato l’impressione di essersi divertito molto e trovare uno speciale coinvolgimento in questo spettacolo, tale aspetto ha sicuramente contribuito alla buona riuscita dell’opera.
Il protagonista era Simone Alberghini, il quale rispondeva validamente ai dettami scenici, un po’ meno a quelli musicali poiché la sua esibizione era spenta e monocorde, quando invece il cantante sarebbe capace di più mordente e accenti di maggiore efficacia.
Molto buona la prova di Hasmik Torosyan, una Fiorilla partita in sordina, ma poi approdata a risultati molti brillanti sfoggiando una voce molto ben impostata, ragguardevole tecnicamente, con bei colori e un preciso utilizzo della coloratura.
Decisamente migliorato rispetto le recite pesaresi il Don Geronio di Nicola Alaimo, il quale a Bologna trova tutte le componenti che hanno reso la sua performance eccelsa. Voce molto morbida, ottimo utilizzo del sillabato, e brillantissimo scenicamente.
Mirabile il Prosdocimo di Alfonso Antoniozzi, calatosi perfettamente nel ruolo, un deus ex machina sornione e compiaciuto, cui si aggiunge una recitazione elegante e istrionica, con un canto ancora puntuale seppur non più verdissimo. Maxim Mironov, Narciso, conferma le ottime qualità vocali nelle impervie parti, le quali sono eseguite con stile e registro acuto ragguardevoli oltre ad un’innata verve teatrale.
Molto bravi Alessandro Luciano e Aya Wakizono, rispettivamente Albazar e Zaida. Il primo divertentissimo e scatenato nel suo travestimento femminile ha il momento di mettersi in luce nell’aria del II atto, l’altra dimostra ancora una volta le sue peculiari doti vocali e una precisa impostazione tecnica.
Al termine un cordiale e convinto applauso ha salutato tutta la compagnia.
MANON LESCAUT [Natalia Di Bartolo] 14 marzo 2017.
Capita a volte che lo spettatore sia colto da qualche perplessità riguardo alle regie teatrali d’Opera. Sono divenute spesso talmente insolite, trasposte arbitrariamente in termini temporali, cinematografiche, che trovarsene davanti una “regolamentare” e ambientata nel “tempo” richiesto dal libretto diventa gradevole, ma perfino inconsueto. In effetti, però, c’è regia e regia anche in questo caso.
Se è pur vero che ormai, perfino nelle recensioni, si cita prima il nome del regista e poi quello dell’autore dell’Opera, e lo si chiama “direttore” nominandolo prima anche del direttore d’orchestra, è vero pure che tale “direttore” debba dirigere ormai cavalcando la cresta dell’onda della qualità, o si troverà sommerso. Dunque in questa sede, per questa volta, si fa una deroga alla canonica disposizione dei protagonisti e si accenna per prima alla regia.
Questo perché una regia teatrale statica con interpreti che non abbiano una fisicità flessuosa e reattiva, come si è visto nella Manon Lescaut di Giacomo Puccini al Teatro Regio di Torino il 14 marzo 2017, non rende merito agli stessi. Anzi! Proprio per questo, il regista Vittorio Borrelli avrebbe dovuto congegnare il lavoro non solo facendo attenzione alle masse, ma in modo soprattutto da evitare per i protagonisti l’effetto “fai da te”. Se avesse “diretto” gli interpreti principali in maniera più dinamica e meno rilassata, lasciando loro meno spazio all’improvvisazione personale, non avrebbe potuto che giovare ai professionisti in scena ed all’intero spettacolo.
Si tornerà sull’argomento, ma è il momento di parlare del vero “direttore” dell’opera pucciniana, quello che stava sul podio: il M° Gianandrea Noseda. I suoi chiaroscuri sono stati curati con estrema attenzione, alla guida dell’ottima orchestra del Regio, pur sembrando rimanere emotivamente in superficie in alcuni punti, in particolare nel celeberrimo Intermezzo, diretto come un pezzo solo sinfonico e dunque con uno spirito non del tutto aderente all’affondo emotivo che questo richiede rispetto alle altre parti dell’opera. Forse un po’ troppo tecnico, il Maestro sembrava in piena empatia con l’orchestrazione pucciniana più che con lo spirito dell’opera: si è beato ad esaltare la perfezione della partitura, a volte trascurando un po’ il cuore. Al debutto nella direzione della Manon Lescaut, il M° Noseda ha però retto con ottimo polso l’intero spettacolo e dato sicuramente grande appoggio agli interpreti sul palcoscenico, seguendoli in maniera ammirevole e mai sovrastandoli con le sonorità pucciniane prorompenti, che ha saputo ben tenere a bada.
Giungendo alle voci, si rileva, se ce ne fosse bisogno, come Maria José Siri, Manon Lescaut, abbia una voce dal colore particolarmente scuro. È quanto di più adorabile ci sia in un soprano, quando poi, come lei, si sia capaci di raggiungere picchi acuti con uno squillo impensato in una voce così brunita. Dunque in quest’opera, soprattutto al secondo atto, la sua vocalità non viene esaltata dal carattere giocoso richiesto dalla partitura al soprano. Inserita in tale contesto, anche la celeberrima “In quelle trine morbide” si rivela poco entusiasmante da cantare per il soprano uruguyano, che ha un gran temperamento e gran desiderio di sfoderarlo con costanza nell’intero arco dell’opera. Appena si toccano le corde del dramma, infatti, ecco i brividi, tutta l’intensità, tutta la proiezione, in un’opera in cui al quarto atto “Sola… perduta… abbandonata…” si è dimostrato un vero pezzo di bravura che sembrava fatto apposta per lei.
Gregory Kunde, De Grieux, si presenta e ripresenta a stupire l’ascoltatore con la freschezza di una voce che nel tempo ha subito una metamorfosi sorprendente e che adesso lo vede debuttare in Italia in questo ruolo pucciniano, lui che è partito dai sovracuti squillanti di Bellini. Molto bravo, Il Kunde, sempre. Ineccepibile vocalmente, con una rotondità come rinnovata ed uno squillo che comunque è ancora il suo pezzo forte.
A questo punto, chi scrive non ritiene di avere doti di preveggenza, ma dire che aveva previsto fin dall’inizio un grande quarto atto, conoscendo bene le doti vocali di entrambi gli interpreti è dire il vero. Sono dei grandi solisti e lo hanno dimostrato proprio da solisti.
Apprezzabile vocalmente il Lescaut di Dalibor Jenis, gradevole il Geronte di Carlo Lepore, altrettanto l’Edmondo di Francesco Marsiglia, corretti gli altri interpreti, fatta eccezione per il lampionaio Cullen Gandy, un po’ debordante vocalmente.
Per tornare al momento opportuno alla regia di Vittorio Borrelli, a cui sopra si accennava, pur considerando positivamente il fatto che, dal punto di vista registico, quello di Torino sia stato il primo atto della Manon Lescaut più “ordinato” che chi scrive abbia mai visto su un palcoscenico, con un Coro mai chiassoso, a onor del vero, e molto ben calibrato dalla direzione di Claudio Fenoglio, allo stesso modo, si considera meno positivo il fatto che l’ultimo atto sia stato il meno aderente a quell’interiorizzazione che invece la musica ed il canto dovrebbero imporre alla regia.
Il regista ha poi reso il fratello Lescaut curiosamente accudente la sorella, al finale del terzo atto: dopo avergli fatto abbracciare i due amanti disperati che partono per le Americhe, gli ha fatto accennare perfino un saluto con la mano, da lontano. Sembrava la partenza per una crociera, non una scena di deportazione.
Il libretto, invece, recita tutto il contrario: “Lescaut, in disparte, guarda, crolla il capo e si allontana”. A parte il fatto che si capiva che si trattasse del porto di Le Havre solo dall’albero di trinchetto del veliero che occhieggiava nel buio dello sfondo. Il momento del dirigersi verso la nave è decisamente il più emozionante ed è mancato, anche per la concezione scenica ideata da Thierry Flamand, per il resto positivamente ortodossa.
Così come è mancata la giusta illuminazione, soprattutto al quarto atto, facendo morire Manon in una landa visivamente piatta, sotto le luci troppo accese e con i pochi chiaroscuri di Andrea Anfossi. L’intero spettacolo non godeva nel complesso di luci che rendessero piena giustizia all’azione scenica, nonostante la diversificazione dei quattro atti, ciascuno illuminato in maniera anche simbolica. In compenso, i costumi di Christian Gasc erano gradevoli e curati. Finalmente, alla frase di Lescaut al primo atto “Ecco il vostro tricorno!”, Geronte si è visto porgere davvero un tricorno e non un cappello stile borsalino.
Una Manon Lescaut apprezzabile , quindi, nel complesso, e debitamente applaudita dal pubblico torinese, nonché trasmessa in diretta nei cinema di alcune città fortunate e in semi-differita da RAI 5, che ha graziato molti telespettatori internauti concedendo anche lo streaming di questa prima dal Teatro Regio.
I PURITANI [Lukas Franceschini] Modena, 16 marzo 2017.
Al Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” è stata rappresentata l’opera seria in tre parti I Puritani su libretto di Carlo Pepoli e musica di Vincenzo Bellini, ultima composizione del catanese il quale morì otto mesi dopo la prima trionfale parigina. I Puritani, il cui vero titolo sarebbe I Puritani e i cavalieri, è tratto dal dramma storico di Jacques-François Ancelot e Joseph Xavier Boniface Têtes rondes et Cavaliers, e debuttò al Théâtre de la Comédie Italienne di Parigi il 24 gennaio 1835. Bellini scrisse all’amico Francesco Florimo: “Mi trovo all’apice del contento! Sabato sera è stata la prima rappresentazione dei Puritani: ha fatto furore, che ancora ne sono io stesso sbalordito… Il gaio, il tristo, il robusto dei pezzi, tutto è stato marcato dagli applausi, e che applausi, che applausi”. L’opera fu composta in nove mesi, dall’aprile del 1834 al gennaio del 1835, un periodo molto lungo per l’epoca, durante il quale l’impianto drammaturgico subì totali trasformazioni e Bellini guidò incessantemente il lavoro dell’inesperto librettista, il Conte Pepoli. Inizialmente strutturata in due atti, l’opera fu suddivisa in tre poco prima dell’andata in scena, su consiglio di Gioachino Rossini; la nuova suddivisione spostò la sequenza di alcune scene del II atto. Alla vigilia della prima rappresentazione, la lunghezza eccessiva dello spettacolo impose il taglio di tre brani, oggi sovente ripristinati in occasione degli allestimenti, e precisamente il cantabile del terzetto tra Arturo, Riccardo ed Enrichetta (atto I) Se il destino a te m’invola, il cantabile del duetto tra Arturo ed Elvira (atto III) Da quel dì ch’io ti mirai, la stretta del finale (atto III) Ah! sento o mio bell’angelo. Contemporaneamente alla versione per Parigi, Bellini approntò una versione destinata al Teatro di San Carlo di Napoli, la cui protagonista doveva essere Maria Malibran e la parte di Riccardo doveva essere sostenuta da un tenore. Per questa versione il compositore modificò, trasportandoli nella tonalità, alcuni numeri dell’opera, affidando alla protagonista la parte principale del finale atto III ed eliminò il duetto Riccardo-Giorgio perché politicamente pericoloso. Sfortunatamente l’allestimento non ebbe luogo, poiché la partitura arrivò a Napoli in ritardo, e la “versione napoletana” fu riscoperta ed eseguita solo negli anni Ottanta del secolo scorso al Teatro Petruzzelli di Bari e poi riversata di disco da Fonit-Cetra. Oggi è possibile utilizzare anche l’edizione critica di entrambe le versioni, a cura di Fabrizio Della Seta, però non utilizzata in questa occasione a Modena. Doveroso rilevare che il successo di Parigi, oltre alla genialità compositiva di Bellini, fu in parte dovuto anche a un cast stellare, infatti, i primi interpreti furono: Giulia Grisi, Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini e Luigi Lablache. Bellini ricerca costantemente la presenza del colore, la tinta dell’affresco e l’utilizzo del coro in maniera determinante. Non mancano un’attenta levigatura dei pezzi d’insieme, vertiginose difficoltà per la parte tenorile, la grande scena di pazzia per il soprano, in un contesto articolato e grandioso anche se contenuto in motivazioni favolistiche.
Molto bello lo spettacolo, una coproduzione tra Modena, Piacenza e Reggio Emila, ideato da Francesco Esposito (regia e costumi), Rinaldo Rinaldi e Maria Grazia Cervetti (scene). L’impianto è funzionale con una scenografia fissa imponente, un muro di torrione semicircolare, dalla cui base escono dei muri in obliquo sul palcoscenico che creano gli ambienti delle diverse scene. Una dimensione poetica (citazione del regista) la quale perfettamente si sposa con l’opera di Bellini, nulla di artefatto o incomprensibile, ma una dimensione narrativa felice e di forte impatto visivo. A questo si deve aggiungere una pertinente impronta drammaturgica sui personaggi, mai banale, molto studiata e di ricercata resa teatrale. I costumi, molto belli, sono in perfetto stile con l’epoca, lo scontro pur 5politico tra le fazioni nell’Inghilterra del XVII secolo, cui si devono aggiungere il bellissimo lavoro alle luci di Andrea Ricci e l’elegante coreografia di Domenico Iannone. Non era del tutto chiara la presenza di mini velati in alcuni momenti, ma non disturbavano e lo spettacolo è veramente bello e piacevole che meriterebbe di essere rivisto e ripreso in future occasioni.
Molto buona la performance dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, la quale era diretta Jordi Bernacer, un direttore che si colloca nella tradizione avendo preferito una versione con numerosi tagli ai daccapo e la soppressione della cabaletta di Elvira nel finale. La sua direzione non ha particolarmente entusiasmato poiché era tendenzialmente monotona e lenta, senza carisma e scarsa personalità.
Al contrario il Coro della Fondazione Teatro Comunale di Modena, diretto da Stefano Calò, coglie in quest’occasione un particolare e meritato successo per coesione e nitidezza d’assieme e merita un plauso incondizionato.
Nel cast, composto da nomi conosciuti e qualche novità, abbiamo avuto sorprese e qualche delusione. Irina Lungu, Elvira si riconferma cantante di spiccata duttilità vocale, molto espressiva nel canto drammatico, quanto in quello virtuoso, senza toccare vette celestiali. La linea di canto era sorretta da un gusto molto appropriato e da una scansione di colori e fraseggio ammirevoli, che avrebbero dovuto indurre il direttore a ripristinare la suddetta cabaletta conclusiva nella quale sicuramente avrebbe trovato ulteriore verde prato musicale.
La parte di Arturo fu scritta per Rubini, lo stesso interprete de Il Pirata, un tenore che aveva una voce soave e lucente, molto estesa con utilizzo del falsetto, agile ed eroica, romantico che si esprime in un’appassionata elegia. L’Arturo da noi ascoltato era Celso Albelo, un tenore che negli ultimi anni ha dato il meglio di sé in parti molto acute e con una voce molto bella. Purtroppo nella recita modenese la sua prestazione non è stata all’altezza del suo nome, poiché gli sfavillanti acuti erano isolati e forzati, il canto monotono in totale assenza di colore e un fraseggio grossolano. L’entrata si poteva anche apprezzare ma il terzo atto è stato veramente faticoso per Albelo, che in luogo di espressione ha usato inutili mezzevoci filate di scarsa credibilità e improprio stile filologico. È indubbio che non potessimo trovarci di fronte alle peculiarità di Rubini, oggi nessun cantante potrebbe tentare tale interpretazione, ma quella di Albelo a Modena è stata sotto le aspettative e alle capacità del cantante.
Il baritono Fabian Veloz, Riccardo, dopo una partenza leggermente nasale e qualche accento eccessivo, ha preso quota e ha dimostrato una buona voce calibrata e un ottimo fraseggio.
Eccellente la prova di Luca Tittoto, Giorgio, un basso con un materiale vocale molto rilevante, morbido, rifinito tecnicamente e nella sfumatura di un canto sempre controllato e di raro ascolto per timbro e uniformità.
Nelle parti secondarie si è distinta l’Enrichetta di Kato Nozomi, cantante molto professionale con ottimi mezzi, e il giovane Juan Pablo Dupré, Bruno, cantante dotato di voce interessante e molto musicale. Un po’ più in ombra il ruvido Gualtiero di Lorenzo Malagola Barbieri.
Al termine dello spettacolo non sono mancati applausi di convinto successo, anche se alle uscite singole si sono registrate due isolate contestazioni al tenore e quattro al direttore.
MANON LESCAUT [Mirko Gragnato] Torino 19 Marzo 2017.
Una Manon Lescaut tradizionale quella ripreso al Teatro Regio di Torino nell’allestimento del 2006 di Jean Reno. Le bellissime scene e i costumi riportano tra parrucche, abiti svolazzanti e arredamento a rocaille nella Francia raccontata dall’Abate Prevost. Nel cast Maria Josè Siri e Gregori Kunde.
La storia di Manon portata sul palcoscenico già dal compositore francese Massenet, trovò risultato in un altro prodotto operistico nelle mani di Puccini dopo parecchi cambi di librettisti, dove lo stesso compositore mise mano personalmente allo sviluppo dell’intreccio. La prima di Manon vide la luce proprio al Teatro Regio torinese nel 1893 fu percepita dal pubblico come un successo e senza quelle paturnie da società perbenista che condannarono ai fischi un’altra eroina, Violetta Valery de La Traviata di Verdi. Manon è sicuramente un personaggio femminile che ha poco della Fiordiligi o della Susanna mozartiana, ma che si propone come una donna dal carattere volubile e anche un po’ civettuolo, Maria Josè Siri ne riesce a dare un risultato di livello sia nel fare lezioso ma anche nella profondità delle emozioni così cangianti ma dal forte impatto sentimentale.
Il De Grieux di Gregory Kunde convince bene nel ruolo, personaggio che guidato dall’amore resta il più coerente e virtuoso proprio perché mosso dalla sincerità e profondità del suo amore per Manon. Nel ruolo di Lescaut, Dalibor Jenis, ottimo interprete, che arricchisce lo sguardo di questo personaggio con la fame da mercante mercenario, assetato di soldi e potere, un carattere così ben riuscito come il ruolo del vecchio Geronte interpretato da Carlo Lepore.
Ottimo il risultato del coro del Regio guidato dal Maestro Fenoglio; di bell’impatto l’aria del lampionaio che in questa scena di romantico decadentismo, all’alba va a spegnere a poco a poco lume per lume, accompagnando col canto di una storia la sua monotona attività, questa nenia si inframezza nell’abilità musicale di Puccini con la tensione del tentativo di fuga di Manon dalla sua prigione.
Queste sovrapposizioni musicalmente emotive così care al compositore lucchese si esalteranno appieno nel Te Deum e l’aria di Scarpia della Tosca.
Personaggio caratterizzato di vero humour il maestro di Danza interpretato dal basso Saverio Pugliese che non ha mancato di estrarre in una sorta di satira tutti i tic e i cliché di questi tronfi maestri da salotto bene, tutti impettiti e boriosi.
Caratterizzazione venuta bene personaggio per personaggio ma nelle scene coreutiche un po’ caotiche, si coglie qualche dispersione. Di grande convolgimento la scena di inizio dove il coro interpreta il gruppo di giovani e fanciulle che cerca di sviare De Grieux dalle sue convinzioni religiose. Le scene e i costumi di Thierry Flamand e Christian Gasc danno un risultato sorprendente di rara bellezza di questi tempi dalle regie astruse alla ricerca del nuovo per forza e ad ogni costo, una regia di tradizione da un po’ pace all’animo e permette di godere al meglio dell’intreccio del racconto.
Uno spettacolo di ottima riuscita, che grazie alla diretta di Rai 5 è stato trasmesso in diretta entrando nelle case di molti italiani. Il Teatro Regio si è dimostrato di essere all’altezza di una città stata capitale e che ancora diventa promotore di eventi di altissima levatura culturale.
Prossimamente con il festival Vivaldi si avrà la prima recita di un opera Vivaldiana “l’incoronazione di Dario” nella città, Torino, che conserva alla biblioteca nazionale molti degli autografi del maestro veneziano.
LA TRAVIATA [Natalia Di Bartolo] Palermo, 19 marzo 2017.
Il rischio più grave che oggi un’opera come La Traviata di Giuseppe Verdi possa correre è quello di diventare routinaria, trita e ritrita, messa in scena stancamente: nulla di più triste. Allora, mantenendo il capolavoro verdiano giustamente in cartellone, probabilmente i teatri cercano di conferire alle messe in scena quel quid in più che, quanto meno, le diversifichi dalle solite crinoline polverose.
Non che si debba fare come al Metropolitan di New York, dove la messa in scena di Decker e Gaussman, con Violetta Valery col vestitino rosso, la splendida Sonya Yoncheva che ha appena trionfato nel ruolo, ha del tutto trasformato i canoni tradizionali: in vista di una nuova produzione, a Palermo si è ritenuto che anche una ridotta trasposizione temporale potesse, evidentemente, conferire all’opera verdiana quella marcia in più che la facesse apparire “come nuova” e sempre appetibile, soprattutto se ideata per essere “esportata” in Giappone nella tournée del giugno prossimo, che vedrà come protagonista il soprano palermitano Desirée Rancatore. È quello che è accaduto, dunque, il 19 marzo 2017 nel capoluogo siciliano con la prima di una nuova produzione del Teatro Massimo del capolavoro verdiano, lanciata come un’innovazione di grande raffinatezza formale, poiché trasposta ai tempi della belle époque palermitana dei Florio, del Ducrot e del Basile, architetto autore proprio del teatro in questione. Ciò recepito, ci si è seduti a teatro con un’aspettativa adeguata a quanto promesso in fase di lancio della produzione. Pubblico delle grandi occasioni, teatro sold out, palchi gremiti, pure il cosiddetto “giro” di sedie imbottite straripante in platea, tutto come di prammatica in un’occasione così attesa.
Ed alle prime note chi si è messo all’ascolto con attenzione, nonostante un insistente chiacchiericcio e qualche immancabile squillo di cellulare, ha subito notato un bellissimo colore orchestrale. Lode alla direzione del M° Giacomo Sagripanti, che ha tratto da subito dall’ottima orchestra del teatro palermitano le dinamiche opportune. Il giovane Mestro si è dimostrato all’altezza della situazione: una discreta dose di brillantezza, orchestra un po’ di sordina all’occasione per non coprire le voci meno dotate, un gradevole piglio. Dunque, all’apertura del sipario, ci si sarebbe atteso un impatto altrettanto positivo.
Per un attimo si è faticato, invece, ad individuare tra la folla del coro la protagonista, il soprano palermitano Jessica Nuccio, poiché il costumista Francesco Zito l’aveva vestita senza dare il giusto risalto all’abito di Violetta, uniformandolo perfino nel colore a quelli delle coriste. Poco male, se la voce avesse oscurato l’abito. Ma la voce della Nuccio si è dimostrata opaca, priva di squillo, non particolarmente ben proiettata né incisiva. Qualche carenza nel legato, spinti gli acuti del primo atto, fino all’uso indebito del cosiddetto “scalino” per lanciarli . Priva anche di una qualsiasi tensione drammatica, lungo tutto l’arco dell’opera, la Nuccio ha dato solo l’impressione di risparmiarsi in vista del finale. Quanto all’espressività attoriale, la presenza scenica di questo soprano è tutta da rivedere: era statica, forse registicamente non sufficientemente guidata. Insomma, una Violetta che scenicamente era spenta tanto quanto lo era vocalmente.
Data la qualità vocale della partner, l’ottimo René Barbera, Alfredo, ha dovuto al primo atto contenere i bollori di una proiezione di rilievo. Anche la qualità della voce, con un vibrato molto stretto palesava la dimestichezza con le agilità di un repertorio rossiniano nel quale il tenore si districa piuttosto bene e, partendo da ciò, può permettersi anche sortite in opere di altri autori, come in questo caso. Quale Alfredo, infatti, al secondo atto, soprattutto nella parte solistica, il Barbera ha dato il meglio, sfoderando quel volume che nel primo atto aveva dovuto contenere per non coprire la partner nei duetti; cosa che è avvenuta anche in altri momenti dell’opera. Come Alfredo è stato apprezzabile, la migliore voce in scena, la più fresca e ambiziosa.
Il pubblico palermitano non è parso accorgersi di tutto ciò, tributando soprattutto alla Nuccio, alla fine del primo atto, scroscianti applausi, che si sono ripetuti nel secondo atto al duetto con l’immarcescibile Leo Nucci, che, reduce da un trionfale Nabucco a Vienna, si cimentava adesso nella sua milionesima Traviata come papà Germont. Ovviamente, nulla da dire sul celebre baritono ormai prossimo ad entrare nella leggenda, se non che questa parte gli si addice, oggi, per vocalità e durata, molto più che quel Nabucco che pure lo ha visto al centro di un apprezzamento che si ritiene da chi scrive, che lo ha ascoltato, essergli stato tributato più alla carriera che alla singola performance. A Palermo, il Nucci, imponendo alla direzione i propri tempi, docilmente assecondato dal M° Sagripanti, ha sfoderato la sua caratteristica vocalità e il personaggio è saltato fuori positivamente più dall’esperienza che dalla voce, in attesa d’imbarcarsi anch’egli in tournée per il Paese del Sol Levante.
La Flora della volenterosa Piera Bivona avrebbe necessitato di una classe scenica di maggiore eleganza, tutti gli altri protagonisti hanno dato il meglio che fosse nelle loro possibilità, il coro diretto da Piero Monti, un po’ esuberante nel primo atto e nella compagine maschile dei toreri, ha comunque prodotto un’esibizione decorosa.
Ma…c’è un ma, in tutto ciò…In questa sede si tratta, come sempre, prima della parte musicale e poi di quella registica e della messa in scena in generale. In realtà una recensione di questa serata avrebbe dovuto privilegiare prima la regia e poi gli interpreti, perché la prima di questa nuova produzione si basava soprattutto sulla messa in scena tanto decantata e l’aspettativa non è stata pari al risultato visto sul palcoscenico.
Tutta l’eleganza che avrebbe dovuto evocare dal punto di vista visivo addirittura i fasti dei Florio, si è ridotta non più che al primo atto ed alla prima parte del secondo, fino alla scena VIII. Qualche richiamo Liberty nel padiglione cartonato della festa al primo atto, qualche gradevole mobile déco, dunque perfino un po’ troppo moderno per l’epoca, che arredava il salottino di Violetta…Alla scena della festa a casa di Flora, senza che si capisse il nesso con ciò che l’aveva preceduta, una immensa cortina di funereo velluto nero si è dispiegata a guisa di sipario sullo sfondo, con un arco sempre più cartonato che vi spiccava sopra, oro su nero. Nulla a che vedere con le scene precedenti. Lo stesso al terzo atto, in cui un letto decisamente vistoso ed ingombrante occupava al centro, da solo, la scena, per giunta soprelevato da un gradino rotondo, su uno sfondo in cui il velluto da nero era divenuto verde.
Scene poco gradevoli, nel complesso, a dire il vero, di Francesco Zito e Antonella Costa, non coerenti con se stesse lungo tutto l’arco dell’opera, illuminate dalle luci piuttosto fredde di Bruno Ciulli, condite dai costumi del suddetto Zito, che dell’eleganza dei Florio avevano soltanto le aigrettes sulle acconciature delle signore. Aigrettes a tutto spiano anche nella scena della festa, questa volta soprattutto sulla testa di Violetta…E a questo punto ci si chiede se tale ciuffetto di piume fosse proprio un accessorio da sera. Forse un’aigrette di strass sarebbe stato più adatto all’occasione… Così come c’è da sottolineare qualche dato che faccia parte del Galateo salottiero di allora e di cui il regista Mario Pontiggia, affannato a rendere sontuoso l’insieme dell’apparenza scenica, al primo atto, non ha tenuto conto: il baciamano non si fa mai se la signora calza i guanti. Invece è stato tutto un susseguirsi di baciamano alla padrona di casa guantata fino ai gomiti. I Florio, probabilmente, si saranno rivoltati, quanto meno per questo… Particolari di poco conto? In un clima di revival d’epoca decisamente non lo sono. Per non parlare, poi, dei fiori ricchi di pollini ed allergeni omaggiati alla moritura già stesa sul letto giusto dal dottore, il valido Romano Dal Zovo, all’ultimo atto: un presente poco opportuno, anche da aspirare, sia pure presumibilmente composto di camelie…
Ma, a proposito di “aspirare”, c’è da sottolineare come si fosse pensato di arricchire la produzione creando un “profumo di scena”, commissionato allo stilista Emmanuel Ungaro e realizzato da parfumeur Alberto Morillas: esperimento mai osato prima in un teatro. Transeat, se tale profumo “Violetta Valery” fosse stato messo in vendita in serie limitata nel foyer per le signore più trendy…Invece era destinato ad essere spruzzato in sala, trasformandosi lungo lo svolgersi dell’opera, accompagnando il corso degli eventi, soprattutto quelli di massima tensione emotiva, quelli in cui giusto l’orchestra e il canto si attestavano ai piano e pianissimo…Dunque il rumore del soffio dell’apparecchiatura che nebulizzava tale profumo, dal sentore di fiori caduchi vari, si dimostrava fastidioso ed invadente, sia per le voci che per l’orchestra. Numerosi brontolii e qualche eco di tosse da parte del pubblico hanno evidenziato anche come probabilmente il profumo in questione non fosse gradito né al gusto, né ai bronchi di alcuni spettatori.
Nonostante tutto, il pubblico che gremiva il teatro ha tributato applausi scroscianti, conditi di certo da una punta di campanilismo, a tutti gli interpreti ed artefici della serata, probabilmente anche perché, volenti o nolenti, La Traviata è sempre La Traviata.
MANON LESCAUT [William Fratti] 22 marzo 2017.
La serata al Teatro Regio di Torino si apre con un annuncio, esposto da alcuni dei dipendenti della Fondazione – tra cui Coro e Orchestra – al fine di sensibilizzare il pubblico in merito alle problematiche che stanno affliggendo pressoché tutti i teatri lirici italiani a causa dell’applicazione dell’ultima riforma. Si tratta di un genere di protesta molto intelligente, poiché mira a coinvolgere gli spettatori circa questioni che li interessano in quanto fruitori dell’arte e della cultura prodotta dalla lirica. Il Regio di Torino ha ben ragione di protestare, poiché si tratta di un teatro molto ben frequentato e ciò significa soltanto che la qualità è alta al punto da soddisfare un pubblico che continua ad acquistare biglietti.
Manon Lescaut torna sul palcoscenico del Mollino nell’allestimento firmato da Thierry Flamand con i costumi di Christian Gasc. L’efficace regia del bravo Vittorio Borrelli sostituisce l’originale ideata da Jean Reno, pur non discostandosene troppo. La scenografia è sempre bellissima, ma poco funzionale, costringendo lo spettacolo a tre pause che quasi pareggiano la durata della musica. Pure i costumi sono sempre preziosi e raffinati, le luci ben riuscite e suggestive curate da Andrea Anfossi, i movimenti mimici raffinati assistiti da Anna Maria Bruzzese.
Gianandrea Noseda e la sua bravissima Orchestra del Teatro Regio eccellono in un’esecuzione precisa e pulitissima, ma al tempo stesso toccante e struggente fino alle lacrime. Emblematici in quanto ad accuratezza certi passaggi di primo e secondo atto, ma assolutamente significativi in termini di emozioni e passione pucciniana sono tutto il terzo e il quarto, sfortunatamente separati da una pausa che distoglie l’attenzione. Sempre ottimo il Coro preparato da Claudio Fenoglio.
Maria José Siri continua la sua sfavillante carriera e ottiene a Torino l’ennesimo successo, ma l’impressione che si ha della cantante è sempre la stessa: brava, ma nulla di più. Non si percepisce il pathos di Manon, né l’ardore pucciniano, neppure brilla nelle numerose note acute, tantomeno si prodiga in un fraseggio che invece dovrebbe trasmettere sentimento e tormento.
Gregory Kunde, negli ultimi anni eccellente interprete del repertorio lirico spinto, rende magnificamente certi passaggi di Des Grieux, come la celebre “No! Pazzo son!” e anche altri momenti di secondo e quarto atto, mentre resta un poco sottotono nei momenti più lezzosi, ma è poca cosa in confronto ad un’interpretazione che dimostra lucentezza e vigore.
Buona la parte di Lescaut a cura di Dalibor Jenis, ma senza particolare pregio. Eccellente Carlo Lepore nei panni di Geronte. Bravo Francesco Marsiglia nel ruolo di Edmondo.
Adeguate le parti di contorno: il maestro di ballo di Saverio Pugliese, il musico di Clarissa Leonardi, il lampionaio di Cullen Gandy, il sergente e l’oste di Dario Giorgelè, il comandante di Cristian Saitta.
Successo entusiastico per tutti al termine della bella serata.
MANON LESCAUT [Natalia Di Bartolo] Catania, 22 marzo 2017.
I brividi suscitati dall’ascolto della Manon Lescaut di Puccini sono particolari, sono “i brividi di Manon”. Dunque, in una messa in scena del capolavoro pucciniano, ricercarli sempre e comunque a volte è vano. E non c’è peggio che rifugiarsi nel passato più o meno remoto per ritrovarli. Quando si va in teatro, poi, il melomane se li aspetta pari a quelli suscitati magari dal sacro disco 33 giri e spesso, troppo spesso, non li trova all’altezza.
Dunque, è piacevole ritrovarseli genuini, dal vivo e anche un po’ inaspettati, in una messa in scena che si presentava un banco di prova improbo per l’intero cast, come sempre avviene per quest’opera. È accaduto, infatti, che a Catania, al Teatro Massimo Bellini, il 22 marzo 2017, i brividi di Manon si siano presentati puntuali all’appello. Il che è davvero tanto, perché con le ultime Manon viste in giro ultimamente erano in fase di quiescenza… Il primo ingrediente dei brividi di Manon è il direttore d’orchestra: se non entra a fondo nella partitura, oppure la personalizza e dunque la spersonalizza, meglio lasciar perdere di sperare. È un primo grave rischio che si corre e a Catania, al primo atto, fin dall’inizio, chi scrive ha avuto la sgradevole impressione che i brividi non sarebbero arrivati, ascoltando la meravigliosa orchestra del Teatro Massimo Bellini lanciata a volume altissimo, fino a sovrastare gli interpreti e perfino il coro. Forse un eccesso di entusiasmo del Maestro José Miguel Pérez-Sierra, che aveva sottocchio la partitura pucciniana e sottomano una così valida orchestra, perché è apparso subito decisamente un “sinfonico”.
La partitura di Puccini, del resto, si presta a tentazioni del genere e il Maestro si è fatto tentare volentieri. Solo che chi ben comincia è a metà dell’opera e l’inizio non appariva dei migliori…Dunque, ci si aspettava una barriera da muraglia cinese davanti al palcoscenico anche nel prosieguo. Invece, il Maestro Pérez-Sierra si è intenerito già dal secondo atto in poi ed ha moderato gli entusiasmi fino alla fine, convogliandoli soprattutto nel meraviglioso Intermezzo. Lì la natura sinfonica del Maestro è venuta fuori in tutta la propria autorevolezza e gli affondi degli archi sono stati degni delle orchestre più blasonate. Il meraviglioso colore dell’orchestra catanese ha avuto pieno risalto, nonostante la mancanza dell’arpa, purtroppo, per un’indisposizione dell’arpista e dunque sostituita da una tastiera che ne ha fatto le veci. Un vero peccato, in un insieme orchestrale che i brividi di Manon avrebbe potuto darli tutti.
In verità, anche la voce di Manon ha saputo suscitare debite emozioni e anche qualche brivido, al finale del quarto atto soprattutto. La bella e brava Alisa Zinovjeva ha dato vita ad un personaggio sentito e comunque anche ben recitato, dotato di una voce dal bel colore, dal timbro scuro e drammatico. L’artista si è districata nei grovigli di una partitura certo non facile, merita una nota di lode e le si augura di affinare questa parte, che le sta molto bene.
I brividi di Manon anche dall’ugola di de Grieux?…E qui viene il bello, perché a Catania de Grieux era Marcello Giordani. Indubbiamente ammirevole la limpidezza della voce dell’esperiente Maestro, che ha anche una presenza scenica di gran rilievo. Ma, ovviamente, la parte è improba e, soprattutto nel finale, l’artista si è appellato più alla tecnica che a ciò che gli veniva offerto a fine serata da una voce che certo risente inevitabilmente dell’usura del tempo. Il Giordani non ha perso però lo smalto e ha dato vita ad un personaggio sentito e ben interpretato. Brividi di Manon anche da de Grieux dunque, soprattutto in “Ah! Manon mi tradisce il tuo folle pensier” al secondo atto, gran momento, quello, affrontato con piglio drammatico sia vocale che scenico.
I personaggi che attorniano i due protagonisti contribuiscono a favorire i brividi, ma non ne sono gli artefici, per la natura delle loro parti. Apprezzabile il Lescaut di Giovanni Guagliardo, che ha dato del personaggio un’immagine non troppo becera, anzi abbastanza protettiva nei confronti della sorella; meno stentorea la voce di Emanuele Cordaro, un Geronte comunque corretto. Parlare del resto del cast significa parlare soprattutto del tenore Stefano Osbat, che ha impersonato diversi ruoli, ma che neanche in uno ha fatto sentire un po’ di voce. La parte più importante, quella di Edmondo al primo atto, è passata quasi inascoltata, tra la carenza di proiezione del cantante ed il muro sonoro creato dal Maestro.
Come sopra accennato, perfino il coro, diretto da Ross Craigmile, ha risentito del volume orchestrale al primo atto, ma è stato, tutto sommato, gradevole.
L’insieme musicalmente apprezzabile era contenuto in una messa in scena altrettanto apprezzabile. La regia esperiente di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, da un allestimento di Pierfrancesco Maestrini proveniente dal Massimo di Palermo, ha dato i suoi frutti, fornendo ai personaggi quel sostegno recitativo che è indispensabile. Mai statici i protagonisti, ben disposte le masse, ben caratterizzati i comprimari, tranne che per una certa approssimazione nella scena di Manon alla toletta, all’inizio del secondo atto. Una regia che comunque ha catturato lo spettatore che si è lasciato trasportare. Gradevoli le scene, ma soprattutto illuminate molto bene: le luci hanno fatto moltissimo in questa produzione, così come i costumi, assai ben curati da Giovanna Giorgianni.
Brividi, in conclusione, allora, per l’accanito melomane, trasmessi e ricevuti debitamente, in una serata godibile. Ed è bello sentire mormorare alle signore, di solito sempre un po’ svagate, in prima fila: “Ma la musica…la musica è meravigliosa!”. I brividi di Manon non risparmiano nessuno, allora: quel geniaccio di Puccini lo sapeva anche troppo bene.
I PURITANI [William Fratti] Piacenza, 24 marzo 2017.
La sublime opera belliniana approda sul palcoscenico piacentino a coronamento di un lungo mese, iniziato con la nuova produzione de La Wally, ricco di eccellenti eventi culturali carichi di emozioni.
Finalmente si ritrova nell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna una certa qualità, anche in quelle sezioni – fatte rare eccezioni – che recentemente avevano sortito un po’ di dubbi. Lucentissimi gli archi. Ottima la direzione di Jordi Bernàcer che, pur non prodigandosi in colori suadenti e fraseggi particolarmente interessanti, riesce ad esprimere molto bene il carattere e la melodia del belcanto belliniano, romantico e patetico dove occorre, marziale e quasi risorgimentale dove necessario.
Presenta invece molte più ombre la regia di Francesco Esposito, che mette le mani avanti scrivendo nelle note del programma di sala che “lo spettacolo è stato concepito ed elaborato in uno spazio di tempo non lunghissimo, che ha richiesto decisioni tempestive e rapide su come affrontare la lettura di un’opera complessa […] Insomma un compito non facile”. Nessuno vuole sostituirsi alla professionalità di un artista, ma il pubblico si trova in presenza di una ricetta obsoleta, seppur meccanicamente efficace. L’impianto scenico a cura di Rinaldo Rinaldi e Maria Grazia Cervetti, anche se già stravisto e non particolarmente grazioso, è molto funzionale – perciò si poteva evitare la pausa tra secondo e terzo atto – e presumibilmente si ispira a un torrione, con pareti a scomparsa per creare gli ambienti e che si sgretola col procedere della narrazione, al pari della vicenda che tocca i protagonisti. Sicuramente le belle luci di Andrea Ricci ne accentuano i pregi, risultando suggestive e decorative al tempo stesso. Adeguati i costumi firmati dallo stesso Esposito, anche se quelli del coro e dei protagonisti maschili sembrano vistosamente riadattati.
La regia è ben centrata sulle due protagoniste femminili, mentre per il resto è un poco più monotona, con il coro piazzato e i soliti mimi che popolano irragionevolmente questo genere di spettacoli, per riempire ingiustificatamente vuoti che non si è saputo colmare con i veri personaggi della storia. Non classificabili le coreografie di Domenico Iannone.
Irina Lungu è alle prese con il ruolo che forse le riesce meglio. Il soprano, che ha troppo spesso vestito parti che le stavano larghe, trova in Elvira il suo terreno di elezione in quanto a portamento, eleganza e stile. L’emissione è davvero buona, sostenuta da una chiara linea di canto ed impreziosita da un fraseggio rifinito, pur non essendo particolarmente brillante in acuto – suo tallone d’Achille – di cui qualcuno addirittura calante. Ottime le agilità, anche se mancano certe volatine che tradizionalmente contraddistinguono questo ruolo.
Decisamente sotto le aspettative la performance di Celso Albelo, esperto del personaggio di Arturo, poiché sembra sempre risparmiarsi per poi spingere e forzare le note più alte. Anche la recitazione pare ridotta ai minimi termini.
Fabian Veloz è un Riccardo corretto, ma poco nobile, non ricercato, povero di fraseggio e parco di colori.
Superlativo il Giorgio di Luca Tittoto, dotato di classe raffinata e gusto finissimo. Il suo canto è particolarmente accurato, arricchito da un fraseggio molto eloquente e un ottimo uso dei colori, oltre a una linea di canto omogenea dalle brillanti note acute alle salde note gravi.
Molto brava Nozomi Kato nei panni di Enrichetta. Un poco tremolanti il Gualtiero di Lorenzo Malagola Barbieri e il Roberton di Juan Pablo Dupré.
Perfetta la prova del Coro della Fondazione Teatro Comunale di Modena preparato da Stefano Colò.
MARIA STUARDA [William Fratti] 28 marzo 2017.
Andrea De Rosa è un regista che si potrebbe definire minimalista. Nei suoi spettacoli non c’è mai “troppo” e spesso tende a quel carattere basico ed essenziale che vuole concentrare l’attenzione su un personaggio o un gesto. In questa Maria Stuarda la semplicità regna protagonista, in un allestimento che prevede una scenografia e un’attrezzeria quasi assenti, ma mai si percepisce un vuoto o una mancanza. I solisti, molto ben vestiti da Ursula Patzak, compiono una serie di sguardi, gesti, movimenti che rapiscono, in perfetta armonia musicale con la partitura. Le scene di Sergio Tramonti, seppur minimal, ci sono e sono molto efficaci e funzionali nel raccontare la prigionia di Maria che si evolve verso il patibolo. Ottime le luci suggestive di Pasquale Mari.
Eccellente la direzione di Paolo Arrivabeni, che pare avere trovato il punto giusto nell’interpretazione di questo Donizetti. I suoni precisi, puliti e mai sovrastanti evidenziano i caratteri melodici del belcanto, senza rallentare troppo nei passaggi patetici, ma lasciando spazio ai fraseggi e ai colori, in un evidente dialogo continuo col palcoscenico. Al direttore va riconosciuto anche il pregio di avere optato per una versione integrale con tutti i da capo, approfittando di belle e interessanti variazioni. Ottimo il Coro dell’Opera di Roma preparato da Roberto Gabbiani.
La giovane Roberta Mantegna, allieva della Fabbrica dell’Opera, mostra una vocalità davvero interessante, rotonda nella sua leggerezza, con quel poco di acidulo che la rende ancor più accattivante e le dona carattere. La linea di canto della sua Maria è piacevolmente omogenea e sa prodursi in sfumature, trillini e volatine che dimostrano buona preparazione. Peccato per la totale assenza di sovracuti e per la mancanza di pathos nella bellissima preghiera di terzo atto, pagina di inarrivabile splendore.
Buona anche la prova di Carmela Remigio nei panni di Elisabetta anche se, non per la prima volta, si riscontrano certe difficoltà quando il soprano interpreta ruoli così drammatici – nella tessitura oltreché nell’accento – andando a cercare suoni che non le appartengono naturalmente e che poi rischiano di renderla afona. La performance è comunque positiva, soprattutto sotto il profilo dell’interpretazione del personaggio. Sarebbe molto interessante ascoltarla in una esecuzione filologica della parte di Maria.
Paolo Fanale è un Leicester incantevole. Il suo gusto classico trova un compimento finissimo nel belcanto italiano, anche in questo ruolo al limite del possibile, scritto per tenorino di grazia e che presumibilmente all’epoca della composizione era cantato diversamente. Oggi, col raddoppio dell’orchestra e una certa tradizione lirica alle spalle, cantare una lunga serie di duetti e ariette con una tessitura che si muove continuamente tra la zona delicata del passaggio e gli acuti, tra fa diesis e la, con punte al si bemolle, do e re naturale, non è certo un compito facile. Diversi grandi artisti, più o meno recentemente o nel passato, hanno avuto problemi con questa parte, oppure hanno addirittura rinunciato. Fanale la prende per il verso giusto, cantando con classe, senza mai forzare, restando sempre naturale ed omogeneo, con una linea di canto morbida che arriva facilmente ai numerosissimi sovracuti, tutti intonatissimi, senza lasciare intravedere alcuna tensione vocale. Il saper amalgamare la dolcezza con l’eroicità esprime indubbiamente un valore aggiunto al suo fraseggio.
Ottimo il Cecil di Alessandro Luongo, abbastanza efficace il Talbot di Carlo Cigni, ben centrata l’Anna di Valentina Varriale, anch’essa allieva della Fabbrica.
DIE ZAUBERFLÖTE [Renata Fantoni e William Fratti] Firenze, 29 marzo 2017.
Esprimere diversi pareri riguardo le performance artistiche di questa produzione non è affare semplice, poiché risulta essere tutto molto omogeneo e sulla stessa lunghezza d’onda. E ciò ne è il pregio maggiore, anche se tale compattezza resta ancorata alla media, senza mai sfogarsi in momenti entusiasmanti.
Partendo dall’ambito musicale, a Roland Böer va riconosciuto il valore di una conduzione ben centrata nello stile classico, con buon dialogo tra buca e palcoscenico, pur non essendo particolarmente prodiga di fraseggi e sfumature. Sempre ottimi il suono dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e la prova del Coro guidato da Lorenzo Fratini.
Lo stesso vale per i cantanti solisti: il Tamino di Leonardo Cortellazzi, la Pamina di Anna Gillingham, il Papageno di Christian Senn e il Sarastro di Goran Jurić mostrano un certo gusto mozartiano corredato di una buona linea di canto, ma mai nessuno brilla, riluce o spicca facendo ricordare una particolare pagina dell’opera.
Si nota invece un buon miglioramento nell’uso dell’accento drammatico di Olga Pudova. La sua Regina della Notte è sempre dotata di buona intonazione e sovracuti impeccabili e luminescenti che, con la maturazione vocale di questi anni, sostenuta da una buona preparazione tecnica, si contraddistingue per una zona centrale un poco più vigorosa. Se la cantante riuscirà a proseguire in questa direzione avrà certamente occasione di lasciare un segno con questo difficile personaggio.
Efficaci e ben adeguati al buon livello qualitativo della rappresentazione anche tutti gli altri personaggi: le tre dame di Heera Bae, Cecilia Bernini, Veta Pilipenko; i tre fanciulli dei solisti del Muenchner Knabenchor, la Papagena di Giulia Bolcato, il Monostatos di Marcello Nardis, l’Oratore di Philip Smith, i sacerdoti e armigeri di Cristiano Olivieri e Oliver Puerckhauer.
Lo spettacolo firmato da Damiano Michieletto – con scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti e video design di Carmen Zimmermann e Roland Horvath – originariamente prodotto sul palcoscenico de La Fenice di Venezia, toglie gran parte del simbolismo attinente alla magia e alla massoneria per concentrarsi sul vero processo di iniziazione alla vita: la scuola nel periodo dell’adolescenza, la fine del tempo del gioco e delle illusioni e l’inizio dell’età adulta. A tale scopo l’intera vicenda è ambientata in un istituto scolastico e risulta essere tutto estremamente funzionale e filologico. Ciononostante le emozioni che ne derivano sono veramente ridotte ai minimi termini, poiché tale visione, seppur condivisibile, rende tutto molto piatto, quasi bidimensionale, poco eccitante. A Michieletto va comunque riconosciuta una professionalità e un saper fare regia di grande pregio.
TOSCA [Lukas Franceschini] Verona, 30 marzo 2017.
La Stagione al Teatro Filarmonico procede a ritmo incalzante pur nella fase di risanamento della Fondazione, pertanto, è plausibile la ripresa dell’allestimento giacente in “casa” di Tosca di Giacomo Puccini ideato da Giovanni Agostinucci nel 2004.
La Roma ideata da Puccini è tutta d’invenzione ma ha un fascino d’ambiente considerevole, in effetti, il compositore non si dimentica di essere un pittore di note in estrema libertà. Anche i personaggi sono pennellati a misura ed esteticamente efficaci: Tosca, amorosa eroina che si trasforma non volendo in assassina, il poetico e spavaldo Cavaradossi, il crudele Scarpia, uomo dello stato non meno viscido per interessi personali ma pur sempre barone e uomo sincero ma corrotto. L’epica conclusione sfocia in una scena teatrale di forza drammatica che raramente si trova nell’opera, anche se fedele al testo di Victorien Sardou.
Giovanni Agostinucci, autore di regia, scene e costumi, come già rilevato nel 2004, non si avvale di una drammaturgia già scritta dal sommo francese, per cui imbocca la strada della violenza tout-court senza individuare tutta la melliflua apparente psicologia che contraddistingue non solo i personaggi ma l’intera vicenda. Non proprio abile nella scena, Sant’Andrea all’inizio non è una chiesa barocca ma un luogo con grandi drappi grigi, per poi apparire mediocremente all’ingresso di Scarpia. La Madonna che dipinge Cavaradossi è fastidiosamente alzata e abbassata dall’alto. Altro grave errore far calare un sipario nero e poi trovarsi di fronte il coro per il Te Deum, cancellando la meravigliosa pagina dell’ingresso dei fedeli, i quali guarda caso sono tutti nobili, nemmeno l’ombra di un popolano. Palazzo Farnese rasenta l’ufficio di un torturatore, aspetto così eccessivo da sfiorare il ridicolo, come lo sono gli sgherri dello Stato Pontificio che fingono una lotta e sono utilizzati in malo modo durante l’interrogatorio. Quando abbiamo una vera scena credibile, atto III terrazza di Castel Sant’Angelo, ecco che il regista ci regala il colpo di teatro finale, Tosca non si getta dal torrione ma si toglie la vita infilzandosi nelle baionette dei soldati. Una Tosca decisamente mancata e sbagliata, in tutto e per tutto, cui andrebbero aggiunte altre situazioni assurde che per ovvietà voglio sorvolare poiché è il dramma e la tragicità dei protagonisti la chiave mancante di quest’allestimento.
Il reparto musicale funziona u po’ meglio. Antonino Fogliani fa una lettura molto sinfonica, apprezzabile nei colori e nelle dinamiche, ma è sovente sopra le righe con la sonorità, la quale è debordante in molti punti fino a coprire le voci. Peccato perché il direttore è un ottimo musicista e raffinato interprete, ma questa volta la sua esibizione non mi ha convinto pienamente.
L’orchestra dell’Arena di Verona rispondeva diligentemente con la consueta professionalità, molto bravo il Coro preparato da Vito Lombardi, e non meno esemplare il Coro di Voci Bianche d’A.Mus. istruito da Marco Tonini.
La protagonista Lilla Lee sfoggiava una voce molto importante, robusta e ben amministrata, capace di pregevoli sfumature nei momenti amorosi, e puntuale nei passi drammatici, con una “lama” ragguardevole.
Meno significativo il Cavaradossi di Mikheil Sheshaberidze, un tenore molto stentoreo che non trova nel fraseggio punto portante del suo canto. Meglio il settore acuto, ma questo non basta per caratterizzare il poeta rivoluzionario, che mi è parso slegato e all’inizio molto incerto.
Boris Starsenko era un barone Scarpia sui generi, mancando tutte le sfaccettature del complesso personaggio, anche tosca 5se dimostrava un canto robusto senza falle particolari ma pur sempre monotono.
Molto bravo il sagrestano di Mikheil Kiria, molto compito e con bona voce rifinita e morbida, eliminando dalla sua interpretazione ogni vezzo di tradizione ed esprimendo un forbito personaggio.
Bravi anche gli altri interpreti, a cominciare dal professionale Gianluca Lentini (Angelotti), Antonello Ceron un brillante Spoletta, Daniele Cusari preciso carceriere e Stella Capelli bravissima nello stornello del pastore.
Abbiamo assistito alla sesta recita, teatro gremito nei tre ordini e composto di numeroso pubblico giovane (ottima visione), che al termine ha salutato tutta la compagnia con accesi e prolungati applausi.
MARIA STUARDA [Simone Ricci] Roma, 1 aprile 2017.
Il Teatro Costanzi ha deciso di puntare sulla versione originale della tragedia lirica, con due atti e due soprani. L’invidia rivela la mediocrità, i grandi caratteri non conoscono che le rivalità: questo aforisma del duca Pierre-Marc-Gaston de Lévis è perfetto per descrivere “Maria Stuarda”, un’opera in cui sono presenti due regine, inevitabilmente rivali. Il Teatro dell’Opera di Roma ha deciso di puntare sulla versione originale del lavoro di Gaetano Donizetti, con due atti e soprattutto due soprani (nell’800 si tendeva spesso ad affidare il ruolo di Elisabetta a un mezzosoprano). Una soluzione che ha permesso agli spettatori di approfondire le caratteristiche più intime e le passioni delle due grandi protagoniste: questa recensione si riferisce alla penultima replica dello spettacolo, quella di sabato 1° aprile.
L’allestimento di Andrea De Rosa, in collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli, ha puntato sull’essenzialità. I personaggi sono entrati in azione su una grande pedana, mentre la parte di fondo ha svolto il ruolo di “narratore silenzioso”, richiamando il bosco del Parco di Forteringa con un rosso intenso e il popolo inglese che si intravedeva appena. Le scene di Sergio Tramonti erano piuttosto oscure e semplici, mentre lo stesso De Rosa ha dato grande importanza alla “cornice” interna di Elisabetta e Mara. I costumi di Ursula Patzak erano sicuramente molto interessanti e rispettosi dell’ambientazione cinquecentesca di questa tragedia lirica.
A giudicare dagli applausi finali, il pubblico romano ha gradito il risultato complessivo, senza però esaltarsi più di tanto. Il cast vocale è stato capeggiato da Marina Rebeka nel ruolo di Maria Stuarda, soprano lettone che si è messa in gioco con una partecipazione totale e coinvolgente. Ci sono ancora margini di miglioramento per quel che riguarda la quadratura musicale, ma la sua regina di Scozia ha conquistato l’applauso più convinto e sonoro degli spettatori grazie agli acuti mai risparmiati e in grado di trascinare e coinvolgere. Carmela Remigio ha mostrato di aver studiato a fondo l’interpretazione di Elisabetta, una performance rispettosa e autoritaria.
Il fraseggio era ben definito, con un registro medio di discreto interesse, mentre le agilità sono state affrontate con parecchia attenzione, un atteggiamento che di tanto attenuava le tonalità altere che caratterizzano questo personaggio. La presenza scenica è stata comunque molto buona, con una immedesimazione che non è poi così scontata. Come accade spesso nell’opera donizettiana, il grande spazio concesso dal compositore bergamasco alle regione relega in secondo piano tutti gli altri cantanti, anche se non sono mancati gli spunti positivi. Gli acuti di Paolo Fanale (Roberto di Leicester) erano spesso coperti dall’orchestra, un dettaglio che non ha permesso di valutarne pienamente l’emissione.
Il tenore palermitano si è affidato a un fraseggio che potesse essere il più efficace possibile, anche se va riconosciuta una buona immedesimazione scenica, nonostante si stia parlando di un personaggio che è piuttosto pallido dal punto di vista drammaturgico. Il Talbot di Carlo Cigni era senza dubbio apprezzabile per quel che concerne il carattere pietoso e compassionevole, senza dimenticare Valentina Varriale, una delle artiste del progetto “Fabbrica” del Teatro dell’Opera di Roma che ha tratteggiato una Anna Kennedy credibile e realisticamente prostrata al cospetto di Maria Stuarda. Discreto elemento Alessandro Luongo, un Lord Cecil borioso e strafottente.
Il coro ha un ruolo più evidente di quello che si possa pensare in questa tragedia, come sottolineato dal maestro del coro del Costanzi, Roberto Gabbiani: la sua presenza preannuncia quella fondamentale e decisiva che negli anni successivi a “Maria Stuarda” verrà incentivata da Giuseppe Verdi e i coristi romani hanno accompagnato con garbo sia i momenti intimistici che quelli più movimentati dell’opera. L’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma è stata diretta con piglio sicuro e attento da Paolo Arrivabeni. Al direttore mantovano va riconosciuto il merito di aver “rispolverato” con cura la partitura originaria.
L’impronta è stata precisa, con l’obiettivo subito chiaro di voler mettere in risalto l’eredità rossiniana di questa tragedia lirica e le anticipazioni verdiane, con momenti intensi e solenni. Forse qualche tempo è stato reso con un ritmo un po’ troppo lento, ma l’assetto complessivo non può certo essere disdegnato. Gli applausi più fragorosi sono stati riservati, come vuole la tradizione, alla Rebeka e alla Remigio, anche se il pubblico del Teatro Costanzi è stato più appassionato in altre occasioni. Da sottolineare, infine, alcune fastidiose interruzioni di luce nel corso del primo atto che hanno reso surreale l’atmosfera, con la platea e i palchi illuminati e il palcoscenico nella semioscurità, un problema risolto dopo diversi minuti.
LE NOZZE DI FIGARO [Lukas Franceschini] Bolzano, 1 aprile 2017.
Al Teatro Comunale di Bolzano è stata rappresentata l’opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, unico titolo non contemporaneo della Stagione Lirica “Oper A 20-21” 2017.
Una produzione importata interamente da Lipsia, spettacolo e cast, coproduzione tra Fondazione Haydn di Bolzano-Trento e Oper Leipzig. Scelta piuttosto opinabile, si sarebbe potuto collaborare alla produzione dello spettacolo e allestire l’opera con un cast specifico per la città del sud Tirolo, tuttavia le scelte della direzione artistica sono state diverse e purtroppo abbiamo avuto una rappresentazione che denotava parecchie lacune musicali.
Lo spettacolo era ideato da Gil Mehmert, regista, Jens Kilian, scenografo, e Falk Bauer, costumista. La scena era composta di un impianto fisso di una ricca casa anni ’60 del XX secolo, sviluppata su tre piani collegati da scale a chiocciola o a elisse. Si potevano chiaramente vedere le stanze da letto dei protagonisti e dei servi, nel piano di mezzo una serie di porte attigue che fungevano da guardaroba e servizi, al piano terra una rimessa per attrezzi da giardino, e con qualche veloce cambio scena, la nuova magione dei novelli sposi o il giardino per la scena finale. Non una novità questo tipo di struttura a vista, ma la felice mano di Kilian è elegante e misurata la sobrietà nei colori. I costumi sono tradizionalmente in stile con l’epoca in cui è sviluppata la vicenda (drammaturgia di Elisabeth Kuhne), molto cromatici di buona fattura, salvo qualche eccesso di colore e stile se indossati da cantanti che non hanno fisico corrispondente all’idea al design, si poteva essere più accorti. La visione nel complesso era piacevole e dava modo con molta leggerezza di spostare l’azione in ambienti diversi. La regia di Gil Mehmert è sufficientemente curata nelle peculiarità drammaturgiche facendo vivere “la folle giornata” con ritmo e incisiva sequenza di avvenimenti. Avremo preferito che non scivolasse su gags ormai logore, che nel teatro d’opera non trovano più spazio, come ad esempio il rockettaro Cherubino. Avrebbe potuto usufruire meglio la situazione scenica, con tutte quelle porte che avremo immaginato più utilizzate per entrate e uscite repentine offrendo maggior brio e vivacità. Non sapendo come impiegare il coro, questo è fermo e immobile, nobilitando la folta servitù del conte schierata. Nel complesso non era una regia innovativa ma neppure brutta, mancava solo di qualche idea più azzeccata. Poco efficaci le luci di Andreas Fuchs, in particolare nel notturno del quarto atto.
Sul podio abbiamo trovato Enrico Calesso, un giovane direttore trevigiano che svolge la sua carriera prevalentemente in area tedesca. La sua era una concertazione molto raffazzonata e poco precisa, soprattutto negli attacchi e nella scelta dei tempi. Inoltre, non mi è parso di ascoltare una chiave di lettura omogenea ma una scollante tempistica e poca coesione tra orchestra e palcoscenico. Avendo a disposizione l’Orchestra Haydn poteva ottenere molto di più, tanto che la stessa compagine era di sotto le qualità più volte ascoltate sia nel sinfonico sia nell’opera.
Molto bravo il Coro Haydn, preciso e uniforme, ben istruito da Luigi Azzolini.
Un altro aspetto imbarazzante è stato il cast dei solisti, molto precario. Come sopra accennato, ci si domanda se valeva il gioco della trasferta da Lipsia. I migliori erano coloro che interpretavano le parti secondarie. Un bravissimo Don Curzio era Patrick Vogel, Marco Camastra istrionico e manierato Antonio, Magdalena Hinterdobler delicata Barbarina, Karin Lovelius simpatica e spiritosa Marcelliana, Randall Jakobsh un vigoroso Don Bartolo.
Note non positive erano rappresentate dall’insignificante Figaro di Sejong Chang, voce molto limitata sia in volume sia in estensione e con una linea di canto povera di armonici, e da Gal James, una contessa esile e sfibrata con blanda personalità vocale.
Inespressivo il Basilio di Dan Karlstrom e poco coeso l’intervento delle due ragazze, Maria Eleni Giuliani e Anna Pellizzari.
Accettabile ma troppo sui generi il Cherubino di Wallis Giunta, più interessante il Conte istrionico di Mathias Hausmann pur non mantenendo sempre una linea di canto omogenea, il sillabato dell’aria era precario, ma la voce è importante e di buon colore. La migliore del cast era Olena Tokar, una Susanna molto rifinita in colori e accenti, mai petulante e con un buon stile vocale, preciso e molto musicale. Troppo poco per un titolo mozartiano d’eccellenza, ma dobbiamo anche accettare che in una stagione molto positiva un titolo poco azzeccato può capitare.
Il Teatro Comunale di Bolzano era quasi al completo e al termine il pubblico ha tributato a tutti un caloroso applauso di approvazione.
TOSCA [Natalia Di Bartolo] Palermo, 2 aprile 2017.
Viene da pensare, a volte, assistendo dal vivo ad un’opera arcinota come Tosca di Giacomo Puccini, che se lo stesso cast in scena oggi si fosse presentato in palcoscenico vent’anni fa, l’effetto sarebbe stato prorompente. Eppure alcuni cantanti della generazione d’oro degli anni ’80 e ’90 sono ancora sul palcoscenico e li ritroviamo ancora oggi sorprendenti. Probabilmente, in un successivo ricambio generazionale, la longevità delle voci non sarà la stessa: diversi i tempi, diversi i maestri, diversa, forse, anche la tempra. Tempra d’acciaio, sempre in gioco, quindi, a Palermo, per Fiorenza Cedolins e Marcello Giordani, rispettivamente Tosca e Cavaradossi nella produzione del Teatro Massimo di Palermo, realizzata dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ed andata in scena il 2 aprile 2017.
Fiorenza Cedolins ha cantato uno dei suoi must sulla scena e, obiettivamente, la voce, non è più quella di un tempo. Ha perso spessore nel registro medio e acuto, i filati e i piano le risultano difficili da governare e i portamenti sono eccessivi e stirati. Eppure ha sprazzi di grandezza, così come momenti di cedimento, come quello in cui, pur bissandola, in “Vissi d’arte” per due volte non ha centrato l’acuto su quel famoso SI bemolle nella parola “Signor”: lo ha solo sfiorato dal basso, meglio la seconda che la prima volta; e il finale della prima esecuzione era calante non poco anch’esso.
Pur mancando la scena di tendaggi a cui aggrapparsi, comunque, la Cedolins, scenicamente ancora oggi può essere considerata una figura di riferimento per questo personaggio, al quale però ha conferito, soprattutto nel rapporto con Scarpia, un che di lascivia che Tosca non possiede; così come l’ha resa svenevole, incline alle smorfie bamboleggianti, non eroina tragica o addirittura grandguignolesca, come sempre ci è stata porta, da Sardou prima e da Puccini poi. Punti di vista, probabilmente accentuati dalla regia di Mario Pontiggia, non sempre condivisibili, ma, ovviamente, indiscutibile presenza scenica.
Quanto a Marcello Giordani, reduce da una buona prova nella Manon Lescaut a Catania, nella sovrana parte pucciniana ha riversato tutta la propria generosità d’interprete in una voce che, anche qui, purtroppo, risente dell’usura del tempo e della stanchezza di prove ardue che si susseguono in tempi ristretti. Bis pure per lui di “E lucevan le stelle”, meglio riuscito anche qui alla seconda performance. In questo caso, è stata non solo l’imprevedibilità della risposta di una voce non più fresca, ma anche, probabilmente, l’emozione che gioca brutti scherzi ancora oggi perfino ai grandi interpreti, che sono i primi, in quanto grandi, a rendersi conto dei limiti del proprio mezzo vocale a rischio e, dunque, a temerlo. È anche per questo che i bis studiati a tavolino dovrebbero essere evitati. Indiscutibile, anche per lui, la presenza scenica.
Di impasto corposo, così come corposa è la stazza, meno quanto a volume, la voce del baritono Sebastian Catana, Scarpia, che ha fornito la prova di maggiore freschezza timbrica, nonostante non fosse particolarmente espressivo scenicamente.
Gradevole il sagrestano Paolo Orecchia, altrettanto l’Angelotti di Romano Dal Zovo, corretti gli altri interpreti, ben istruito da Piero Monti il Coro, anche quello di voci bianche, del Teatro Massimo.
Last, but not least, la concertazione e direzione d’orchestra del M° Gianluca Martinenghi, che ha retto con buon polso l’orchestra del teatro palermitano, donando belle dinamiche pucciniane e bei colori, nonostante, in buca, qualche momento d’incertezza abbia incrinato la resa dell’ottima orchestra del Massimo.
La regia di Mario Pontiggia era abbastanza curata, ma, probabilmente per non mostrarsi routinaria in un allestimento tradizionale, non solo pare aver lasciato campo libero ai virtuosismi scenici della Cedolins, ma anche l’ha fatta muovere o restare ferma in momenti poco confacentisi allo svolgimento della vicenda: nella scena precedente il “Vittoria” di Cavaradossi al secondo atto, una Tosca accasciata da una parte e non, invece, avvinghiata all’amante “qual leopardo” come recita il libretto, è risultata quanto meno inconsueta. Ovviamente, l’insieme scenico ha pagato in termini di tensione drammatica, che calava decisamente di tono con imprevisti alti e bassi. Un tira e molla di emozione-relax, insomma, che non ha giovato alla coerenza dello spettacolo, comunque di complessivo buon livello.
Il tutto in una messa in scena, illuminata dalle luci di Bruno Ciulli, che al primo atto appariva sontuosa, ancor di più al secondo, calando di tono al terzo, in cui il retaggio del pavimento lucido della gemella La Traviata, in partenza in tournée con Tosca per il Giappone, si faceva sentire in tutta la sua sgradevolezza. Meno che ne La Traviata, anche in Tosca, quindi, lo scenografo Francesco Zito ha oscillato, a decrescere, tra un atto e l’altro nella qualità e nello stile della messa in scena, curando invece con attenzione i costumi.
Grande successo di pubblico per un’opera di così tanto richiamo, in un teatro che sta giustamente sperimentando di aprirsi anche al pubblico esterno, sia con i maxi schermi in piazza, che con la trasmisione in diretta streaming. Lodevoli iniziative.
DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG [Lukas Franceschini] Milano 5 aprile 2017.
Dopo ventisette anni il Teatro La Scala allestisce l’opera Die Meistersinger von Nürnberg di Richard Wagner, produzione dell’Opernhaus di Zurigo e diretta da Daniele Gatti.
I Maestri hanno avuto una frequenza piuttosto assidua alla Scala, infatti, dalla prima del 1889 (prima esecuzione in Italia) al 1962 si contano ben quattordici edizioni, poi una ripresa nel 1990, infine quella attuale. L’analisi delle stagioni passate fa ben comprendere quanto sia cambiato il repertorio teatrale, e non solo a Milano, la complessa e lunga opera wagneriana oggi in Italia è decisamente poco rappresentata, mentre in Germania è uno dei titoli del repertorio nazionale.
Composta nel periodo 1862-67 ebbe la prima rappresentazione, con esito trionfale, alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera il 21 giugno 1868, diretta da Hans von Bülow. Era ovviamente presente in sala il mecenate del compositore il re Ludwig II di Baviera. La vicenda si svolge nel XVI secolo in quella Norimberga, che fu comune imperiale uno dei centri del Rinascimento nordeuropeo. La trama si sviluppa attorno alla corporazione dei Meistersinger, un’associazione realmente esista di poeti e musicisti “dilettanti”, provenienti soprattutto dai ceti artigiani e popolari. Wagner studiò dettagliatamente le regole proprie di composizione ed esecuzione che questi artisti svilupparono all’interno del loro gruppo. Hans Sachs, poeta, ciabattino e protagonista principale, è un personaggio storico realmente esistito, fu il più famoso dei maestri cantori e una delle figure più amate della letteratura tedesca del ‘500. I maestri cantori di Norimberga sono affascianti per la fedele ricostruzione storica della città e delle tradizioni delle corporazioni. Idealmente essa è il simbolo dello spirito della “sacra arte tedesca”, elemento di coesione nazionale e popolare. Infatti, nelle parole conclusive del poema, si afferma: “Finisca pure in polvere il Sacro Romano Impero, ci resterebbe sempre la sacra Arte tedesca!”. Alcuni musicologi hanno affermato che i Cantori di Norimberga rappresentano il glorioso popolo, prima ancorato alle borghesi tradizioni, poi pronti ad avventurarsi verso una nuova verità ma restando “integri” luterani.
Unica commedia composta da Wagner, in essa riaffiorano alcune caratteristiche tradizionali che il compositore aveva abbandonato nella sua nuova concezione del dramma musicale, in particolare nell’uso dei pezzi d’assieme. Tuttavia, la presenza di monologhi, arie, canzoni, concertati e cori finali, i quali sarebbero affini al grand opéra, trovano qui una concezione drammatica anche se utilizzati in forma diversa. I Leitmotiv, utilizzati brevemente da Wagner in altre opere, nei Maestri si sviluppano in lunghe melodie che possono apparire integrate nello spirito musicale e determina, nello stile wagneriano, un’espansione melodica del leitmotiv stesso.
Lo spettacolo proposto alla Scala era del regista Harry Kupfer, Hans Schavernoch scenografo, Yan Tax costumista, Jurgen Hoffmann light designer e Thomas Reimer ideazione video. Regia molto innovativa e intellettuale, ambientata nel secolo XX subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Ci troviamo in una Norimberga interamente bombardata, infatti, la cattedrale è un rudere con dei grossi ponteggi per la ricostruzione. La chiave di lettura si sviluppa proprio su quest’aspetto, la ricostruzione non solo della città ma della società tedesca, la quale deve uscire dal nazismo, il suo periodo più buio, e lo fa attraverso la propria cultura e tradizione. Un popolo che deve prendere il coraggio di continuare e edificarsi su concetti di società che si erano appannati durante il periodo hitleriano, i valori di una società giusta e corretta ma che trova, pur nel conservatorismo dei Meistersinger anche una luce d’innovazione e novità nella figura quasi cavalleresca del giovane Walter. Sullo sfondo i video non invasivi, in bianco e nero, ci fanno vedere una continua ricostruzione edile della città con gru e palazzi che crescono. Il concetto è molto accattivante e sotto taluni aspetti emozionante, una società che deve e vuole ritrovare il suo senso di appartenenza al mondo moderno. Tuttavia, la regia si muove con molta prudenza senza trovare focalizzazioni particolari sui singoli, ma segue prevalentemente la strada della semplice narrazione, sarebbe potuta essere più sviluppata. Molto bella la scena, la cui cattedrale è poggiata su un praticabile girevole avendo così la possibilità di cambiare in continuazione la scena. I costumi, molto eleganti ci riportano a qual periodo di rinascita non solo tedesco ma europeo, e danno un senso di vintage cinematografico. Eccezionali sia il progetto video sia le luci, meno espressiva la coreografia e gli spostamenti di massa.
Sul podio il Maestro Daniele Gatti ci offre una delle sue migliori prove, a cominciare dalla splendida overture, complice un’Orchestra della Scala in forma smagliante. La sua direzione è appassionata e ammirevole, cesellata in ogni nota, seguendo un tracciato narrativo di forte impatto musicale senza mai cadere nel facile solco drammatico ma reggendo perfettamente l’equilibrio della commedia epica, con un peculiare sinfonismo sviluppato in armonie celestiali. Una grandissima prova del direttore. L’Orchestra lo segue oserei dire con “amore” e grande partecipazione, come anche il Coro, diretto da Bruno Casoni, che trova momenti eccelsi in tutti i suoi interventi.
Nel lungo elenco dei solisti emerge per proprietà d’accento e stile il Pogner di Albert Dohmen, non è da meno l’arrogante Beckmesser di un convincente Markus Werba, e il bravissimo David di Peter Sonn. La recita da me ascoltata era l’unica in cui cantava Michael Kupfer-Radecky, un Hans Sachs molto equilibrato e prudente, che dimostrava ottimo fraseggio e piena capacità di colore anche se la voce era tendenzialmente piccola e penso il personaggio da mettere più a fuoco in futuro.
Piuttosto anonima sia per carisma sia per proprietà vocali la Eva di Jacquelyn Wagner, più incisiva la Magdalene di Anna Lapkovskaja.
Le note più infelici erano per il Walter di Erin Caves, che subentrava a un collega già dalla prima, un tenore poco eroico e con molte lacune tecniche che apparivano al terzo atto perfino imbarazzanti.
Molto uniforme l’ensemble dei Meistersinger che era composto da Iurie Ciobanu (Kunz), Davide Fersini (Konrad), Markus Petsch (Balthasar), Neal Cooper (Ulrich), Stefan Heibach (Augustin), James Platt (Hermann), Dennis Wilgenhof (Schwarz), Milkos Ebestyén (Foltz), ed emergeva il bravo Detlef Roth (Kothner). Impeccabile il guardiano notturno di Wilhelm Schwinghammer.
Molto coesi anche i giovani apprendisti: Oreste Cosimo, Aleksander Rewinski, Jungyun Kim, Jèrémie Schutz, Francesco Castoro, Santiago Sanchez, Omer Kobiljak, Katrin Heles, Alice Hoffmann, Dorothea Spilger, Franziska Weber, Sofiya Almazova, Mereike Jankowsky, molti dei quali erano allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala.
Successo pieno e convinto con particolari acclamazioni per il maestro Gatti, da parte dello scarso pubblico, gli assenti hanno perso una rara e preziosa occasione.
NORMA [Renata Fantoni e William Fratti] Ferrara, 7 aprile 2017.
Lo spettacolo andato in scena al Teatro Comunale di Ferrara, coprodotto con Treviso, si avvale di scenografie dipinte che riprendono l’allestimento originale della prima rappresentazione dell’opera nel 1831 firmato da Alessandro Sanquirico.
Talvolta è piacevole assistere a questo ritorno al passato, ma se non corredato di una regia minuziosa e puntuale, risulta essere soltanto polveroso. Purtroppo il lavoro di Alessandro Londei è pressoché inesistente, molto più breve di quanto non siano le note pubblicate sul programma di sala. Le idee potranno essere anche interessanti, ma non sono sviluppate sul palcoscenico. Pertanto si assiste solo ad una serie di ingressi, qualche gesto e uscite. Fortunatamente le due protagoniste femminili ci mettono del loro e risultano credibili, mentre Pollione sembra un tarantolato e Oroveso appare inchiodato e inamovibile. Buono il primo ingresso del coro, mentre per il resto è soltanto piazzato. In più ci sono i soliti mimi che si agitano, che sempre più spesso popolano gli spettacoli provinciali che hanno bisogno di essere riempiti in qualche modo. Apprezzabili i costumi di Veronica Pattuelli e le luci di Roberto Gritti.
Qualche ombra invade anche l’ambito musicale. Sergio Alapont è un direttore alterno, con dei bei momenti di belcanto e altri più noiosi. Lo stesso vale per l’Orchestra Città di Ferrara, che si produce in un bel suono in certe pagine, mentre è approssimativa in altre. Corretto ma leggermente insipido è il Coro Ensemble Vocale Continuum.
Silvia Dalla Benetta è una Norma deliziosa. È annunciata indisposta – si apprende poi dai social network che si tratta di una grave infezione alle vie respiratorie – ma tale inconveniente è circoscritto a un minor velluto e un poco ridotto vigore. Per il resto la sua è una vera e propria lezione di bel canto: intonazione impeccabile, tecnica perfetta, stile raffinato, portamento elegante, fraseggio eloquente.
La giovane Yulia Gorgula è un’Adalgisa morbida e delicata, con una buona ed omogenea linea di canto. Peccato che le note più estreme, sia in alto che in basso, siano piuttosto imprecise.
Nelson Ebo è un Pollione da dimenticare. Ottimo materiale vocale ma privo di tecnica e ogni nota se ne va alla deriva, denotando problemi di ogni sorta sui fiati, sulla maschera, sull’appoggio e sul passaggio.
Il giovane Volodymyr Tyshkov è un Oroveso precario, Valentina Corò è una Clotilde poco intonata, Eder Vincenzi è un Flavio accettabile.
LA VOIX HUMAINE – CAVALLERIA RUSTICANA [Lukas Franceschini] Bologna, 13 aprile 2017.
Inedito dittico quello presentato al Teatro Comunale di Bologna, La Voix Humaine di Francis Poulenc e Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, diretto dal direttore principale Michele Mariotti e in un nuovo allestimento ideato da Emma Dante.
In effetti, il francese Poulenc e il livornese Mascagni non hanno nulla in comune soprattutto dal punto di vista compositivo e professionale. Ciò non toglie che sono dei nomi importanti nel panorama musicale europeo, anche se operarono in periodi differenti. L’accostamento delle due opere si sviluppa esclusivamente sul piano drammaturgico, le protagoniste sono due donne abbandonate dal loro uomo, il quale ha pure un comportamento poco onorevole, tanto da infliggere una ferita forte, in un caso letale. Un legame che trova una visione umana e sociale appropriata nel focalizzarsi sull’elemento femminile, non certo fragile, ma che soccombe a eventi che non può e non riesce a cambiare.
La regia era affidata a Emma Dante, la quale volutamente ha deciso di realizzare due spettacoli differenti e senza comune drammaturgia. Più riuscita la realizzazione dell’opera francese, nella quale i pochi elementi erano costituiti da due pareti bianchissime, un letto, comodino e telefono. A prima vista sembra un ambiente borghese anni ’60, poi durante il dialogo telefonico della protagonista, si percepisce che il luogo è una lussuosa clinica psichiatrica. L’ambiente ospita la paziente che è in preda al delirio dell’abbandono, nella sua folle visione rivive o vorrebbe vivere le sensazioni di un colloquio con l’amato fino alla tragica conclusione. Sono apparse superflue le apparizioni fugaci degli attori, i pur bravissimi Allievi della Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone, ma in compenso abbiamo avuto una impressionate attrice, bravissima esecutrice nella scansione della parola del respiro, più azzeccata rispetto a un canto forbito ma, in effetti, limitato dallo spartito. È Anna Caterina Antonacci la trionfatrice della serata, artista che desta stupore per la trasformazione psicologica in questo ennesimo ruolo, cui va sommata una bellezza eterea e una movenza da grande primadonna.
Ben diversa la situazione in Cavalleria Rusticana, forse volutamene tutta in nero per creare il contrasto con la precedente opera. Idea in parte azzeccata, peccato però che la Dante abbia voluto calcare la mano su una visione di elementi religiosi popolari troppo opprimente. Abbiamo visto in continuazione la sfilata della processione di Cristo che porta la croce, le scene mimiche della Madonna che piange il figlio, una sorta di ragazze giullari-circensi che accompagnano Alfio, e chi può più ne metta. Sono “quadri” che forse si rifanno alla tradizione siciliana, ma francamente poco comprensibili, soprattutto se predominano sull’aspetto sociale della vicenda, nella quale i personaggi sono lasciati a libero agire e poco focalizzati, tolta la scena finale dove le due madri, Lucia e Maria, trovano una convergenza per aver entrambe perso il figlio in situazioni agli antipodi. Uno spettacolo nel complesso poco chiaro e troppo soffocato drammaturgicamente in cui manca la tinta sociale dell’omertà. Carmine Marignola, scenografo, ha mano più felice nella Voix Humanine, in Cavalleria tolto una scala scomponibile, non c’è altro. I costumi di Vanessa Sannino sono pertinenti e attutali. Cristian Zucaro avrebbe potuto in entrambi i casi di effetti luci meno statici.
Il cast non presentava nulla di realmente valido ma una stantia routine. Carmen Topciu è una corretta Santuzza alla quale però manca la scansione degli accenti e un registro acuto valido, Marco Berti, Turiddu, che sarebbe tenore ideale con ottimi mezzi, è più preoccupato a mostrare le peculiarità della voce a scapito di fraseggio e intenzioni interpretative. Professionale Gezim Myshketa, Alfio, ma non lascia traccia indicativa. Brava Anastasia Boldyreva una Lola sensuale e mediocre la mamma Lucia di Claudia Marchi.
Infine, ma non per ultimo, il direttore Michele Mariotti, che debuttava in entrambi i titoli. Mariotti ha studiato molto gli spartiti, e si sente, concertando Poulenc con arguta maestria di colori, e tinte sprezzanti ma tenendo assieme il difficile rapporto con la solista in maniera encomiabile, anche se era l’unica strada percorribile. In Cavalleria Rusticana non ha voluto essere influenzato da nessun’altra lettura, ma ha seguito il suo istinto musicale che gli ha permesso di cesellare con grande precisione i colori e le scansioni sia armoniche sia timbriche. Mai sopra le righe, ma con un grande concetto narrativo, dove il suono sempre robusto e raffinato erano il comune denominatore di una direzione molto ragguardevole non priva di momenti di grande effetto. Lo seguiva con devozione un’Orchestra molto diligente e un Coro diretto da Andrea Faidutti, in Mascagni, altamente professionale e preciso.
A termine successo pieno per tutti, con ovazioni per la Antonacci e Mariotti.
ANNA BOLENA [Lukas Franceschini] Milano, 14 aprile 2016.
Terza edizione di Anna Bolena di Gaetano Donizetti al Teatro alla Scala, nel quale pare che l’opera non trova la giusta realizzazione e il successo che merita quale capolavoro della cosiddetta trilogia Tudor.
Dopo l’esordio memorabile del 1957 con Gavazzeni sul podio e un cast stellare, lo stesso spettacolo, di Luchino Visconti, fu riproposto nel 1982 nel venticinquesimo anniversario, in un burrascoso momento scaligero, per arrivare all’oggi con una proposta che alla prima ha suscitato proteste accese.
Produzione “nata male” sin dalla programmazione, pare che il ruolo in titolo fosse stato offerto ad Anna Netrebko, la quale in seguito ha preferito rifiutare e accomodarsi nelle tre più tranquille recite de La Traviata. Non trovando altro nome blasonato si è deciso di puntare su un nome sconosciuto, affiancato da altre personalità musicali di nota esperienza. Resta un mistero l’uscita di scena di Bruno Campanella, direttore annunciato, sostituito senza annunci da Ion Marin. Infine, la scelta dello spettacolo che proveniva da L’Opéra National di Bordeaux (2014) ove non ebbe grande successo ma critiche piuttosto pesanti. Considerati i fatti, sarebbe stato più opportuno cambiare titolo, soprattutto perché il pubblico della Scala pretende molto dal suo teatro.
Passate le forti turbolenze della prima, alla quinta recita, alla quale ho assistito tutto è filato liscio come accoglienza, non si cancellano invece le molte perplessità. In primo luogo lo spettacolo curato da Marie-Louise Boschofberger, la quale non trova una lettura drammaturgica accettabile ma si limita a illustrare una tragedia nello stile cartolina, senza un filo conduttore chiaro e soprattutto d’effetto. Assieme alla regista non aiutano sicuramene i costumi atemporali di Kaspar Glarner e soprattutto le scene discutibili di Eric Wonder, indeterminate, con ambienti poco realistici e bui, un incomprensibile rombo sghembo sul fondale che non lascia traccia, unico elemento azzeccato il trono, che ribaltato nel finale si trasforma nel patibolo. In quest’ambiente la mano della Bischofberger non trova idee particolari, e quando le realizza sono tutto bol 4sommato scontate, come quella di aggiungere una bambina-mima che impersonala la piccola futura Elisabetta I. Ambientazione quasi unica, senza grandi momenti di teatro e anche nelle fasi concitate, finale I, nulla fa pensare alla tensione emotiva della protagonista. In definitiva uno spettacolo molto dozzinale e poco edificante sul piano teatrale come l’insensato velo nero che avvolge Bolena nel finale dell’opera.
Il direttore Ion Marin, il quale ha fornito nel corso della sua carriera performance molto rilevanti, non trova un terreno altrettanto fertile nel repertorio belcantistico. Infatti, è stata una vera sorpresa trovare il suo nome in locandina. Marin inoltre applica una serie di tagli, cabalette senza daccapo e sforbiciate varie, che rendono l’opera molto debilitata nel suo spirito e nella stessa teatralità. L’orchestra e il Coro, diretto da Bruno Casoni, rispondevano con impegno e ottima professionalità ma la scansione dinamica, i tempi, ritmo e colori imposti dal direttore rendevano il capolavoro donizettiano molto ridimensionato e non soddisfacente.
La protagonista Hibla Gerzmava si può definire solo volenterosa. La voce è bella, le intenzioni anche apprezzabili in particolare nel fraseggio, ma gli accenti sono monotoni e tralascia molto passi importanti non mancando una buona musicalità solo nell’aria finale ma non nella cabaletta poiché il registro acuto è limitato.
Sonia Ganassi, Seymour, che a Parma aveva fatto una bella figura qui l’abbiamo trovata molto ridimensionata e il personaggio, sia interpretativamente sia vocalmente era poco incisivo e sovente monotono.
Ancor più perplessità ha destato l’Enrico VIII di Carlo Colombara, cantante che presumo stia passando un momento infelice poiché il canto era sfibrato e parlato, mancando di spessore e autorità convincenti.
Corretto il Percy di Piero Pretti, al quale manca di una struttura tecnica più elevata per eseguire lo spartito difficilissimo, tuttavia riesce a essere accettabile anche con l’aiuto dei tagli effettuati. Professionale Martina Belli, Smeton, musicale ma con voce troppo chiara per il ruolo e latitante nel canto fiorito.
Completavano la locandina il corretto Mattia Denti, Rocherfort, e il giovane Giovanni Sebastiano Sala, Harvey, allievo dell’Accademia Scala, che sarebbe da rivalutare in altra occasione.
Pubblico molto partecipe e caloroso di applausi con tutta la compagnia al termine, le turbolenze della prima erano ormai archiviate ma l’appuntamento con Anna Bolena alla Scala è rimandato.
TOSCA [Natalia Di Bartolo] Baden-Baden, 17 aprile 2017.
Una delle caratteristiche che contraddistinguono le grandi orchestre è la flessibilità. Dunque, quando a eseguire l’Opera sono i Berliner Philharmoniker, si fermi il mondo.
La meraviglia di un’orchestra del genere è anche la fluidità d’esecuzione, la docilità di risposta al gesto direttoriale, la capacità di ascoltare e supportare i cantanti anche al di là del direttore stesso. Dunque l’esperimento Tosca del M° Sir Simon Rattle, per il Festival di Pasqua 2017 al Festspielhaus di Baden-Baden, dal punto di vista orchestrale è riuscito. Il concertatore e direttore principale dei Berliner ha tenuto l’orchestra in pugno e s’è fatto tenere in pugno dall’orchestra. Una reciprocità che, come la flessibilità di cui sopra, è propria solo delle grandi compagini orchestrali.
Con materiale sonoro del genere in buca, i “suoi” Berliner, il M° Rattle ha dato vita ad una serata pucciniana, il 17 aprile 2017, con un capolavoro la cui resa melodica e armonica è stata lodevole. Nonostante qualche indugio nei tempi nel Te Deum al primo atto, qualche momento che avrebbe necessitato di meno lirismo e di uno stringere più nervoso dei tempi, la direzione del M° Rattle è stata irreprensibile. Grandi colori sparsi a profusione, con dinamiche sottolineate magistralmente. Anche il supporto ai cantanti è stato curato allo spasimo: cantare con i Berliner non è roba da poco. Lo sapevano bene gli interpreti, che ne apparivano, a tratti, anche intimiditi, ma lo sapeva assai bene soprattutto il Maestro, che ha contenuto la piena dal golfo mistico, scatenandosi in virtuosismi nei momenti solo orchestrali.
Intimidito, in particolare, sembrava Marco Vratogna, uno Scarpia che avrebbe necessitato di un maggiore agio nella zona acuta e di meno spinta nei forti. Tutto sommato corretto, era però anche spiazzato e lasciato a se stesso dalla regia. Ma se ne riparlerà…
Avendo iniziato a ritroso con gli interpreti principali, si passa al Cavaradossi di Marcelo Álvarez, il quale sembrava assolutamente convinto di essere un protagonista maschile di tutto rispetto, impegnato soprattutto a sfoggiare le proprie capacità di tenore eroico. Ad onta dei suoi sforzi, il fraseggio era assai poco elegante, il legato a tratti inesistente…il bel canto, insomma, era accantonato a favore di un sillabare le frasi musicali e perfino le singole parole. In E lucevan le stelle, il tenore forzava le T e le raddoppiava: ascoltare un “Che non ho ama-TTO mai TTAn-TTO la vi-TTA” per dare al finale delle parole il risalto che reputava necessario, per esempio, ha prodotto solo una mancanza assoluta di eleganza e confermato l’assenza di stile di una voce che, se correttamente emessa ed espressa, potrebbe essere notevole. La mancanza di eleganza, poi, non era da meno, purtroppo, neanche nell’interpretazione. La regia non lo aiutava per niente…
E, dulcis in fundo, la Tosca di Kristine Opolais, che era tutta un “callassare” nelle movenze, ma vocalmente, per fortuna, era la migliore in scena: almeno lei la voce l’aveva tutta. Anche troppa, in verità, quando, così come ha fatto, si prende un SI naturale anziché un SI bemolle in Vissi d’arte, nell’acuto su “Signor”, cioè si sale di tono, forse a ragion veduta, per evitare il tanto temuto calo. E poi, perché un fiato fuori posto che spezzava una delle frasi larghe e splendide, sempre in vissi d’arte? Un vero peccato, perché la Opolais di fiato ne ha tanto. Di espressività, invece, non molta, nonostante la prova di perizia scenica da mancata attrice hollywoodiana. La sua Tosca era priva di tensione drammatica, era troppo recitata, in un contesto che poi, per il resto, era davvero fuori luogo e fuori posto in ogni senso.
Bypassando il pur corretto Angelotti di Alexander Tsymbalyuk, costantemente ammanettato con le mani dietro la schiena (come avrà fatto a svuotare il paniere di Mario dal cibo per nutrirsi?); non ignorando le sottese tendenze pedofile imposte dalla regia al sagrestano, Peter Rose, nei confronti di un ragazzino che poi è stato “utilizzato” senza alcun nesso logico come solista per la canzone in romanesco del pastore al terzo atto; i mediocri comprimari con seri problemi di dizione italiana (e non solo) e il Philharmonia Chor Wien, pur gradevole e ben istruito da Walter Zeh, non si è potuto che cogliere sui volti degli spettatori una sconsolata perplessità nei confronti della nuova produzione di Philipp Himmelmann.
Chi scrive non può togliersi dalle orecchie un’intervista con un altro dei più rampanti registi sulle scene tedesche, che quasi si giustificava contrito per non aver potuto trasporre nel tempo un’opera che necessitava assolutamente dell’ambientazione storica nella quale era stata creata. Si arriva oggi a tali paradossi! Bene, quell’opera non era Tosca…ma anche per Tosca lo Himmelmann avrebbe dovuto fare lo stesso ragionamento di quel regista, che una volta tanto lasciò tutto al proprio posto nel proprio tempo.
E qui si riprende il discorso accennato prima a proposito degli interpreti principali, mossi come pedine su un immenso palcoscenico semivuoto e squallido. Troppi film di fantascienza nel bagaglio visivo di questo regista, nelle scene algide e sgradevoli e nei costumi impersonali. Il sostegno agli interpreti, era anch’esso distorto e spesso li si lasciava a se stessi. Risultato di assoluta approssimazione all’approccio con un capolavoro.
Scarpia era a capo di una sorta di confraternita malefica alla Matrix, uniformato nell’aspetto con i suoi scagnozzi, coro compreso nel Te Deum. Ma perché, se l’ambientazione, il tempo, lo snodarsi della vicenda e tutto il resto sono porti dal libretto su un piatto d’argento? Il libretto reca pure la data: è ambientato a Roma nel giugno del 1800, nella chiesa di S. Andrea della Valle al primo atto, a Palazzo Farnese nella camera di Scarpia al piano superiore al secondo e sulla piattaforma di Castel Sant’Angelo nel terzo, checché se ne dica, checché se ne pensi, volendo financo ignorare l’originario dramma in prosa del Sardou.
Il viso della Maddalena-Attavanti al primo atto era stampato su un maxi-schermo…ma non solo: il suo ritratto era dipinto sul pavimento di S. Andrea della Valle. Trovata assurda in ogni senso, non solo perché ben pochi spettatori l’hanno potuto vedere, come con spicciolo senso pratico rilevava il critico di un giornale americano, ma soprattutto perché è impensabile che dentro una chiesa qualsiasi, sia pure in qualsivoglia tempo, un pittore dipinga sul pavimento, neanche fosse stato un madonnaro. E senza offesa per questi artisti, che a volte sono più bravi dei pittori ben più celebri di loro.
Poi quella sottesa tendenza complessiva della regia al voyeurismo, tutti quegli schermi e quelle riprese, un déjà vu da Biennale di Venezia anni ’90. Una trovata un po’ attempata, se non altro, da padiglione della mostra veneziana che forse allora poteva destare qualche “ohhh” di meraviglia. I media nella Tosca? A che pro? Qui si annunciava la sconfitta di Melas a Marengo e se ne verificava la veridicità al computer!
Fucilazione, poi? Obsoleta. Eppure Scarpia dice: “il prigionier sia fucilato!” Invece qui Cavaradossi muore con un colpo in testa inferto da una pistola per mattazione, che poi la stessa Tosca utilizza per il suicidio. No comment, se non che Illica e Giacosa, insieme a Sardou, si saranno rivoltati nella tomba.
Lo sgomento sui visi degli spettatori era palese, come prima si accennava. Applausi soprattutto alla parte musicale, quindi, che si è dimostrata il punto forte della serata; e qualche dissenso. In attesa che questa produzione faccia il giro dei grandi teatri…
DON CARLO [Natalia Di Bartolo] Genova, 21 aprile 2017.
Tutto un debutto il Don Carlo di Giuseppe Verdi, versione 1884 in quattro atti, a Genova il 21 aprile 2017 al teatro Carlo Felice. Una serata di debuttanti nell’opera verdiana, tra cui, per primo, il direttore d’orchestra, il M° Valerio Galli.
Se consideriamo che non meno del 70% della riuscita di un’opera sta nella corretta direzione d’orchestra, un debuttante come il M° Galli ha sorretto un vero macigno, ma con non poco sforzo. Proveniente da un imprinting esclusivamente o quasi pucciniano, il Direttore si è impelagato in un’impresa titanica, che avrebbe fatto tremare le ginocchia a chiunque, anche ai direttori più blasonati.
Risultano dalla sua biografia, brevi “contatti” verdiani con “Il Trovatore “ e “Un ballo in maschera”….Nient’altro. Allora bisogna convenire che approcciarsi al Don Carlo, capolavoro monumentale, in una fase così anticipata rispetto a quello che dovrebbe essere il normale sviluppo di una carriera direttoriale riguardo alle opere di Giuseppe Verdi è stato quanto meno azzardato. Chi scrive pensa che prima di arrivare a governare debitamente un’opera come il Don Carlo, un direttore, sia pure relativamente giovane (il Maestro Galli ha 38 anni) debba accostarsi a Verdi con timore reverenziale e iniziando da opere ben più note (di più facile, in Verdi, non c’è proprio niente) e quindi anche più brevi e comunque più collaudate, se non altro anche all’ascolto. Il Direttore può aver ascoltato anche l’opera omnia riguardante il Don Carlo, ma prima di renderlo proprio occorrerà ancora molto tempo, molta strada fare e soprattutto molta umiltà.
La sua direzione, in definitiva, quindi, si è dimostrata discontinua, a tratti slegata. La resa agogica addirittura ne veniva coinvolta e alterata. Il “tutto forte” da tutte le sezioni era pesante da ascoltare, gli attacchi non arrivavano, a volte sembrava di essere in levare anziché in battere e viceversa. Una squadratura scolastica, la mancanza di dinamiche adeguate e un insieme confuso e disarmonico caratterizzavano il tutto. I cantanti, poi, a momenti, dettavano legge sovrastando la direzione; a volte, invece, era come se restassero soli e smarriti sul palcoscenico. Nei concertati è accaduto anche questo.
Dunque è consigliabile per il Direttore Galli, prima di affrontare di nuovo il capolavoro verdiano, di farsi un bel po’ di gavetta, magari dalle parti in cui Peppino è nato ed è venerato come una reliquia. Non si sa bene, se avesse diretto questo Don Carlo in quelle contrade, come sarebbe andata a finire con la falange peppiniana degli ultras…
Eppure il capolavoro verdiano è un panzer e ti prende, c’è poco da fare, anche perché il cast era di debuttanti, ma solo parzialmente.
Al debutto nel ruolo anche la più “debole” in scena, la Elisabetta di Svetla Vassileva, che ha reso un personaggio senz’anima, nonostante cercasse di essere ligia ai dettami registici, che a volte, poi, non erano così aderenti al testo del libretto. E, a proposito di testo, la bella cantante bulgara dovrebbe ripassarsi meglio le parole, a volte ha pure scambiato il verbo avere con il verbo essere e si è inventato qualche termine: quando canta in Italia gli ascoltatori se ne accorgono! La voce, poi, è potente, anche troppo. Quando si possiede una voce grande bisogna saperla modulare e non spingere come una forsennata, oltretutto senza motivo, soprattutto al primo atto. Filati inesistenti, piano assenti o quasi, espressività da tutt’altra parte. Un soprano che, tutto sommato, però, potrebbe essere una buona Elisabetta, e che quindi necessita di maturare ancora un bel po’ la parte e soprattutto d’immedesimarsi in ciò che canta.
Lode a questo proposito al tenore venezuelano naturalizzato spagnolo Aquiles Machado, nei panni del protagonista Don Carlo, che, pur non avendo una voce particolarmente brillante, soprattutto negli acuti che vibravano un po’ troppo, è entrato in parte ed ha beccato in pieno il personaggio. Questo fa moltissimo ed il risultato è stato credibile . La figura di Don Carlo non è facile da rendere: va adeguata anche al concetto spicciolo di “cane bastonato”, che è difficile da cogliere. Pochi tenori ci riescono, presi dall’impegno vocale e dall’albagia da protagonista. Qui, invece, c’era tutto, sentito ed espresso.
Un altro debuttante, Riccardo Zanellato, Filippo II, era molto preso dalla parte vocale e meno da quella scenica. Un maggiore senso di algida, arrogante regalità non gli starebbe male: l’imponenza fisica c’è tutta, quella vocale un po’ meno, soprattutto nei gravi profondi, ma il suo “Ella giammai m’amò” è stato ben cantato. Però la parte di Filippo va ben al di là di questo celeberrimo brano ed anch’egli ha ancora molto da lavorare su questo personaggio, che spesso è la vetta per un basso, quella inseguita e perseguita da una vita. Ma lo Zanellato ha le potenzialità per arrivarci anch’egli, mettendolo a fuoco, dosando meglio voce e scena e amalgamando meglio il tutto.
Molto gradevole, con un bellissimo legato e una presenza scenica appropriata il Rodrigo di Franco Vassallo, che anch’egli, come il Machado, ha azzeccato in pieno lo spirito del personaggio.
Dulcis in fundo, un vero monumento della lirica di ieri e ancora di oggi: la Eboli di Giovanna Casolla, che, nonostante la staticità scenica che denuncia anche una scuola d’altra epoca, ha ancora voce da vendere.
Piuttosto chiara la vocalità da basso del grande inquisitore Marco Spotti, ma del tutto corretta e apprezzabile; altrettanto quella di tutti gli altri interpreti in scena. Bene il coro del teatro genovese, guidato da Franco Sebastiani.
La produzione diretta da Cesare Lievi, nell’allestimento in coproduzione tra Fondazione Teatro Carlo Felice, Fondazione Teatro Regio di Parma e Auditorio de Tenerife “Adán Martìn”, era marmorea, di aspetto monolitico, ma gradevole nel complesso e la regia, con qualche défaillance rispetto al libretto, era curata. Oltretutto, al finale, finalmente Don Carlo viene trascinato nel sepolcro dal nonno Carlo V, che appare in tutta la propria regalità: non lo fa più nessuno! Regia tradizionale, quindi, che ha dato qualche tocco d’effetto, come nelle ombre cinesi mascherate della festa, nella scena I del secondo atto, così come nell’Autodafé, che è stata gestita correttamente, riguardo soprattutto alle masse.
Le scene di Maurizio Balò viravano sui toni del marmo bianco, i suoi costumi vi spiccavano di scuro e le luci ben dosate di Andrea Borelli hanno reso fin dall’inizio la corretta atmosfera chiesastica e quasi sepolcrale che caratterizzava l’intera messa in scena.
Una serata potenzialmente di livello che, se meglio diretta, avrebbe brillato nel cartellone del teatro genovese.
LUCIA DI LAMMERMOOR [Lukas Franceschini] Venezia, 21 aprile 2017.
Al Teatro La Fenice una nuova produzione di Lucia di Lammermoor, opera considerata il capolavoro di Gaetano Donizetti, merito raggiunto anche per l’immensa popolarità che indubbiamente le conferisce il titolo di grande opera della prima metà del XIX secolo, mai uscita dal repertorio.
Dramma tragico in due parti fu messo in versi dal quel sommo poeta che fu Salvatore Cammarano, il quale trasse il soggetto dal romanzo “The Bride of Lammermoor” di Sir Walter Scott, scrittore scozzese che può essere considerato il padre del moderno romanzo storico con predominante citazione al territorio locale. Infatti, anche “La sposa di Lammermoor” si rifà a episodi in parte avvenuti e in parte tramandati dalla leggenda popolare. Sullo sfondo il predominante paesaggio scozzese, con i suoi castelli, la brughiera, spiagge e boschi.
Tali peculiari descrizioni di Scott, riportate anche da Cammarano e musicate da Donizetti, non sono state trasportate nello spettacolo veneziano creato da Francesco Micheli, il quale sposta la vicenda ai primi anni del secolo scorso. L’intera vicenda è sviluppata attraverso un flashback nel quale Enrico, fratello di Lucia, rivive la tragedia famigliare e il crollo della sua fortuna nobiliare. Elemento portante della drammaturgia è la perdita della “roba” (citazione del regista da Giovanni Verga), tutto il patrimonio di famiglia è perduto con la follia della protagonista che ammazza lo sposo impostole dal fratello per salvare il casato. Sin dall’inizio troviamo Enrico sempre in scena, guarda sconsolato i ritratti degli avi e resta ammutolito di fronte ad una catasta di mobili ormai distrutti dal crollo sociale e politico della famiglia. Partendo da questa suggestione Micheli riavvolge il nastro all’indietro e tutto ritorna al suo posto per iniziare il drammatico racconto. Idea suggestiva e pertinente ma non sempre funzionale. Troppa luce sul personaggio di Enrico, il concetto è molto espressionista, meno caratterizzazione sugli altri. Non mancano scene rilevanti, come la pazzia di Lucia giocata su una sorta di danza sul tavolo del banchetto attraverso dei bicchieri, riferimento credo alla glassarmonica utilizzata in questa edizione, un solo bicchiere è tinto di rosso. L’ambiente via via resterà sgombro come uno svuotarsi dell’anima. Meno riusciti i movimenti delle masse tra cui un incomprensibile balletto del coro. Inoltre poco credibili i petali che scendono al primo atto durante il duetto di Lucia ed Edgardo, e la neve (o le ceneri?) durante la scena finale del tenore. Azzeccata la scelta di far stendere a terra il coro durante “Tu che a Dio”, un cimitero senza lapidi, ma ridicolo poi che questi si animano nel finale. Scena pertinente ma non emozionante di Nicolas Bovey, costumi opinabili per stile di Alessio Rosati, luci bellissime di Fabio Barettin.
Sul podio c’era Riccardo Frizza, il quale regge con mano esperta e sicura le redini dello spettacolo in una lettura pertinente, molto ricercata nello stile e di forte tinta drammatica. Peccato i piccoli tagli come la soppressione di alcuni daccapo e il volume talvolta eccessivo, ma pur sempre una prova molto positiva cui va aggiunto l’encomio per l’inserimento della glassarmonica, anche se non sempre perfetta nell’esecuzione. Brillante la prova dell’orchestra.
Nadine Sierra, la protagonista, riceve un personale trionfo con tanto di esagerata standing ovation finale. È stata una prova positiva ma del tutto ordinaria, nella quale non si possono non rilevare parecchi difetti d’intonazione nell’aria d’entrata, cui vanno aggiunte cadenze poco credibili e un sostenuto utilizzo del registro acuto non sempre preciso che andava a discapito della drammaturgia. Tuttavia, la sua performance è stata positiva ma da mettere a fuoco in seguito.
Francesco Demuro, Edgardo, è palesemente spaesato in questo ruolo, nel quale non trova l’efficace utilizzo di un fraseggio pertinente, un colore credibile, la tessitura è al limite delle sue potenzialità e marca limiti tecnici.
Più riuscito l’Enrico di Markus Werba, che non trova difficoltà a rendere il crudele fratello con precisa musicalità, anche se per mio gusto avrei preferito più nobiltà d’accento e interpretazione.
Limitato il Raimondo di Simon Lim, cantante sovente ingolato e poco morbido, molto bravo invece Francesco Marsiglia, Arturo, cantante di apprezzabile vocalità ed eleganza nel fraseggio.
Poco efficace il Normanno di Marcello Nardis, cantato con tratti vocali spinti, più corretta Angela Nicoli nel ruolo di Alisa.
Bravissimo il coro istruito da Claudio Marino Moretti.
Al termine successo pieno per tutta la compagnia, con punte particolari di ovazioni per la protagonista come suddetto. All’uscita del regista non sono mancati applausi ma uno spettatore, immagino di galleria, ha contestato la produzione utilizzando un fischietto. Non tolgo il diritto di esprimere opinioni ma l’utilizzo di tale strumento pone molte perplessità.
LA GAZZA LADRA [Lukas Franceschini] Milano, 26 aprile 2017.
Dopo un’assenza di centosettantasei anni dall’ultima edizione il Teatro alla Scala ha messo in cartellone l’opera semi-seria La gazza ladra di Gioachino Rossini, la quale ebbe la prima esecuzione proprio nel teatro milanese il 31 maggio 1817.
Un inspiegabile oblio, come affermato dal maestro Riccardo Chailly, il quale ha voluto fortemente questa nuova proposta e allo stesso tempo ha aggiunto un altro titolo rossiniano al personale catalogo d’esecuzione.
Ne’ La gazza ladra la favola e il romanzo si amalgamano in modo caratteristico e il ritmo porta avanti la vicenda fino al lieto fine. C’è però l’aspetto drammatico e patetico, non secondario al brillante, e in particolare è sottolineato dal rapporto padre e figlia (Ninetta-Fernando) con accenti che sono antesignani del romanticismo operistico della scuola italiana. L’intera partitura, molto difficile sia per i cantanti sia per l’orchestra, è un perfetto equilibrio tra fasto e candore, ritmo e ironia. Opera poi dimenticata, escluso la sinfonia, per quasi due secoli non solo a Milano, che vanta una ripresa consistente solo negli ultimi anni. Molti musicologi affermano che l’opera è per altezza d’ispirazione e per drammatica potenza e accuratezza nella forma, una delle migliori dell’autore, identificata anche in una strumentazione raffinata. E’ un dramma realistico che dalla semplice commedia campagnola diventa, specie nel II atto, una vera tragedia e si conclude riprendendo il carattere iniziale. Anche se il “fatto” è assurdo, una ragazza condannata a morte per un furto di posate d’argento, Rossini trova modo di sviluppare drammaturgia e musica sfoderando tutte le variegate possibilità, arie di sortita brillanti, grandi arie solistiche, innumerevoli pezzi d’assieme, un brindisi, giocando con grande maestria sui diversi stili, toccando vertici compositivi davvero rilevanti e d’effetto. A tal proposito è interessantissima l’intervista al M.o Chailly, pubblicata nel programma di sala, che illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche musicali dell’opera.
Poco efficace la regia di Gabriele Salvatores, che si limita a narrare in senso onirico ma senza un’idea drammaturgica vera e propria, poco edificanti le scene brillanti e non sufficientemente focalizzate quelle drammatiche. Sotto un peculiare punto di vista si potrebbe ipotizzare che il regista nella sua lettura abbia voluto parafrasare la commedia dell’arte, ecco allora inserite con pertinenza nella sinfonia le straordinarie marionette di Carlo Colla, in seguito nel corso dell’opera utilizzate con dozzinale riuscita. Discutibile lo spostamento delle masse, poche idee innovative e qualche “imprestito” da altri, come la mima-acrobata che interpreta la gazza cui va aggiunto l’improbabile corteo dell’esecuzione a morte di Ninetta da Santa Inquisizione con gendarmi incappucciati di nero. La scena semifissa di Gian Maurizio Fercioni pur nella statica bellezza non aiuta, ad eccezione della struttura sulla destra che, teatro nel teatro, si trasforma in casa nobile, prigione e tribunale. Lo stesso Fercioni ha mano più felice nei costumi, anche se quello del podestà, che parafrasava il conte Dracula, era alquanto bizzarro. Le luci di Marco Filibeck erano molto efficaci e di grande impatto.
La direzione di Riccardo Chailly era esemplare per cristallina esecuzione e massima attenzione a tutti i dettagli, cesellata in ogni angolo con cura maniacale assieme all’ottima orchestra e al coro in forma lucenti. Tuttavia, egli sceglie una lettura più giocata sul terreno drammatico a discapito talvolta del ritmo incalzante, già dalla sinfonia si percepisce il ruolo fondamentale della solennità, anche se i tempi erano ben sostenuti. Se la scena del tribunale e strabiliante per aderenza stilistica, e funzionali sono tuti i terzetti e concertati, meno riuscito è parso il brindisi, ma probabilmente è solo questione di gusto personale. Inoltre, non è da sottovalutare l’amorevole contributo del maestro nei confronti delle voci, sempre sorrette con perizia e giusto equilibrio sonoro.
Nel complesso la compagnia di canto era apprezzabile, anche se più concentrate sullo spessore rispetto l’espressività. Rosa Feola, Ninetta è un soprano musicale e precisa, convince sul lato patetico meno su quello drammatico. Piuttosto esile, pur senza gravi pecche, il Giannetto di Edgardo Rocha.
Migliori le voci basse di Alex Esposito, Fernando, per perizia e precisione vocale anche se talvolta monocorde, e Paolo Bordogna, Fabrizio, elegante e istrionico il quale offre una luce accattivante al personaggio che sovente scivola in disparte. Onore alla professionalità di Michele Pertusi, Gottardo, ma ormai ruoli così virtuosi dovrebbero cedere il passo ad altri più congeniali.
Rilevante per accento e musicalità la Lucia di Teresa Iervolino e straordinariamente bravissimi tutti gli altri interpreti nei ruoli minori, Matteo Macchioni (Isacco), Matteo Mezzaro (Antonio), Claudio Levantino (Giorgio e pretore) e Giovanni Romeo (Ernesto).
Il ruolo meno riuscito è stato quello di Pippo interpretato da Serena Malfi, la quale non possiede le caratteristiche necessarie ed è penalizzata anche da una voce poco affascinante.
Alla quinta recita cui ho assistito il teatro era quasi esaurito e giustamente prodigo di applausi, la gazzarra della prima è ormai dimenticata.
NORMA [Lukas Franceschini] Verona, 27 aprile 2017.
Al Teatro Filarmonico è stara rappresentata l’opera Norma di Vincenzo Bellini nello storico allestimento di Hugo De Ana ideato per la Fondazione Arena nel 2004.
Norma è un titolo molto difficile da eseguire per l’impegno mostruoso cui sono chiamati i protagonisti, e oggi lo è ancora di più considerato che le voci disponibili sono piuttosto rare.
Lo dimostra anche l’edizione veronese, la quale è molto volenterosa ma con risultati molto discutibili.
La protagonista Csilla Boross, indisposta alla prima e sostituita, è rientrata per le ultime due recite tra cui quella da me ascoltata. Il soprano ungherese possiede una voce molto importante, grande e brunita ma le lacune tecniche rendono il suo canto stridulo soprattutto nel settore acuto. Dopo un’entrata, “Casta Diva”, con difetti d’intonazione ha proseguito in una performance sempre al limite, trova un limitato riscatto solo nel finale, quando la tessitura è notevolmente centrale e riesce anche in un fraseggio eloquente, ma nel complesso la prova non è positiva.
Rubens Pelizzari è un Pollione vigoroso vecchio stampo di teatro di provincia, abbastanza sicuro e con un colore vocale anche pertinente, ma i risultati non sono del tutto soddisfacenti se si analizzano accenti e stile, tuttavia, riesce con onestà in un ruolo che a mio avviso dovrebbe escludere dal suo repertorio.
Molto migliore l’Adalgisa di Anna Maria Chiuri le cui intenzioni sono molto rilevanti, la vocalità pertinente anche se qualche estremo acuto un po’ forzato, ma notevolmente una prova positiva.
Mediocre Marko Mimica, Oroveso, il quale avrebbe voce e stile pertinenti per tale ruolo, ma sovente la vocalità è alterna e lo stile non proprio rifinito. Considerando la giovane età è auspicabile in futuro una messa a fuoco del ruolo più studiato soprattutto nella nobiltà interpretativa.
Bravissima Madina Karbeli, Clotilde, credibile nel misurato personaggio e perfetta nei brevi interventi, professionale il Flavio di Antonello Ceron.
Orchestra e Coro, quest’ultimo diretto da Vito Lombardi, della Fondazione Arena hanno fornito una prova molto convincente confermando l’ottima professionalità.
Sul podio Francesco Ivan Ciampa, un direttore che sta facendo una carriera importante, anche se le occasioni non sono sempre equilibrate. La prova veronese è una delle sue migliori direzioni da me ascoltate. Molto attento alle sonorità che non sono mai eccessive ma sostenute e vibranti, capace di coordinare buca e palcoscenico in maniera convincente. La sua non è una lettura filologica, eliminati tutti i daccapo e vari tagli qua e là, ma considerato il cast è il caso di rilevare tali scelte che forse sono state obbligatorie. Resta il plauso di aver condotto con maestria e senso teatrale una recita non facile.
Infine lo spettacolo interamente curato da Hugo de Ana, un monumentale allestimento in stile neoclassico con colonne e una maestosa parete, cui si aggiungono proiezioni con effige di Napoleone e sculture settecentesche che raffigurano l’arte greco-romana in voga in tale periodo. L’aggettivo predominante è l’eleganza, sia nelle scene dei singoli sia negli assiemi. Tuttavia è incomprensibile il messaggio che vuole dare il regista, ambientare Norma in epoca Napoleonica lascia molti dubbi sul perché di tale operazione, cosa vuole rappresentare nello scontro tra i druidi e i romani, e l’ambientazione stessa. Bellissimi i costumi in stile impero.
Il pubblico ha applaudito tutti con acceso calore e grande partecipazione.
ANDREA CHÉNIER [Simone Ricci] Roma, 30 aprile 2017.
Il dramma di Umberto Giordano mancava dal Costanzi dal 1975: la regia di Marco Bellocchio ha attirato un pubblico molto curioso.
Dopo ben 42 anni il pubblico romano del Teatro Costanzi è tornato ad apprezzare l’opera più famosa di Umberto Giordano, “Andrea Chénier”: la regia di Marco Bellocchio ha assicurato la giusta aspettativa tra gli spettatori, alle prese con uno spettacolo rispettoso della più nobile tradizione, irrinunciabile come non mai in un lavoro storico tanto preciso come quello del compositore pugliese. L’ambientazione accurata ha permesso di immedesimarsi molto bene negli anni della rivoluzione francese: Roma è stata “dimenticata” per lasciare spazio alla Parigi di fine ‘700, anche se le ideologie di quel periodo sono state messe in secondo piano per dare maggiore risalto alla vicenda amorosa del dramma in quattro quadri.
Questa recensione si riferisce alla replica di domenica 30 aprile 2017. Le scelte registiche di Bellocchio e le scene di Gianni Carluccio sono state studiate con attenzione per non far perdere al pubblico il minimo dettaglio, in particolare il tribunale popolare e il semplice balconcino da cui appare fugacemente Robespierre. L’importanza assegnata alle parti minori, poi, ha impreziosito il risultato complessivo, all’insegna di un vero e proprio quadro d’insieme in cui non mancava proprio nulla. Il passaggio del carretto dei condannati è stato forse eccessivamente rapido e accompagnato da un entusiasmo non convinto del popolo, ma questo non vuol dire che la narrazione storica non sia stata scorrevole.
Un altro piccolo appunto può essere fatto alla scena finale, quella in cui Andrea e Maddalena affrontano fieramente e serenamente la ghigliottina: le ultime note dell’orchestra accompagnano tenore e soprano al centro della scena, senza far intendere realmente cosa accadrà nel giro di poco tempo. Chiudere il sipario con i due protagonisti che si tengono per mano in un grande ambiente un po’ scarno ha privato il pubblico dell’emozione finale che avrebbe fatto apprezzare maggiormente il momento drammatico della condanna a morte.
Gregory Kunde ha affrontato con esperienza ed eleganza il ruolo del titolo, senza risparmiare gli acuti e mostrando un registro grave a tratti disomogeneo che non ha però “macchiato” la performance, apprezzata con convinzione dal pubblico capitolino. Gli aspetti innamorati e slanciati del giovane poeta sono stati resi con sicurezza e Un dì all’azzurro spazio è filato via senza eccessivi problemi. Maria Josè Siri, apprezzata alla Scala nella “Madama Butterfly del 7 dicembre scorso, ha impersonato una Maddalena scenicamente credibile e dalla dizione corretta e precisa. Il momento più atteso della sua serata, La mamma morta, è stato affrontato con una lieve titubanza iniziale che ha poi lasciato spazio a note passionali e dolci.
Il voto non può che essere positivo anche per Roberto Frontali: il suo Gérard ha colpito per il timbro baritonale ben definito e le parole scandite in maniera efficace dal punto di vista teatrale, con tanto di inflessioni interpretative più che adeguate a un personaggio di acceso verismo come questo. Natascha Petrinsky ha deciso di non strafare con l’interpretazione di Bersi, puntando sulla correttezza delle note e sulla freschezza teatrale. Anna Malavasi ha caratterizzato con garbo la Contessa di Coigny, autorevole e altera come richiede il personaggio, mentre Duccio Dal Monte è stato un Roucher suadente e impeccabile.
Grande entusiasmo ha suscitato Elena Zilio, una Madelon accorata e commovente al punto da far trattenere a fatica le lacrime. Il resto del cast era composto da Graziano Dallavalle nel doppio ruolo del Romanziero e di Fouquier-Tinville, Gevorg Hakobyan in quello del sanculotto Mathieu, il mellifluo Incredibile di Luca Casalin, il puntuale Abate di Andrea Giovannini e Timofei Baranov che ha garantito la presenza di Schmidt, del maestro di casa e di Dumas. Roberto Abbado ha diretto con piglio sicuro e deciso l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma: i momenti di più intenso lirismo sono stati resi con vere e proprie ondate di tensione e una presenza strumentale davvero gradevole.
Apprezzabile, come di consueto, la prestazione del coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Roberto Gabbiani: il popolo rivoluzionario è stato tratteggiato con gli slanci giusti e ombreggiature espressive, un “personaggio” che in un’opera come “Andrea Chénier” deve essere affrontato con mezzi appropriati. Gli spettatori romani hanno tributato applausi convinti e scroscianti, qualche accenno di fischio (prontamente coperto dal resto del teatro) stava per caratterizzare l’accoglienza a Maria Josè Siri, ma sarebbe stata una punizione davvero esagerata. Il dramma di Giordano tornerà per l’ultima volta in questo teatro martedì 2 maggio con la direzione affidata a Pietro Rizzo.
IDOMENEO [Lukas Franceschini] Pistoia, 30 aprile 2017.
L’80° Maggio Musicale Fiorentino ha avuto la prima produzione operistica nella bellissima cornice del Teatro Manzoni di Pistoia, poiché la città toscana è una delle capitali della Cultura Europea per il 2017.
Questa trasferta regionale è da considerarsi eccezionale poiché il Maggio Musicale ha sempre realizzato le proprie produzioni nelle sedi della città di Firenze. L’opera in cartellone era Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart, nell’allestimento di Damiano Michieletto creato per il Teatro an der Wien nel 2015.
Il desiderio di Mozart di comporre una grande opera seria si realizzò nell’estate 1780 quando arrivò la commissione dell’intendente teatrale dell’Elettore Kark Theodor per il Carnevale di Monaco di Baviera. Il soggetto fu indicato dal principe stesso e fu affidato all’abate Antonio Varesco. Esso si basava su un dramma mitologico, con risvolti fiabeschi, già elaborato in precedenza da altri compositori. Tuttavia, il librettista nella stesura del testo restò ancorato alla tradizione metastasiana, sfrondando lo sfondo mitologico-allegorico e la conclusione fu forgiata su un lieto fine celebrativo. Per Mozart fu una gestazione molto complessa per la renitenza di Varesco di apportare modifiche al testo, e per i capricciosi illustri cantanti che crearono difficoltà a non finire. Anche se ideata secondo le regole dell’opera tradizionale del tempo, con Idomeneo Mozart produsse alcune rivoluzionarie novità drammaturgiche e musicali: trasformò i recitativi accompagnati in vero dialogo strumentale-vocale, ampliò l’impianto orchestrale e attribuì un rilievo insolito agli strumenti a fiato. Partitura unica, la più ricca e forse enciclopedica di tutto il settecento, nella quale il compositore offre una maestria rilevante per quel che concerne il colore e la forza dell’orchestra, il grande respiro di tutta l’opera, la linea melodica e l’arte del recitativo accompagnato.
Il tema principale dell’opera è il rapporto tra padre e figlio e giustamente Damiamo Michieletto durante l’overture fa proiettare un video nel quale Idomeneo, in partenza per la guerra, veste il giovanissimo figlio in giacca e cravatta per assumere i suoi compito di reggente del regno. Ma i buoni propositi di una regia, spesso interessante per il conflitto non solo generazionale ma anche dell’esuberanza giovanile, finiscono lì. Pur nella coerenza di un racconto drammaturgico, il regista inserisce soluzioni e aspetti teatrali non certo innovativi e sovente sopra le righe. Non contribuisce la scena, di Paolo Fantin, il quale in questa occasione non ha la stessa mano felice di altre occasioni. Tutta l’opera si svolge sulla spiaggia in riva al mare con sabbia vera. Entrate ed uscite del coro e dei solisti sono avvolte da candide tende bianche. La scena si apre, e resta fissa, su una spiaggia invasa di stivali e scarpe dopo il passaggio di uno tsunami, cui sia aggiungono in seguito cataste di mobili, sedie, valigie, tanto da rasentare un disordinato centro raccolta rifiuti. Idamante è già amante di Ilia, la quale appare in scena in avanzato stato di gravidanza, partorirà nel finale sulle note del balletto. Elettra è una donna volitiva e cerca di sedurre Idomeneo attraverso abiti succinti, volgari e probabilmente acquistati in negozi di griffes o centro commerciale, che indossa in scena senza alcun senso, e nell’aria finale s’imbratta di fango. Nel finale primo il coro, un insieme di straccioni, si gratta nervosamente come se colpiti dalla scabbia. Diversamente dal libretto Idomeneo ed Elettra ido 6muoiono e restano in scena, per il re segue anche il commiato funebre con i ceri. Troppe cose, troppa confusione, poco rispetto della musica e della drammaturgia, usuale nel regista, ma in questo caso ha reso il pubblico annoiato e perplesso. I costumi di Carla Teti erano moderni e in funzione dell’idea registica, ma non lasciano traccia. Considerato che lo spettacolo non era nuovo è lecito chiedersi se non c’era altra soluzione di allestimento.
Sul podio c’era Gianluca Capuano, giovane direttore con spiccata carriera estera, che ha fornito una prova di concertatore molto efficace con tempi ben sostenuti, ritmo incalzante e precisa calibrazione sonora, una narrazione musicale di stampo settecentesco-drammatico d’effetto. Complice un’Orchestra del Maggio in grande forma e un Coro, istruito da Lorenzo Fratini, degno della sua fama.
Il cast nel complesso non annoverava elementi di spicco, a cominciare dal disarmante protagonista di Michael Schade, ormai alla frutta di un canto logoro e sovente poco intonato, aspetto che non gli permette neppure di sfoderare qualche freccia credibile nei recitativi. Molto migliore l’Elettra di Carmela Remigio, cantante di spiccata musicalità e intuizioni vocali, fraseggio e colore erano rilevanti anche se la risata satanica dell’aria “D’Oreste e d’Ajace” è approssimativa.
Rachel Kelly, Idamante, è perfetta come interprete molto convenzionale nel canto nel quale trova poca suggestioni vocali. Ekaterina Sadonnikova è una corretta Ilia senza emozioni, e i “Zeffiretti lusinghieri” non lasciano segni di memoria.
Bravissimo Leonardo Cortellazzi per stile, incisività e canto raffinato, purtroppo confinato nel secondario ruolo di Arbace, avrei preferito fosse il protagonista. Professionali e precisi il sacerdote di Nettuno di Mirko Guadagnini e la voce dell’Oracolo di Chanyoung Lee.
Pubblico molto scarso per un titolo non abituale nei cartelloni italiani, applausi alla compagnia, qualche isolato dissenso agli artefici dello spettacolo che non erano presenti ai saluti finali.
LA GAZZA LADRA [William Fratti] Milano, 5 maggio 2017.
Riportare in scena titoli che al Piermarini hanno avuto i loro natali, per poi essere ingiustamente dimenticati, è compito lodevole, culturalmente vincente, ma al contempo difficile da mediare col gusto odierno del pubblico. Nel caso della pregevole La gazza ladra, come lo scorso anno per Giovanna d’Arco, si assiste a un recupero molto intelligente: l’opera, nella sua interezza e revisione critica a cura del compianto Alberto Zedda, è già stata più volte rappresentata al Rossini Opera Festival di Pesaro, pertanto questa della Scala appare come una conferma internazionale del ritorno di questo capolavoro – fatto di numeri musicali fin troppo all’avanguardia per l’epoca – sulle scene di tutto il mondo.
Riccardo Chailly, che in molte occasioni ha dimostrato di essere un ottimo esecutore del repertorio rossiniano, si avvale di un cast composto quasi interamente di specialisti – in molti hanno già interpretato il ruolo – e il risultato complessivo che ne ottiene, soprattutto in termini di stile, è davvero eccellente, eccezion fatta per le variazioni che sono veramente ridotte ai minimi termini. Il vigore con cui dirige “la grandiosa vastità dell’affresco” è superbo, pur non mancando accenti drammatici e sfumature patetiche, anche se in alcuni momenti si nota un eccessivo volume orchestrale. Pregevole il fortepiano di James Vaughan. Ineccepibile il Coro del Teatro alla Scala guidato da Bruno Casoni.
Rosa Feola è una bravissima Ninetta, tecnicamente impeccabile, soprattutto nell’intonazione e nelle colorature. Il timbro è leggermente acidulo e ciò rende ancor più interessante il gusto rossiniano, particolarmente nei passaggi più meccanici. Per questo ruolo si preferirebbe una vocalità più morbida e scura, tanto da rendere maggior pathos nelle pagine più sentimentali e commoventi, purtuttavia Rosa Feola riesce comunque a rendere i giusti colori.
La affianca il Giannetto di Edgardo Rocha che in questa parte mostra ulteriori pregi rispetto a performance precedenti, principalmente negli staccati, nelle punte, in generale in tutti i virtuosismi, ma anche nelle belle frasi melense del finale primo.
Il canto di Michele Pertusi è da prendersi come una scuola. Il suo modo di porgere il suono, di articolare la parola, di dare intenzione ad ogni singolo fraseggio, in ambito rossiniano non ha rivali. È naturale che la sua voce non abbia più l’elasticità di un tempo, ma l’espressività è insuperabile e il suo Gottardo vive di tutte le sfumature volute dal compositore, dalla quasi buffa cavatina, alla viscida e drammatica seconda aria, fino alla resa conclusiva.
Alex Esposito è un Fernando più che eccellente. Stile perfetto, linea di canto sempre uniforme, agilità sopraffine, colori centratissimi e notevole spessore drammatico arricchiscono la sua vocalità già naturalmente bella e predisposta al repertorio del pesarese.
Teresa Iervolino è una buona Lucia, principalmente nell’interpretazione e nel canto patetico, ma c’è ancora molto spazio di miglioramento nelle agilità e nella proiezione. Serena Malfi è un Pippo più che discreto, ma volume, timbro e proiezione hanno bisogno di maggior corpo. Ottimo il Fabrizio di Paolo Bordogna, costantemente brillante e con suoni sempre in punta. Molto piacevole l’Isacco di Matteo Macchioni. Efficaci anche Matteo Mezzaro nei panni di Antonio, Claudio Levantino in quelli di Giorgio e del Pretore, Giovanni Romeo in quelli di Ernesto.
Lo spettacolo di Gabriele Salvatores è abbastanza deludente. Salvatores, come molti altri registi di cinema che si sono accostati o riavvicinati al teatro dopo tanti anni, non appaga poiché privo di idee originali. La gazza acrobata, le marionette, i doppi o le proiezioni dei personaggi, il teatro nel teatro, sono tutte cose già viste e riviste che da sole, senza una novità che faccia da zoccolo duro, non giustificano l’alto nome del regista coinvolto. Detto ciò va comunque riconosciuta l’eccellenza del lavoro minuzioso fatto con gli interpreti in termini di gesti, sguardi, espressioni, movimenti, azioni che riempiono costantemente le oltre tre ore di musica, poiché non c’è uno spazio vuoto, ma tutto è studiato nel minimo dettaglio pur nella massima naturalezza.
In perfetta linea con lo spettacolo, anche se un poco anonime, le scene di Gian Maurizio Fercioni e le luci di Marco Filibeck. Migliori i costumi, sempre di Fercioni.
ORFEO [Mirko Gragnato] Cremona, 5 maggio 2017.
Al teatro Ponchielli di Cremona si celebrano i 450 anni di Monteverdi, ma non solo: eventi, mostre, concerti, la città intera si veste a festa e propone un cartellone ricchissimo per celebrare il compositore a cui ha dato i natali.
L’Accademia Bizantina condotta dal clavicembalista Ottavio Dantone ci trasporta nel mondo di Orfeo, con la musica di Monteverdi ed il libretto di Alessandro Striggio il giovane, in un viaggio da compiere assieme alla posata regia di Andrea Cigni con i costumi di Lorenzo Cutùli le luci di Fiammetta Baldisserri.Il tutto all’insegna della semplicità dei mezzi e delle intenzioni, perché la meraviglia è cosa diversa dallo stupore artificiale indotto da macchine grandiose e messe in scena altisonanti.
Tra le voci del cast brillano il tenore Emiliano Gonzalez Toro e Anna Maria Sarra.
Una favola davvero, il mondo creato da regie, scene e costumi, per queste celebrazioni monteverdiane. Ma anche, più prosaicamente, non si loderà mai abbastanza la decisione di offrire biglietti ridotti per gli studenti. Si aggiunga a ciò la presenza a Cremona della Facoltà di Musicologia e dell’Accademia di Liuteria, ed ecco spiegato l’incredibile richiamo che la manifestazione esercita non solo sui giovani del circondario, ma anche da varie città del Veneto, della Lombardia, dell’Emilia e più oltre: segni che la cultura di qualità ha ancora una speciale capacità di attrarre e unire, il teatro è sold out. Prima dell’inizio si respira un’aria di emozionante attesa, e quando, subito dopo l’ingresso del maestro Dantone, dai palchi di proscenio, trombe e tromboni da parata danno il via al racconto dell’Orfeo con la Toccata, ecco che subito si innalza un fragoroso applauso.
Le scene e i costumi di Lorenzo Cutùli rievocano un mondo bucolico e pastorale senza tempo e senza età, fatto di frasche, ruscelletti, ninfe e pastori. Scelta vincente, come detto, la semplicità dei materiali utilizzati e un fondale video, che nel primo atto animava l’orizzonte di un cielo trapunto di stelle, ammantato dalla luce argentea della luna. Questo è il mondo che vede l’unione amorosa di Orfeo ed Euridice e dei cori amici di Ninfe e Pastori. Se nell’Euridice di Peri il prologo era affidato alla Tragedia, nell’Orfeo di Monteverdi è la Musica che apre le scene, qui interpretata dal soprano Anna Maria Sarra, che interpreta anche il ruolo di Euridice. Scelta casuale, o voluta? Fatto sta che in questa recita la musa e l’amata sono incarnate dalla stessa voce, con con il suo timbro leggero e il suo spirito teatrale. Alla Musica quindi spetta dare inizio a questa storia, che come ogni favola inizia con l’apertura di un libro per cominciare il racconto…
Le parti corali, come il “Lasciate i monti, lasciate i fonti”, sono un ottimo intreccio di voci nel pieno rispetto dello stile monteverdiano grazie all’abilità del coro “Costanzo Porta”. I pastori Giacomo Schiavo, Daniele Palma, Federico Benetti e Maximiliano Banos hanno una buona presenza scenica ma complessivamente non raggiungono alti livelli di espressione.
Ottimo, invece, l’Orfeo di Emmanuel Gonzalez Toro: bel timbro e resa vocale, ottima mimica facciale, peccato per qualche estremizzazione teatrale di troppo che appesantisce il personaggio nel senso dell’irrealtà. Ottima, in particolare, la cura posta nell’esecuzione di “Vi ricorda o boschi ombrosi”, con rotondità di timbro e sostegno nel fraseggio: rivedremo Emmanuel quest’anno anche come tenore solista ancora in Monteverdi nel “Vespro della Beata Vergine” a Versailles.
Dopo la morte di Euridice il viaggio verso il mondo dei morti invece è evocato da un movimento delle scene verso l’alto, che senza stravolgere il palcoscenico veicola il messaggio di un viaggio verso il Tartaro. La corte di Plutone è resa ottimamente dalle proiezioni che rievocano un tempio antico, con un lungo colonnato dai colori freddi.
Purtroppo il Plutone di Federico Benetti e il Caronte Luigi de Donato hanno un timbro che non evoca le profondità dell’abisso alla cui voce sarebbe affidato il suono dell’Averno. La Proserpina di Gaia Petrone, agghindata in una strana mise rossa che ricorda il Dracula di Bram Stocker, non primeggia, mentre la Speranza che conduce Orfeo alle porte degli inferi interpretata da Anna Bessi (a cui si deve anche il ruolo della messaggera foriere di infauste notizie) raggiunge per qualità Anna Maria Sarra.
Uno spettacolo ben riuscito, concluso dall’ascesa di Orfeo e Apollo, speculare alla discesa all’Averno: come prima le scene salivano verso l’alto dando l’impressione che la scena sprofondasse per segnare il passaggio sottoterra, ora salgono ma stavolta elevandosi al cielo.
Lunghi applausi a tutto il cast, entusiastiche ovazioni per il Maestro Dantone.
Una serata indimenticabile per molti punti di vista e che difficilmente Cremona dimenticherà.
QUARTETT [Lukas Franceschini] Trento, 5 maggio 2017.
La Stagione Lirica, Opera 20.21, dell’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano si è conclusa con la rappresentazione di Quartett di Luca Francesconi al Teatro Sociale.
Opera in tredici scene commissionata dal Teatro alla Scala dove ebbe la prima rappresentazione assoluta il 26 aprile 2011. Il libretto, in lingua inglese, è dello stesso compositore dall’omonima pièce teatrale di Heiner Muller, a sua volta liberamente tratta da “Les liaison dangereuses” di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. Libro scandaloso e a lungo proibito, fu pubblicato nel 1782 e resta uno dei capolavori della letteratura di sempre. La straordinaria qualità letteraria fruttò un enorme successo, fu ammirato anche dalla regina Maria Antonietta, ma probabilmente sfugge che l’autore fosse uno scrittore dilettante, la cui carriera si svolse come ufficiale d’artiglieria, il corpo diplomatico e funzionario del regno. La vicenda narra e osserva in forma di romanzo l’implacabile cinismo della corrotta società dell’ancien régime poco prima dello scoppio della Rivoluzione, identificandosi con la quintessenza della letteratura libertina del ‘700, fornendo spunto per innumerevoli trasposizioni cinematografiche e teatrali. Tra quest’ultime si annovera Quartett (1982) di Heiner Muller che ebbe una notevole fortuna cui contribuirono allestimenti curati da celebri registi. L’opera di Francesconi più che un adattamento ne fa una riscrittura e reinterpretazione del romanzo di Laclos, cui l’autore si è a sua volta ispirato in maniera molto generica. Muller riduce i plurimi intrighi a solo due protagonisti, la marchesa di Mertuiel e il visconte di Valont, un “gioco” reso ancor più opprimente per il fatto di svolgersi in una dimensione celebrale. Il libretto si sviluppa in due piani strutturati in scene. I due personaggi, e i loro doppi, hanno funzioni di amplificazione e proiezione sonora del canto e delle azioni. Le due orchestre, a Trento, una era registrata, hanno compiti drammaturgici diversi, sviluppando le pulsioni private degli attori e a sua volta il riflesso della sfera sociale come un suono del mondo, una forza naturale e atemporale. Il dramma musicalmente è intriso di tinte forti, quasi sanguinee ma lo sviluppo orchestrale sfrutta l’aspetto informatico musicale nel nuovo linguaggio odierno e il pathos del supporto nella voragine cui convergono i due protagonisti ed è veramente efficace in un lirismo sfaccettato e struggente del linguaggio moderno quasi stralunato.
Ben realizzato da John Fulljames, registra, lo spettacolo proveniente dal Covent Garden di Londra, nel quale sarà il colore nero predominante a tingere la scena in maniera opprimente, una storia raccontata ai bordi della società delimitata da pochi elementi, ringhiera, letto e teli squarciati che denotano un ambiente tragicomico nel quale il centro è rappresentato dalla sfida dei due attori, forse unici rappresentanti di una società “cancellata” dalla rivoluzione. Sountra Gilmor, scenografa e costumista, ben si produce nel creare questo mondo nascosto e solitario.
I due cantanti sono esemplari per introspezione teatrale e canto raffinato che raccoglie tutte le diverse sfumature ed esasperate emozioni. La marchesa era Adrian Angelico, il visconte Robin Adams, quest’ultimo interprete anche della prima assoluta alla Scala.
L’orchestra Haydn, in ottima forma, ha dimostrato la speciale duttilità e delicata strumentazione, diretta da un valente Patrik Davin che sfodera con naturalezza tutte le pulsioni della partitura.
Teatro purtroppo semivuoto ma il pubblico presente ha decretato un autentico successo all’intera produzione.
DON CARLO [Lukas Franceschini] Firenze, 14 maggio 2017.
Recita speciale la pomeridiana di Don Carlo di Giuseppe Verdi al Maggio Musicale Fiorentino, infatti, segnava l’ultima esibizione del Maestro Zubin Mehta sul podio del Teatro in qualità di direttore musicale.
A essere precisi c’era stato anche un concerto la sera precedente al termine del quale i festeggiamenti sono stati molto partecipi e accompagnati da discorsi ufficiali, tuttavia domenica al termine della recita non sono mancate ancora una volta manifestazioni di simpatia e ammirazione nei confronti del direttore indiano, il quale non senza commozione lasciava la direzione del Maggio Musicale Fiorentino dopo ben trentadue anni di permanenza. Dal prossimo settembre sarà sostituito da Fabio Luisi ma Firenze non resterà senza la celeberrima bacchetta di Mehta, il quale ritornerà ancora in veste di ospite sia in occasioni concertistiche sia operistiche.
Sarebbe troppo prolisso fare un’analisi degli anni fiorentini di Mehta, gli archivi parlano da soli, vorrei però rilevare il lungo periodo di residenza del maestro, probabilmente la più longeva presenza nazionale a capo di un’orchestra e un teatro, eseguendo un repertorio vastissimo in piena sintonia con una compagine orchestrale portata a livelli internazionali e autentici trionfi sia in sede sia in trasferte estere. Sappiamo che non ” perderemo” Mehta ma inevitabilmente si chiude un ciclo, e l’identificazione anche mia personale di tale artista con la città Fiorentina resterà indelebile nella memoria, grato di tante belle serate.
Don Carlo è la seconda opera del Maggio 2017 e la versione scelta è quella in quattro atti in italiano, denominata di Milano 1884.
L’allestimento, una coproduzione con i teatri di Bilbao, Oviedo, Siviglia e Tenerife, curato nella regia da Giancarlo Del Monaco si lascia guardare ma non entusiasma perché troppo statico e con molte soluzioni se non arbitrarie almeno discutibili. La più clamorosa è l’omicidio di Carlo da parte del padre nel finale, ma anche l’entrata di Eboli che porta lo scrigno durante il grande assolo del violoncello mentre Filippo dorme su un letto a baldacchino. Poca emozione durante l’autodafé, nel quale è mosso senza senso un Cristo in croce bianco disposto orizzontalmente e il coro è perennemente inerme. Meglio gli ultimi due atti, in particolare la scena del carcere. Molto belle le scene di Carlo Centolavigna che evocano un fondale perennemente presente e mobile raffigurante una carta geografica nella quale si percepisce l’estensione dell’impero sul quale non tramonta mai il sole, i costumi di Jesus Ruiz sono pregevoli e di foggia storica. Luci non sempre azzeccate ma pertinenti di Wolfgang von Zoubek.
Cast nel complesso valido, ma con distinzioni. Al levarsi del sipario Don Carlo era Roberto Aronica, il quale non appena apre bocca lascia interdetti per il precario stato vocale, infatti, si fa sostituire dalla scena successiva. Aronica è cantante ben diverso da quello da quello in parte ascoltato a Firenze. Sergio Escobar, il sostituto, è catapultato in scena e fa quel che può, avendo a disposizione un materiale rilevante ma limitato tecnicamente nella zona di passaggio poiché tutto il settore acuto è forzato e insicuro.
L’Elisabetta di Juliana Di Giacomo s’impone per la bellezza timbrica, il cercato fraseggio e la duttilità nei vari registri. Molto buona la prova di Massimo Cavalletti, che s’impegna per disegnare un Rodrigo nobile e fiero, talvolta non sempre puntuale con i compiti vocali ma la morte è decisamente emozionante. Il giovane Dmitry Beloselskiy, Flippo II, colpisce per un timbro omogeneo e grave di grande fascino, molto misurato, nella scansione del canto applica una particolare dovizia d’accento e colore. Un ruolo reso molto bene anche teatralmente e che in futuro avrà modo di calibrare e rodare con risultati ancora maggiori. Non lascia traccia l’Inquisitore di Eric Halfvarson, greve nel canto e con dizione incomprensibile.
Brava Simona Di Capua nel ruolo di Tebaldo, reso con briosità e precisione, austero e convincente il Frate di Oleg Tsybulko. Nel solco della professionalità le altre parti: Enrico Cossutta (Conte di Lerma), Saverio Fiore (araldo), Laura Giordano (voce dal cielo), Tommaso Barea, Benjamin Cho, Quanming Dou, Min Kim, Chanyoung Lee, Dario Shikhmiri (deputati fiamminghi).
Infine, ma non per ultima, Giovanna Casolla. Il soprano partenopeo è giunto all’ultimo da Genova per sostituire la collega prevista alla recita del giovedì e ha cantato anche all’ultima cui abbiamo assistito. La Signora Casolla è giunta nella fase conclusiva della sua lunga e bellissima carriera, tuttavia lascia stupiti come riesca ancora a rendere credibile vocalmente un ruolo come quello di Eboli. Non dobbiamo aspettarci particolare scioltezza nelle agilità della canzone del velo, resa comunque con precisione. Emerge ovviamente nel terzetto del II atto per felino impeto, solida padronanza di mezzi, e ancor più veemente in “O don fatale” dove sfodera le frecce migliori, incisiva e disperata. Ovvio che qualche limite c’è, ma che il soprano ancor oggi riesca a essere convincente in questo difficilissimo ruolo, sempre intonata, in possesso di un timbro ancora affascinante, musicale e con una preparazione tecnica strabiliante la dice lunga anche su colleghe molto più giovani ma inferiori.
Zubin Mehta, se non erro al suo secondo Don Carlo a Firenze, indirizza la sua lettura musicale sulla nobiltà della scansione cromatica, eseguita con precisa metrica e tempi sostenuti ma mai trasbordanti, attento e capace di equilibrare buca e palcoscenico con grande senso teatrale. Imprime enfasi e grande teatralità nel monologo del re e successivo duetto con l’Inquisitore, ricchezza di sfumature e predominanza di suono pulito e vigoroso. Incalza la “sua” orchestra, che risponde a dovere e con precisione certosina, a sviscerare tutte le delicate e ricercate sonorità dello spartito, ottenendo un risultato egregio e sempre improntato di cavalleresca personalità. Una menzione particolare merita il primo violoncello, che dovrebbe essere Patrizio Serino, per l’assolo del III atto. Bravissimo il Coro, istruito da Lorenzo Fratini, sempre preciso, omogeneo e di grande effetto complessivo.
Successo trionfale al termine, con festeggiamenti calorosi per Mehta da parte del pubblico, professori d’orchestra, Coro, tecnici e maestranze dell’Opera di Firenze. Ma sappiamo che è solo un arrivederci.
DIE ZAUBERFLÖTE [Natalia Di Bartolo] Torino, 16 maggio 2017.
Non giovano a Die Zauberflöte di Mozart né tronfi afflati germanici, né troppa leggerezza da favoletta: è un capolavoro di imperscrutabile profondità, che miscela il Singspiel all’Opera seria. L’esecuzione del 16 maggio 2017 al Teatro Regio di Torino, presentata col titolo in italiano, “Il flauto magico”, mi pare che in questo senso abbia sfiorato la perfezione. Tale perfezione, secondo i miei parametri personali, mi si attesta nella memoria al lontano 1992 al teatro Massimo Bellini di Catania, con il compianto Spiros Argiris sul podio: fu il mio “primo” Flauto magico, dopo averne sorbiti un’infinità in piena noia. Probabilmente non che il grande Argiris avesse colto in toto la perfezione di Mozart, ma ritengo che ci fosse andato molto vicino.
Altrettanto ha saputo fare, forse con maggiore cognizione di causa di scuola teutonica, il M° Asher Fisch, a Torino. Specialista nel repertorio tardo-romantico di matrice tedesca, Il M° Fisch, tornerà il 31 maggio p.v. a dirigere l’Orchestra del Teatro Regio per un concerto dedicato a Richard Strauss; il che la dice tutta sulla sua competenza mozartiana. Dall’entusiasmo nell’ouverture frizzante, al suono pieno e teatrale ma delicato, che ha seguito nelle dinamiche il suono della lingua tedesca, la sua direzione del Singspiel mozartiano è stata da manuale. Polso fermo, tempi brillanti, leggero quando servisse, serio quando l’opera virasse verso il serio, ha colto in pieno la lezione del suo maestro, il grande Daniel Barenboim, dimostrandosi “artigiano” nelle prove, ma “re” sul podio. La magnifica orchestra del Regio sembrava galvanizzata. Ma certo! Quando sul podio c’è chi sappia quel che ha in mano da dirigere, anche i professori sono motivati; e si sente. L’alchimia, poi, si rende perfetta quando a cotanta direzione si unisce uno stuolo d’interpreti di prim’ordine: è accaduto anche questo. Un mix sonoro tra buca e palcoscenico che ha tenuto gli spettatori ben svegli e attivi, facendoli applaudire a scena aperta molte e molte volte e tributare un’ovazione al finale a tutti gli interpreti.
Per cominciare a parlare degli interpreti, appunto, viene l’imbarazzo della scelta, ma trovo che il protagonista assoluto sul palcoscenico di Torino sia stato il Papageno di Markus Werba. L’ennesimo Papageno di un artista che ne ha fatto il filo conduttore della propria carriera, ma che adesso lo va centellinando, rispetto ad altri ruoli di un repertorio che è divenuto vastissimo, promettendone uno venturo al Metropolitan Opera di New York. A Torino il Werba ha dato prova di “essere” Papageno. Impressionanti la competenza vocale, la resa della parte, la scioltezza e la padronanza scenica, in una regia di Roberto Andò, ripresa abilmente da Riccardino Massa, che lo portava anche ad interagire col pubblico, strizzando l’occhio al “barolo”, sedendosi in braccio ad una spettatrice di prima fila, fino ad abbracciare il Maestro scendendo nel golfo mistico. Era lui stesso, poi, che suonava il flauto e pure il glockenspiel, che dà i suoni argentini inconfondibili che sottolineano il carattere del personaggio.
Al fianco di Werba e notevole per il centro ed il colore, la Pamina di Ekaterina Bakanova; molto gradevole e ben emesso il Tamino di Antonio Poli; più disinvolta scenicamente che vocalmente la Papagena di Elizabeth Breuer; ottimo il Sarastro di Antonio Di Matteo; ma si giunga, ovviamente, alla regina della notte, la Königin der Nacht, la tremenda Astrifiammante.
A Torino, la Mutter crudele e severissima, che non precipita però nel finale tra “i cattivi”, tutti graziati in questa produzione, era il soprano Olga Pudova. Notevole, non c’è che dire: la parte è difficilissima, si sa. Il FA sovracuto c’era tutto e non solo toccato, ma anche girato. Buona la pronuncia, ben delineate le agilità, vocalizzazione però preceduta nei momenti più difficili dall’emissione silente del fiato. Lucia Aliberti ne è maestra. Ma non è detto che sia una buona soluzione…Salvaguarda le corde e porge il suono senza “urti”? Forse, ma non è gradevole e personalmente trovo che non sia neanche molto elegante. La prestazione della Pudova, però, è stata assolutamente apprezzabile ed apprezzata dal pubblico plaudente. Il suo strumento è di gran bella qualità e il soprano sa usarlo comunque con cognizione di causa. Forse più bella la prima scena di “O zittre nicht, mein lieber Sohn” al primo atto, che la successiva, quella celeberrima di “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”, al secondo atto. La prima scena della regina è meno conosciuta, ma altrettanto difficile e si renda merito alla Pudova di averla resa con pregnante vocalità e presenza scenica.
Tutto il resto del cast era di alto livello, compresi i tre fanciulli, istruiti, come il magnifico Coro del Regio, da Claudio Fenoglio.
Intelligente e coinvolgente, dunque, la produzione dei suddetti Roberto Andò e Riccardino Massa, con le scene e le luci di Giovanni Carluccio e i costumi fantasiosi di Nanà Cecchi. Tradizionale, un po’ onirica, favolistica, come prima si accennava, ha fatto interagire i personaggi col pubblico e ha visto nel finale precipitarsi in platea tutti gli interpreti. Era anche ben studiata nei riferimenti esoterici all’antico Egitto che sono del Sarastro e sottendono tutta una filosofia sulla quale si sono sparsi fiumi d’inchiostro, ma che qui sarebbe fonte di noia per il lettore sottolineare.
Si sottolinea, invece, come in definitiva, la serata mozartiana a Torino sia stata di gran livello sotto ogni aspetto e che Amadeus da lassù se ne sarà certamente compiaciuto.
DON GIOVANNI [Lukas Franceschini] Milano, 17 maggio 2017.
Dopo sette anni l’opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart è stata riproposta al Teatro alla Scala nell’allestimento di Robert Carsen che inaugurò la stagione 2011-2012.
Molteplici sono state le regie del dramma giocoso mozartiano, ovviamente non solo alla Scala, tradizionali, moderni, estremi o convenzionali e la realizzazione di Carsen potremo ascriverla tra quelle equidistanti dalla tradizione e dalla novità, con una personale concezione drammaturgica-teatrale di rilevante effetto. Il notevole tocco del regista consiste nel mettere in relazione la vita odierna degli spettatori con la vicenda cui assistiamo sul palcoscenico. Non si tratta di teatro nel teatro, formula ormai superata, ma di mescolare equamente opera e realtà (il pubblico) nelle dissolute vicende del libertino protagonista. Questo intento lo raggiunge innanzitutto attraverso la scena, non proprio originale ma efficacissima, creata da Michael Levine, la quale nel primo atto è dominata da una grande parete a specchio che proietta sul palcoscenico il teatro stesso con il suo pubblico, nel secondo atto la riproduzione interna del teatro in prospettiva sempre più piccola ed infinita. Infine, l’utilizzo della platea in alcune scene rende ancora più coinvolgente la lettura per il pubblico. Sfaccettata la regia con particolare focalizzazione sui singoli personaggi, il libertino Don Giovanni, dissoluto nei suoi convincimenti, al quale indifferentemente e in diversa maniera gravitano gli altri interpreti, senza trovate banali ma chiarissime negli intenti. I costumi di Brigitte Reiffenstuel, moderni ma di taglio elevato, s’imprimono per il cromatico elemento del colore che indentifica il personaggio, in bianco, rosso e nero. Uno spettacolo godibile, preciso, e funzionale anche se non memorabile.
Sul podio abbiamo trovato Paavo Jarvi, un direttore molto professionale e scrupoloso, che ha espresso la sua arte soprattutto in una cura estrema dell’accompagnamento musicale, talvolta a scapito di un ritmo un po’ slentato, ma la sua concertazione è molto rispettosa dello spartito e soprattutto del canto, il suono è sempre controllato e uniforme, le dinamiche incisive. Nel complesso pregevole direzione. In ottima forma sia la compagine orchestrale, confermando l’ottima qualità scaligera, sia il coro, diretto da Bruno Casoni, che nei brevi interventi ha mostrato eccellente professionalità.
Protagonista era Thomas Hampson, che stranamente solo oggi debuttava alla Scala in un’opera lirica. Il cantante americano dopo essere stato un Don Giovanni di riferimento negli anni ’90, è ancor oggi un personaggio credibile e molto variegato nell’interpretazione. Ovvio, lo smalto è leggermente appannato e i fiati un po’ accorciati, ma la calibrazione del recitativo è esemplare, il timbro sempre seducente, il fraseggio don 5eloquente e il volume molto vigoroso. L’interprete rasenta vertici rilevanti, e la sua performance sarà ricordata per la perizia nella scansione del colore e la variegata modulazione dell’accento, un Don Giovanni completo e affascinante.
Il Leporello di Luca Pisaroni s’impone per la doviziosa perizia stilistica che non sfocia nella macchietta, gran pregio! Il giovane baritono, dotato di voce morbida e molto sonora, ha realizzato un servo molto controllato, mai volgare e molto rifinito nel fraseggio.
La prova di Hanna-Elisabeth Muller, Donna Anna, è andata in crescendo, poiché pur essendo cantante molto educata e musicale, non è dotata di voce particolarmente drammatica e il primo duetto e l’aria “Or sai chi l’onore” non erano del tutto incisivi. Nel secondo atto ha trovato uno sviluppo vocale più pertinente, soprattutto nel recitativo, e nella grande aria ha saputo esprimere accenti molto più convincenti e una buona coloratura.
Molto buona la prova di Bernard Richter, un Don Ottavio dotato di voce lirica e corposa ma capace di sfumature, accenti, e finezze davvero ragguardevoli, espressi attraverso una e corposa vocalità e una tecnica appropriata.
Molto espressiva sul versante interpretativo la Donna Elvira di Anett Fritsch, anche se vocalmente non del tutto omogenea, poiché se nel primo atto ha espresso vibranti accenti e precisa esecuzione nel secondo era molto affaticata e “Mi tradì” non era all’altezza delle attese.
Bravissima la giovane coppia di contadini, Giulia Semenzato è stata una Zerlina delicata e di preziosa voce rifinita, Mattia Olivieri, un baritono sempre in crescendo, ha reso il personaggio di Masetto in maniera superlativa attraverso una voce robusta e una peculiare amministrazione dei colori.
Molto efficace anche il Commendatore di Tomasz Konieczny, dotato di voce molto potente ed estremamente drammatico nei suoi interventi.
Teatro completamente esaurito in ogni ordine di posto, con pubblico partecipe che al termine ha decretato un meritato e vivo successo a tutta la compagnia.
IL VIAGGIO A REIMS [Lukas Franceschini] Verona, 25 maggio 2017.
L’ultimo titolo della stagione Lirica al Teatro Filarmonico della Fondazione Arena è stato Il viaggio a Reims di Gioachino Rossini, in prima esecuzione a Verona.
Non percorreremo qui la genesi di quest’opera particolare, la quale per precisione era una cantata scenica, fu composta e rappresentata a Parigi appositamente per i festeggiamenti dell’incoronazione di Carlo X. Rossini, il più celebrato compositore del momento, compose la cantata su un tessuto drammaturgico piuttosto debole ma affidò arie, duetti, e scene di rilevante invenzione musicale a tutti i protagonisti, i quali erano l’élite canora del tempo presente a Parigi: Giuditta Pasta, Laura Cinti-Domoreau, Carlo Zucchelli, Ester Mombelli, Domenico Donzelli, Adelaide Schiassetti e Nicholas-Prosper Levasseur.
Dopo le recite previste, e una ripresa sotto altro titolo, il manoscritto non avrebbe avuto occasione e significato di rappresentazione, pertanto, il compositore decise di utilizzare molte parti per un’opéra-comique Le Comte Ory, che differenzia notevolmente dall’originale. La partitura del Viaggio si credeva perduta, ma una casualità negli anni ’70 portò alla luce il manoscritto, non integrale, attraverso ricerche e studi effettuati in quattro città differenti. Si venne a capo della complicata edizione critica solo ai primi anni ’80 del secolo scorso, che produssero la prima esecuzione in forma scenica che fu al Rossini Opera Festival nel 1984 con un cast memorabile e sotto la direzione di Claudio Abbado, cui seguirà la prima incisione discografica. Abbado sarà il nome più legato alla riscoperta del titolo, il quale sarà nuovamente diretto dal direttore milanese, alla Scala, Vienna, Ferrara, Giappone, Berlino e ancora al Rof nel 1992. In seguito, Il Viaggio a Reims ha avuto vita propria ed è stato rappresentato a livello internazionale, anche se è opportuno rilevare le difficoltà di programmazione poiché per allestire l’opera, è indispensabile avere a disposizione ben dieci cantanti protagonisti, con parti molto impegnative, e sette altri artisti.
Lo spettacolo proposto a Verona proviene da Kiel allestito in prima nel gennaio scorso. Il cast veronese è stato invece all’insegna di proporre nuove promesse del teatro lirico, scelta obbligatoria per un verso (costi esosi) opinabile per altri considerate le ardue difficoltà.
Il regista Pier Francesco Maestrini ripropone la formula del cartone animato-video che nel passato Barbiere di Siviglia fu molto apprezzato, ma in quest’occasione i risultati non sono stati all’altezza. È cancellata ogni sostanza di eleganza, scivolando spesso nel banale, retorico e talvolta superflua pruderie. Se all’inizio vediamo la carrozza, che dovrebbe portare i nobili all’incoronazione, distruggersi in un viaggio spericolato, in seguito ci troviamo catapultati in un mondo surreale (e questo ci sta) che tuttavia non rende giustizia alla vicenda. Troppi i riferimenti sessuali, che proprio non ci stanno, soprattutto quando nel duetto Melibea-Libenskof si assiste a un amplesso tra la nobile dama e i camerieri. Ridicolo far apparire in scena Corinna in una toilette mobile, sempre occupata, cosi da costringere Trombonok a fare pipì all’aperto. Il lord inglese è un alcolizzato cronico, ben lontano dalla classe nobile che dovrebbe rappresentare (e la sua grande aria lo definisce bene). Poca attendibilità nella drammaturgia dei personaggi, i quali sono nobili e dovrebbero recarsi a un’incoronazione, privilegio riservato a pochi. Non contribuiscono i costumi, che parafrasavano le comiche anni ’20, a rendere efficace la scena vuota ma colmata da una visual-animazione curata da Joshua Held. Scene e costumi portano la firma di Alfredo Troisi. Non risolto e poco funzionale il celebre concertato a quattordici voci che dovrebbe essere un vertice sia musicale sia teatrale dell’opera, divertente invece la scena degli inni con la cartina geografica e il tentativo di recuperare il Regno Unito a seguito della Bretix. È indiscusso che ogni opera possa essere vista o concepita in modo diverso, tuttavia, in questo caso credo che le idee fossero scarse tanto da scivolare su troppe banalità talvolta anche fastidiose. La proiezione e il disegno animato erano di prim’ordine, però questo tipo di spettacolo è anche autore di distrazione musicale da parte dello spettatore. Non ci si diverte perché essenzialmente mancano fantasia e magia.
Francesco Ommassini, direttore e concertatore, era attentissimo alle raffinatezze della partitura, eseguita con grande disinvoltura di colore, buon equilibrio con il palcoscenico, e una controllata esecuzione in tutte le sezioni dell’organico. L’orchestra dell’Arena di Verona era in stato di grazia per precisione e solidità, tuttavia in generale a questa lettura mancava il ritmo e il brio, spesso preferito a tempi non serrati ma molto musicali.
Il Coro, diretto da Vito Lombadi, era preciso e puntuale nei brevi interventi.
Il cast, interamente composto di giovani, ha invece fatto rilevare le difficoltà nel recuperare voci opportune per i ruoli, anche brevi, ma di arduo impegno.
Tra i migliori si sono distinti: la Corinna di Lucrezia Drei, deliziosa cantante dotata di bella voce lirica, timbrata d irreprensibile tecnicamente, il Conte di Libenskof di Pietro Adaini che conferma le sue particolari doti vocali oltre ad un uso mirabile delle agilità e del registro acuto, Giovanni Romeo, spassosissimo Barone di Trombonok tanto azzeccato scenicamente quanto preciso nel canto, sempre controllato e rifinito è Xabier Anduaga, Cavalier Belfiore, buon cantante, omogeneo nei registri e rilevante nel fraseggio.
Meno efficace il resto della compagnia. Francesca Sassu è una Madama Cortese limitata soprattutto nella zona centrale e grave, Marina Monzò, Contessa di Folleville, è abbastanza disinvolta scenicamente ma non sempre precisa nella coloratura. La Marchesa Melibea di Raffaella Lupinacci risente di uno spessore vocale ridotto (specie in basso) e di un accento poco scolpito, Marko Mimica, Lord Sidney, avrebbe una voce ideale per il ruolo ma la coloratura non è pertinente, inoltre il personaggio è dozzinale per colpa della regia, quando invece il cantante avrebbe caratteristiche ben maggiori per emergere in nobiltà e teatralità. Fuori ruolo Alessandro Abis, Don Profondo, per carenze sia tecniche sia vocali per eseguire un’aria così complessa come quella delle medaglie. Molto bravo e rifinito il Don Alvaro di Alessio Verna e istrionico e puntuale il Don Prudenzio di Omar Kamata. Completavano la locandina la professionale Maddalena di Alice Marini, il preciso Don Luigino/Zeffirino di Stefano Pisani, e i puntuali Francesca Micarelli e Stefano Marchisio rispettivamente Delia e Antonio.
LULU [Simone Ricci] Roma, 27 maggio 2017.
Il capolavoro di Alban Berg torna per la seconda volta e dopo quasi mezzo secolo nella Capitale, ma si è trattato del debutto nella sua versione originale.
“Lulu”, capolavoro del compositore austriaco Alban Berg, è tornata per la seconda volta a Roma, ma l’allestimento curato dal regista sudafricano William Kentridge ha affascinato il pubblico del Teatro Costanzi con il “profumo” tipico del debutto. Si tratta di una delle opere principali del repertorio lirico del XX secolo e l’unico precedente nella Capitale risaliva al 1968, anche se in quel caso si puntò sulla versione in due atti. Stavolta, invece, è andata in scena quella integrale, più precisamente la versione ultimata nel 1979 da Friedrich Cerha. Il Teatro dell’Opera di Roma ha quindi scommesso su un titolo non semplice e su un libretto che già nel 1937 (anno della prima apparizione) provocò grande scandalo. Questa recensione si riferisce alla recita di sabato 27 maggio 2017.
Kentridge si è mostrato molto rispettoso delle indicazioni fornite da Berg e il suo allestimento si è avvalso della coproduzione con New York, Londra e Amsterdam. Gli spettatori romani hanno assistito a una sorta di doppio piano, quello delle scene realizzate insieme a Sabine Theunissen e dei costumi d’epoca (anni Venti) di Greta Goiris da una parte e dall’altra i disegni delle videoproiezioni, capaci di trasmettere tutta l’estetica dell’Espressionismo tedesco. Molto interessante è stato anche il cortometraggio realizzato dal regista e inserito tra la prima e la seconda parte del secondo atto, un film preparato seguendo le “istruzioni” di Berg e in grado di riassumere omicidio, processo, prigionia, malattia e declino finale di Lulu.
I segni di inchiostro nelle proiezioni, metafore di lame taglienti, hanno caratterizzato i tre atti. A impreziosire la scena ci hanno pensato due attori, l’australiana Joanna Dudley (sguardo penetrante e movenze sensuali in bilico sul pianoforte) e Andrea Fabi (la sua andatura inquietante ha evocato i film muti del periodo di “Lulu”, in particolare “Il gabinetto del dottor Caligari” di Robert Wiene, simbolo dell’Espressionismo tedesco). Entrambi erano al di fuori della narrazione lirica e non hanno mai parlato, ma hanno evocato con le loro maschere, sia facciali che reali, ogni singola emozione della storia con gesti e movimenti ben cadenzati.
La complessa partitura vocale dell’opera è stata affrontata con buone competenze e professionalità da tutti i cantanti. Non poteva non spiccare il soprano svedese Agneta Eichenholz, in grado di valorizzare la sua intensa interpretazione con una voce ben dispiegata e una notevole presenza scenica: l’insensibilità e l’indifferenza ai sentimenti sono stati resi in maniera egregia fino alle umiliazioni dell’ultimo atto. Jennifer Larmore ha tratteggiato i tormenti della Contessa Geshwitz con un denso timbro vocale, mentre il baritono tedesco Martin Gantner si è disimpegnato con maestria nel doppio ruolo del Dottor Schön e Jack lo Squartatore. Di pregevole fattura anche la performance di William White, uno Schigolch di buon impatto.
Nel cast, poi, si sono messi in evidenza Tamara Gura, un credibile studente innamorato e smaliziato ma anche guardarobiera di teatro e Groom, oltre a Charles Workman, intenso e sprovveduto Alwa. Decisamente positiva la prestazione di Zachary Altman, domatore e atleta dal timbro ben scolpito e convincente. Non vanno dimenticati gli altri personaggi, nello specifico Peter Savidge (banchiere e direttore del teatro), Brenden Gunnell (pittore e negro), Cristopher Lemmings (principe, domestico e marchese), il bel trio composto da Eleonora De La Peña (una quindicenne), Sara Rocchi (madre della quindicenne) e Reut Ventorero (arredatrice), Francesco Salvadori (giornalista), David Ravignani (cameriere) e Andrey Maslenkin (primario, professore e commissario di Polizia).
Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, il maestro Alejo Pérez ha dimostrato grande impegno nel cercare di vincere la complessità delle note di Berg, con una direzione sicura e senza fronzoli: il pubblico romano ha così approfondito le diverse sequenze tonali che contraddistinguono ogni personaggio dell’opera. Inoltre, è stato possibile immedesimarsi nel clima psicologico del libretto, localizzato nell’Europa degli anni Trenta tra Vienna, Parigi e Londra, in particolare le angosce successive alla fine della prima guerra mondiale e la grave depressione economica in Germania.
Alla fine della rappresentazione il pubblico del Costanzi ha tributato applausi a tutto il cast, con una ovazione prevedibile per la Eichenholz e la sua Lulu. Non si è trattato forse di un’accoglienza fanatica e intensa, d’altronde “Lulu” è un’opera moderna e non può essere alla portata di tutti, ma i commenti positivi tra gli spettatori sono la conferma di un vivo interesse. Di sicuro il teatro romano ha prodotto uno sforzo non indifferente per garantire un risultato godibile. Il lavoro di Berg verrà rappresentato ancora una volta nella recita finale di martedì 30 maggio.
LA CAMBIALE DI MATRIMONIO [Lukas Franceschini] Vicenza, 3 giugno 2017.
La XXVI edizione delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico è stata inaugurata dalla farsa La Cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini.
L’edizione 2017 si svolgerà dal 2 al 18 giugno, una serie di concerti in vari luoghi della città palladiana e quattro recite dell’opera rossiniana. La rassegna è ideata da Giovanni Battista Rigon, che ricopre la carica di direttore artistico assieme a Sonig Tchakerian che è responsabile del progetto musica di camera. Grande novità è il cambio della presidenza che da questa edizione è ricoperta da Tiziano Tiozzo, giovane imprenditore vicentino che durante la conferenza stampa ha illustrato il suo impegno che si concreterà nel fornire nuova luce al Festival valorizzando i progetti in corso e attirare un nuovo pubblico giovane. Inizia con questa edizione il progetto delle cinque farse di Rossini, che saranno rappresentate fino al 2021.
La prima opera composta di Rossini fu “Demetrio e Polibio”, a Bologna negli anni 1808-1809, su richiesta della famiglia Mombelli che la eseguì privatamente in casa loro. La prima esecuzione pubblica fu a Roma nel 1812. La seconda in ordine di composizione, ma prima per rappresentazione, fu invece La Cambiale di Matrimonio, primo contratto ufficiale del diciottenne pesarese con il Teatro Di San Moisè di Venezia ove fu rappresentata il 3 novembre 1810. Il successo procurò al compositore la commissione di altre quattro farse, e tre anni dopo il “salto” di qualità approdando alla Fenice con due capolavori come Tancredi e L’italiana in Algeri. La peculiarità del genere farsa, molto in voga fino alla meta del XIX secolo, era quella di creare un’opera in un atto, della durata di circa un’ora o poco più, senza la presenza del coro, orchestra ridotta a pochi elementi, con pochi personaggi (doveva sempre figurare il basso buffo e la primadonna), di genere comico-brillante e con finale lieto. Tale genere operistico era molto apprezzato e allestito comunemente in teatri minori, che programmavano la serata con molteplici spettacoli d’opera o balletto. Rossini conferma la straordinaria inventiva compositiva, la freschezza e la brillantezza sono encomiabili, le quali abbinate a un gusto ironico e un ritmo esilarante fanno di questi “piccoli” lavoro degli autentici gioielli del teatro d’opera comico.
Ogni volta che si entra al Teatro Olimpico, si resta esterrefatti per la bellezza del luogo, come la prima volta. Tuttavia tanta espressione d’arte limita la realizzazione di uno spettacolo d’opera, poiché il teatro non è stato costruito con tali prerogative. La bravura di un regista è di trovare una chiave di lettura pertinente utilizzando il luogo senza scene e con pochi elementi. In questo intento abbiamo ammirato l’idea e la realizzazione di Marco Gandini che ha realizzato uno spettacolo gradevole, divertente, e brioso quanto ci aspettava. Impera una lettera “R” in rosso (citazione del cognome del compositore) attorno una serie interminabile di lettere bianche sparse che saranno spostate dai cantanti creando nomi e citazioni della vicenda. Una specie di gioco, come in un’antica tipografia, con un tocco forse da cartone animato, ma che è funzionale e spassoso, per i settantacinque minuti dello spettacolo. Ben caratterizzata l’azione dei singoli, intricata e vorticosa. Moderni ma azzeccati per i ruoli i costumi di Michele Becce; Marco Tocchio, curatore del progetto scenico, utilizza a meraviglia tutto il possibile calpestabile del teatro, e Virginio Levrio firma delle luci autorevoli.
Giovanni Battista Rigon, direttore e maestro al cembalo, dirige con consumata esperienza, innata musicalità e non manca lo spiccato senso teatrale. La direzione è briosa e insieme raffinata, in cui la precisione ritmica nulla sacrifica al rigore e ai preziosi colori, mantenuta in perfetto equilibrio con il palcoscenico. In questa prelibata rappresentazione, il maestro è assecondato e seguito con estrema partecipazione dall’Orchestra di Padova e del Veneto, in stato di grazia.
La compagnia di canto, in prevalenza composta di giovani promesse, era capeggiata dalle maiuscole prove di Daniele Caputo e Paolo Ingrasciotta. Il primo, che impersonava Mill, sfoderava un’irresistibile vivacità teatrale ma non meno rilevante era l’aspetto vocale, padroneggiato con tecnica raffinata, soprattutto nel registro acuto, disinvolto nel fraseggio e nella varietà degli accenti. Il secondo, che interpretava Slook, era suo degno compagno quanto a bravura e stile, poiché anche in questo caso la voce era perfettamente calibrata, riuscitissimo il personaggio e molto precisi fraseggio e colori. Due prove notevolmente maiuscole.
La Fannì di Lara Lagni, lascia intravedere un futuro che speriamo luminoso, ma con i suoi solo “vent’anni” manca dell’autorevolezza della primadonna, anche se lo stile era buono e lodevole l’esecuzione della difficile aria.
Yauci Yanes Ortega, Edoardo, è un tenore con buoni mezzi ma ancora da raffinare soprattutto nello stile.
Frizzante e di buona fattura musicale la Clarina di Sara Fanin, bravissimo Diego Savini, Norton, un giovanissimo baritono molto promettente che sfoggia un timbro assai bello, morbido e compatto, una linea di canto ragguardevole assieme ad un’interpretazione di grande effetto teatrale.
Il piccolo teatro vicentino era esaurito in ogni settore, e alla fine ha giustamente decretato un interminabile applauso a tutta la compagnia.
RIGOLETTO [Lukas Franceschini] Forte Arena – Santa Margherita di Pula, 10 giugno 2017.
È stato inaugurato il primo festival estivo al Forte Arena di Cagliari, con l’opera lirica Rigoletto di Giuseppe Verdi.
Il Festiva estivo al Forte Arena è stato realizzato in collaborazione con vari enti locali, tra cui la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e il Resort Forte Village, e ha lo scopo di fornire alcuni spettacoli durante l’estate di vario genere in una conca naturale all’aperto a circa quaranta chilometri dal capoluogo sardo. Il progetto si intitola “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico, internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale degli attrattori locali”. Al termine dello spettacolo, considerato il successo, la folta presenza di pubblico e tutta l’organizzazione possiamo affermare che l’operazione è riuscita, e ci auguriamo che in futuro possa essere sempre più valorizzata e rifinita, divento un appuntamento fisso per l’isola, poiché si tratta dell’unica realtà di spettacoli all’aperto in tutta la Sardegna.
Lo spettacolo era ideato da Joseph Franconi Lee, assistente per molti anni di Alberto Fassini, è proprio da un allestimento di questi trova una felice realizzazione per “ideare” e adattare al palcoscenico sardo un Rigoletto di fattura nel solco della tradizione. Lodiamo questa idea poiché non era il caso di cercare soluzioni moderne, magari intrinseche e poco comprensibili, e rilevano ancora una volta che uno spettacolo di tradizione non è assolutamente segno d’inferiorità. Lo dimostra pienamente la realizzazione cagliaritana, la quale si avvale di una scena imponente ben costruita, è realizzata per opera di Alessandro Ciammarughi. Montata su una pedana girevole era idealmente strutturata per cambi scena veloci, facendo in modo che l’opera fosse, giustamente, rappresentata in due parti con un solo intervallo. La regia era efficace e ben concentrata sulla drammaturgia dei personaggi, il libertino duca, il giullare dalla doppia vita che trova amorevoli sfumature più nella figura del padre, la giovane fanciulla sacrificata quasi in una clausura che trova respiro in un amore impossibile, i cortigiani subdoli quanto bonariamente accondiscendenti ai voleri del loro signore. Tutto questo insieme è stato reso senza calcare troppo la mano in facili banalità, ma mantenendo un equilibrio apprezzabile e ricco di sfumature, intenzioni e buon teatro. Molto belli i costumi, sempre di Ciammarughi, in classico stile cinquecentesco. Fabio Rossi ha fornito un pertinente apporto al disegno luci.
Molto buona la prova dell’’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari diretta da Donato Renzetti, bacchetta sicura ed esperta che ha concertato il tutto con tempi sostenuti e una gamma di colori molto pregevoli, mantenendo una linea interpretativa incisiva e forgiando un ottimo rapporto con il palcoscenico. E’ quasi superfluo affermare che trovandoci all’aperto è stato utilizzato un impianto di amplificazione, ma questi era ben calibrato offrendo un apprezzabile ascolto.
Una menzione particolare va al Coro del Teatro per l’ottima esibizione offerta, merito anche del maestro Gaetano Mastroiaco.
Star della serata e protagonista era Leo Nucci, il Rigoletto per antonomasia degli ultimi decenni. Il baritono emiliano che proprio nel 2017 festeggia i cinquant’anni di carriera, ha offerto la sua “solita” interpretazione, vissuta partecipata, straziante. Non c’è nota o angolo dello spartito che non sia conosciuto da Nucci, e che egli non possa realizzarlo nel migliore dei modi. Sarebbe banale affermare che il cantante si trovi nel momento folgorante della sua carriera, ci troviamo nella fase finale, e proprio per questo siamo di fronte ad un grande artista. Non tutte le note erano perfettamente calibrate o realizzate, ma poco importa, il personaggio era impressionante nella sua essenza drammatica multipla di padre e buffone di corte. Nucci ha ancora frecce nel suo carniere e a Cagliari le ha sfoderate tutte, reggendo benissimo il confronto con se stesso.
Barbara Bargnesi era una Gilda delicata ma non bambola, molto inserita nella realizzazione del personaggio forte e senza dubbi del suo agire. La voce squisitamente lirica, non ha tutte le agilità richieste ma è molto musicale e il fraseggio era molto curato.
Esuberante il Duca di Antonio Gandia, tenore sempre in ascesa, spavaldo e di facile squillo, anche se limitato e la zona di passaggio richiede perfezionamento, ma il personaggio era ben tracciato.
Molto bene Cristiana Saitta, uno Sparafucile molto credibile e realizzato con mezzi rilevanti e precisi, e Martina Serra, Maddalena di temperamento sempre puntuale. Di solida professionalità il Monterone di Gocha Abuladze.
Tra le parti minori si mettevano in luce per accento e carisma vocale Enrico Zara (Matteo Borsa) e Francesco Leone (Conte di Ceprano). Tra gli altri giustamente citiamo con plauso: Leonora Sofia (Giovanna), Nicola Ebau (Marullo), Ivana Canovic (Contessa Ceprano/Paggio).
Successo trionfale al termine per tutta la compagnia. La scommessa di questa prima è stata vinta, auguriamoci l’inizio di un appuntamento fisso con il Forte Arena.
LA BOHÈME [Lukas Franceschini] Milano, 15 giugno 2017.
Al teatro alla Scala l’ennesima proposta dell’opera La Bohème di Giacomo Puccini, nello storico allestimento di Franco Zeffirelli del 1963.
C’è poco da aggiungere su questo meraviglioso spettacolo, sempre godibile, sempre piacevole, e oserei dire quasi perfetto nella sua essenza ancor oggi dopo oltre mezzo secolo di vita. Quando uno spettacolo ottiene un successo così elevato sia da parte del pubblico sia della critica, con numerosissime riprese, noleggi in tutto il mondo, senza contare le occasioni in cui la Scala stessa l’ha portato in numerose tournée estere, i numeri parlano da soli. Ma oltre a questi siamo di fronte ad una bellissima realizzazione, che seppur nel solco della tradizione (la quale non è sinonimo d’inferiorità creativa), piena di poesia, luce, perfetta drammaturgia che rende questa messa in scena probabilmente la migliore realizzata nel ‘900. Il lavoro di Zeffirelli, encomiabile, è stato ripreso da un suo storico collaboratore, Marco Gandini, il quale ha il pregio di aver saputo rispettare le intenzioni originali, con poche garbate e apprezzabili modifiche.
Sul podio il direttore Evelino Pidò, il quale ha concertato la partitura con eccellenti risultati. Particolarmente attento al variegato gioco di colore orchestrale, la rifinita tinta sia drammatica sia gioviale. La scioltezza dei tempi precisa e la sensibilità della bacchetta infonde all’intero cast e al coro una comunicativa efficace. Splendida la prova del coro, istruito da Bruno Casoni, preciso e puntuale in tutte le occasioni assieme al Coro di Voci Bianche, spigliatissimo e bravissimo.
Nel cast Sonya Yoncheva, cantante sempre più in ascesa che debuttava alla Scala, coglie nel ruolo di Mimì un meritato e personale successo. La sua esibizione è stata molto toccante sotto il profilo interpretativo, ottimo fraseggio ed efficace recitazione. Vocalmente la brillantezza dei colori, l’uniformità dello strumento e una tavolozza timbrica autorevole cui si deve sommare un legato ammirevole. Una gran bella prova.
Fabio Sartori è stato un ardente Rodolfo, sempre puntuale e tutto sommato preciso, da quale ci si sarebbe aspettata anche una scansione più ricercata ma nel complesso il personaggio è eloquente e piacevole.
Simone Piazzola, Marcello, ha esibito una buona classe interpretativa ma il volume della voce è molto ridimensionato rispetto a qualche anno fa, e talvolta era di difficile ascolto, tuttavia, il cantante sfodera accenti e intenzioni ragguardevoli.
Molto bravo Mattia Olivieri, Schaunard, che ha fornito al personaggio una personale e molto gradita vivacità teatrale, accomunata con un’esibizione canora molto elevata per spontaneità d’accento, colore e fermezza timbrica.
Peculiarità che non si sono trovate in Carlo Colombara, Colline, il quale possiede ancora un materiale importante ma purtroppo molto appiattito e povero di armonici tanto da far passare sotto silenzio la sua delicata aria del IV atto.
Molto brava Federica Lombardi, Musetta, cantante con spiccata musicalità e senso teatrale raffinato che risolve il personaggio con simpatica eleganza e seduzione senza scadere nel facile cliché volgare.
Impagabile il Benoit di Davide Pelissero, simpatico l’Alcindoro di Luciano Di Pasquale e bravi i solisti dell’Academia che interpretavano i ruoli minori. Francesco Castoro (Parpignol), Gustavo Castillo (sergente), Rocco Cavalluzzi (doganiere), Jeremy Schutz (venditore). Successo trionfale al termine.
LUCIA DI LAMMERMOOR [Lukas Franceschini] Bologna, 16 giugno 2017.
Importante proposta al Teatro Comunale: Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti in un nuovo allestimento di Lorenzo Mariani e con il debutto nel titolo del direttore Michele Mariotti.
Lucia di Lammermoor è il titolo più famoso del compositore bergamasco, in passato spesso soggetto a tagli scellerati. Oggi fortunatamente le esecuzioni sono integrali, le quali rendono maggior drammaticità e un impegno canoro più rilevante.
A Bologna abbiamo visto il nuovo spettacolo creato da Lorenzo Mariani, con scene di Maurizio Balò e costumi di Silvia Aymonino, una coproduzione con Bilbao, Bratislava e Genova.
Il regista idealizza il dramma di Scott in una selvaggia e violenta brughiera scozzese, cupa e oppressiva. La famiglia Ashton vive rinchiusa nella sua dimora, la quale mostra il lustro dell’alta società, anche se le risorse sono risicate. Ambientazione molto bella e originale, i difficili anni ’30 del secolo scorso, dopo il conflitto mondiale e in piena crisi economica. Le scene erano bellissime, magnificenti le ampie verte dalle quali s’intravedeva una splendida brughiera in bianco e nero. I costumi eleganti e in stile scozzese di grande fattura, lasciava a desiderare solo il succinto vestito da sposa Lucia. L’idea registica funziona nel suo insieme, e possiamo tollerare anche talune forzature cruente. Tuttavia, non si possono sottacere alcune cadute di gusto imperdonabili che potrebbero essere ascritte alla paura di scarsa efficacia teatrale del testo. Mi riferisco al tentativo di stupro ai danni della protagonista da parte del fratello al termine del duetto del II atto, inutile e notevolmente fuori luogo. Il personaggio di Arturo che nella scena della pazzia stramazza agonizzane sul tavolo del banchetto nunziale nell’indifferenza dei commensali. E infine il manichino impiccato di Lucia mentre Edgardo canta l’aria finale. Peccato! Perché nel suo insieme lo spettacolo era gradevole e ben focalizzato sui personaggi con scene molto efficaci, ma queste “idee” hanno prodotto al termine una sonora contestazione al regista e ai collaboratori.
Michele Mariotti offre una lettura molto pertinente della partitura, in simbiosi con la buona orchestra del Comunale. La sua lettura è molto energica con tempi sostenuti, da poco spazio al romanticismo ma gioca con mano esperta nel colore e nella tinta drammatica della partitura. Inoltre non bisogna dimenticare l’ottimo rapporto della buca con il palcoscenico, sempre controllatissimo e in sovente in palese aiuto ai solisti.
Validissima la prova del Coro istruito da Andrea Faidutti.
La protagonista era Irina Lungu, che conferma la sua professionalità già espressa in questo ruolo. La voce è sempre bellissima e anche estesa, tuttavia, non è possibile affermare che la signora Lungu sia una virtuosa di razza ma risolve tutta la difficile parte sfoderando i migliori mezzi: un fraseggio perfetto, sfumature, accenti e colori da grande interprete, i quali le permettono di superare il compito con giusta lode.
Stefan Pop, Edgardo, sfoderava una voce di primordine ricca di fascino e proiettata con forza nel settore acuto risolto con fermezza. Tutte qualità importanti che però dovrebbero essere amministrate con maggior raffinatezza e cercare qualche sfumatura più romantica e un accento più sentimentale. Le doti ci sono, credo che siano solo da raffinare.
L’Enrico di Markus Werba è un buon Enrico, il canto è talvolta un po’ forzato, forse anche per l’enfasi della regia, ma quando si concentra ecco che prevale il buon canto raffinato, morbido e di classe, oltre alla pregevole figura scenica.
Molto bravo il Raimondo Evgeny Stavinsky, basso in possesso di un materiale vocale di prim’ordine, cui si somma un’eloquente fraseggio e una linea di canto molto apprezzata.
Alessandro Luciano, Arturo, s’impegnava con onore nel ruolo dello sposino con carattere e temperamento. Professionali il Normanno di Gianluca Floris, e l’Alisa di Elena Traversi.
Al termine successo per tutta la compagnia con punte di calore per il tenore Pop e il maestro Mariotti, e come predetto contestazioni al regista.
L’INCORONAZIONE DI POPPEA [Mirko Gragnato] Venezia, 21 Giugno 2017.
L’incoronazione di Poppea alla Fenice è una delle tre opere proposte per il 450° anniversario della nascita di Monteverdi. Una versione semiscenica che vede Sir John Elliot Gardiner nella doppia veste di direttore e regista a guidare l’ English Baroque Soloists e un cast di vero pregio per vocalità.
In questa scelta semiregistica con pochi tocchi di semplice scena, come i costumi, essenziali ma molto comunicativi; la parte propriamente scenografica la fa il teatro la Fenice, che con giochi di luci e riflessi coinvolge i suoi fregi dorati, stucchi e decori, calandoli in un tutt’uno con l’opera.
Il suono dell’ English Baroque Soloists è certo tra i più curati, soprattutto la sezione dei fiati composta da flauti dolci e di cornetti; flauti dolci che hanno vari pezzi a solo già nella breve sinfonia di apertura. Il cast è verosimilmente lo stesso per le tre opere: Orfeo, il ritorno di Ulisse in patria e l’incoronazione di Poppea, con qualche cambio e modifica.
Un teatro tutto esaurito, dalla platea, ai palchi, al loggione, non c’era un solo posto vuoto, la fama di Gardiner e della sua orchestra hanno sicuramente destato l’interesse di Veneziani e non, ma soprattutto la musica di Monteverdi che per questo straordinario anniversario ha dato la possibilità di arricchire i cartelloni di molte stagioni con musiche monteverdiane, che mancavano dalle stagione di molti teatri Italiani. Sir John Elliot, inoltre, servendo la musica sceglie di ridurre gli intervalli, cercando di fare un’esecuzione il più possibile capo fine senza troppe interruzioni, a Versailles qualche anno fa abbiamo scritto di un Orfeo, per duri e puri senza nemmeno una pausa; in Fenice un solo intervallo è stato inserito nella metà del II atto di questa Poppea.
Nel cast il contro tenore che presta la voce all’imperatore Nerone è Kangsim Justin Kim – giovane stella della vocalità maschile più acuta, nominato cantante dell’anno nel 2016 dall’opernwelt – con aria giovane e sbarazzina ha mostrato di riuscire ottimamente nel ruolo di Nerone, sia per tessitura vocale che per presenza scenica, rendendo efficacemente l’interpretazione di un imperatore giovane e volubile, il vigore dell’età mescolato al potere può far in effetti danni catastrofici, ma è ancora da venire l’incendio la cui colpa ricadrà proprio su questo imperatore così curioso e così dedito alle arti. Un vero personaggio Kangsim, il viso efebico e il nome orientale creavano molta ambiguità e nel pubblico non si capiva se fosse una voce maschile o femminile quella che interpretava il ruolo di Nerone. Il duetto tra lui e Seneca, interpretato dalla splendida voce cupa e profonda di Gialuca Buratto, trasmetteva il pieno scontro tra saggezza e inesperienza, tra il vecchio maestro e il giovane allievo. Buratto tocca punte di fantastica vocalità grave e di grandissimo pathos in “Solitudine Amata!” duettando poi con Mercurio, interpretato da John Taylor Ward, che nel farsi messaggero celeste si manifesta solo con riuscitissimo gioco di luci sul proscenio, il messaggero degli dei viene così evocato nella sala anche se “vero amico del cielo” viene cantato dalla galleria o dal loggione con un coinvolgente effetto surround.
Nel ruolo di soldato e liberto Furio Zanasi che avevamo già incontrato nel ruolo di Ulisse ne “Il ritorno in patria” qui nel farsi ambasciatore di morte nel ” Seneca, Seneca, assai m’incresce di trovarti” non tocca punte di meraviglia ma riesce a catturare la compassione del pubblico, che nell’intervento del Monteverdi Choir nel ruolo dei Familiari in “non morir Seneca no!” raggiunge un bellissimo momento tragico che lascia il pubblico completamente silente grazie alla disperazione tratta dai bellissimo giri sul limite acuto delle voci maschili, quasi fosse un rotto singhiozzo.
Altra vocalità speciale di questo cast è Anna Dennis, che oltre a interpretare la Fortuna veste anche i panni di Drusilla, amante di Ottone. Una donna che punta a sacrificarsi e prendersi le colpe dell’amato per il tentato assassinio di Poppea, seppur innocente. Molto convincente nelle intenzioni sceniche riesce ad ottenere la simpatia e l’affetto del pubblico che arriva a preoccuparsi nell’attesa del verdetto Neroniano.
Molte sono le dame di quest’opera, dove seppur l’ultima sentenza spetti all’imperatore, molto ruota attorno al gentile sesso, come i ruoli della nutrice dell’imperatrice Ottavia o l’ancella di Poppea, Arnalta.
La prima interpretata comicamente da un contro tenore, Michal Czerniawski, così da unire gli acuti della voce femminile ai gravi toni della vecchiezza, un commediante che riesce a strappare più di un sorriso al pubblico e che teatralmente mescola le tessiture acuta e grave senza difficoltà e con molta naturalezza; un personaggio ottimamente riuscito anche nel duetto con il valletto, Silvia Frigato, che interpreta anche amore. Di statura piccina la Frigato è perfetta anche registicamente in questo ruolo un po’ giovane birbante, un po’ spiritello alato, che si nasconde dentro l’arpa per difendere le sorti di Poppea.
Arnalta, interpretata dal contralto (mezzo soprano) Lucile Richardot, riesce benissimo nel ruolo di serva arrampicatrice sociale, nel bellissimo solo, che molto induce a riflettere “Oggi sarà Poppea di Roma Imperatrice! Io, che son la nutrice, ascenderò delle grandezze i gradi: no, no, col volgo io non m’abbasso più”. Bellissima voce dal colore scuro e vivace. L’avevamo già sentita nelle vesti di Penelope ne “ Il ritorno di Ulisse in patria” e sembra quasi “dal nascer matrona e morir serva” o “nascer serva e morir matrona” come suggerisce il libretto, ci sia stato un simpatico e comico ardimento in questo scambio di ruoli, neanche a farlo apposta.
In quest’opera completano il cammeo di Marianna Pizzolato, ottima nel ruolo di Ottavia, che nel “disprezzatta regina” tocca punte di forte drammatismo.
Il controtenore Carlo Vistoli, nel ruolo di Ottone, apre l’opera subito dopo il prologo con una voce piena e misurata nonostante gli alti svolazzi della tessitura acuta.
Ovviamente l’opera non ci sarebbe senza Poppea, interpretata dal soprano Hana Blažíková, che veste anche i panni della Virtù nel prologo. Anche lei una bellissima voce cristallina che si intreccia perfettamente con gli acuti del Nerone di Kangsim. L’ultimo duetto “pur ti miro pur ti godo” che vede i due amanti, Nerone e Poppea, finalmente concedersi l’un l’altro senza più nessun limite corona l’opera di una grazia speciale.
Dall’Orfeo come per l’Ulisse qui la musica di Monteverdi si mostra molto più consapevole e matura, l’aria di Venezia sospesa sulle acque della laguna sicuramente è stata musa ispiratrice per molti estri musicali in Monteverdi.
NABUCCO [Lukas Franceschini] Verona, 23 giugno 2017.
Il 95° Opera Festival all’Arena di Verona è stato inaugurato da una nuova e molto attesa produzione di Nabucco, opera di Giuseppe Verdi, con la regia di Bernard Arnaud.
Nabucco segna il grande trionfo di Verdi al Teatro alla Scala, dopo un successo di stima (Oberto) e un clamoroso fiasco (Giorno di regno). Terza opera cronologica del maestro di Busseto, fu allora giudicata con enfasi per la musicalità accesa e una scrittura che seppur ruvida ponesse le basi di uno stile che avrebbe avuto una lenta maturazione per sfociare anni più avanti in un vero e proprio fenomeno nazionale. Nel 1842 Verdi si rifaceva ancora, in parte, ad autori da lui studiati tenacemente nel periodo milanese, nel quale non fu ammesso al conservatorio e studiò privatamente. L’opera, su libretto di Temistocle Solera, rivela nel suo insieme un tessuto di sintesi che contraddistingue i melodrammi verdiani e disegna drammaturgicamente i personaggi con entrate indicative e arie grandiose. Non manca l’utilizzo cospicuo del coro, e non solo nel celebre “Va pensiero” del III atto, ma in molte occasioni 3durante tutta l’opera. Successo fin dall’inizio con numerose repliche, al tempo era sinonimo di trionfo, e opera in seguito mai uscita dal repertorio, pertanto esclusa da quella Verdi-renaissance che iniziò negli anni ’30 del secolo scorso.
All’Arena di Verona negli ultimi anni abbiamo visto molte produzioni di Nabucco, le quali erano comunemente d’impostazione tradizionale. Il regista Arnaud si è volutamente ispirato a un elemento primario il Risorgimento italiano, nel quale oggi in malafede si crede che i lavori di Verdi influirono nei loro contenuti alle vicende politiche dell’epoca. Se si supera tal errore storico, possiamo tuttavia apprezzare un lavoro di grande messa in scena, forse addirittura kolossal. Il regista, ha preso a prestito la scena iniziale del celeberrimo film “Senso” di Luchino Visconti, nel quale all’interno della Fenice si rappresenta Il Trovatore, e al termine del terzo atto il loggione inneggia alla liberazione di Venezia d parte degli austriaci. Partendo da questi presupposti, cioè considerando Nabucco un simbolo e ideale di tale epoca, Arnaud ha trasportato la vicenda durante le Cinque Giornate di Milano, con barricate, tumulti e il monumento più famoso della città: il Teatro alla Scala.
Per analizzare questa lettura non dobbiamo cadere nel facile tranello della filologia drammaturgica e storica. Questo è un prodotto di fantasia, nel quale lo spettatore deve lasciarsi accompagnare in una lettura anomala ma avvincente quasi cinematografica. Se non si sorpassa questo scoglio, il “Nabucco” Arnaud non piacerà e sarà soggetto a critiche anche molto pesanti. Se invece ci si rende disponibili ad affrontare un racconto epico, nel conflitto tra due popoli, oppressi e oppressori, lotta per il potere, insurrezioni eccetera, allora si potrà godere di questa nuova e diversa lettura, che personalmente trovo avvincente e originale. La scena, strepitosa, di Alessandro Camera, è costituita dall’edificio del Teatro alla Scala visto dall’esterno, e posto di sbieco su una pedana circolare movibile. Ai lati le classiche barricate composte di mobili, carretti. Già durante la sinfonia si ammirano i tumulti dei milanesi che fanno fronte all’invasore austriaco, con spari di fucili e cannoni, è un grande movimento di masse che rende la visione mozzafiato. Crocerossine, carbonari, patrioti, soccorritori, popolo, in uno dei momenti di maggior conflitto. Arnaud è maestro nel muovere alla perfezione artisti del coro e comparse, e in quest’occasione c’è n’erano veramente tanti. Volutamente della dimensione spirituale di Babilonia e degli ebrei non c’è traccia. I personaggi possono essere accostati a figure del Risorgimento. Ecco dunque che Zaccaria, il profeta, non è altro che un fiero rivoluzionario che potrebbe essere paragonato a Giuseppe Mazzini, Abigaille una sorta generale in gonnella, qui frutto della fantasia, Nabucco è l’alter ego di Francesco Giuseppe, l’imperatore invasore del Lombardo Veneto, Fenena una fiera Contessa Serpieri dal racconto di Camillo Boito. Il lavoro è totalmente di fantasia, il quale sfocia in una plausibilità drammaturgica che affascina. Lo spettacolo è in stile kolossal a tutti gli effetti. Il grande spostamento delle masse come predetto è esemplare ma non mancano grandi effetti come quando il teatro alla Scala si gira nel II atto creando un nobile appartamento ottocentesco per la grande scena di Abigaille, e ancor più, con fragoroso applauso, quando nel terzo atto siamo all’interno del Teatro alla Scala esattamente ricostruito con i suoi pacchi in raso rosso è una platea con panche in stile ottocento. Il coro è messo tra platea e palchi, ed è lo stesso pubblico che assiste a una rappresentazione di Nabucco, il quale chiede il bis del celebre coro come simbolo d’insurrezione. A mio avviso tutto funziona drammaturgicamente pur in una annunciate e deliberata fantasia. Molti durante gli intervalli discutevano sulle divise dei soldati non corrette, di alcune bandiere opinabili, o altri elementi, ma penso che in questo caso siano capziosità, nab 7poiché non era intento del regista fare un documentario storico, bensì una narrazione popolare di eventi che hanno segnato la vita del nostro paese. Approvo le parole del regista “… Mi sono permesso questa fantasia perché l’ambiente narrato nel libretto di Solera è fantasia. È più la forza del simbolo che la storia stessa ad avermi guidato”.
Da rilevare gli splendidi costumi, disegnati dallo stesso regista, dei quali non so dire se colori o taglio siamo esattamente coerenti con il momento, ma siamo di fronte a manufatti di alta scuola del costume che lasciano una traccia non facilmente dimenticabile. Lo stesso ricordo che ha lasciato anche la scena, imponente e meccanicamente perfetta. Non sono sicuro ma credo costruita interamente dai laboratori della Fondazione Arena, che confermano un lavoro straordinario.
Grande partecipazione scenica di numerose comparse che hanno letteralmente invaso l’anfiteatro, con grande professionalità.
Il versante musicale ha confermato la grande professionalità di alcuni e parecchie delusioni nei solisti.
Sul podio c’era Daniel Oren, un’istituzione in Arena, il quale ha concertato con la solita tecnica precisa, e un ritmo tipicamente verdiano della prim’ora. Tuttavia, in taluni momenti il suono era molto contenuto e di difficile ascolto, e certe raffinatezze della bacchetta non si potevano cogliere. Penso che anche la posizione dell’orchestra debba essere riveduta e migliorata nella presa di suono che diversamene per le voci è adesso collaudata tramite dei riporti. Resta innegabile l’efficace direzione del direttore israeliano, anche se in taluni momenti mi sarei aspettato più impulsività, e l’ottima prova dell’Orchestra dell’Arena.
Ha trionfato il grandioso Coro dell’Arena, istruito da Vito Lombardi, che sempre più è punto di riferimento per le esecuzioni teatrali a Verona in particolare all’Arena. Immancabile il bis di “Va pensiero” al terzo atto, giustificato per una prima ma con l’auspicio che non diventi prassi per tutte le altre recite.
Deludente nel complesso la compagnia di canto. Il Nabucco di George Gagnidze, non possiede la caratura del cantante verdiano soprattutto nella padronanza del fraseggio e dell’accento, eseguiti con genericità. Non aiutato dal portamento scenico e da qualche scivolata nell’intonazione, bisogna riconoscere che nel finale ha saputo in parte riscattare una performance molto ridimensionata.
Tatiana Melnychenko, Abigaille, è il classico soprano dell’est dotato di tanta voce ma per nulla rifinita in tecnica e stile. Infatti, oltre a una dizione incomprensibile in ogni parola, la sua esibizione si è basata sulla forza delle corde vocali, ma molto limitata in fraseggio e colori tanto da essere anche banale.
Note non meno negative, o forse più, per il basso Stanislav Trofimov, Zaccaria, che ha sfiorato l’imbarazzante per appariscenti lacune vocali che non gli permettono minimamente di superare un giudizio accettabile.
Walter Fraccaro, Ismaele, è il solido professionista che conosciamo, ma credo non in serata poiché leggermente appannato. Meglio la Fenena di Carmen Topciu, professionale cantante capace di finezze attraverso una voce ben calibrata e sostenuta nell’accento e colore.
Bravissimo Romano Dal Zovo, Gran Sacerdote, che a ogni occasione conferma qualità che un prossimo futuro dovrebbe portarlo a ruoli di protagonista.
Molto buone le prove di Paolo Antognetti, Abdallo, e Madina Karbeli, Anna, due dei più validi artisti nei ruoli minori fortunatamente spesso utilizzati a Verona.
A termine di una serata torrida, che credo abbia anche condizionato l’esibizione di molti soliti, il successo non è mancato con convinti applausi per tutti. Due annotazioni a margine. Possibile che non si possa nascondere la gru all’esterno dell’anfiteatro, un vero pugno nell’occhio; e peccato l’opera non fosse rappresentata in due parti con un solo intervallo. Spettacolo sicuramente da rivedere con cast alternativo.
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL [Lukas Franceschini] Milano, 29 giugno 2017.
Al Teatro alla Scala è stato allestito Die Entführung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart nello storico allestimento di Giorgio Strehler.
Le recite in programma dell’opera mozartiana sono state inserite nell’attuale stagione d’opera per una doppia commemorazione: i vent’anni dalla scomparsa di Strehler e i dieci di Luciano Damiani, scenografo e costumista. Questo spettacolo fu creato per il festival di Salisburgo nel 1965, erano protagonisti Annaliese Rothenberger, Fritz Wunderlich e Fernando Corena, direttore Zubin Mehta, lo stesso di questa ripresa scaligera. La produzione fu poi acquistata dal Teatro alla Scala e allestita nel 1972, 1979 e 1994 con cast differenti ma rilevanti.
Rivedere questo bellissimo spettacolo è stato emozionante (per i ricordi del ‘94) e occasione per ripensare al teatro di regia. Trattasi di uno dei pochi casi di spettacolo perfetto, ideato sulla musica e su un teatro in stile nel segno dell’eleganza e nel rispetto mozartiano. Pare che alcuni abbiano espresso delle critiche, preferendo una regia più moderna al passo con i tempi, ma mi permetto di dissentire con forza, poiché questa produzione del Ratto è agile, lineare, costituita da fondali bellissimi, quinte mobili tradizionali in stile orientale, costumi irreprensibili nella fattura. Poi la regia di Strehler (oggi ripresa da Mattia Testi) ci regala un mondo mozartiano sicuramente del suo tempo ma attuale e vivo nella recitazione, stilizzato, elegante, comico senza eccessi, una piacevole visione che appaga l’anima dello spettatore. Inoltre, la drammaturgia è sviluppata tra proscenio (in ombra) durante le arie e la recitazione, con i dialoghi parlati, al centro della scena illuminata da luci più sostenute (ottimo il lavoro di Marco Filibeck), che sottolineano l’appartenenza dell’opera al singspiel. Il teatro illuminato durante l’overture e la grande aria di Konstanze al secondo atto, hanno segnato grandi momenti di teatralità Poiché recentemente abbiamo visto alcuni nuovi allestimenti del Ratto molto meno fortunati, intrisi di cervellotica psicologia e scelte registiche ambigue, meglio la vecchia e tradizione strada che le nuove proposte.
Molto bella la direzione di Zubin Mehta, che si sviluppa in tempi dilatati ma sempre armoniosi e stilizzati, senza eccedere in frenetiche sonorità che identificano la scuola del maestro indiano. La perfetta sintonia con l’Orchestra del Teatro alla Scala, in forma mirabile, ha prodotto un di suono dolcissimo, forse nostalgico, ma calibrato e sfumato, indubbiamente di grande effetto teatrale.
Bravissimo il Coro, diretto da Bruno Casoni, nei brevi interventi e impeccabili i quattro solisti.
Il cast era prevalentemente “tedesco” con limiti vocali ma perfetta dizione anche se ha dimostrato una generale omogeneità però senza punte particolari.
Mauro Peter, Belmonte, ha voce non particolarmente seducente ma è musicale, però le agilità sono il suo tallone d’Achille. Più compita la Konstanze di Lenneke Ruiten incisiva nei brani di eroica determinazione pur non possedendo una tecnica virtuosistica afferrata, e, infatti, l’esecuzione di “Marten aller Arten” era molto approssimativa.
Tobias Kehrer, Osmin, imperversava la scena con una compita recitazione mai sopra le righe, accomunata ad un canto rifinito anche se il registro grave richiesto non è risolto a dovere.
Maximilian Schmitt è un simpatico e professionale Pedrillo. La migliore era Sabine Devieilhe, Blonde, che recita in maniera impeccabile e canta con una voce esile ma nitida e pulita e assolve tutti i suoi compiti, soprattutto nel registro acuto, con precisione e duttilità.
Da menzionare la bravura dell’attore Cornelius Obonya (Selim), l’ottima prova del servo (ruolo muto) di Marco Merlini, elegante e brillante e i quattro bravissimi mini.
Successo incontrastato per tutti al termine, anche se l’ovazione l’ha ricevuta il maestro Mehta.
RIGOLETTO [Lukas Franceschini] Verona, 6 luglio 2017.
La terza opera del 95° Festival Opera è Rigoletto di Giuseppe Verdi, proposta nell’allestimento creato da Ivo Guerra nel 2003, liberamente ispirato a uno spettacolo areniano del 1928.
Un allestimento classico, nella forma più elevata del termine, contraddistinto da una scenografia imponente della reggia ducale di Mantova, ideata da Raffaele Del Savio, giganteggia sulle gradinate per tutta l’opera, sul palcoscenico con cambi scena veloci sono ideati i diversi ambienti del I atto. Tutto funziona perfettamente in un racconto “epico” senza banalità, pulito, strettamente aderente al libretto e di considerevole efficacia narrativa. La lettura registica di Ivo Guerra è sostanzialmente narrativa e riporta a una forma di spettacolo forse ormai sorpassato, avrebbe potuto mettere evidenziare meglio i caratteri dei personaggi, ma si lascia vedere come un piacevole romanzo d’appendice. Straordinario il lavoro dello scenografo che ci riporta in una Mantova cinquecentesca di meravigliosa monumentalità, contribuisce anche la mano esperta di Carla Galleri, costumista, che realizza costumi sontuosi in perfetto stile storico. Non del tutto efficaci il gioco di luci che avrebbero potuto fornire una visione ancor più espressiva, ma nel complesso questo classico spettacolo è godibile ed è azzeccato in una stagione che offre differenti letture drammaturgiche in altre opere (Aida e Nabucco).
Delude la direzione di Julian Kovatchev che si sviluppa in una monotonia disarmante. Il direttore ha concertato in maniera anomala e priva di qualsiasi colore orchestrale, scansione di effetti e una lentezza esasperante, i quali spesso hanno messo in difficoltà i solisti. Non ricordavamo il maestro come una bacchetta di mirabilissima, tuttavia sempre di solida professionalità, che in quest’occasione non è stata confermata. L’orchestra dell’Arena, sempre precisa, si deve adeguare alle disposizioni del podio e pare le esegua di controvoglia. Molto buona la prova del Coro, istruito da Vito Lombardi, che purtroppo fatica ad adeguarsi ai tempi del direttore.
Ottima esibizione quella di Amartuvshin Enkhabat, Rigoletto, al suo debutto in Arena, dopo un concerto nella scorsa stagione presso l’Associazione Verona Lirica. La qualità della voce è bella, di prim’ordine, robusta e uniforme in tutti i registi. Il cantante mongolo sfodera un fraseggio eloquente, anche migliorabile, e accenti di cantante di gran classe. Il personaggio è musicalmente ben costruito nella drammaturgia canora che non lascia indifferenti, un po’ meno la resa teatrale, ma considerata l’esigua carriera finora intrapresa, abbiamo da augurarsi prossime altrettante felici, e più rifinite esibizioni.
Jessica Pratt, Gilda, ha dimostrato la consueta predisposizione al ruolo, reso con efficace drammaturgia e senza bamboleggiamenti, ma con sicura padronanza di colori, fraseggio, anche se in più occasioni avrebbe avuto bisogno di maggior supporto dal podio per mettere in luce le sue peculiari qualità che sono ben note. Nel finale atto primo non ha cantato le due battute dopo il rapimento, ma credo possa ascriversi ad un malinteso in retropalco.
Il duca di Francesco Demuro non delude, anzi, conferma qualità vocali rilevanti, proponendo un personaggio sfaccettato nell’interpretazione e puntuale nella gamma canora, squillante, disinvolto e contraddistinto da un’ottima musicalità.
Un plauso particolare merita Andrea Mastroni, Sparafucile, che ha realizzato un personaggio da manuale sia interpretativamente sia vocalmente. Il canto è raffinato e tagliente quanto conviene a un sicario. Fraseggio e accenti sono di esemplare precisione cui si somma una voce calibrata e rifinita nella gamma del registro basso di rilevante fascino. L’attore scenico non è da meno, realizzato con movenze tetre e intuizioni drammaturgiche, soprattutto nel primo atto, di forte impatto teatrale.
Sensuale e di classe vocale la Maddalena di Anna Malavasi, impeccabile il Monterone di Nicolò Ceriani. Francesco Pittari e Marco Camastra, rispettivamente Matteo Borsa e Marullo, sono perfetti nei loro compiti.
Completavano il cast Dario Giorgelè, Conte Ceprano, Marina Ogii, Contessa, Alice Marini, Givoanna, Omar Kamata, usciere, e Lara Lagni, Paggio. Raramente è possibile trovare un cast così professionale e affiatato nei ruoli secondari, ma non inferiori.
Al termine successo trionfale per tutta la compagnia.
MITRIDATE RE DI PONTO [Mirko Gragnato] Londra, 7 luglio 2017.
Tra un cartellone che comprende Turandot e Otello va in scena una delle prima opere mozartiane, “Mitridate Re Di Ponto” alla Royal Opera House. Un revival della regia del 1991 di Graham Vick e la direzione di Christophe Rousset, al suo debutto nel teatro inglese del Covent Garden.
Scene che sbeffeggiano un po’ questo spirito di pieno classicismo, che va a ripescare temi della storia antica, tra cui il famoso re Mitridate VI Eupàtore, tramandatoci grazie ai testi di Appiano sulle guerre mitridatiche e portano in forma di libretto da Vittorio Amedeo Cigna-Santi a seguito del libro di Jean Racine tradotto nient’altro che da Giuseppe Parini.
Ecco quindi che tutti i protagonisti si trovano a indossare ampie crinoline che nel caso di Aspasia risultano un vero e proprio baldacchino. Scene permeate di rosso dove campeggia un “Mitridate Rè” scritto come uno dei graffiti a pittura che popolano le mura dell’antica Pompei, una partitura ricca di arie fiorite e abbondanti di sali-scendi e guizzi vocali a cui questo cast ha dato ottima prova di riuscita.
Di gran valore l’Aspasia di Vlada Borovko che sostituisce all’ultimo Albina Shagimuratova, malata. Borovko, nonostante la chiamata last minute ha dato un’ottima prova di prontezza e abilità scenica, un timbro dal colore chiaro e posato, qualche piccola sbavatura su alcuni passaggi difficili, ma sempre mantenendo salda la concertazione in un’emissione curata della voce. Gli applausi che hanno omaggiato questo cambio nottetempo dicono più delle parole. Oltre alle crinoline un elegante e colto tocco etnico nei costumi delle guardie ma soprattutto per i panni di Ismene, per le sue ancelle e le guardie reali; che donano con ghirigori e colori accesi un sapore di esotismo a tutta la scena.
Il ruolo di Ismene interpretata dall’inglese Lucy Crowe, muovendosi sulla scena con movimenti plastici e fissili ricorda una marionetta di tradizione armena. Il ruolo più apprezzato, il soprano inglese è forse la stella più chiara di questo cast di alto spessore. Un timbro cristallino che nell’aria del III atto “Tu sai per chi m’accese”nei ghirigori vocali di grado congiunto ha incantato la platea della Royal Opera House, raggiungendo punte di rara bellezza.
Altra voce del cast di alta levatura è quella di Bejun Mehta, controtenore statunitense, recentemente in tournée con il Concert Gebouw in un programma da solista ” Mi palpita il cor”. In questa produzione nel ruolo del figlio più anziano di Mitridate, Farnace, anche lui applauditissimo dopo l’aria “Va l’errore mio palesa”, nell’estensione che va dal Si basso al re acuto, Mehta ha mostrato ottimo equilibrio tra acuto e grave in un pasto timbrico veramente pregevole, con una bellissima cadenza finale, curatissima la messa di voce delle note lunghe, con una voce veramente ricca di armonici nonostante il ruolo controtenorile oltre che all’agilità e alle abilità tecniche ne ” Venga pur minacci e frema”.
Dalla Georgia che è una regione vicina all’antica area del Ponto Eusino, raccontataci da Appiano, è la soprano Salome Jicia che debutta nel ruolo del giovane Sifare e che recentemente è stata ingaggiata dal Rossini Opera Festival per il ruolo della contessa di Folleville ne “Il Viaggio a Reims”. Lei oltre alla chiarezza della voce ha dalla sua una intensità di voce veramente formidabile, riuscendo a mantenere fermo il controllo della qualità del suono ma con volume che le permette crescendi ricchi di pathos. Ne “Lungi da me mio bene” curatissimi i trilli e i passaggi in acuto in piena voce senza nessun vacillamento, voce ferma e presente per tutta questa aria, arricchita dai predominanti ingressi di corno che si intrecciato perfettamente con la voce del soprano arricchendola di sfumature in quello che poi diventa un vero e proprio duetto, nonostante qualche piccola sbavatura del cornista verso il passaggio acuto.
Completano il cast nel ruolo di Mitridate Michael Spyres, che recentemente ha eseguito lo stesso ruolo per la Monnaye di Bruxelles, nella parte scenica risultava un po’ troppo esagerato e fin troppo costruito come personaggio anche se vocalmente irreprensibile.
Oltre a lui Jennifer Davis nel ruolo di Arbate, ottima presenza scenica e vocale virtù che non mancano a Rupert Charlesworth che interpreta Marzio sostituendo Andrew Tortoise.
Ottima resa musicale dell’orchestra della Royal Opera House nelle mani del Maestro Christophe Rousset direttore e cembalista che debutta in questa stagione come direttore del Mitridate, recentemente diretto anche a La Monnaie di Bruxelles.
Grande cura nelle parti ribattute degli archi che accompagnano le voci e nei cambi di colore, crescendo e diminuendo, che caricavano fortemente la partitura di carica emotiva.
Un grande successo di pubblico, un teatro quasi sold out, per questa produzione che unisce barocco e teatro orientale in un’efficace fusione.
OTELLO [Mirko Gragnato] Londra, 8 luglio 2017.
Alla Royal Opera House va in scena Otello, di Verdi, con la direzione scenica di Keith Warner, nel ruolo di Otello un Gregory Kunde in forma smagliante, mentre nel ruolo di Jago il teatralissimo Zeljko Lucic, mentre la dolce Desdemona ha la voce di Dorothea Roschmann. La direzione musicale è affidata a Sir Antonio Pappano con le scene di Boris Kudlicka e i costumi di Kaspar Glarner.
In Otello il personaggio chiave non è certo il Moro di Venezia che dà il titolo all’opera e alla tragedia shakespeariana, il vero deus ex machina è Jago. È lui che all’apertura del sipario, orchestra silente, nella penombra, si presenta al pubblico solingo e con tra le mani due maschere una bianca e una nera. Nello stringerle, scaraventa la più chiara a terra tenendone la più cupa tra le mani; con questo gesto si manifesta anche il primo fortissimo ingresso di archi, percussioni e ottoni che apre quest’opera. Il fondale scenico precipita sul palco e dietro di esso tra una coltre nebbiosa appare il coro che avanza scrutando l’orizzonte: “Una vela, una vela… è l’alato lion”. Un coro dal sapore drammatico e concitato come alcune parti del requiem verdiano ricordano. Nessuna sinfonia ma come un mare in tempesta lo spettatore è scaraventato nella musica di Otello.
Le scene di Boris Kudlicka su questa atmosfera di attesa costruiscono una realtà cittadina, un luogo sociale dove però le vie della luce sono ridotte, tutto comunica e si può intravedere attraverso feritoie, o una trina di ghirigori. Nulla è realmente manifesto e in questo alternarsi di vedo non vedo, di detto non detto, le macchinazioni di Jago trovano una città che è occhiuta e cieca, sorda e dall’udito fine al contempo: il terreno più adatto per manipolare animi e menti.
Di Gregory Kunde stupisce sempre la voce di questo tenore ultra sessantenne, che mantiene nel fisico e nella voce una freschezza e una chiarezza sorprendenti anche nel ruolo di Otello. Introdotto dal breve quartetto di violoncelli a sordina nel duetto tra Otello e Desdemona “Già nella notte densa” i due amanti si rifugiano nelle loro stanze le cui pareti sono una trina di vedo non vedo, ottimo incontro vocale tra Dorothea Roschmann e Kunde, un momento di grande patetismo, con dolcezza cala il sipario sul primo atto, una dolcezza però punta dall’amarezza di Jago che scruta meditabondo gli amorosi amplessi.
Zeljko Lucic, la voce di Jago, è un baritono che sul palco si muove benissimo dalla vocalità irreprensibile, la mimica formidabile e dallo sguardo pungente. Nel celebre “Credo in un dio crudel” che anticipa sonorità pucciniane, nel timbro e nell’esecuzione Lucic riesce a condire di rabbia e odio l’esecuzione. Iniziando con questa professione di fede le macchinazioni di Jago trovano piena sintonia con le luci pensate da Bruno Poet, che nel mentre Otello viene accecato dalla gelosia diventano sempre più fioche, sino a quando la gelosia e il dubbio non si impadronisco della mente di Otello, facendo calare nel buio totale le scene.
Nel ruolo di Cassio il piacente tenore canadese Frederic Antoun che sembra perfettamente tagliato nel confrontarsi con le ubbie di Otello; ottimo il basso sud africano Simon Shibambu nel ruolo di Montano, bel timbro pieno e scuro, così come Thomas Atkins nel ruolo di Roderigo, anche se molto più concentrato sul ruolo teatrale che vocale.
Desdemona che per molto resta un personaggio abbastanza discreto e defilato, nel quarto atto si espone completamente nella sua infinita e tenera umanità. Dorothea Roschmann nella ballata del salice e l’Ave Maria riesce con abilità sceniche e vocali a commuovere lo spettatore, realizzando pienamente gli intenti musicali di Verdi. Sull’acuto perde forse di chiarezza mantenendo un timbro un po’ cupo, dando un’idea di una Desdemona un po’ più vissuta; ottima l’Emilia del mezzo soprano estone Kai Ruutel.
Nel drammatico epilogo che vede i due amanti scatta la trasformazione di Otello, la stanza del primo atto avvolta tra il dolce mormorare teneramente ora diventa l’avello di un talamo di morte. Verdi con sonorità mosse da rapide scalette dei violoncelli sino ai fortissimi del trombone basso che segnano l’ultimo singulto di Desdemona.
Il Maestro Pappano conduce l’orchestra della Royal Opera House anche nei momenti concitati con grande cura e nei momenti più dilatati come il passaggio a due dei fagotti e i crescendo diminuendo, nel momento della morte di Otello, lascia senza fiato.
Una produzione e un cast non di secondo piano, anche i ruoli non protagonisti che si sono formati tutti allo Jette Parker Young Artist for the Royal Opera hanno realizzato una performance egregia. La Royal Opera House è un teatro poco incline ai fronzoli delle soirée d’opera da struscio ma va direttamente, come è usanza inglese, al concreto. Ottima realizzazione di questo Otello nella prima del secondo cast, secondo solo per temporalità e non per livello artistico e bravura.
TOSCA [Simone Ricci] Roma, 8 luglio 2017.
La prima recita del capolavoro pucciniano alle Terme di Caracalla è stata caratterizzata da un’ambientazione in epoca fascista. Mussolini è un uomo straordinario. Ha un’audacia e un genio napoleonico. Anche fisicamente mi ricorda Napoleone. Una delle più celebri frasi del giornalista e scrittore tedesco Maximilian Harden è stata presa alla lettera per l’allestimento di “Tosca” alle Terme di Caracalla, in occasione della stagione estiva 2017 del Teatro dell’Opera di Roma. Pier Luigi Pizzi ha infatti deciso di puntare sugli anni Trenta del fascismo per il capolavoro pucciniano, mettendo in stretta correlazione Bonaparte e il duce di Predappio. Non è la prima volta che il regista milanese si affida a questo periodo storico, ma in questo caso qualche accorgimento in più sarebbe stato gradito.
Questa recensione si riferisce alla prima recita a Caracalla dell’opera, il debutto di sabato 8 luglio 2017. Pizzi ha deciso di festeggiare 40 anni di carriera con un allestimento sobrio in cui il bianco e il grigio chiaro sono gli unici colori dello sfondo. Lo scenario è rimasto sempre lo stesso: la Chiesa di Sant’Andrea della Valle è stata privata dei pochi riferimenti ecclesiastici per trasformarsi in Palazzo Farnese, con la cupola tagliata a metà che è rimasta in scena anche nel terzo atto, senza alcun riferimento diretto a Castel Sant’Angelo. Le intenzioni del regista erano quelle di conferire intimismo e claustrofobia all’opera di Puccini, un effetto che si è intuito bene soprattutto nel secondo atto.
Le scelte registiche meritano comunque alcune critiche. Anzitutto, il finale non è stato convincente: Tosca impiega più del dovuto prima di gettarsi nel vuoto, aspettando che la cupola si apra come se fosse una porta scorrevole. Sempre nel terzo atto, poi, il pastorello non appare neanche per un secondo, lasciando un po’ perplesso chi è meno abituato alla lirica e che all’improvviso ascolta una voce fanciullesca e romanesca in lontananza. Non si sono visti nemmeno i due candelabri che Tosca dovrebbe appoggiare davanti al cadavere di Scarpia nel finale del secondo atto, tanto da far apparire la protagonista del titolo in scena senza un motivo valido e col rischio di essere scoperta da qualcuno.
I costumi (curati sempre dal regista) sono apparsi più convincenti e adatti al periodo scelto, all’insegna dell’arroganza del potere e della passione. L’ambientazione fascista ha trasformato il barone Scarpia in un gerarca del ventennio, con tanto di posture e movimenti non molto diversi da quelli dello stesso Mussolini: molto apprezzabile è stato il Te Deum che conclude il primo atto, in cui Pizzi ha evitato un sovraffollamento di personaggi, permettendo una migliore fruizione di una delle parti più attese dell’opera. Per quel che riguarda il cast vocale, poi, Tatiana Serjan è apparsa volitiva e immedesimata, anche se con qualche difetto di dizione.
Il soprano russo ha messo in mostra mezze voci e pianissimi molto interessanti, anche se non sono stati convogliati in un disegno interpretativo davvero fluido. La sua voce ha comunque la potenzialità per esprimere la sensualità di questo personaggio così complesso, come evidenziato nel duetto d’amore del primo atto. Giorgio Berrugi ha affrontato il palcoscenico nonostante un infortunio e il suo Cavaradossi è stato caratterizzato da grande dignità, con una voce maggiormente a fuoco negli acuti e una qualità timbrica tutto sommato sicura. Roberto Frontali ha affrontato con la consueta verve il ruolo di Scarpia, mettendo in luce la supponenza del capo della polizia papalina e destando l’ammirazione del pubblico con squarci di grande ampiezza e sonorità.
Gli interpreti “minori” si sono fatti apprezzare per il contributo offerto nel corso della serata. Bisogna cominciare con il misurato e incisivo Sagrestano di Domenico Colaianni, senza dimenticare l’intenso Angelotti di Francesco Milanese, l’appropriato Spoletta di Saverio Fiore, lo Sciarrone di Leo Paul Chiarot e il Carceriere di Antonio Taschini. Gli applausi del pubblico romano non sono mancati soprattutto in occasione delle arie più celebri, con una inevitabile preferenza nei confronti di E lucevan le stelle, resa da Berrugi in maniera commovente.
Donato Renzetti ha diretto con piglio l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, garantendo una buona coesione e ritmo narrativo: le tinte drammatiche sono state impreziosite da pieni orchestrali ampi e vibranti, per non parlare degli stacchi energici. Una maggiore ricerca sugli impasti timbrici soffusi avrebbe potuto alzare ulteriormente il giudizio finale. Infine, il Coro del Teatro Costanzi e gli allievi della Scuola di Canto Corale hanno sottolineato in maniera adeguata la solennità del Te Deum che chiude il primo sipario di “Tosca”. I tre atti di Puccini torneranno a Caracalla per altre sette sere, fino al prossimo 8 agosto.
AIDA [Lukas Franceschini] Verona, 9 luglio 2017.
Come di tradizione Aida, l’opera in quattro di Giuseppe Verdi, è il titolo più eseguito nella Stagione all’Arena di Verona. Anche quest’anno ci saranno due diversi allestimenti, quello ideato dalla Fura dels Baus nel 2013 e quello “storico” basato sui bozzetti di Franco Fagioli del 1913 ideato da Gianfranco De Bosio negli anni ’80.
Lo spettacolo con la regia di Carlus Padrissa e Alex Ollé fu concepito per la stagione del centenario. Ebbe numerose critiche ma anche molteplici apprezzamenti, anche da chi scrive, e resterà tuttavia una messa in scena che difficilmente si scorderà. A distanza di qualche anno è possibile affermare che esso trova una sua specificità nel grande spazio all’aperto ed esprime un’idea moderna, anche se non sempre coerente, che giustamente si stacca completamente dalla tradizione. Altra considerazione è lo scarso apprezzamento del pubblico areniano, il quale preferisce il solco della tradizione, ma è doveroso rilevare che un’alternanza delle produzioni oltre che plausibile è anche doveroso.
La narrazione drammaturgica inizia mentre il pubblico sta entrando nell’anfiteatro, una troupe di archeologi è all’opera per estrarre reperti e inviali al British Museum. Tra i ritrovamenti ci sono simboli ed elementi che poi si vedranno nel corso dell’opera. Le vicende dell’antico Egitto saranno raccontate come un romanzo d’appendice, un flashback, scoperta tra i ritrovamenti. Un passaggio tra il moderno e l’antico che però non è gestito con efficacia poiché il limite del confine non è palese, costumi, scene, sono decisamente moderne, e la commistione tra ieri e oggi non è del tutto riuscita. Una grande mancanza di questa produzione è la completa non considerazione del grande balletto del II atto, aspetto che è poco consono alla struttura dell’opera. Convincono poco i costumi in stile “film di fantascienza” di Chu Uroz, più coerenti le scene di Roland Olbeter, con un’immensa impalcatura al centro e delle grandi dune di sabbia sulle gradinate e illuminate da luci di grande effetto. Sintetizzando si può affermare che l’atto III è il più azzeccato, per la bellissima impostazione notturna, con palme e coccodrilli umani che girovagano nell’acqua. Il meno efficace il II atto nel quale trasformare la grande scena del trionfo in una sfilata di muletti e piccole automobili elettriche non hanno certo corrisposto all’aspetto anche spettacolare che l’opera contiene. Per il resto ci sono scene più azzeccate altre più banali ma il quarto atto con il grande “monumento” (forse della vittoria) che scende e copre a modo di tomba gli infelici amanti è di grande effetto.
Resta tuttavia una produzione di forte impatto anche se non sempre lineare, e credo si debba considerare che il team iberico non era cosi esperto di spazi enormi e all’aperto, pertanto qualche soluzione non è particolarmente calibrata.
Sul versante musicale abbiamo trovato Julian Kovatchev sul podio, il quale fortunatamente non si riproduce come nel recente Rigoletto ma riesce in una direzione più sostenuta ma pur sempre nel solco della tradizione, senza un minimo accenno più variegate sfumature ed equilibri orchestrali, compreso il versante drammatico, non elaborato quanto meriterebbe.
Molto buona e pienamente convincente la prova del Coro diretto da Vito Lombardi.
Sae-Kyung Rim è un’Aida convincente con voce brunita e buoni mezzi in acuto, smorzature e intenzioni. Il registro grave è meno omogeneo e talvolta il fraseggio non è particolarmente rifinito, ma resta una prova positiva.
Molto positiva la prova di Yusif Eyvazov, Radames, tenore in continua crescita artistica. Egli è preciso in tutti i registri e dimostra una sicurezza oggigiorno invidiabile per il ruolo. Dovrebbe curare con maggiore attenzione il gioco dei colori e il fraseggio poiché risulta spesso monotono e con poca scansione d’accenti, ma è forte l’auspicio di un completamento del ruolo.
Molto brava Anastasia Boldyreva, Amneris, la quale possiede una voce possente e armoniosa da buon mezzosoprano, cui si deve sommare una presenza scenica rilevante e un canto forbito ed elegante, curato nei dettagli e nelle sfumature. Peccato sia stata scritturata per questa recita solamente.
Positiva anche la prova del baritono Boris Statsenko, Amonasro, un cantante in possesso di una voce robusta e piena e un canto preciso e sicuro, che gli permettono di emergere in particolare nel duetto del III atto, anche se la dizione è approssimativa.
Di ottima professionalità il Ramfis di Giorgio Giuseppini, cantante incisivo negli interventi lui riservati in specie nella seconda scena del I atto nel quale sfodera accenti ragguardevoli.
Deyan Vatchkov è un pregevole Re, Antonello Ceron un bravo messaggero, e Marina Ogii una puntuale sacerdotessa.
Anfiteatro che registrava parecchi vuoti per un titolo “principe” ma come predetto credo sia il tipo di spettacolo a essere poco accattivante. Successo pieno per tutta la compagnia.
MADAMA BUTTERFLY [Lukas Franceschini] Verona, 13 luglio 2017.
La Stagione del 95° Opera Festival all’Arena prosegue con la ripresa del melodramma Madama Butterfly di Giacomo Puccini nell’allestimento di Franco Zeffirelli del 2004.
Lo spettacolo, giunto alla quarta ripresa, si colloca nel solco del più manierato tradizionalismo, che potrebbe stupire solo a inizio atto per la bella e monumentale collina con annessa la tipica casetta giapponese. Il tutto si ferma qui! Come il solito, il regista toscano abusa nell’utilizzo di figuranti, i quali anche in quest’occasione popolano sin dall’inizio la scena. Assistiamo alla sfilata di ogni tipo di personaggio immaginabile, anzi oltre l’immaginazione, che di per sé stride e talvolta infastidisce. Tutto questo a discapito del vero dramma della protagonista, cui vengono a meno disperazione, solitudine, speranze, immolazione finale. Non c’è traccia di una drammaturgia teatrale pertinente che lascia spazio a tableau “da cartolina” fine a se stessi. Non è dato sapere chi abbia ripreso la regia in quest’occasione ma essa non si discosta dall’impianto originale. Un’opera cosi moderna e drammatica come Madama Butterfly meriterebbe una lettura diversa più focalizzata sulla protagonista, in questo caso assoluta, e dei personaggi collaterali, importanti ma sempre di riflesso. Forse è difficile in Arena trovare chiavi differenti, il solco della tradizione è stato sovente abusato, ma talvolta il coraggio dell’innovazione ha premiato. Tuttavia, al pubblico piace, ma si preferirebbe un qualcosa di più focalizzato e non il solito mondo degli ombrellini e kimoni, peraltro poi nemmeno tanto stilizzati nella gestualità con l’ambiente giapponese d’inizio secolo.
La mano dello scenografo, sempre Zeffirelli, è più felice, e si ammirano piacevolmente i bellissimi costumi di Emi Wada.
Sul podio il maestro Jader Bignamini conduceva la professionale Orchestra dell’Arena in una lettura di routine, senza particolari scansioni di colori e dinamiche sonore, in particolare nel II atto e nella prima parte del III. Tuttavia la sua è una direzione corretta anche se inanimata, ed è giusto rilevare che sovente andava in soccorso a solisti non certo ottimali.
Buona la prova del Coro istruito da Vito Lombardi.
Deludente nel complesso il cast a cominciare dalla Cio-Cio-San di Oksana Dyka. La cantante ha una voce robusta e anche molto sonora ma limiti tecnici non le permettono di essere un personaggio credibile in quest’opera. Manca innanzitutto una capacità espressiva vocale che le possa permettere di passare da giovane ragazzina infatuata a donna-madre coraggiosa e risolutiva. Il timbro non è dei più felici, il fraseggio, la ricercata modulazione dei colori nel canto parlato è assente, il registro acuto limitato, cui si aggiungono appariscenti falle nell’intonazione. Anche il lato teatrale interpretativo era piuttosto sommario.
Marcello Giordani, Pinkerton, non era in una serata particolarmente felice poiché il suo canto era sovente strozzato e non trovava gli accenti e le fini morbidezze cui eravamo abituati. Resta sempre il professionale cantante che conosciamo ma non nel suo standard.
Buona prova invece quella di Alessandro Corbelli, il quale ha avuto pochi incontri con Madama Butterfly nel corso della sua lunga e mirabile carriera. Il cantante ha fornito prova di eccelso cesellatore della parola, in un canto levigato e morbido, manierato quanto austero nella recitazione.
Particolari lodi vanno a Francesco Pittari, un Goro perfetto in ogni suo intervento, che dosava il giusto carattere viscido del personaggio senza eccessi. Vocalmente inappuntabile, preciso e di grande musicalità.
Molto brava anche Silvia Beltrami, una Suzuki di buona scuola e ottima professionalità.
Onorevolmente completavano la locandina l’imponente Deyan Vatchkov, Zio Bonzo, l’austero Nicolò Ceriani, Yamadori, e i professionali Alice Marini, Kate Pinkerton, Marco Camastra, Commissario imperiale, Dario Giorgelè, ufficiale del registro, Tamta Tarieli e Marina Ogii, rispettivamente madre e cugina di Cio-Cio-San.
Arena con scarsissimo pubblico ma particolarmente prodigo di applausi a tutta la compagnia al termine.
LUCIA DI LAMMERMOOR [Lukas Franceschini] Padova, 27 luglio 2017.
È ormai assodato l’appuntamento estivo al Castello dei Carraresi, preludio della Stagione Lirica padovana, la quale propone un titolo nello spazio aperto sito nel centro della città. Quest’anno è stata la volta del più famoso spartito di Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor, su libretto di Salvatore Cammarano tratto dal romanzo di Sir Walter Scott.
Lo spazio del cortile del Castello pur essendo suggestivo offre molte limitazioni per uno spettacolo lirico, la cui scena è limitata dalla facciata del palazzo con due gallerie a volti al pianoterra e al piano rialzato, con il palcoscenico “a vista” posto a ridosso. Paolo Giani, regista, scenografo, costumista e ideatore delle luci, ha dovuto tener conto di questo non trascurabile aspetto. Inventa pertanto uno spettacolo più simbolico che effettivamente teatrale, che si sviluppa scenicamente su un’improbabile scala bianca illuminata, che ricordava l’avanspettacolo più che un castello scozzese. Il palcoscenico è diviso in due parti, da un lato una grande sfera, forse cosmica, dall’altro una più piccola, sulla quale la protagonista versa un liquido durante la grande scena della pazzia. Un insieme di finti corvi sono collocati sia sul palcoscenico sia sulla galleria superiore. Onestamente non ho capito questo spettacolo, il quale si lascia guardare senza grandi trasporti, ma il segno drammaturgico e la chiave di lettura mi sono del tutto estranei, e anche volendo focalizzare i temi della ragione famigliare imposta, la trama politica e l’amore tra fazione opposte non si trova un’idea drammaturgica chiara e pertinente. La scala è utilizzata in numerose occasioni con movimenti lenti sia dei cantanti sia del coro. Del tutto superflui i quattro figuranti che creano un po’ di scena, come la danzatrice Nicoletta Cabassi, peraltro bravissima, che potrebbe essere un alter ego di Lucia. Forse la contrapposizione registica tra i valori positivi e negativi, ha un senso in questa regia, ma non sono uscite idee chiare ed effettive che possano trovare una creatività teatrale rilevante, e dobbiamo registrare che i solisti sono stati lasciati alle loro personali capacità nella recitazione teatrale.
Costumi di taglio moderno molto banali tutti in bianco per le donne, in nero per gli uomini (senza cambi), luci non sempre risolte con precisione.
Migliore l’apparato musicale. A cominciare da Giampaolo Bisanti, direttore e maestro concertatore, il quale ci offre un’appassionata lettura che valorizza sia la drammatica vicenda sia il romantico lirismo dei protagonisti. Il direttore milanese è bravissimo nel creare momenti musicali di ampio respiro romantico (finale atto I), e altrettanto in molti momenti drammatici (duetto Lucia-Enrico e finale secondo) riuscendo a scavare nella partitura ed evocando sonorità efficaci e molto teatrali. Non meno rilevante il bravo concertatore che segue i solisti con accurata precisione e anche evidente aiuto in più occasioni. I tempi giustamente sono variegati e serrati secondo la narrazione, ma sempre con un’attenzione particolare al canto, elemento imprescindibile nel repertorio donizettiano.
Buona la prova dell’Orchestra di Padova e del Veneto, ensemble sempre in crescita, che si propone con particolare predisposizione alle indicazioni del direttore. Altrettando buona la performance del coro Lirico Veneto, istruito da Stefano Lovato, con particolare menzione per la sezione maschile.
La compagnia di canto era composta di giovani ormai rodati e conferme dell’odierno teatro lirico.
È il caso di Mattia Olivieri, Enrico, che si conferma uno dei giovani baritoni italiani più interessanti della sua nuova generazione. I mezzi vocali sono di primordine, cui si aggiunge un canto preciso e forbito nel colore e nel fraseggio. Penso sia la prima volta che canta il ruolo e sicuramente lo spazio aperto potrebbe non averlo aiutato, ma giustamente i debutti si dovrebbero fare in provincia ed è auspicabile che future occasioni in teatro saranno ancor più pregevoli.
Meno riuscita la prova di Venera Protasova, che dimostra poca dimestichezza con il repertorio virtuoso, ma è una cantante molto precisa e musicale e riesce con onesta professionalità nel ruolo, anche se il fraseggio e gli accenti dovrebbero essere più curati, ma il suo terreno è altro repertorio.
Anche Giordano Lucà, Edgardo, dovrebbe curare aspetti interpretativi e vocali con maggior perizia, poiché il colore vocale è bello e la linea di canto rilevante, ma il suo personaggio poco credibile, anche per colpa della regia.
Bravo e più omogeneo che in altre occasioni il Raimondo di Simon Lim, e professionale Matteo Mezzaro nel ruolo di Arturo. Più disomogenei Normanno e Alisa, rispettivamente Orfeo Zanetti e Lara Botili.
Buon successo al termine. La macchina organizzativa era un po’ a corto di personale, il quale avrebbe dovuto contenere e istruire il pubblico, che con molta disinvoltura durante l’esecuzione si alzava per necessità personali o girovagava per la platea.
L’allestimento sarà proposto anche al Bassano Opera Festival.
CARMEN [Simone Ricci] Roma, 30 luglio 2017.
Il capolavoro di Bizet mantiene intatto il proprio fascino anche con gli allestimenti moderni e provocatori come quello proposto a Caracalla.
Da qui a dieci anni “Carmen” sarà l’opera più famosa di tutto il pianeta. Il giudizio di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, grande ammiratore di Georges Bizet, è valido come non mai anche a distanza di secoli e questo spinge molti registi ad azzardare scelte particolari. Non è di sicuro una regia convenzionale quella a cui si è assistito alle Terme di Caracalla, in occasione della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. L’argentina Valentina Carrasco ha deciso di eliminare qualsiasi riferimento al 1830 e alla città di Siviglia, proponendo invece la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti e facendo trovare a Carmen ospitalità tra gli immigrati illegali messicani. Questa recensione si riferisce alla recita di domenica 30 luglio 2017.
Il pubblico romano è stato proiettato al confine tra le due nazioni, una zona del mondo di cui si è parlato molto nei mesi scorsi in seguito alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, intenzionato a costruire un muro. L’ambientazione ci può stare in questo caso, a patto che ci si distragga quando nel libretto si parla di Siviglia e della Spagna: alcuni dettagli, poi, sembravano essere stati scelti solamente per il gusto di provocare, come ad esempio l’osteria di Lillas Pastia trasformata in un vero e proprio bordello con trans e rapporti orali alla luce del sole. Non potevano mancare gli smartphone che comunque non disturbavano eccessivamente la trama originale.
La presenza di un ape-car in scena caratterizzava l’intero terzo atto, mentre il quarto si faceva apprezzare per la celebrazione del “Dia de muertos”, il giorno dei morti che in Messico è particolarmente sentito e vissuto sempre in maniera gioiosa. A Escamillo è stata riservata la struttura più alta con tanto di toro dorato da decapitare nel momento culminante dell’opera. Il messaggio di una Carmen libera ed emancipata, eroina di bassa condizione sociale, è arrivato anche con una trasposizione moderna, nonostante la presenza praticamente superflua di diversi elementi. Intrigante la soluzione della bambina che si avvicinava a Carmen nei punti cruciali del racconto, consegnandole il fiore per Don Josè e preannunciandole la morte.
Il mezzosoprano georgiano Ketevan Kemoklidze ha tratteggiato la protagonista del titolo cercando di equilibrare in maniera sapiente il colore brunito del registro grave e un registro acuto in grado di trasmettere la sensualità della sigaraia. La presenza scenica, poi, è stata decisamente buona, tanto che la sfacciataggine e la volubilità di Carmen sono emerse con chiarezza. Andeka Gorrotxategui ha impersonato un Don Josè dalle sfumature adeguate: l’emissione è apparsa sicura, con una intensità interessante soprattutto in La fleur que tu m’avais jetée, appassionata dichiarazione d’amore.
Rosa Feola ha conquistato uno degli applausi più fragorosi della serata grazie a una interpretazione a tutto tondo di Micaela. Il soprano ha messo in mostra la tenera ingenuità del personaggio, senza tralasciare però la resa vocale, ben accurata nel fraseggio e dallo spessore non indifferente. L’Escamillo di Francesco Beggi ha dato il giusto spolvero a un ruolo che viene spesso e colpevolmente messo in secondo piano: in particolare, si è mostrato a suo agio in Votre toast, je peux vous le rendre, la “canzone del toreador” che lo ha presentato in maniera degna. Brillante e piacevole, inoltre, è stato il cosiddetto “quartetto dei contrabbandieri”, formato da Daniela Cappiello (Frasquita), Anna Pennisi (Mercedes), Alessio Verna (Dancairo) e Pietro Picone(Remendado).
Il cast vocale era completato dall’intenso Zuniga di Gianfranco Montresor e dal Morales di Timofei Baranov. Jordi Bernàcer ha guidato con equilibrio e consapevolezza l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, valorizzando con appropriate finezze le voci e affrontando in modo garbato la partitura, in primis gli intermezzi. Nel secondo intermezzo, tra l’altro, è comparso il Corpo di Ballo del Costanzi: gli spettatori hanno apprezzato la “danza degli scheletri” che preannunciava l’ingresso in scena dei “carrozzoni” del giorno dei morti. Il contributo del Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Roberto Gabbiani e degli allievi della Scuola di Canto Corale hanno chiuso con precisione il cerchio delle voci.
“Carmen” sa sempre come conservare il proprio status di opera popolarissima e capace di attirare tanti spettatori: di sicuro non ci si è annoiati, nonostante qualche mugugno per alcune scelte registiche, anche se alla fine ha prevalso il gradimento. Il capolavoro di Bizet verrà rappresentato ancora due volte nell’affascinante scenario delle Terme di Caracalla, per la precisione martedì 1 e venerdì 4 agosto con lo stesso cast che è stato appena descritto, fatta eccezione per Roberta Mantegna che interpreterà il ruolo di Micaela al posto di Rosa Feola.
NABUCCO [Lukas Franceschini] Verona, 4 agosto 2017.
Sono stato ancora una volta all’Arena per assistere a una seconda recita di Nabucco, melodramma di Giuseppe Verdi, con cast alternativo.
Sull’allestimento si riconfermano i positivi giudizi espressi in occasione della prima rappresentazione (recensione del 23 giugno N.d.R.), qui aggiungo che trattasi di uno dei migliori spettacoli visti nell’anfiteatro negli ultimi anni, e il regista Aranud Bernard è bravissimo artefice nel muovere le masse, in particolare la pantomima durante l’esecuzione della sinfonia. Uno spettacolo efficace in ogni suo momento ma che trova particolare fantasia nella trasposizione storica e romantica della vicenda nella Milano risorgimentale.
Sul podio sempre il maestro Daniel Oren, che in questo spartito trova un’interpretazione di particolare riferimento per tempi sostenuti, effetti di colori e dinamiche (per quanto si possa cogliere all’aperto) e un’energica atmosfera del primo Verdi, non solo battagliera ma rifinita anche nelle scene più intimistiche. Solo in un momento, finale atto II, penso per un disaccordo con l’orchestra la conclusione è stata piuttosto squilibrata, ma può capitare in uno spettacolo dal vivo.
Brillante e notevolmente precisa la prova dell’Orchestra dell’Arena, collaudata da anni su queste note, ed esemplare la prova del coro, con ennesimo bis del celebre “Va pensiero”, istruito da Vito Lombardi.
Grande performance quella di Anna Pirozzi, Abigaille, la quale ha offerto una prova di grande classe vocale e interpretativa. Dotata di voce bella e ampia, soprattutto nel centro, supera le impervie difficoltà del ruolo con innata classe sfoderando un fraseggio accurato, e un’ampiezza di suono rilevante. Qualche estremo acuto è risultato leggermente forzato, ma sono poca cosa di fronte al temperamento, le intenzioni riuscite e l’utilizzo di una voce piena, rifinita, sempre controllata e musicale. Una recita da ricordare.
Leonardo Lopez Linares, Nabucco, avrebbe dalla sua una voce importante e di spessore, peccato che tali qualità non fossero abbinate a uno scavo interpretativo del personaggio e a una scelta di colori più rifinita, tuttavia, possiamo che ascrivere la sua performance a una solida routine.
In Sung Sim, Zaccaria, è stato un corretto cantante, dotato di voce morbida e giustamente calibrata, forse non particolarmente adatta agli spazi aperti poiché il volume era leggermente ridotto, ma non possiamo non considerate la pregevole musicalità e le buone intenzioni interpretative.
Mikheil Sheshaberidze è un ottimo Ismaele, veemente e perfettamente calato nel ruolo, cui si deve aggiungere una buona e precisa vocalità. Molto bene anche la Fenena di Carmen Topciu, mezzosoprano dotata di voce scura e ottima resa scenica.
Alta professionalità hanno dimostrato gli artisti nelle parti minori, a comunicare da Nicolò Ceriani (Gran Sacerdote di Belo), Cristiano Olivieri (Abdallo) e Madina Karbeli (Anna). È doveroso rilevare che la serata era particolarmente calda, all’inizio dell’opera in Arena si registravano ben 35°, e con tale temperatura non oso immaginare lo sforzo anche fisico cui solisti e musicisti sono stati costretti, tuttavia al termine si è registrato un successo trionfale con continue chiamate al proscenio da parte di un pubblico particolarmente entusiasta e numeroso.
LE SIÈGE DE CORINTHE [Lukas Franceschini] Pesaro, 7 agosto 2017 (prova generale).
Il Rossini Opera Festival Per la seconda volta nel corso della sua quasi quarantennale storia allestisce Le Siège de Corinthe nella versione francese del 1826.
Questa tragédie lyrique è come comunemente risaputo la trasposizione francese dell’opera Maometto II, andato in scena a Napoli con scarso successo nel 1820. Quando Rossini, stabilitosi definitamente a Parigi dal 1823, ricette la commissione per un lavoro da parte dell’Opéra, non ebbe dubbi nel riutilizzare materiale precedente. In un primo momento ci fu l’intenzione di prendere di pari lo spartito di Maometto II e trasporlo in francese, in seguito ad alcuni rinvii da parte del teatro, il compositore rimaneggiò tutta l’opera. Bisogna rilevare che l’odierna versione critica curata da Damien Colas, non può basarsi sulla versione originale ascoltata nel 1826 poiché nessuna partitura autografa completa è oggi reperibile, esistono solo alcuni frammenti sparsi conservati in biblioteche e collezioni private, e fatto ancor più inspiegabile mancano le copie per cantanti e strumentisti della copisteria del teatro. Compito di Colas è stato dunque quello di ricostruire una partitura partendo dall’edizione “Troupenas” del 1827 e sviluppando il materiale esecutivo ritrovato della versione abbreviata del 1835, facendone i debiti confronti e ricostruendo misura dopo misura e rigo musicale. Una procedura inusitata per la ricostruzione di un’edizione critica operistica. Il risultato di tale monumentale e difficoltoso lavoro è l’edizione proposta oggi al Rof 2017.
Altro aspetto non secondario è ricordare che Le Siège de Corinthe fu la prima opera in francese proposta da Rossini a Parigi, precisamente all’Academie Royale de Musique, e il fatto destava interesse sia nell’ambiente musicale francese sia nella società della capitale. Inoltre le vicende dell’opera furono trasportate a Corinto, città greca, e tale peculiarità faceva eco all’allora contemporanea Guerra d’indipendenza ellenica (1821-1830) della quale l’opinione pubblica, non solo francese, era particolarmente partecipe e appassionata. Con questi presupposti si può affermare, come anche scritto da Colas, che Le Siège de Corinthe fu una delle prime opere liriche direttamente collegate all’attualità storica.
A differenza di Maometto II, Le Siège de Corinthe (o L’assedio di Corinto, nella successiva traduzione italiana) non fu opera totalmente dimenticata, fu rappresentato fino al 1870 circa (anche se in versioni mutilate o pasticciate), in seguito vi furono alcune riprese all’inizio degli anni ’50 del XX secolo e qualche esecuzione radiofonica. Si dovrà arrivare al 1969 con le celeberrime recite scaligere dirette da Schippers (protagoniste le sensazionali Beverly Sills e Marilyn Horne) per cominciare a parlare di una nuova riscoperta dell’opera. Sarà allestito anche al Matropolitan Theatre di New York per numerose rappresentazioni e fu prodotta anche un’incisione discografica in studio. Tuttavia, tali esecuzioni non possono dirsi filologiche poiché erano delle edizioni “miste” contenendo brani da Maometto II (sia nella versione napoletana sia veneziana), dall’Assedio di Corinto nella versione italiana dal francese e arie da Aureliano in Palmira e una da Pacini, quest’ultima per mettere in luce le doti della Sills (come ce ne fosse necessità). Questo solo dal punto di vista dell’edizione, perché per quanto concerne il valore musicale (Schippers) e canoro (le predette cantanti) credo non ci siano paragoni per le vette raggiunte.
La nuova produzione de Le Siège de Corinthe che ha aperto la XXXVIII edizione del Festival è stata affidata a Carlus Padrissa, del collettivo catalano La Fura dels Baus, assieme alla pittrice e videoartista Lita Cabellut. Per La Fura si tratta del debutto al Festival pesarese ed anche nel repertorio rossiniano. Purtroppo dal folgorante Ring fiorentino non abbiamo più avuto modo di parlare della Fura con toni entusiastici, e la realizzazione pesare si colloca tra le produzioni meno riuscite. Attraverso un comunicato apprendiamo, ma in parte era comprensibile, che “l’idea alla base della messinscena è la Guerra, una presenza costante nella storia dell’umanità, nel corso della quale ci si combatte continuamente per i più svariati motivi: il potere, il denaro, la terra, lo spazio. Nello spettacolo l’elemento per cui si combatte è l’acqua, simboleggiata da muri di bottiglie di plastica disseminate sulla scena. La vicenda si svolge su un terreno arido e salato, l’ambientazione è volutamente atemporale e i costumi che indossano i due popoli (Greci e Turchi) si differenziano solo per le macchie di sangue che imbrattano i costumi dei Turchi”.
Considerazioni che sulla carta possiamo condividere, meno quando si assiste al prodotto teatrale. Per simboleggiare l’acqua si utilizzano innumerevoli bottiglioni di plastica, quelli che si trovano capovolti sui dosatori automatici negli uffici. Corinto è raffigurata da pareti composte di queste bottiglie, all’occorrenza disposte in maniera diversa. Non è chiara l’idea di far circolare per la platea figuranti con le bottiglie in spalla, e quando questi raggiungono il molto ridimensionato palcoscenico, l’acqua sarà versata in ipotetiche cisterne sotterranee. È comprensibile che l’acqua da sempre sia un elemento fondamentale per la vita sul pianeta ma non è il tema della guerra tra greci e turchi, la quale si svolge su tutt’altro terreno come dimostrato dal libretto e dalla storia. Forse l’idea di attualizzare l’opera è considerare che oggi in quelle regioni l’acqua sia elemento indispensabile mi sembra ridicolo è superfluo, semmai la notizia sarebbe lo scioglimento dei ghiacciai nella regione artica. Si sarebbe potuto attualizzare la drammaturgia nella contrapposizione tra estremismo islamico e mondo occidentale, ma presumo che anche in questo caso si sarebbe scesi nel banale. E allora perché non corrispondere un libretto e un’opera tal e quale pretenderebbero di esserlo, pur con la fantasia e in parte la bizzarra inventiva che il collettivo spagnolo da sempre ha dimostrato? Forse troppo si pretende. Lo spettacolo non lascia grande traccia per una somma d’intrinsechi significati che ognuno interpreta a modo suo dovendo ipotizzare. Non metto in dubbio il talento di Lita Cabellut ma i dieci grandi ritratti che campeggiavano prima sul palcoscenico poi per la platea chi e cosa volevano rappresentare? Di elementi scenografici non è il caso di parlarne, piuttosto impressionava il surreale palcoscenico, le calibrate luci e video designer, ma ancor più i cromatismi atemporali dei costumi, questi sì che potevano essere pertinenti. La regia di Carlus Padrissa è scarsa d’idee e soluzioni che non certo originali. Troppe scene realizzate sulla passerella, che circoscrive la buca dell’orchestra, e in platea. Ma perché non utilizzare il palcoscenico? Che, oltretutto, all’Adriatic Arena è piuttosto grande! Il continuo spostamento del coro, sempre in platea ora a destra ora sinistra, disturba poiché sulla scena nulla succede in contemporanea. Quanto ai singoli interpreti non si possono registrare particolari soluzioni, piuttosto sommaria recitazione. Infine, è parsa superflua e dozzinale la proiezione d’interi brani letterari di Lord Byron sullo schermo poiché nulla avevano in comune con l’opera di Rossini oltre ad essere di difficile lettura. Un’attenuante potrebbe essere quella che il poeta partecipò alla suddetta guerra d’indipendenza greca nell’Ottocento, ma fosse anche questa la chiave di lettura mi pare alquanto dozzinale.
Debuttava al Rof l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in sostituzione a quella del Comunale di Bologna recentemente defilatasi, con Roberto Abbado direttore e maestro concertatore. Egli si conferma direttore di rango anche in campo rossiniano, sia per le prove precedenti, sia in quest’occasione. Abbado punta, giustamente, alla monumentalità dell’opera tenendo sempre contenuta e incisiva la sonorità. Il ritmo è incalzante, il tempo sostenuto, i colori e le dinamiche ben accentante, elementi che determinano una lettura emotiva e di forte fascino drammatico. L’orchestra asseconda a meraviglia il maestro in una lettura ove il variegato schema dell’orchestrazione è mutevole secondo i brani ma scolpisce l’epicità della partitura e il tragico evolvere degli eventi nei quali prevale il sentimento patriottico, che appassiona nella misura che un ensemble è una bacchetta possano dialogare nei colori e nelle frementi sonorità senza accensioni strabordanti com’è stato magnificamente eseguito a Pesaro.
Altra novità rilevante è stata la prova del Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, istruito da Giovanni Farina, che ha dimostrato una brillantezza d’assieme ragguardevole, assieme ad una professionalità esecutiva ammirevole per la solida tenuta è omogenea impostazione resisi concreta nella scena del terzo atto con l’invettiva di Hiéros.
Tra gli interpreti si segnala la brillante prova di Luca Pisaroni, Mahomet II, il quale attraverso una voce scura, una particolare perizia in accento e fraseggio e una buona tenuta nella coloratura, egli tratteggia significativamente il condottiero musulmano ma non è meno efficace nei brevi sprazzi romantici con la protagonista femminile.
Nino Machaidze, Pamyra, è anche professionale ma decisamente fuori parte poiché il registro acuto è molto ridimensionato rispetto a un tempo, accenti non scanditi, assenza di colori, e non emerge nei momenti di grande primadonna che la partitura le offre, in particolare la celebre preghiera, cui va sommata una dizione incomprensibile.
Sergey Romanovsky, Néoclés, potrebbe far ravvisare futuri più rosei se riuscisse a trovare una linea di canto più compatta, senza scivolare nel falsetto, e sapesse capacitarsi nel dispensare adeguatamente le energie, poiché nella grande aria del III atto era piuttosto affaticato.
Meglio l’altro tenore John Irvin, Cléomène, che trovava distinguo dal collega con una voce più baritonale, e dimostrava accenti efficaci e una linea di canto più omogenea.
Molto positiva la prova di Carlo Cigni, Hiéros, di austera e autorevole presenza scenica accomunata a un canto drammatico e incisivo soprattutto nell’invettiva finale con ottimi risultati per tenuta e robustezza di voce.
Nelle parti minori Iurii Samoilov, Omar, tratteggiava un sicuro personaggio, Xabier Anduaga era un interessante Adraste, mentre Cecilia Molinari era un’anonima Ismène per scarsa incisività canora.
LA PIETRA DEL PARAGONE [Lukas Franceschini] Pesaro, 8 agosto 2017 (prova generale).
Il Festival 2017 potrebbe avere essere sottotitolato “le seconde edizioni” Infatti, oltre al precedente Siège de Corinthe, anche per La pietra del paragone trattasi del secondo allestimento nella città natale del compositore, come lo sarà anche la successiva opera in programma.
La Pietra del paragone, melodramma giocoso in due atti, è un punto di riferimento nella prima parte della carriera di Gioachino Rossini. Fu il primo titolo commissionatogli dal Teatro alla Scala, se non il più importante teatro italiano dell’epoca uno dei punti d’eccellenza musicale della penisola. La scrittura scaligera fu sicuramente motivata dai successi e dalla fama che il compositore andava conquistando, ma sicuramente un appoggio decisivo fu quello che perorarono Filippo Galli e Maria Marcolini, cantanti di fama, scritturati in quella stagione al teatro milanese, ai quali sarebbero stati destinati i ruoli principali della nuova opera del giovane Rossini. I due cantanti avevano già cantato lavori rossiniani e avevano instaurato un ottimo rapporto con l’autore, oltre a essere consapevoli che la sua musica avrebbe valorizzato quanto nessun’altra le loro doti di cantanti e artisti, pertanto la scrittura vocale de La pietra è fortemente influenzata dalla peculiarità dei due sommi artisti.
Com’era prassi al tempo, e Rossini non era da meno, nell’opera furono riprese molte pagine di altri lavori che il compositore riteneva di comprovato valore. L’opera è di difficile programmazione per l’arduo impegno riservato ai cantanti, non solo i protagonisti, ma anche agli altri, i quali sarebbe riduttivo e improprio definire secondari. Infatti, le esecuzioni della Pietra, dal 1950 in avanti, si possono contare sulle dita di due mani, e sarebbe qui superfluo farne un elenco. Piuttosto è più interessante rilevare che la prima edizione pesarese del 2002 si basava sull’edizione critica curata da Patricia B. Brauner e Andres Wilkund, i quali hanno approntato l’aggiornamento proposto per l’odierna edizione, esaminando ulteriori diverse fonti secondarie oltre a documenti che si riferiscono alla genesi e alle successive riprese. Queste includono undici copie manoscritte della partitura e due manoscritti incompleti, quattordici pezzi singoli, più due della sostituzione fatta per la prima ripresa a Venezia del 1812. Abbiamo avuto pertanto il piacere di ascoltare una Pietra del paragone leggermente diversa da come la ricordavamo dal 2002, più completa e sotto taluni aspetti rinnovata nell’orchestrazione.
Lo spettacolo proposto era firmato in regia, scene e costumi da Pier Luigi Pizzi, stesso artefice dell’allestimento del 2002, qui modificato per gli spazi dell’Adriatic Arena, riadattato nei costumi e nella regia in funzione della nuova edizione critica. Tutta l’azione si svolge in una villa, forse una dimora per le vacanze, di bellissima fattura architettonica che potremo collocare approssimativamente negli anni ’60-‘70 del secolo scorso. La vicenda è sviluppata in una regia molto elegante, proprietario e ospiti nobili o ricco borghesi gozzovigliano in una vita tipicamente balneare tra drink, partite di tennis, battute di caccia. Un soggiorno agiato e spensierato, ma che al suo interno contiene i classici elementi di ogni epoca, l’amore, l’arrampicamento sociale e l’approfittare di situazioni superiori al proprio stato. Pizzi realizza uno spettacolo molto godibile, fresco, vivace e molto divertente, tracciando con garbata ed esperta mano una vita forse più immaginabile che reale, ma sempre sul filo di un savoir vivre d’altri tempi. Tutti i personaggi sono ben focalizzati nei loro intenti circa genuini, e lo spettatore ne esce appagato. Meravigliosi i costumi, soprattutto quelli femminili, ma anche gli uomini sovente in giacca bianca, quando non in costume da bagno quando si utilizza una vera piscina. Unico neo da rilevare è che il regista, rispetto all’edizione del 2002, abusa oggi si molte scene macchiettistiche che hanno tolto quella tinta elegante che preferivo nello scorso allestimento. Anche i costumi in parte sono cambiati e pur nella grande classe del costumista, si preferivano i precedenti.
Anche in questo spettacolo è impegnata l’Orchestra Sinfonica della Rai, che conferma l’ottima professionalità anche perché guidata dalla frizzante bacchetta di Daniele Rustioni, al suo secondo incarico al Festival. Il maestro milanese inizia subito con una sinfonia molto incalzante e ben staccata nei tempi. Prosegue con ottima fattura narrativa, un ritmo molto teatrale e squisitamente brioso come la partitura richiede. Si dimostra esperto concertatore anche nel cesellare i passaggi più lirici o semiseri come l’aria di Giocondo, pur mantenendo lo stile rossiniano scoppiettante negli assiemi e nelle cabalette. Doveroso rilevare che Rustioni è consapevole delle qualità del cast e la sua direzione è sempre stata in funzione del canto, con un accompagnamento molto peculiare alle necessità dei cantanti. Una prova davvero ragguardevole, nella quale si denotano eleganza e ispirazione.
Altrettanto buona la prova del Coro Maschile del Teatro Ventidio Basso, diretto da Giovanni Farina, che partecipa allo spettacolo in maniera precisa e inappuntabile.
Il cast nel suo complesso non era perfettamente azzeccato, soprattutto nelle scelte azzardate per i ruoli.
Delude il Conte Asbrubale di Gianluca Margheri, il quale ha evidenti problemi nei passi di coloratura, non trova un terreno fertile per la sua vocalità troppo contenuta per il ruolo e purtroppo si deve sommare anche una precaria intonazione. Il personaggio scenico era invece ben realizzato ma si doveva anche ascoltare.
Altrettanto fuori parte la giovane Aya Wakizono, Marchesa Clarice, che affronta una parte di autentico contralto con una voce quasi da soprano. Infatti, nel settore grave era completamente afona, e il registro acuto molto limitato. Nei concertati era sovente coperta, sotto taluni aspetti in qualche duetto si poteva apprezzare una certa varietà d’accento ma naufragava clamorosamente nella grande aria del II atto per insufficienza di mezzi.
Meglio il Pacuvio di Paolo Bordogna, che sfodera un talento teatrale innato (anche se potrebbe contenersi dal superfluo) e trova momenti felici con una voce ampia e ben dosata e un’aria spassosissima. Molto apprezzabile Davide Luciano, Macrobio, cantante molto preciso nel canto sillabato attraverso una voce rifinita ed eguale in tutti i settori.
Il miglior cantante era Maxim Mironov, tenore che da tempo ci ha abituato a felici esibizioni. Anche in quest’occasione non è stato da meno, anzi l’eleganza del personaggio, quasi patetico, e l’esibizione vocale sono stati di grande valore. La sua grande aria era cantata con dizione impeccabile e morbido abbandono, cui si aggiunge, in tutta l’opera, un canto sempre corretto e forbito e non meno efficace nei passi di agilità, aspetti che confermando le qualità del tenore russo come una delle migliori carte spendibili nei ruoli rossiniani (e non solo).
Molto acerbe e squilibrate sia Marina Monzò, Donna Fulvia, sia Aurora Faggioli, Baronessa Aspasia, che vocalmente dimostravamo molto mancanze, anche se i personaggi erano divertenti. Bravissimo invece William Corrò, Fabrizio, efficiente cantante, rifinito e impeccabile nei brevi interventi.
Successo clamoroso per tutti al termine.
LA SPOSA E I SUOI CARNEFICI [Angelo Rivoli] Volterra, 8 agosto 2017.
In scena a Volterra, in prima assoluta, con Patrizia Ciofi e Simone Migliorini, al piano Laura Pasqualetti, uno spettacolo di Natalia Di Bartolo, per la serata conclusiva del XV Festival Internazionale del Teatro Romano, nel monumento millenario, tra Opera e Prosa: “La sposa e i suoi carnefici”.
Protagoniste due eroine immortali del teatro di tutti i tempi: Giulietta e Desdemona, accomunate entrambe dall’essere spose, ma costrette al sacrificio estremo dalla violenza cieca dei propri congiunti: il padre per Giulietta e il marito per Desdemona. I congiunti, armati di un amore che diventa potere inconsapevolmente crudele e vessatorio, sanno diventare i più spietati carnefici.
Il canto lirico era tratto dalle opere di Vincenzo Bellini “I Capuleti e i Montecchi”, di Charles Gounod “Roméo et Juliette” e di Giuseppe Verdi “Otello”. L’idea era però anche quella di far “parlare” i librettisti di tali opere, insieme a Shakespeare, oltre che farli “cantare”. Un lavoro di cesello tra frasi musicali, canto e recitazione, che ha dovuto tenere conto di passaggi musicali e canori, di fiati e suggestioni, di duetti traslati dall’Opera alla Prosa. Apparentemente un semplice collage, è stato invece un gran lavoro anche di scrittura, che si è giovato di sinergia ed ha tenuto conto delle singole competenze.
A Volterra, la protagonista Patrizia Ciofi, soprano di fama internazionale, non si è risparmiata, ha recitato abilmente per la prima volta e la sua ben nota presenza scenica ha conferito spessore alle due spose protagoniste. Il suo canto è stato sentito, emozionante ed emozionato, intenso e coinvolgente. L’artista era anche al debutto come Desdemona verdiana, in un evento nell’evento che ha conferito un valore aggiunto allo spettacolo.
La pianista Laura Pasqualetti, già collaboratrice del M° Riccardo Muti, ha eseguito le musiche al pianoforte con un tocco volutamente orchestrale e intensa sensibilità.
Quanto ai carnefici è bastato un grande interprete per entrambi, ma anche per altri personaggi cardine delle due trame: Simone Migliorini, nella veste di “attore fine dicitore”. È una figura che va scomparendo dai teatri, questa. È quella di colui che sa pronunciare il verso, che ne conosce gli accenti, i ritmi e i respiri, che ne sprigiona l’afflato e il canto e dunque utilizza la propria vocalità con un’impostazione simile a quella del canto lirico. L’interprete si è così districato tra i brani di Shakespeare e le rime dei librettisti, duettando con il soprano in un incalzare di voci, canto, parole e poesia da mettere i brividi.
Il pubblico era incantato. Gli spettatori, che colmavano la platea del meraviglioso monumento volterrano, trattenevano il respiro e seguivano agilmente le trame, riconoscendo i personaggi, nell’abile interscambio vocale, negli atteggiamenti e nelle posture, nei gesti contenuti, ma pregni di significati simbolici di entrambi gli interpreti, anche abilissimi registi.
Un pugnale e un fazzoletto ricamato, disposti su un leggio al centro del palcoscenico erano tutta la scena, ma sufficienti a definire luoghi ed azioni. Lo splendido scenario di Volterra e del suo teatro romano, dotato d’acustica sublime, faceva da cornice ed amplificava atmosfera ed emozione.
Uno spettacolo originalissimo, dunque, in cui è stato percorso un sentiero mai battuto prima. Si potrebbe parlare di una particolare “avanguardia”. La commistione di generi performativi in questo caso va ben al di là della commistione di generi, tecnologie e multimedialità, come oggi va tanto di moda. Qui si è trattato, invece, di un teatro “semplice”, fatto di pochi mezzi e grande talento e che recupera il ruolo centrale dell’artista, anche con rilevanti essenzialità ed eleganza.
TORVALDO E DORLISKA [Lukas Franceschini] Pesaro, 9 agosto 2017 (prova generale).
La terza opera proposta del Festival pesarese è stata il dramma semiserio Torvaldo e Dorliska, nella produzione del 2006, per la seconda volta in cartellane nella manifestazione.
Anche questo spartito riserva delle peculiarità importanti nella parabola artistica di Gioachino Rossini. Il libretto fu il primo scritto da Cesare Sterbini, autore non famoso al tempo, il quale collaborerà al più celebre Barbiere di Siviglia. L’opera, che un lavoro ragguardevole, appartiene al genere semiserio, o “sentimentale” come si definiva al tempo, che fu praticato dal compositore pesarese in seguito con esiti maggiori in Matilde di Shabran e La gazza ladra. Torvaldo e Dorliska, prima commissione romana per il compositore, fu rappresentata al Teatro Valle nel 1815, con esito non trionfale, e nel cast figuravano tre star come Filippo Galli, Domenico Donzelli e Raniero Remorini, nomi che possono far capire l’impegno previsto per i rispettivi ruoli. L’opera ebbe una discreta circuitazione nella prima metà del XIX secolo, tra gli altri si cimentarono nei ruoli la Colbran, la Malibran e Nozzari. In seguito il perse attrazione poiché il genere semiserio fu accantonato in favore del grande dramma.
Lo spettacolo era quello ideato da Mario Martone (regia), Sergio Tramonti (scene) Ursula Patzak (costumi) e Cesare Accetta (luci) nel 2006 per la prima proposta nell’edizione critica curata da Francesco Paolo Russo. Spettacolo molto riuscito e giustamente riproposto. Martone, assieme al suo solito team, crea un ambiente cavalleresco in un immaginario nord dell’Europa, differenziando il piccolo palcoscenico del Teatro Rossini con un imponente cancello che suddivide l’azione tra il castello del Duca e il bosco retrostante. La regia è molto garbata ma vitale. Dal bosco sovente scompaiono coro e qualche protagonista, gli abitanti del castello sono invece più circoscritti dentro la cancellata. Martone sviluppa uno spettacolo epico, medievale, che contiene i classici temi della guerra, del sopruso, del cattivo, della coppia amorosa alla sua mercé e di alcune figure buffe. Non calca mai la mano nel tratteggiare i personaggi, in particolare Giorgio, custode del castello, è sobrio e non cade nel facile cliché della macchietta, ma anche la giovane Dorliska non è una svenevole figura amorosa, ma una donna forte e combattiva per il suo Torvaldo. Una lettura mirabile, spontanea e d’effetto, nella quale non mancano riferimenti risorgimentali. Bellissimi i costumi della Patzak, e geniale la scena creata da Tramonti, il quale utilizza una passerella che all’occorrenza da fondo si trasforma in una gabbia-prigione per il protagonista maschile.
L’orchestra Sinfonica “G. Rossini” di Pesaro non ha le qualità della Sinfonica della Rai, ma ha avuto modo di mettersi in luce per una solida professionalità e una corretta esecuzione. Merito anche di Francesco Lanzillotta, direttor e maestro concertatore, che guida i musicisti con polso fermo e sostanzialmente un pertinente ritmo. Talvolta abusa in qualche sonorità, scivolando in un artefatto equilibrio che non è peculiarità dell’opera. Tuttavia nel complesso non sono mancati momenti felici, nei quali ha prevalso il racconto “da romanzo d’appendice” e ha equilibrato con efficacia le diverse sfaccettature musicali dell’opera.
La prova del Coro del Teatro della Fortuna “M. Agostini”, istruito da Mirca Rosciani, è sta molto professionale.
Nel complesso molto funzionale il cast, a cominciare dal Duca d’Ordow di Nicola Alaimo che è impegnato in ruolo di ardua difficoltà. Il cantante siciliano offre una prova molto rilevante attraverso uno strumento vocale di prim’ordine disegnando un personaggio convincente e in particolare molto preciso nella difficile prova vocale. Altre caratteristiche sono l’eccellente musicalità, la voce importante, e la scansione ragguardevole degli accenti. Ben realizzata l’aria d’entrata ma ancor più la grande pagina “Indietro. Ah qual voce”, al II atto, nella quale le difficoltà sono superate con spiccato fraseggio e modulazione della voce, anche se il canto d’agilità non sempre è sciolto.
Salome Jicia, Dorliska, non vanta un timbro molto seducente e sovente il registro acuto risulta stridulo, la zona grave non è del tutto rifinita, le agilità non particolarmente brillanti. Una prova piuttosto modesta, cui si deve solo apprezzare l’estro interpretativo.
Molto meglio il Torvaldo di Dmitry Korchak, il quale sfodera una linea di canto forbita e sfumata, mezzevoci precise e un registro acuto puntuale, accomunato da una coloratura di tutto rispetto.
Strepitoso Carlo Lepore nel ruolo di Giorgio, che interpretava con un braccio fratturato con fascia al collo. La migliore prova da me ascoltata in teatro dal cantante, il quale è padrone assoluto del fraseggio e della difficile coloratura, la dizione è impeccabile e le sfumature dei colori rilevanti. Inoltre, l’interprete non era secondario al cantante, cui dobbiamo lodare la stilizzata recitazione, divertente e umana che non è trasbordata nel facile stereotipo insopportabile del buffo-clown.
Positive le prove di Raffaella Lupinacci, Carlotta, che ha modo di mettersi in luce nella sua aria di sorbetto eseguita con carisma e fermo registro acuto, e di Filippo Fontana che ha disegnato un preciso Ormondo.
Grande successo al termine.
TURANDOT [Simone Ricci] Macerata, 13 agosto 2017.
Il progetto creativo di Stefano Ricci e Gianni Forte ha provocato e fatto discutere nel corso dell’edizione 2017 del Macerata Opera Festival.
Clown, orsi polari, colpi di pistola e cartelli in ricordo di Paolo Borsellino: possono coesistere tutti questi elementi in “Turandot”, il lavoro che da molti viene considerato la conclusione della tradizione operistica italiana? Secondo il regista Stefano Ricci la risposta è affermativa: il tema della 53ª edizione dello Sferisterio Opera Festival di Macerata era l’oriente e non poteva mancare l’opera incompiuta di Giacomo Puccini, rivisitata molto liberamente per l’occasione. Questa recensione si riferisce alla recita di domenica 13 agosto 2017, l’ultima di uno spettacolo che ha provocato e fatto discutere. La Pechino del “tempo delle favole” ha lasciato spazio a un racconto moderno e decisamente innovativo che non ha però convinto del tutto.
In realtà è proprio una favola quella immaginata dal progetto creativo dello stesso Ricci e Gianni Forte, anche se la presenza di troppi dettagli ha confuso e non poco gli spettatori marchigiani. Turandot e apparsa in abiti sgargianti, più precisamente nelle vesti di una principessa volubile e sognatrice: ogni personaggio presente in scena era quindi il frutto del suo spazio mentale, rappresentato da una distesa di ghiaccio in cui ogni forma di vita viene catalogata con cura. Si poteva intuire la metafora del cuore di ghiaccio di Turandot e sul palco era costantemente presente un orso polare, cavalcato dalla principessa e da Calaf trionfante dopo aver risolto i tre enigmi.
Ancora più particolari erano gli altri protagonisti: Timur non aveva assolutamente l’aspetto di un vecchio cadente, anzi si faticava a credere che fosse il padre di Calaf a causa del suo aspetto elegante e giovanile. Liù, invece, indossava un abito da sposa, mentre Ping, Pong e Pang sono stati presentati in tre modi diversi per ogni atto (botanici in camice, clown e in abiti eleganti). Questo fantasy delirante era poi completato dal popolo di Pechino, i cui vestiti erano un vero e proprio trionfo del verde, salvo poi passare agli impermeabili termici nella scena dell’alba, senza dimenticare i figuranti che accompagnavano ogni azione dei vari protagonisti, “congelandoli” e risvegliandoli a ogni comando di Turandot.
Alcune scene sembravano essere state pensate soltanto per il gusto di provocare: in particolare, al posto dell’esecuzione del Principino di Persia si è pensato di bendare e uccidere a colpi di pistola i bambini della folla. Inoltre, Ricci ha deciso di stravolgere il terzo atto, cancellando il suicidio di Liù che è stata invece uccisa da Turandot. Interessante, ma forse poco adatta alla narrazione, è stata la scelta di far mostrare al popolo di Pechino una serie di cartelli: le varie lettere formavano la frase “Chi ha paura muore ogni giorno”, un chiaro riferimento al giudice Paolo Borsellino che forse poteva non essere scomodato in un racconto di questo tipo.
Passando al versante vocale, France Dariz è stata apprezzabile nei centri, oltre che capace di affrontare gli acuti senza fatica e di gestire senza problemi la tenuta dei fiati, tanto da conquistare applausi scroscianti e convinti. Rudy Park ha esibito acuti facili e squillanti, nonostante qualche difficoltà di emissione dal punto di vista timbrico, un particolare che si è notato anche nell’atteso Nessun dorma. La regia ha privato Liù del suo impatto emozionale, ma Davinia Rodriguez ha risollevato le sorti del ruolo con una linea vocale molto elegante e una serie di pianissimi di buona fattura: qualche applauso in più lo avrebbe meritato il suo Tu che di gel sei cinta.
Molto buono è stato il terzetto delle maschere, composto dall’irreprensibile Ping di Andrea Porta e dai più che corretti Gregory Bonfatti (Pang) e Marcello Nardis (Pong). Il Timur di Alessandro Spina, nonostante l’aspetto troppo giovanile, ha brillato per autorità vocale e scenica, senza dimenticare gli altri interpreti, vale a dire i validi Nicola Ebaud (Mandarino), Andrea Cutrini (Principe di Persia) e Stefano Pisani (l’Imperatore Altoum). Il Coro Lirico Marchiginao “Vincenzo Bellini” si è ben disimpegnato, arricchendo di un protagonista fondamentale la narrazione, per non parlare del contributo prezioso del Coro di voci bianche Pueri Cantores “Domenichino Zamberletti”.
Pier Giorgio Morandi ha guidato con sicurezza l’Orchestra Regionale delle Marche, assicurando una lettura viva, appassionata e fiabesca, senza tralasciare il lato umano della partitura. La grandiosità delle note pucciniane non è stata mai opprimente, coinvolgendo il pubblico maceratese nella ricerca delle atmosfere orientali e sognanti che il compositore toscano aveva cercato fino alla morte. Gli spettatori hanno tributato lunghi applausi a tutto il cast vocale, ma non sono mancati segni di disapprovazione a una regia così poco convenzionale, soprattutto al termine del primo atto.
IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA [Lukas Franceschini] Innsbruck, 14 agosto 2017.
All’Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, nell’ambito delle celebrazioni di Claudio Monteverdi, non poteva mancare una sua opera, così è stata messa in scena Il ritorno di Ulisse in Patria al Tiroler Landestheater.
Il soggetto è tratto dall’Odissea di Omero su libretto di Giacomo Bordaro, e l’opera denominata “tragedia di lieto fine in un prologo e cinque atti SV 325” fu eseguita per la prima volta al Teatro di San Cassiano o Teatro Santi Giovanni e Paolo a Venezia nel 1641. La vicenda segue fedelmente il testo di Omero (libri XIII-XXIII).
Nella più malinconica e meditativa delle tre opere monteverdiane, Ulisse, il protagonista, è una sorta di eroe fragile, non pago del sapere acquisito ma più ancora desideroso di riscoprire gli affetti perduti in quattro lustri. Monteverdi raggiunge vertici assoluti nell’invenzione musicale e d’introspezione psicologica dei personaggi. Straordinaria la scena dell’agnizione di Ulisse e Telemaco più ancora di quella tra il protagonista e Penelope. Molto originale la perizia con cui il compositore ha contraddistinto vocalmente i ruoli. Ogni personaggio è connotato da un modo espressivo adatto al suo rango e alla sua tempra: la dimensione sovraumana delle divinità è resa dallo stile alto, melismatico, mentre ruoli come quelli di Melanto ed Eurimaco intervengono sempre con facili canzonette. L’austera Penelope declama un recitativo severo nello stile tragico di Ulisse, il quale però si sdoppia e nella condizione di finto mendicante imita lo stile umile. Antinoo si esprime con un declamato impervio di sbalzi, segno di statura sociale elevata, ma anche di pravità. E ad esempio nel confronto con Eumete i suoi sgraziati scarti di registro cozzano con la serena compostezza del pastore, che rispecchia uno stile medio e la sua condizione inferiore. L’attenzione ai diversi tipi di esposizione crea una retorica vocale impiegata a fini teatrali: è importante il modo in cui i personaggi si esprimono, e il registro stilistico scelto di volta in volta è funzionale al racconto, come ad esempio quando un personaggio esce dal suo registro abituale per assumerne un altro.
Il recitativo è ricco d’impennate liriche, incisi ripetuti e spunti ritmici, che dopo uno sbalzo ricadono nella declamazione libera, come nell’abbandono gioioso. Il compositore nei momenti in cui il recitativo lievita ad arioso, per esigenze teatrali e interpretative, ritma le sue dimensioni forzando il tempo rappresentato e seguendo la logica degli affetti e della musica.
L’unica copia manoscritta che esiste del Ritorno di Ulisse in patria è conservata a Vienna ed è redatta da un copista. La ricostruzione della genesi dell’opera è stata fatta nel 2007 sulla base dei dodici libretti originali. Ma in quest’occasione delle rappresentazioni a Innsbruck un eccelso musicologo come Alessandro De Marchi ha approntato una differente versione, suddivisa in due parti, rafforzando il recitativo rendendolo più musicale e “teatrale” e con l’inclusione di altre composizioni dello stesso Monteverdi (madrigale “Lamento della Ninfa” e madrigale “Zefiro torna”) e di Francesco Cavalli (Sinfonia a 12). Scelta che molti segnaleranno come non filologica, ma io penso che ai fini della rappresentazione sia stata molto efficace, sia dal punto di vista drammaturgico sia musicale, poiché nulla toglie anzi, offre maggior spessore.
Proprio De Marchi è l’artefice principale della bellissima esecuzione cui abbiamo assistito. Esperto conoscitore del repertorio barocco, ha guidato con mano ferma e competente l’eccellente Orchestra Academia Montis Regalis (su strumenti originali). Il direttore è stato molto vario sulle indicazioni fornite ai cantanti rispetto al testo, pertanto i recitativi sono stati molto ben eseguiti e non si è caduti nella classica banalità talvolta tradotta in noia, al contrario abbiamo ascoltato un lavoro emozionante. Negli ariosi e nei ritornelli era predominante un’eleganza arcaica di grande effetto e brillantemente eseguita.
Il cast nel suo complesso era molto valido ed era preponderante una grande classe esecutiva scorrevole e dinamica. Kresimir Spicer, Ulisse, è stato un cantante molto morbido e stilizzato trovando colori e accenti felici. Molto rilevante la Penelope di Christine Rice, dotata di voce melodiosa e dolente, ma senza abusarne poiché nei momenti più concitati trova un bel vigore e un fraseggio vibrante cui va sommata una bella vocalizzazione e un’ottima pronuncia.
Bravo il controtenore David Hansen, Telemaco, dal timbro molto chiaro che determina la giovinezza e una buona tecnica che gli permette di superare brillantemente i passi fioriti. Valido il Melanto di Vigdis Unsgard, aggraziato e preciso, altrettanto possiamo affermare della spiritosa ed elegante Ingebjorg Kosmo, Ericlaea.
Notevole la classe di Jeffrey Francis, Eumete, soprattutto nella dizione, di Carlo Allemanno, un Iro molto considerevole, e Petter Moen, Eurimaco, di precisa musicalità. Dei tre tentatori di Penelope si apprezzano l’Antinoo di Marcell Bakonyi e l’Anfinomo di Francesco Castoro per lo stile, meno il Pisandro di Hagen Matzeit piuttosto gracile e graziato vocalmente.
Professionali ma anche molto variegati nel canto Nina Bernsteiner (Giunone e Amore), Halvor F. Meilen (Giove), Andrew Harris (Nettuno e il tempo), e la frizzante Ann-Beth Solvang (Minerva e La fortuna).
Lo spettacolo, una coproduzione tra Innsbrucker Festwochen e Norske Opera di Oslo era curata nella regia da Ole Anders Tandberg, scene di Erlend Birkeland, costumi di Maria Geber. Non abbiamo trovato una chiave di lettura molto pertinente per l’opera, anche se attualizzata ai giorni nostri. Tutto si svolge nell’ambiente elegante di una ricca casa nobile, dove l’attesa di Ulisse da parte di Penelope (spesso in abito da sposa) è sviluppata in una sorta di pantomima più sviluppata sul lato comico che drammatico. I personaggi entrano ed escono creando dei siparietti autonomi, oppure sono tutti in scena, anche se non cantano e si fingono comparse come in un dramma di Ibsen. Tutto poco credibile e per molti aspetti poco comprensibile. Doveroso però rilevare la bravura dei cantanti, i quali in questa concezione astrusa sono stati oltre che ottimi esecutori anche bravissimi attori. L’elegante scena era a volte sviluppata in altri ambienti più intimi come la cucina o la sala da biliardo per il gioco. Costumi nella norma con l’abbigliamento odierno che non si faceva ammirare ma neppure deprecare.
Le quasi quattro ore dell’esecuzione sono scivolate in un ascolto mirabile e molto avvincente, le incomprensioni dello spettacolo erano superate della musica e dall’esecuzione, che al termine ha meritato il lungo applauso da parte di un Tiroler Theatre tutto esaurito.
AIDA [Lukas Franceschini] Verona, 16 agosto 2017.
Aida è titolo principe all’Arena di Verona, e anche quest’anno è stato riproposto l’allestimento di Gianfranco De Bosio che nel 1982 ricostruì lo spettacolo che fu realizzato nel 1913 basandosi sui bozzetti di Ettore Fagioli.
Questo spettacolo si colloca nel solco della piena tradizione, faraonico ma anche intimista, e da sempre ha raccolto i più ampi consensi. In esso è contenuta l’essenzialità del grande melodramma verdiano, colorato e maestoso, sono solo quattro coppie di colonne che opportunamente spostate creano una scena di grande fascino e indubbia qualità artistica. Oggi che è stato anche “rinnovato” nei colori, è ancora più luminoso e piacevole. Nel corso degli anni qualche ritocco è stato apportato, ma sempre in meglio, e in questa stagione la possibilità di accorpare i primi due atti senza intervallo è davvero rilevante, poiché la durata della recita è in tempi accettabili. La regia di De Bosio, è fermamente classica, non sottovalutando la drammaturgia e focalizzandosi in maniera egregia sui personaggi, i quali sono “fissati” da Verdi, e il regista si attende scrupolosamente alla partitura. Molto belli i costumi, in pieno stile liberty, azzeccate le coreografie di Susanna Egri. È indiscusso che questo spettacolo “tradizionale”, ma molto ben fatto e piacevole, sia un classico, che il pubblico areniano si aspetti e apprezza e se è in cartellone da quasi quarant’anni, un motivo ci sarà.
Protagonista era il soprano Maria José Siri, la quale rispetto a una recita scaligera di qualche anno fa ha messo molto a fuoco la parte vocale. Abbiamo avuto un’interprete molto rifinita nel fraseggio e nella varietà degli accenti, musicale e mai fuori tempo. Abbozza appena il difficile “do” dell’aria al III atto ma nel complesso è cantante di spessore e rilevante interprete.
Al suo fianco il valido Radames di Walter Fraccaro, cantante sicuro e preciso che non teme, in genere nessun ruolo. Come ho più volte avuto occasione di dire Fraccaro è un cantante che gode di una salute vocale invidiabile peccato che non sempre sia rifinito nel fraseggio e nel dosaggio dei colori risultando un po’ monotono.
Discorso ben diverso per l’Amneris di Giovanna Casolla. Dopo quarant’anni di carriera è qualcosa di miracoloso cantare ancora il ruolo. Tuttavia, alcuni limiti ci sono, e vorrei vedere se non fosse così, però la cantante è ancora grintosa, con una voce sorprendentemente ferma e sicura, sia in acuto sia nel grave e il personaggio è altamente regale. Aggiungo che in questa recita mi ha convinto e mi è piaciuta molto di più rispetto occasioni passate.
Molto buona la prova di Carlos Almaguer, Amonasro, cantante ben impostato e rifino con una valida personalità sia vocale sia interpretativa.
Professionale il Ramfis di Deyan Vatchkov, incisivo e altero, molto più spento il Re di George Andguladze.
Perfetto nel suo breve intervento Paolo Antognetti, il messaggero, e buona la prova di Tatma Tarieli, la quale cantava il ruolo della sacerdotessa.
Notevole la prova di Andrea Battistoni, direttore e concertatore, che assieme all’orchestra dell’Arena, coglie appieno il significato dell’opera che spazia nei vari momenti drammaturgici siano essi intimi e di grande effetto corale. I tempi sono molto calibrati e un’attenta scansione dei colori fa sì che la sua direzione offra un rilevante tassello alla recita con grande sfarzo di sonorità sempre controllate e di grande effetto teatrale. Se ottima è stata la prova dell’orchestra, altrettanto bisogna registrare anche per quanto riguarda il Coro, ben diretto da Vito Lombardi.
Successo trionfale al termine.
IL VIAGGIO A REIMS [William Fratti] Pesaro, 16 agosto 2017.
Come di consuetudine, accanto ai tre titoli principali, il Rossini Opera Festival propone Il viaggio a Reims nello storico allestimento di Emilio Sagi, con costumi di Pepa Ojanguren, ripreso da Elisabetta Courir, con la partecipazione dei giovani solisti dell’Accademia.
Sul podio della Filarmonica Gioachino Rossini è il bravo Michele Spotti che sa dosare i giusti colori.
Beatriz De Sousa è una piacevole Corinna, un poco imprecisa nell’aria di sortita, ma più corretta nel duetto. Martiniana Antonie è una Marchesa Melibea in possesso di un buon materiale vocale, ma ancora leggermente insipida. Giorgia Paci rende una buona prova nei panni della Contessa di Folleville, sicura in acuto e brillante nei sovracuti (tranne un piccolo incidente proprio al termine della cabaletta), ma deve migliorare il legato e la proiezione. Noluvuyiso Mpofu è una Madama Cortese precisissima e intonatissima, con un’ottima linea di canto.
Oscar Oré è un bravissimo Cavalier Belfiore, soprattutto in acuto, perfettibile nella timbratura dei piani. Emmanuel Faraldo è un Conte di Libenskof poco intonato e poco preciso. Elcin Huseynov è un Lord Sidney corretto, ma con un vibrato un tanto eccessivo in certi punti. Roberto Lorenzi esegue eccellentemente l’aria di Don Profondo, ma i recitativi sono da migliorare. Michael Borth è un brillantissimo Barone di Trombonok.
Valeria Girardello mostra un bellissimo colore e un’ottima emissione nelle poche frasi assegnate a Maddalena, come pure Daniele Antonangeli in quelle di Don Prudenzio.
Buona la prova di Francesco Auriemma nei panni di Don Alvaro, Alasdair Kent in quelli di Don Luigino, Francesca Tassinari in quelli di Delia, Marigona Qerkezi in quelli di Modestina, Ruzil Gatin in quelli di Zefirino e Gelsomino. Conclude Aleksandr Utkin nelle vesta di Antonio.
LE SIÈGE DE CORINTHE [William Fratti] Pesaro, 16 agosto 2017.
Negli anni in cui si stavano ultimando le edizioni critiche dell’intera opera rossiniana, ci si ponevano numerose domande in merito al futuro del ROF e della Fondazione, ma oggi si può sinceramente affermare che il loro lavoro è ancora assolutamente indispensabile.
Lo dimostra anche il titolo inaugurale dell’attuale edizione del Festival, che dopo solo diciassette anni si presenta con una nuova forma drammaturgica, più improntata al senso teatrale della tragedia che non alla spettacolarità del canto e con molta musica in più. Non c’è alcun dubbio che continuando a cercare, scavare e studiare sia possibile scoprire ancora tanta novità nell’opera del compositore pesarese.
Roberto Abbado, coadiuvato da Andrea Severi, è indubbiamente uno dei punti di forza di questa produzione, sia per la sua competenza in ambito rossiniano, sia per il lavoro svolto in passato sulla partitura di Maometto II. È un vero e proprio collante tra buca, palcoscenico e pure la platea: ogni passaggio si risolve omogeneamente, perfettamente legato a quello successivo, in un dialogo continuo con gli interpreti vocali e l’orchestra e per questo direttamente connesso con le emozioni e i sentimenti del pubblico. Il debutto a Pesaro dell’OSN è un vero successo, poiché oltre a esprimere una purezza di suono oltre ogni misura, si dimostra anche assolutamente in grado di dare vita a colori e sfumature di una certa intensità drammatica in totale sincronismo col canto.
Tanta magnificenza purtroppo non la si può riscontrare nello spettacolo creato da La Fura dels Baus – l’altro grande novizio del ROF – e per vari motivi. Innanzitutto il filo conduttore che risiede nella guerra per l’acqua, se non fosse stato tanto promosso attraverso la campagna mediatica sarebbe stato ben difficile da cogliere. Un allestimento fatto di boccioni per erogatori che non vengono quasi mai toccati, non può certo risvegliare le attenzioni del pubblico. E una grande occasione persa per poter davvero raccontare questa storia è la musica delle danze, momento in cui una pantomima fatta come si deve avrebbe potuto esprimere un vero significato. E invece prima ci si è persi in un video con versi di Lord Byron – interessante durante l’ouverture, ma la seconda volta diventa ridondante e soprattutto distoglie l’attenzione dalla musica – e poi è stata eseguita una scena mimica davvero brutta e giustamente contestata dalla platea. Più azzeccato è il lavoro svolto da Carlus Padrissa sulla trama e sui sentimenti dei personaggi: centratissimo in tutto primo e terzo atto, è invece un po’ debole in secondo, dove i tormenti interiori e le tragiche decisioni prese da Mahomet e Pamyra non sono ben rese e l’azione risulta troppo lenta. Utili allo scopo i costumi di Lita Cabellut, atemporali, forse futuristici, quasi alieni. Ottime le luci di Fabio Rossi.
Molto ben riuscita anche la prova del Coro del Teatro Ventidio Basso preparato da Giovanni Farina.
Debuttante a Pesaro e nella parte di Mahomet, ma già interprete di Maometto e di numerosi altri ruoli rossiniani nei teatri più importanti del mondo, è Luca Pisaroni, eccellenza italiana che nel nostro Paese è ancora tutta da scoprire. La sua vocalità da bass barytone, cresciuta e perfezionata tra barocco, classicismo e belcanto, è perfetta per questo personaggio autoritario, innamorato, conflittuale, forse cedevole, sapendosi muovere con duttilità all’interno della tessitura, arricchendola di fraseggi e accenti che la rendono viva, reale e umana. Il suo timbro si impone su tutti ed è assolutamente auspicabile un suo futuro ritorno al Festival.
Il 15 agosto Luca Pisaroni si è anche cimentato in un delizioso recital, accompagnato al pianoforte dall’eccellente Giulio Zappa, interpretando diversi pezzi di Schubert col giusto timore reverenziale, emotivamente intenso, profondo e toccante; carattere intimo che poi riporta anche nell’esecuzione raffinata di alcune tra le più belle pagine di Liszt. Fraseggio eloquente, eleganza nei portamenti e gusto nell’interpretazione contraddistinguono poi il suo cantare Rossini, con alcuni pezzi provenienti da Soirée musicales e da Péchés de vieillesse.
Nino Machaidze dimostra una miglior padronanza tecnica rispetto a precedenti occasioni, sia nelle colorature che qui sono meglio sgranate, sia nell’appoggio a beneficio dell’intonazione. Ma nonostante il bel timbro di sempre, la sua Pamyra risulta povera d’accenti e d’espressività – se non nel patetico – insipida nelle intenzioni drammatiche ben poco chiare, talvolta in difetto anche nel legato.
Anche Sergey Romanovsky debutta al ROF ed è una piacevolissima sorpresa. Vocalità luminosa e ben timbrata, ottima salita all’acuto con voce piena, notevole interpretazione rossiniana sotto ogni punto di vista. Oltre a vestire i panni di Néoclès, il17 agosto si cimenta in un concerto, accanto al collega John Irvin e all’eccellente Michael Spyres, dove conferma le sue doti soprattutto in termini di emissione, sicurezza e coerenza nella linea di canto, oltre a una salda discesa verso le note più basse tipiche del baritenore.
Pure John Irvin è per la prima volta a Pesaro e tanto col ruolo di Cléomène quanto con l’esecuzione del concerto del 17 agosto, mostra una grande padronanza tecnica, ma un poco povero di fraseggio e di intensità drammatica, oltre a un timbro davvero molto leggero.
Va comunque segnalato che il terzetto “Céleste providence” che vede coinvolti Nino Machaidze, Sergey Romanovsky e John Irvin è sinceramente toccante; momento in cui i tre interpreti riescono tutti a comunicare la commozione che li pervade.
Ennesima novità al ROF 2017 è Carlo Cigni, che porta in scena un Hiéros autorevole, davvero anticipatore di uno Zaccaria. L’unica pecca della sua performance è che forse risulta troppo verdiano piuttosto che rossiniano. Ma la scena della profezia è forse la pagina teatralmente meglio riuscita della serata.
Ottimi i morbidissimi acuti di Cecilia Molinari nella parte di Ismene. Buona la prova di Xabier Anduaga e Iurii Samoilov nei ruoli di Adraste e Omar.
LA PIETRA DEL PARAGONE [William Fratti] Pesaro, 17 agosto 2017.
Seconda opera nel cartellone del ROF 2017, anche La pietra del paragone come Le Siège de Corinthe è riproposta in una edizione critica aggiornata e dopo quindici anni è possibile riascoltarla in una versione ancora più originale.
Per l’occasione si è deciso di rispolverare e riallestire sul più grande palcoscenico dell’Adriatic Arena il celebre spettacolo ideato a suo tempo da Pier Luigi Pizzi, dimostrandosi ancora attualissimo, azzeccatissimo nella filologia seppur di stampo contemporaneo, divertente e misurato, un poco audace, ma quel tanto che fa sorridere. Ogni pezzo del grande puzzle è perfettamente al suo posto: la regia puntuale e minuziosa sui personaggi e sulle masse, le belle e funzionali scenografie, gli eccellenti costumi alla moda e le adeguate luci di Vincenzo Raponi.
Sul podio della superlativa Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Daniele Rustioni compie un ottimo lavoro soprattutto in termini di colori, sfumature e di dialogo col palcoscenico, indubbiamente complice la bravura di Richard Barker, eccellenza rossiniana, depositario di un sapere che contribuisce a mantenere alti i livelli delle esecuzioni pesaresi.
I panni del protagonista, il Conte Asdrubale, sono vestiti dal bravo Gianluca Margheri, cantante sempre corretto – tranne per qualche incertezza iniziale – in possesso di un bel timbro scuro e un colore molto piacevole. Purtroppo lo stile di canto sembra avulso dal contesto rossiniano e molto lontano da quello dei colleghi, tanto da apparire come un pesce fuor d’acqua. La sua recitazione è comunque molto apprezzata dal pubblico, ma non è sufficiente ad evitare alcune contestazioni che gli vengono rivolte al termine della recita.
Pure criticata è la marchesa Clarice di Aya Wakizono, forse a causa della voce piccola che è spesso coperta dal peso orchestrale o dal canto degli altri solisti. A parte ciò la sua tecnica è veramente sorprendente, precisissima e al tempo stesso morbidissima, arricchita da un fraseggio davvero eloquente ed espressivo, oltre a delle agilità puntuali e vellutate, soprattutto in “Se per voi le care io torno”.
Il Cavalier Giocondo di Maxim Mironov è un tripudio di colori. Il bravo tenore belcantista riconferma le sue doti tecniche, la sua consapevolezza rossiniana, i suoi virtuosismi sapientemente sgranati, la sua espressività raffinata, il suo portamento elegante, il suo saper legare i suoni con un’ottima capacità di rendere sfumature e accenti.
Eccellenti, brillantissimi, precisissimi, vere punte di diamante, il Macrobio e il Pacuvio di Davide Luciano e Paolo Bordogna, veri rossiniani DOC.
Molto buone anche le parti di contorno con Aurora Faggioli nel ruolo della Baronessa Aspasia, Marina Monzò nella parte di Donna Fulvia e William Corrò nei panni di Fabrizio.
Ottima la prova del Coro del Teatro Ventidio Basso diretto da Giovanni Farina.
TORVALDO E DORLISKA [William Fratti] Pesaro, 18 agosto 2017.
La rarissima Torvaldo e Dorliska è riproposta sul palcoscenico del Teatro Rossini, nel fortunato allestimento di Mario Martone del 2006, per la prima volta nella sua edizione critica, pubblicata soltanto un anno dopo la precedente messinscena dello spettacolo.
Inutile soffermarsi sull’importanza di questo titolo, una delle perle rossiniane appartenenti al genere semiserio, intrisa di momenti tragici, drammatici, romantici, patetici, cui si affiancano il buffo e il grottesco. La regia di Martone è ancora perfettamente efficiente e accattivante, anche se ricca di autoimprestiti, soprattutto nell’utilizzo della platea e della pedana adiacente al golfo mistico, ma fortunatamente in questa occasione non esagera nel concentrarsi sulla sala anziché sul palcoscenico, come avvenuto in altri spettacoli, dunque funziona, spaventa, diverte, racconta una storia. Altrettante note positive valgono per i costumi di Ursula Patzak, le scene di Sergio Tramonti e le luci di Cesare Accetta.
Ottima la direzione di Francesco Lanzillotta, che riesce a far emergere i giusti ed eterogenei caratteri dalla complessa partitura, pur avendo a disposizione l’Orchestra Sinfonica G. Rossini che ancora dimostra di avere ampio spazio di miglioramento in quasi tutta la sezione dei fiati. Eccellente la collaborazione di Gianni Fabbrini, buona la prova del continuo di Anselmo Pelliccioni, discreto il Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini guidato da Mirca Rosciani.
Salome Jicia, dopo il successo lo scorso anno ne La donna del lago, qui si presenta nelle vesta di Dorliska e sempre dà sfoggio delle sue abilità tecniche, coi virtuosismi ben sgranati, i legati che abbelliscono e ammorbidiscono i suoni, gli accenti che esprimono disperazione, angoscia, pathos, rassegnazione e romanticismo.
Il bravissimo Dmitry Korchak rende un Torvaldo davvero riuscitissimo, arricchendo di sublimi mezze voci i suoi fraseggi da innamorato, per poi mostrare acuti pieni e svettanti nei momenti di coraggio, il tutto in perfetto stile rossiniano.
Ottimo il Duca di Nicola Alaimo, personaggio difficilissimo e dalle mille sfaccettature, qui reso con opportuna varietà d’intenti ed espressività, senza mai davvero poter capire se si tratta di un personaggio cattivo o sfortunato.
Interpretazione magistrale quella di Carlo Lepore nei panni del custode Giorgio, che inizialmente appare il personaggio goffo e buffo della situazione, poi gentile nel voler aiutare i due poveri innamorati, infine un vero demonio che vuole solo farla pagare a quel tiranno del suo padrone. La voce è sempre sicura e brillante, le limpide note acute fanno da contrappeso alle salde note gravi, le fioriture sempre impeccabili.
Si riconferma ottima Raffaella Lupinacci che qui interpreta Carlotta, sorella di Giorgio. Buona la prova di Filippo Fontana nel ruolo di Ormondo.
TOSCA [Lukas Franceschini] Verona, 25 agosto 2017.
L’ultimo titolo del lungo cartellone operistico all’Arena è stata l’opera Tosca di Giacomo Puccini, nel grandioso allestimento ideato, regia, scene e costumi, da Hugo de Ana nel 2006.
Lo spettacolo è ancora uno dei migliori allestimenti presentati in Arena negli ultimi anni. Tradizionale ma allo stesso tempo innovativo, s’impone per una scena nella quale è posta una grande testa d’angelo con spada e sullo sfondo un’immensa grata apribile che crea un’emozionante finale atto I. Il simbolismo del potere, del destino, dell’autorità, si muovono con grande realismo teatrale attraverso una raffinata ricerca della drammaturgia sui personaggi. Di grande effetto i cannoni che sparano a salve, e imprimente la continua presenza del potere militare papalino attraverso soldati che girano sulle gradinate, ma interagiscono anche nel racconto. Spettacolo di forte impatto visivo e grande fascino romantico, che non tralascia anche altre sfaccettature dell’opera. Qualsiasi aggettivo superlativo è inferiore per descrivere la magnificenza dei costumi, in particolare quelli della protagonista. Il momento più riuscito, da mozzafiato, è il Te Deum, affresco storico-religioso del potere temporale dei Papi. In questa messa in scena è efficace la resa nella sua solennità con numerose comparse e coro, e con l’aprirsi della grata compaiono gli spietati principi della chiesa, l’effetto teatrale è notevole.
Sul podio Antonino Fogliani regge molto bene una lettura incalzante, ricca di colori, grandi scansioni romantiche e ferma incisività nei passi drammatici. Egli guida un’Orchestra dell’Arena, puntuale e precisa, in una lettura rilevante e non priva di ricercati tempi e sostenuto fraseggio.
Il cast non era all’altezza delle attese, e probabilmente possiamo affermare che ci troviamo di fronte a una classica serata “no”, considerate le intenzioni del maestro concertatore e del regista.
Ainhoa Arteta, Tosca, è cantante molto diligente ma non ha i requisiti vocali per il ruolo. Il volume è molto ridotto, la tessitura la mette sovente in difficoltà sia nel canto di recitazione sia nel settore acuto; e l’attrice non è memorabile.
Tutt’altro che da ricordare il Cavaradossi di Aleksandrs Antonenko, un tenore quasi sempre in difficoltà tecnica nella messa in voce, e quanto riesce manca di abbandono romantico poiché i mezzi non sono particolarmente raffinati, cui va aggiunto un colore monotono, talvolta sgraziato.
Boris Statsenko, Scarpia, è il banale cantante russo che canta con pessima dizione e non trovava ne fraseggio ne colori pertinenti, tanto meno intenzioni interpretative, per rendere efficace il famigerato Barone.
Molto superiori alla media le parti secondarie, nelle quali si mettevano in luce il compito e non caricaturale Sagrestano di Nicolò Ceriani, il bravissimo Angelotti di Romano Dal Zovo, il viscido e preciso Spoletta di Antonello Ceron. Bravi anche Marco Camastra, Sciarrone, Omar Kamata, un carceriere, e un plauso particolare a Emma Rodella, un pastorello, che intonava il celebre stornello con assoluta perizia.
Oltre alla grande professionalità dell’orchestra, sopra citata, è da rilevare l’ottimo contributo del Coro, diretto da Vito Lombardi, che nel primo atto offre una prestazione davvero incisiva, e molto bravi i ragazzi del Coro di Voci Bianche A.d’A.MUS istruito da Marco Tonini.
Anfiteatro gremitissimo, un classico nelle ultime recite del Festival, che comunque ha tributato un caloroso successo a tutta la compagnia.
ARIODANTE [Renata Fantoni e William Fratti] Salisburgo, 28 agosto 2017.
La messinscena del celebre – e al tempo stesso misconosciuto – Ariodante di Georg Friedrich Händel al Salzburger Festspiele 2017 si rivela una scelta azzeccata, con uno spettacolo veramente riuscito.
Mantenere alta l’attenzione del pubblico per ben oltre quattro ore con un genere d’opera che, si sa, fa accadere la poca azione che c’è durante i recitativi, mentre si concentra solo sulla manifestazione di un sentimento – all’ennesimo infinito – durante la sterminata successione delle arie, è affare davvero complicato, ma Christof Loy ci riesce benissimo, pur con un allestimento per nulla pretenzioso ideato dal bravo Johannes Leiacker, coi bei costumi di Ursula Renzenbrink che uniscono intelligentemente le epoche dell’Orlando Furioso e del Settecento di Händel con i giorni nostri. Tutti i solisti sono impegnati in una recitazione davvero puntuale, sia nei movimenti e nelle gestualità, sia negli sguardi e nelle espressioni, accompagnati da un lungo stuolo di ballerini davvero ben preparati. Le eccellenti coreografie sono di Andreas Heise, le luci di Roland Edrich.
Le scelte musicali di Gianluca Capuano sul podio de Les Musiciens du Prince – Monaco sono sinceramente strabilianti, poiché riesce a fare emergere tutti i caratteri drammatici e tragici della vicenda, mantenendo sempre un’omogenea morbidezza nelle pagine patetiche. Ottimi il cembalo di Andrea Marchiol e il violoncello continuo di Patrick Sepec.
Superlativa, nella parte del protagonista, è Cecilia Bartoli, che riceve un sincero e meritato successo personale. Nulla da eccepire in merito allo stile, al gusto e all’intero ambito del canto d’agilità, poiché come sempre non le sfugge mai una nota. Ma Bartoli dà anche prova di fraseggi delicatissimi e accenti raffinati con “Scherza infida” dove rende molto commovente e toccante la lunga pagina in cui Ariodante decide di partire.
La Ginevra di Kathryn Lewek è molto credibile nelle parti patetiche, dove canto e interpretazione sono ben eseguiti e amalgamati, mentre difetta un poco di drammaticità nell’accento dei passaggi più incisivi, poiché si lascia andare troppo oltre e i suoni risultano spesso sporchi. È inoltre un po’ tirata nel registro acuto e ciò è particolarmente evidente in primo atto.
Eccellente è Christophe Dumaux nel viscido ruolo di Polinesso. Non solo sa esprimere un personaggio riuscitissimo – arrogante e seducente, violento e superbo – ma mostra anche qualità vocali davvero sorprendenti. Spesso il canto del controtenore è accompagnato da suoni che paiono di testa e in falsettone, mentre la sua esecuzione sembra ben poggiata e proiettata.
Bravissima Sandrine Piau nei panni di Dalinda, interprete elegante e raffinata, limpida in acuto e ben centrata nell’uso degli accenti.
Buona anche la prova del Lurcanio di Rolando Villazón, sempre morbido ed omogeneo, qui alle prese con un ruolo abbastanza centrale dove mai trova ostacoli.
Riuscito solo a tratti il Re di Nathan Berg, un poco in difficoltà nelle arie di primo atto, ma sinceramente struggente in “Invida sorte amara”.
Efficacie l’Odoardo di Kristofer Lundin. Buona la prova del Salzburgher Bachchor diretto da Alois Glassner.
LUCREZIA BORGIA [Renata Fantoni e William Fratti] Salisburgo, 30 agosto 2017.
Lucrezia Borgia è indubbiamente uno dei capolavori drammatici del prolifico Gaetano Donizetti, opera intrisa di azione intensa e talvolta tragica, solo a tratti alleggerita da qualche pagina goliardica o patetica.
E il senso teatrale della vicenda è sapientemente raccontato da Marco Armiliato alla guida della Mozarteumorchester Salzburg, la cui lettura musicale è ricca di fraseggi e sfumature, con un certo vigore all’italiana senza comunque rinunciare alla purezza di suono. Ottimo il Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor diretto da Ernst Raffelsberger.
La Lucrezia di Krassimira Stoyanova è di una eleganza oltre misura, di una raffinatezza impareggiabile, forse troppo, poiché il velluto della sua voce, l’omogeneità della linea di canto, la bellezza del legato quasi tendono a diminuire la resa drammatica, che sfocia come si deve soltanto nel lugubre finale.
Il Gennaro di Juan Diego Florez è di un incanto indescrivibile e sembra ridondante sottolineare l’ennesimo successo del tenore. Al di là della perfezione tecnica, dei suoni purissimi e degli accenti strepitosi, ciò che sorprende sempre di più sono i cromatismi, i fraseggi, la sua capacità di cantare ogni singola consonante, ciò che non solo rende comprensibilissime tutte le parole, ma soprattutto arricchisce il canto di una articolazione complessiva che produce un ascolto sempre più piacevole.
Eccellente l’Alfonso di Ildar Abdrazakov, cantante morbidissimo, voce pastosa, interpretazione smaltata, abile fraseggiatore, forse fin troppo regale per il terribile ruolo.
Bravissima Teresa Iervolino nei panni di Maffio Orsini, della quale si apprezzano soprattutto i brillanti acuti e le perfette colorature, mentre difetta sempre un poco di proiezione e talvolta risulta coperta.
Sufficiente il lungo stuolo dei comprimari (Minjie Lei, Ilker Arcayürek, Gleb Peryazev, Ilya Kutyukin, Andrej Filończyk, Gordon Bintner) tra i quali svetta soltanto il Rustighello di Andrew Haji.
Grandissimo successo per tutti, davvero meritato, e ovazioni da stadio per Juan Diego Florez.
ORFEO [Lukas Franceschini] Vicenza, 6 settembre 2017.
La quinta edizione di “Vicenza in Lirica 2017 – Dialoghi barocchi” offre come spettacolo di punta la rappresentazione dell’opera Orfeo di Claudio Monteverdi in un luogo affascinante come il Teatro Olimpico.
Orfeo, favola in musica in un prologo e cinque atti, su libretto di Alessandro Striggio, ebbe la sua prima rappresentazione il 24 febbraio 1607 nella sala per l’Accademia degli Invaghiti del Palazzo Ducale di Mantova. Opera, o meglio “favola pastorale”, è da annoverare al tardo Rinascimento e all’inizio dell’era barocca musicale, ed è considerata il primo vero capolavoro della storia del melodramma, poiché contiene tutte le risorse fino ad allora concepite nell’arte musicale con una forma notevolmente avanzata della polifonia. Dopo la prima mantovana, il lavoro fu eseguito nuovamente anche in altre città italiane ma con la morte del compositore (1643) cadde nell’oblio. Si ebbero alcune riprese a fine Ottocento, prevalentemente esecuzioni in forma di concerto, come quella del 1904 al Conservatorio di Parigi diretto da Vincent d’Indy nella versione francese. Fu al Teatro La Fenice di Venezia nel 1910 che si registra la prima forma scenica diretta da Guido Carlo Visconti di Modrone, e da qual momento inizia una lenta ma continua riscoperta in tutti i teatri del mondo. Dalla seconda metà del XX secolo, non solo Orfeo ma tutta la produzione di Monteverdi, ebbe una felice riproposta basandosi su studi filologici e ripristinando esecuzioni con strumenti musicali, culminati con le proposte di Nikolaus Harnoncourt tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. Oggi fortunatamente è opera quasi di repertorio e sovente eseguita.
La messa di scena di un’opera al Teatro Olimpico è sempre impresa molto complicata per i vincoli che il sito impone. La narrazione scenografica è stata affidata a un video mapping, realizzato con grande efficacia da Mauro Zocchetta (per Zebra Mapping), che proietta sulla facciata interna sequenze di aerei che si rifanno al bombardamento che investì Vicenza nel 1944. Il senso di questo dovrebbe essere la rinascita della città. Lavoro grandioso ma indecifrabile allo stesso tempo, poiché è piuttosto astruso il parallelismo con la drammaturgia dell’opera. Molto migliore, sempre con tecnica mirabile, quando si colorano in alternanza alcune parti interne del teatro, qui con un gioco di colori rilevante si sviluppa un senso narrativo pertinente. In tale ambiente s’inserisce la regia di Andrea Castello (ideatore del Festival N.d.R.) che ambienta l’opera nell’immediato dopoguerra aggiungendo una figura di mimo-ballerino, Paolo Pincastelli, inutile (però bravissimo) che dovrebbe essere Orfeo, che prende atto al termine della vicenda della propria omosessualità. Un aspetto troppo psicologico che può ravvedersi nella parte letteraria del testo ma non certo nella trama dell’opera monteverdiana. Tuttavia, la drammaturgia realizzata dal regista resta abbozzata, reggendosi soprattutto sulla staticità dei personaggi e qualche scelta poco chiara del filo conduttore, mancando in sostanza proprio sul racconto ove avrebbe dovuto scegliere una strada più coraggiosa. Il tutto era anche abbastanza godibile ma ci saremo aspettati un estro più focalizzato, il quale probabilmente verrà con l’esperienza.
Molto belli i costumi femminili, molto meno quelli maschili, realizzati da Roberta Sattin in chiaro stile anni ’40.
Il versante musicale ha fornito grande interesse sia con la direzione di Francesco Erle sia con la compagnia di canto preparata da Gemma Bertagnolli.
Il direttore Erle sul podio della Schola San Rocco e dei Fiati di Harmonia Parnassia, tutti con strumenti d’epoca, trova un terreno a lui particolarmente congeniale in un autore come Monteverdi. Egli concerta in tempi molto energici e uno stile notevolmente appropriato, l’orchestra ha un mordente di suo molto apprezzabile, anche tagliente e laconico. Forse solo i fiati, in qualche occasione, non sono ben collimati, ma nel complesso abbiamo avuto un apporto musicale di buon livello non facilmente riscontrabile in altre occasioni teatrali.
Molto bravo il Coro della Schola San Rocco che offre una performance quasi da manuale per stile, compattezza e aderenza musicale interpretativa filologica. Doveroso segnalare Alberto Maron, clavicembalo, e Roberto Loreggian, organo e regale, per la grande professionalità e stile nell’esecuzione.
Il cast, composto prevalentemente da giovani, qualcuno al suo debutto, ha mostrato un entusiasmo molto volenteroso con qualche piacevole sorpresa.
Marco Saccardin, protagonista, affronta una prova vocale molto impervia per la sua giovane esperienza, tuttavia è capace di un misurato equilibrio nel recitar cantando e negli ariosi, che sarebbero stati più apprezzati se accompagnati da accenti più incisivi. La prova è sostanzialmente buona e le doti del giovane cantante sono ragguardevoli, manca solo di maggiore esperienza poiché nel finale è apparso leggermente affaticato ma è un cantante da tenere in considerazione.
Giulia Bolcato, che interpretava Musica, Euridice ed Eco, offre una buona prova attraverso un fraseggio variegato e uno stile barocco preciso.
Valeria Girardello è una messaggera brillante e stilizzata, Arianna Lanci una Proserpina molto musicale e precisa, Anna Bessi trova una personale interpretazione barocca di ottimo stile con grandi risorse vocali.
Meno efficace il Caronte di Mateusz Drozda, il quale vanta una voce di grandi risorse ma necessita di approfondire studio e soprattutto impostazione.
I quattro pastori, Fulvio Fonzi (che interpreta anche Plutone), Enrico Busia (anche Apollo), Enrico Torre e Antonio Orsini, si mettono in luce uno stile appropriato e un canto ragguardevole, cui bisogna aggiungere la preziosa prova di Martina Loi, delicata Ninfa.
Successo trionfale al termine, con numerose chiamate e ovazioni per tutta la compagnia, da parte di un pubblico entusiasta che gremiva in ogni settore il teatro vicentino.
L’OCCASIONE FA IL LADRO [Lukas Franceschini] Venezia, 7 settembre 2017.
Il ciclo delle cinque farse di Gioachino Rossini, allestite in anni recenti al Teatro Malibran, passa ora Teatro La Fenice. Quest’anno, come anticipo delle celebrazioni rossiniane previste per il 2018, è la volta de L’occasione fa il ladro, produzione 2012 della Fondazione veneziana.
L’occasione fa il ladro è denominata burletta per musica in un atto, su libretto di Luigi Prividali, che lo ha tratto dalla vaudeville “Le prétendu par hasard, ou L’occasion fait le larron” (edita nel 1810) di Eugène Scribe.
La prima rappresentazione ebbe luogo il 24 novembre 1812 al Teatro San Moisè di Venezia ed è l’ottava opera composta da Rossini. La farsa ebbe, fin dall’esordio, una buona fama e fu rappresentata spesso sia in Italia sia in Europa, ma con la morte del compositore cadde nell’oblio come ben più celebri opere buffe, e scomparve dal repertorio. Ebbe però un’importante ripresa nel 1892 a Pesaro, nel centenario della nascita del compositore. Nella seconda metà del ‘900 importati furono le esecuzioni alla Piccola Scala nel 1962 (con Fiorenza Cossotto) e la prima rappresentazione al Rossini Opera Festival nel 1987, diretta da Salvatore Accardo, con Luciana Serra e segnò l’ultima regia rossiniana di Jean-Pierre Ponnelle. In particolare, l’esecuzione pesarese è contraddistinta dall’edizione critica e anche se l’opera non è entrata in repertorio come le opere buffe quali Il Turco in Italia, La pietra del paragone e Le Comte Ory, da allora vanta un considerevole numero di rappresentazioni e qualche incisione discografica.
La farsa contiene spunti musicali di grande valore che confermano non solo il talento ma anche lo stile del compositore, ormai talento a tutti gli effetti nel genere comico. In particolare si ammirano, oltre a due bellissime arie per soprano e tenore, i concertati e i duetti, e un “temporale” sinfonico che Rossini utilizzerà come overture nell’opera successiva.
Sul podio dell’Orchestra del Teatro La Fenice, il direttore e maestro concertatore Michele Gamba offre una prova positiva in una lettura di variegata brillantezza e un ritmo appropriato al brio rossiniano. Va lodata inoltre la capacità di un efficace equilibrio tra voci e orchestra.
Rocio Perez, Bernice, è cantante raffinata con peculiare predisposizione al canto d’agilità, cui va sommato un registro acuto di assoluto rilevo. Non meno efficace la brillantezza scenica, la quale era accompagnata da una prova musicale notevolmente positiva.
Giorgio Misseri, Conte Alberto, è cantante diligente e abbastanza stilizzato nel canto fiorito e brillante, senza toccare vette acrobatiche.
Omar Montanari, Don Parmenione, si riconferma come uno dei più rilevanti bassi buffi della nuova generazione. Eccellente il gusto interpretativo, sempre elegante e mai parafrasato a macchietta, la voce è rifinita e ben amministrata nel fraseggio e nei colori.
Positiva anche la prova di Enrico Iviglia, un Don Eusebio preciso ed elegante. Completavano la locandina, la brava Rosa Bove, Ernestina, e il divertente e professionale Armando Gabba, Martino.
Non entusiasma lo spettacolo creato da Elisabetta Brusa, le scene, i costumi e le luci sono realizzati dagli allievi della Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Per la precisione: Alberto Galeazzo scenografo, Laura Palumbo costumista, Sara Martinelli ideatrice della costruzione. Va detto che questi ultimi hanno svolto un lavoro molto rilevante, in particolare lo scenografo che racchiude tutto in uno spazio bianco, quasi immaginario, con dipinti sul fondale, che danno un tocco d’ancienne a tutta la vicenda. Molto belli i costumi anche se avrebbero potuto essere più cromatici, il tutto bianco alla lunga stanca. La regia sarebbe stata anche divertente e frizzante, con un pizzico di concezione astratta che ha un senso preciso nella drammaturgia della farsa. Peccato che la signora Brusa abbia voluto inserire una folta schiera di mini, inutili, sia in platea prima dello spettacolo sia in scena durante l’esecuzione, e un velario che offuscava la vista poiché tutti i cantanti avevano costumi uguali e con lo stesso trucco-parrucco era difficile la distinzione. Tuttavia non si può non rilevare un’eleganza innata, anche se avremo preferito fosse più marcata nel gioco del teatrale.
Vivissimo successo al termine.
LA FINTA TEDESCA – LA DIRINDINA [Lukas Franceschini] Vicenza, 8 settembre 2017.
È ormai prassi consolidata che al Festival “Vicenza in Lirica- Dialoghi Barocchi” siano rappresentati in una serata due intermezzi per musica del ‘700. Quest’anno è stata l’occasione per ascoltare La finta tedesca di Johann Adolf Hasse e La Dirindina di Domenico Scarlatti.
L’opera seicentesca ha ignorato lo spettacolo comico come genere autonomo e distinto. Nei drammi musicali del XVII secolo ci sono ampi episodi buffi, nei quali i personaggi, in genere popolani, si cimentano cantando arie meno impegnative anche in dialetto ma non s’impegnano in veri e propri spettacoli comici indipendenti. Il genere dell’opera comica ha origine nel momento in cui dal dramma per musica, sotto la pressione di richieste riformistiche, sono estromessi gli elementi comici. Il genere comico prende una vita autonoma proprio in questo momento e otterrà una rapida fortuna in tutta Europa, ma in particolare saranno Venezia e Napoli le città ove ebbe origine e maggior successo. In questa situazione prende forma un genere buffo nuovo: l’intermezzo in musica. Si tratta di una rappresentazione comica breve, divisa in pochi episodi e interpretata da due o tre soli personaggi e un apparato strumentale assai ridotto, che è inserito fra gli atti di un’opera seria, per offrire un diversivo e allentare la tensione dell’opera seria. L’intermezzo si articola in una successione di recitativi e arie, queste ultime d’impianto generalmente semplice, e mostra inoltre un caratteristico stile “parlante” che diverrà una delle peculiarità di tutto il genere comico.
Entrambi gli intermezzi proposti a Vicenza presentano i tratti comuni stilistici del genere con melodie spigliate e vivaci, strutturalmente semplici ma brillanti, le quali assecondano il gioco teatrale veloce e giocoso.
Nella composizione di Hasse la trama rispecchia il canone della giovane serva che escogita ogni mezzo, compreso il travestimento, per farsi sposare dal ricco padrone, in Scarlatti c’è una spiccata ironia del mondo musicale, nel quale una giovane cantante, non particolarmente dotata, fa la civetta con il vecchio maestro, che pende dalle sue labbra, e un giovane castrato suo innamorato.
La finta tedesca fu eseguita a Napoli nel 1728 circa ma è stata eseguita in tempi moderni a Spoleto nel 2015. Per l’occasione Claudio Toscani ha curato un’edizione critica, utilizzata anche nella ripresa vicentina, nella quale si sono mantenute le stesse notazioni, abbellimenti e la cifratura originale del basso continuo. In essa si evince uno stile molto brillante ove la musica è da supporto a un gioco teatrale rilevante nella recitazione, con spunti dialettali bolognesi ma anche riferimenti alla lingua tedesca e qualche citazione latina. La vivacità musicale, non di grandi pretese ma inopinabilmente giocosa e divertente, peculiare soni i lunghi recitativi, nei quali si da modo ai cantanti di sfoggiare l’arte attoriale non secondaria al canto.
La Dirindina, andata in scena a Roma nel 1715, è molto più spassosa per un intreccio teatrale-musicale di forte impatto ritmico cui si somma una melodia brillante e spassosa di alta fattura, che non a caso è facilmente riscontrabile in composizioni successive anche di altri autori.
L’allestimento, curato come un semi-stage da Andrea Castello, trova una cornice ideale nel cortile di Palazzo Leoni Montanari, il portico offre una visione deliziosa. I pochi elementi, un tavolo e qualche sedia, erano più che sufficienti per rendere l’atmosfera settecentesca e i bellissimi costumi ideati dalla Sartoria Sattin completavano un quadro davvero ragguardevole e di deliziosa ambientazione.
Il direttore Gianluigi Dettori, a capo dell’ottimo ensemble I Solisti dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, ha concertato con stile appropriato fornendo una lettura scintillante e un brio musicale idoneo agli intermezzi, che si contraddistinguono in questo caso per piacevole comicità e ironica teatralità.
Il basso-baritono Lorenzo Malagoda Barbieri, interprete sia di Pantalone sia di Don Carissimo, è cantante raffinato e preciso, il quale poggia la sua esibizione su un fraseggio molto ricercato e una vocalità morbida e stilizzata.
Sabrina Cortese, interprete di Carlotta e Dirindina, è un soprano efficace in questi ruoli brillanti con una verve scenica molto rilevante cui si somma una prova vocale precisa e raffinata.
Giuseppe Montagno, Liscione ne La Dirindina, è un giovane controtenore con buone doti musicali, una tecnica rilevante, anche se non sempre preciso nell’intonazione.
Esecuzione piacevolissima e spettacolo supportato soprattutto dalla verve teatrale dei tre protagonisti, molti stilizzati e mai scivolati nella greve comicità.
Successo pieno al termine della recita da parte di un folto pubblico che gremiva il cortile del Palazzo vicentino, giustamente accorso per due “rarità” non frequentate dal più istituzionale teatro d’opera.
TAMERLANO [William Fratti] Milano, 19 settembre 2017.
Milano, 19 settembre 2017. Dopo il grande successo riscosso ne Il trionfo del tempo e del disinganno, Diego Fasolis torna alla Scala per dirigere Händel in Tamerlano, ancora una volta con i suoi collaboratori I Barocchisti della Radiotelevisione Svizzera e con i musicisti della Scala su strumenti storici.
L’opera in tre atti, su libretto di Nicola Francesco Haym, è indubbiamente uno dei capolavori del prolifico compositore tedesco, poiché non solo straripa di musica sublime, ma si basa su un libretto dalla drammaturgia intensa e significativa.
Lo spettacolo firmato da Davide Livermore è sicuramente uno dei migliori del regista torinese, certo non solo per l’accattivante trasposizione ai tempi della Rivoluzione d’Ottobre, ma soprattutto per l’attenzione ai particolari, al minuzioso lavoro sulla gestualità, al meticoloso impiego di continui movimenti e spostamenti per rendere l’azione anche durante le lunghe arie sentimentali. Alcuni passaggi sono altamente realisti, altri molto poetici – anche grazie all’aiuto dei bravissimi mimi – in un amalgama che tiene alta l’attenzione per oltre quattro ore. Letteralmente strabilianti i costumi femminili di Mariana Fracasso, pure centratissimi quelli maschili, trucco compreso. Bellissime le scene di Davide Livermore e Giò Forma, come pure i video di Videomakers D-Wok.
Diego Fasolis si riconferma eccellente direttore di questo repertorio, in particolare per lo stile e la coerenza. Soprattutto si apprezza il lavoro di taglia e cuci svolto sulle varie versioni dell’opera al fine di arrivare al miglior adattamento possibile alle esigenze degli interpreti e del nuovo allestimento.
La star americana Bejun Mehta veste con estrema disinvoltura i panni del protagonista, ruolo scritto per contralto. Il controtenore mostra una vocalità sopranile limpida e sonora che sfocia nel falsetto soltanto negli acuti più estremi, forse a causa dell’annunciato raffreddore. Ottima la resa del personaggio, soprattutto nell’accostamento Tamerlano/Stalin, da cui traspira una bonaria perfidia che pare quasi surreale.
Pure eccellente è l’argentino Franco Fagioli nella parte mezzosopranile di Andronico. Se inizialmente appare un poco modesto, a partire dal finale primo dimostra in pieno le sue capacità. Dunque non solo “Benché mi sprezzi l’idol che adoro” è pagina davvero riuscita, ma anche le successive “Cerco in vano di placare” e “Più d’una tigre altero”, dove il controtenore mette in mostra le sue grandi doti nelle colorature e l’incredibile abilità di scorrere velocemente dalle note più gravi a quelle più acute.
Buona la prova di Maria Grazia Schiavo nei panni di Asteria, molto corretta nello stile, ma forse un poco carente nell’accento drammatico.
Più puntuale nelle sfaccettature del suo personaggio è l’Irene di Marianne Crebassa, soprattutto nella riuscitissima “Par che mi nasca in seno”, aria patetica che il mezzosoprano francese rende davvero commovente.
Riuscitissimo il Leone/Rasputin di Christian Senn, in particolare nella seconda aria mutuata dalla versione del 1731.
Troppo anziano il Bajazet di Placido Domingo, che nonostante tutto riscuote un grande successo personale.
HANSEL UND GRETEL [Lukas Franceschini] Milano, 21 settembre 2017.
Dopo quasi sessant’anni dall’ultima rappresentazione la celeberrima opera Hansel und Gretel di Engelbert Humperdink torna la Teatro alla Scala, allestita nell’odierna stagione all’interno del Progetto Accademia.
Titolo molto rappresentato, anche in Italia spesso in lingua locale, fino alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, per una strana casualità è poi scomparso dai cartelloni dei nostri teatri. Eppure, basta solo scorgere la cronologia scaligera per rendersi conto di quanto popolare fosse nella prima metà del XX secolo, attirando l’attenzione di bacchette quali Arturo Toscanini, Herbert von Karajan e interpreti del calibro di Rosina Storchio, Concita Supervia, Giulietta Simionato, Elisabeth Schwarzkopf, Sena Jurinac, Fiorenza Cossotto, Renata Scotto.
Hänsel und Gretel è un’opera romantica in tre atti su libretto di Adelheid Wette (sorella del compositore), tratta dalla fiaba omonima dei fratelli Grimm.
Composta nel 1891 fu rappresentata per la prima volta a Weimar il 23 dicembre 1893, diretta con successo da Richard Strauss. Questa composizione dette a Humperdink la celebrità. Fino allora era un duttile musicista, docente e critico, che aveva collaborato con Richard Wagner a Bayreuth. Rispetto alla fiaba originale la librettista modifica molti elementi, soprattutto i più brutali. Infatti, la matrigna diventa madre disperata per i ragazzi spersi nel bosco, e il padre è un capofamiglia intento al sostentamento della stessa. E’ presente anche una dimensione fantastica e religiosa, che si ravvisa nei personaggi del Nano Sabbiolino (non presene nella fiaba), l’omino della rugiada e gli angeli custodi. Oltre al soggetto fiabesco, l’opera, contiene un filone popolare, contraddistinto dall’utilizzo di canzoni e musica d’estrazione popolare. La ricercata trama sinfonica si associa a motivi ricorrenti e limpidi temi o personaggi che offrono al compositore l’occasione per vari pezzi chiusi. Rilevante è costatare che il canto popolare è radicalmente teatralizzato da Humperdink, e molti brani pendono punto dal folklore tedesco.
Musicalmente l’opera si contraddistingue per una tinta cameristica con sonorità raffinate, talvolta sussurrate, anche se l’organico orchestrale è cospicuo. In ultimo, non mancano le allusioni a Wagner, che il compositore ammirava, basti pensare alla scena bel bosco che ha una specie di parallelo con il mormorio della foresta (Siegfried).
Una partitura eccellente, di spirito incantevole nella semplicità della melodia, aspetti cui va sommata anche un’arte superlativa nella struttura orchestrale. Grave errore è considerare l’opera uno spartito per bambini, o infantile, tutt’altro! Anche se tratta da una fiaba, gli aspetti sociali e drammatici sono ben evidenziati.
Alla Scala abbiamo assistito ad uno spettacolo che senza dubbi possiamo definire: memorabile, poetico, onirico, rifinito sotto tutte le prospettive e di una piacevolezza visiva che resterà in memoria per parecchio tempo. Autori: il regista Sven-Eric Bechtolf, lo scenografo Julian Crouche e il costumista Kevin Pollard.
Lo spettacolo si apre come in un sogno, nel quale i due ragazzini sono attorniati da coetanei nella periferia di una ricca metropoli abitata di vagabondi e clochard che saranno scacciati dai bimbi. Da un cartone posto sullo spoglio palcoscenico entrano nella drammaturgia della storia i due fratellini, catapultandosi nella favola. Si passa dalla povera e spoglia casa alla magica foresta, con scene che cambiamo a vista entrando lateralmente, calano dall’alto o arrivano da fondo. L’onirica foresta tutta fiori e piante è bellissima e crea una visione fantastica di forte emozione, la quale è ancora più indicativa quando appare la casa della strega, una villetta stile primo novecento, molto colorata che improvvisamente s’illumina con elettrizzanti luci. Altra scena di forte impatto è quando gli angeli, si trasformano in clochard per poi volare in cielo alla fine della pantomima. Rilevante il contributo dei video, ideati da Josua Higgason che interagiscono con lo spettacolo in maniera stupefacente e realistica. Molo belli i costumi, come ci aspetteremo da una favola raccontata dalla nonna. Funzionale e molto bella la regia curata da Bechtolf che non cerca strade troppo impegnative ma racconta solamente con garbo e grande senso teatrale. E’ immaginabile che il regista abbia attinto ai ricordi della sua infanzia per raccontare questa fiaba universale e ci è riuscito in maniera eccelsa. Di grande fascino il progetto luci ideato da Marco Filibeck.
Uno dei migliori spettacoli realizzati dal Progetto Accademia, il quale è da augurarsi non finisca in cantina, ma sia ripreso nelle prossime stagioni, anche come titolo vero e proprio della stagione poiché sarà un vero piacere rivederlo.
Non meno efficace anche la parte musicale. Merito soprattutto di Marc Albrecht, direttore di grandi doti, che racconta l’opera in maniera equilibrata e incisiva, scavando in tutte le sezioni del difficile spartito e traendo tutto quanto è possibile. Alla guida dell’ottima, anzi direi sorprendente orchestra dell’Accademia (per professionalità e uniformità), il direttore sceglie una lettura sostanzialmente romantica, sempre in equilibrio perfetto tra vivacità ritmiche e delicate sonorità più intime e poetiche. Il suono è sempre pulito e cristallino, il podio non perde mai la concentrazione e il rapporto con i cantanti. Il variegato uso e delle dinamiche, e la loro felice realizzazione, è di formidabile cromatismo, brioso nelle ballate fanciullesche, terso e aereo nei momenti fiabeschi del racconto nel bosco. Una grande lezione di stile e interpretazione, ma anche una grande conoscenza musicale che il direttore ha impresso a tutta l’orchestra, ottenendo grandi risultati in una lettura perfettamente calibrata.
Gli interpreti solisti, preparati dal soprano Eva Mei, hanno dimostrato grande professionalità e intenti più che ragguardevoli. Molto piacevole la Gretel di Sara Rossini, cantante in possesso di voce molto rifinita in ogni registro, sempre controllata nell’emissione e con una varietà d’accento rilevante. Un po’ più disomogenea Dorothea Spilger, Hansel, la cui voce dimostra ancora qualche lacuna d’intonazione e in alcuni momenti un controllo dei fiati che dovrà essere sistemato. Tuttavia, l’insieme è stato accettabile e per entrambe l’interpretazione era eccellente.
Paolo Ingrasciotta, Pietro, è un padre nobile nell’accento, che nell’aria d’entrata dimostra un’ottima vocalità sempre controllata e di felice emissione. Molto raffinato nel fraseggio, che denota una tecnica di livello, esprime sempre un variegato colore e mette a disposizione un’arte attoriale rifinita per un personaggio mai sopra le righe ma di grande espressione teatrale e umana.
Era la prima volta che ascoltavo il ruolo della Strega interpretato da un tenore e non posso negare che avevo qualche curiosità e perplessità. Immediatamente fugate dall’esibizione di Oreste Cosimo, un cantante molto musicale e stilizzato, peculiarità alle quali va aggiunta una divertente e disinvolta interpretazione en-travesti.
Efficace Ewa Tracz, Gertrud, una mamma molto caratterizzata nell’indaffarato personaggio e adeguatamente amministrata vocalmente.
Molto brave Enkeleda Kamani, Nano sabbiolino, e Céline Mellon, Omino rugiadoso, che con voce bella e stilizzata interpretano i rispettivi ruoli in maniera giustamente fantasiosa.
Infine, non secondaria la prova del Coro di Voci Bianche dell’Accademia della Scala, istruito da Marco De Gaspari, che ha assolto il compito con assoluta professionalità e partecipazione.
Successo pieno e convinto al termine per tutta la compagnia da parte di un teatro quasi esaurito in ogni ordine di posto. Un successo meritato e l’occasione per ascoltare un’opera che meriterebbe più diffusione nei cartelloni dei teatri italiani.
TAMERLANO [Lukas Franceschini] Milano, 27 settembre 2017.
Alla Scala torna in scena il repertorio barocco. Con piacere si riscoprono capolavori dell’opera sei-settecentesca che mancano da decenni nella sala del Piermanirini, o addirittura non sono mai stati rappresentati. È il caso di Tamerlano di Georg Friedrich Händel, proposto in coda alla stagione 2017-2018.
Opera seria in tre atti fu composta per la compagnia teatrale Royal Academy of Music di Londra, libretto in italiano di Nicola Francesco Haym, tratto da Il Tamerlano di Agostino Piovene insieme ad un altro libretto intitolato Bajazet sulla falsariga del Tamerlan, ou La Mort de Bajazet di Nicolas Pradon. Trattasi di una delle opere più importanti di Händel, il quale la scrisse nel brevissimo arco di venti giorni nel luglio del 1724, il compositore nello stesso anno creò anche capolavori come Giulio Cesare e Rodelinda. Il ruolo di Bajazet, che a dispetto del titolo è il vero protagonista, fu uno dei più grandi ruoli per tenore in tutta l’opera lirica settecentesca, anzi fu il primo grande ruolo per un tenore in un’opera e Händel ebbe un intuito assoluto nel delineare il personaggio. L’opera è contrassegnata da un tono fosco e notevolmente tragico, culmina con il suicidio finale di Bajzet e anche il coro rappacificatore finale non cambia l’accento generale dello spartito.
Nella drammaturgia di Tamerlano è peculiare la capacità di sviluppare lo scavo psicologico dei personaggi, sia per il peso politico che rappresentano sia, con maggiore incisività, per i legami affettivi fra loro. Tamerlano fu un imperatore tartaro che nel ‘400 sconfisse il sultano ottomano Bajazet, che tiene prigioniero nel suo palazzo. Il tartaro che avrebbe dovuto sposare Irene, s’innamora di Asteria, figlia del prigioniero, la quale era già promessa sposa del principe Andronico. Dopo congiure fallite per eliminare Tamerlano, sarà il sacrificio di Bajazet a riportare una temporanea pace, con la rinuncia di Tamerlano alla figlia di questi, che potrà sposare l’amato, il ricongiungimento di Irene con il re Tartaro e una sorta di finale che almeno nell’immediato si presenta lieto.
Molto bello e particolare lo spettacolo creato da Davide Livermore (debuttante alla Scala), autore anche delle scene in tandem con Giò Forma, con i costumi di Marianna Fracasso, le luci di Antonio Castro e i video di Videomakers D-Wok.
Doveroso fare una precisazione, prendendo spunto dalle note di regia e focalizzando i temi e gli sviluppi che hanno ispirato il regista. Giustamente egli afferma che le vicende di re, imperatori, che sono citati nelle opere, soprattutto quelle del periodo barocco, hanno avuto un trattamento drammaturgico che quasi nulla aveva a che fare con precisi fondamenti storici. Si usavano le loro vicende umane, vere o raccontate dalla tradizione, per creare teatro. In effetti, anche Händel e il pubblico del King’s Theatre non avevano per nulla interesse delle cronache del conflitto tartaro-ottomano. A loro interessava l’animo umano svelato e messo in scena, il pianto e il riso, e per tale intento si creavano spostamenti temporali, artifici drammaturgici, e “meravigliosa” finzione. Non possiamo che essere d’accordo, aggiungendo che al pubblico londinese interessavano soprattutto le prodezze vocali di Francesco Borosini (primo Bjazet), i castrati Andrea Pacini (Tamerlano) e Francesco Bernardi detto il Senesino (Andronico), il soprano Francesca Cuzzoni (Asteria) e il contralto Anna Vincenza Dotti (Irene).
Pertanto l’allestimento di Tamerlano che abbiamo visto alla Scala non era ambientato nel ‘400 bensì ai tempi della Rivoluzione Russa del 1917, e questo spostamento storico è un modo tipico dell’opera settecentesca, muovendo l’azione si muove l’anima degli interpreti. A perorare l’idea di Livermore dobbiamo considerare che nell’opera vi son tre dittatori con specificità diverse. Bajazet è un monarca che perde il potere prima che si alzi il sipario ed è accomunabile all’imprigionato Zar Nicola II dopo la rivoluzione. Andronico è un idealista, amato e riamato dalla figlia del suo sconfitto, e lui stesso è sempre in collisione con i propri sentimenti, lo potremo accostare a Lenin (o forse anche a Trotskij). Tamerlano è classico dittatore spietato, talvolta violento e demenziale, ovvio che la figura di riferimento sia Stalin. Leone, personaggio minore, ha le sembianze di Rasputin. Livermore è anche un cinefilo e seguendo questa chiave di lettura non poteva che non ispirarsi a Sergej Ejzenstein, il maestro russo che ha raccontato quel periodo della storia russa con maggior incisività attraverso l’arte cinematografica.
È indubbio che una tale lettura potrà far storcere il naso ai “puristi”, i quali avrebbero preferito una regia più tradizionale. Invece abbiamo assistito a uno spettacolo molto affascinante, di grande effetto teatrale e perfettamente pertinente con la drammaturgia raccontata.
Saranno i sentimenti, fulcro dell’opera haendeliana, il comune denominatore della lettura di Livermore che li accenta con sviluppi magnifici incastrando coerentemente tutti gli innesti emozionali che essa contiene. La scena è bellissima e sontuosa, nel caso del primo atto impressionante, come quel treno transiberiano che fermo sul palcoscenico, adombrato da nebbia, ci ricorda non solo altri film più recenti ma l’enfasi storica di quel periodo. E poi il grande palazzo con maestosa scalinata nel secondo atto, devastato dalla rivoluzione, che ricorda la reggia d’Inverno degli zar. Non meno efficaci i costumi, bellissimi quelli femminili con stole di pelliccia e grande taglio sartoriale; più convenzionali quelli maschili, divise d’epoca ma adeguatamente stilizzate storicamente. Infine, ma non per ultimo, il disegno video, che crea un effetto estetico, non di contorno ma di rilevante impatto, nell’immaginario collettivo di quella Russia d’inizio secolo. In tale visione così ben realizzata è impressionante, anzi sussiste per ciò, il lavoro del regista poiché la caratterizzazione, la traccia caratteriale e lo sviluppo della drammaturgia sulle vicende intime dei protagonisti è di alto teatro d‘espressione e recitazione.
Dopo l’ottima prova nella scorsa stagione, il podio era di ben diritto per Diego Fasolis, e bene ha fatto la Scala a riconfermalo. A capo di un complesso composto dall’Orchestra del Teatro alla Scala su strumenti storici e “I Barocchisti” della Radiotelevisione Svizzera Italiana, l’esecuzione si distingue per accuratezza d’equilibrio, rigorosamente filologico, suono quasi immacolato. Il direttore segue una prassi esecutiva moderna ma di ampio respiro e straordinaria drammaticità, con sapiente resa teatrale e stile rappresentativo.
Nel cast i trionfatori sono i due controtenori Bejun Mehta, Tamerlano, e Franco Fagioli, Andronico. Cantanti con caratteristiche vocali dissimili, i quali esaltano per bravura tecnica, stile e precisione. Mehta si cimenta in ruolo molto virtuosistico non mancando il bersaglio, con fulgida voce e timbro seducente cui si somma una personalità teatrale davvero emozionante. Fagioli, cui è riservata la parte composta per il Senesino, sbaraglia tutte le insidie dello spartito con una tecnica sbalorditiva, piegando una voce, anche per lui molto seducente, sia in momenti di grande seduzione e stampo melanconico, sia nel canto d’agilità, nel quale sfodera trilli mirabili, passa dall’acuto al grave con facilità, facendoci capire il suo vero talento che non conosce insidie in questo difficile ruolo.
Maria Grazia Schiavo è stata un’Asteria molto delicata, la quale trova un terreno fertile nelle grandi arie elegiache, con un gusto molto pertinente attraverso una voce bella e sfavillante, anche se il registro acuto spesso era limitato o leggermente forzato.
Marianne Crebassa, disegna un’Irene di alto spessore drammatico-teatrale. La voce, più di soprano che mezzosoprano, si adatta a un fraseggio eloquente con appropriate sfumature.
Christian Senn, Leone, è vocalmente spigliato, vigoroso e musicale, pur non possedendo un registro grave appropriato al ruolo.
Infine, ma non per ultimo Placido Domingo che interpretava Bajazet. Molti hanno rilevato che il cantante ritorna ora al registro di tenore, aspetto ridicolo poiché non l’ha mai abbandonato, egli ha cantato con la sua voce tenorile ruoli scritti per baritono, ma non è mai stato o è un baritono. Si resta impressionati per la grande volontà e la misura di professionalità espressa dal cantante nel cimentarsi in ruolo che neppure durante la primavera della sua carriera sarebbe stato del tutto appropriato alle sue corde. Considerata anche l’età, non si può che rimanere ammirati da tanta energia e ricerca di stile. I risultati però sono limitati. Impensabile che la sua voce, che oggi denota un naturale deterioramento, possa piegarsi alle esigenze del canto barocco, il recitativo pur essendo molto ben scandito è sovente monotono e scarso di colore. Nella prima parte dell’opera trova anche accenti pertinenti, ma risulta sempre un po’in affanno e la pesantezza del ruolo si fa sentire. Arrivato al terzo atto, riesce con strabiliante teatralità a interpretare con tragicità molto espressiva la scena della morte con ferma voce (anzi mai oscillante in tutta l’opera) ed emotivamente teatrale. E qui il Domingo sfodera le frecce che ancora può permettersi, il carisma dell’artista. Ciò che non può invece permettersi nell’aria di forza precedente dove cade clamorosamente.
Nel corso dell’esecuzione, peraltro di grande pregio e stile, due sono stati i momenti memorabili: l’esecuzione dei duetti “Vivo in te” (Asteria-Andronico) e “Coronata di gigli e di rose” (Tamerlano-Andronico), un chiaro esempio di trionfo di belcanto.
Teatro quasi esaurito, cosa in parte eccezionale per un’opera barocca, ma il genere da qualche tempo è sempre più apprezzato anche in Italia. Applausi convinti a ogni aria, i quali si sono trasformati in ovazione al termine per tutti gli interpreti.
ETTORE MAJORANA. CRONACA DI INFINITE SCOMPARSE [Marco Benetti] Como, 28 settembre 2017.
La musica d’oggi inaugura la Stagione 2017-2018 del Teatro Sociale di Como con Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse, opera nata dalla collaborazione del compositore Roberto Vetrano, del regista (e librettista) Stefano Simone Pintor e dello scenografo Gregorio Zurla, vincitrice del concorso OperaOggi indetto da OperaLombardia, in coproduzione con il Theater Magdeburg e il Palau de les Arts di Valencia e in collaborazione con Casa Ricordi.
Il soggetto dell’opera non è un lavoro biografico sul fisico teorico italiano Ettore Majorana. Essa vuole riassumente, nel susseguirsi delle scene di un atto unico, le differenti ipotesi legate alla sua misteriosa scomparsa, avvenuta la notte tra il 26 e il 27 aprile del 1930, su un traghetto diretto da Palermo a Napoli. “La fine è un nuovo inizio… la vita è circolare”: queste parole, pronunciate da Majorana alla fine della prima scena (chiamata nel libretto Ipotesi), irradiano innanzitutto lo svolgimento della drammaturgia e della musica, facendo entrare lo spettatore in loop che vede ripetersi scene con il medesimo inizio ma una diversa conclusione, esponendo le differenti versioni risolutive, seppur apparenti, del Caso Majorana. E così assistiamo alla presunta fuga in sud america (variabile a “Il fu Ettore Majorana), alla decisione di vivere come un barbone (variabile b “Uomini e cani”) e all’ipotesi del rapimento politico (variabile c “Della stessa sostanza degli atomi”).
Si spezza a questo punto parzialmente il blocco delle scene a loop, per sviluppare una narratività più sfuggente, ma nella quale la musica ripropone materiali già sentiti: il corpo del fisico che tenta di suicidarsi scompare in un buco nero (variabile d “E l’abisso si allargò”), la madre di Ettore ne piange la scomparsa mentre il fratello lo ricerca nei conventi (variabile e “Teorema di incompletezza di Majorana”), Majorana che lavora all’equazione a infinite componenti (variabile f “Funzione d’onda dell’essere o non essere”), che la espone (n variabili “L’equazione a infinite componenti”) e la dimostra dialogando con Dio e la Fisica (Dimostrazione “Dialogo con i due massimi sistemi del mondo”). E il gioco di circolarità del tempo ci conduce all’ultima scena (Postulato) in cui veniamo riportati all’inizio della storia di Majorana: alla radio, il 5 agosto 1906, viene data la notizia che a Palermo è nato il piccolo Ettore, mentre la madre in scena gli canta, cullandolo in braccio, una ninna nanna siciliana.
La musica di Roberto Vetrano scorre, adattandosi al multiforme libretto di Stefano Simone Pintor senza intoppi, presentando materiali eterogenei che trovano nella costruzione del timbro il loro punto in comune. L’incipit dell’opera, un velo di frequenze acute modellato dagli armonici degli archi, dai tubi corrugati e dall’elettronica, fa da refrain alle varie scene accompagnando l’ascoltatore tra il chiassoso (ma dettagliatamente scritto) momento degli imbarchi, il neoromantico spettacolo della cantante o la polifonia nei cori di monaci, etc …
“La fine è un nuovo inizio… la vita è circolare”: se come abbiamo già detto testo e musica rispondono a questo motto, anche le scene di Gregorio Zurla vengono pervase dall’idea di circolarità. Non solo perché il palco straborda nella platea attraverso una passerella di legno che ricorda quella del Viaggio a Reims ronconiano, ma anche perché le proiezioni video dello Studio Antimateria riempiono tutte le pareti del Teatro Sociale di cieli stellati, elementi geometrici ed equazioni.
Nell’ensemble vocale spicca sicuramente quella di Lucas Moreira Cardoso, alias Ettore Majorana, che affronta senza problemi la complessa parte del protagonista. Altrettanto da notare Federica Livi, nella molteplice veste di una Studentessa, della Matriarca e della Fisica, e Pietro Toscano, che interpreta il Comandante, il Fisico, il Fratello e l’Antimajorana.
Buono il saggio dell’Orchestra I Pomeriggi musicali, diretta da Jacopo Rivani: la complessa concertazione, anche in relazione al dialogo con l’elettronica, viene ben condotta da Rivani che ne fa risaltare compiutamente i piccoli dettagli.
Come sempre un particolare elogio al Coro OperaLombardia, dieretto da Diego Maccagnola, che interpreta questa impegnativa partitura con una passione non indifferente.
ECCESSIVO È IL DOLOR QUAND’EGLI È MUTO – CEFALO E PROCRI [Lukas Franceschini] Venezia, 29 settembre 2017.
Il teatro La Fenice si conferma ancora una volta molto attento alla musica del ‘900e contemporanea. Infatti, al Teatro Malibran è stata rappresentata Cefalo e Procri di Ernst Krenek, opera composta per il Teatro Goldoni di Venezia nel 1934, assieme a Eccessivo è il dolor quand’egli è muto di Silvia Colasanti, un brano lirico-sinfonico, commissione della Fenice, su testo di Giovanni Francesco Busenello tratto da “Gli amori d’apollo e di Dafne” di Francesco Cavalli.
Colasanti ha affrontato la vicenda di Ovidio favorendo l’originale aspetto tragico, in esso s’incontrano gelosie insinuate da terze figure che sviluppano tradimenti che altrimenti non si sarebbero consumati, per culminare nella tragica morte di Procri. È imperante il sentimento angoscioso e drammatico. Il testo è uguale all’originale e anche la linea vocale è rimasta pressoché identica, con delle aggiunte che potremo definire preludio e finale orchestrale che si rifanno a una composizione moderna. Convince pienamente l’intreccio tra antico e moderno per la trasformazione armonica che l’autrice utilizza, e l’idea positiva di non interferire drasticamente sulla linea di canto contribuisce a rafforzare la drammaturgia cui si affianca un raffinato utilizzo della narrazione, qui predominante più che mai.
Ernst Krenek nacque a Vienna nel 1900, città ove compì i suoi studi prima di trasferirsi a Berlino, diventando allievo di Franz Schreker. In Germania lavorò spesso come direttore d’orchestra nei teatri d’opera, nel 1922 conobbe Alma e Anna Mahler, moglie vedova e figlia di Gustav, che gli richiesero di completare la Decima Sinfonia del maestro. Egli accettò, lavorando sul primo e sul terzo movimento, e nel 1924 sposò Anna, da cui si separò nemmeno un anno dopo le nozze. L’opera compositiva di Krenek fu messa al bando dal Partito Nazista come esempio di arte degenerata, di conseguenza nel 1938 egli partì per gli Stati Uniti, dove divenne cittadino americano nel 1945 e insegnò in diverse università, principalmente la Hamline University nel Minnesota. Morì a Palm Springs 1991.
Krenek utilizzò nel corso della sua carriera diversi stili compositivi; partì dal tardo-romanticismo in cui forte si sente l’influenza del maestro, Franz Schreker. In seguito, si cimentò con l’atonalità ma durante un soggiorno a Parigi conobbe Igor Stravinskij e Les Six, che lo portarono verso il neoclassicismo. La sua celebre opera, composta nel 1926, Johnny spielt auf, successo duraturo in tutta Europa, evidenzia il suo interesse per il jazz. Un nuovo peculiare ritorno al neoromanticismo è presente nel ciclo di lied “Reisebuch aus den österreichischen Alpen” (Diario delle Alpi Austriache), per poi passare alla tecnica dodecafonica, uno stile che ha caratterizzato la seconda parte della parabola compositiva, un esempio è identificabile nell’opera Karl V (1931-33). Inoltre, fu autore anche di musica elettronica e aleatoria.
Cefalo e Proci fu composta su libretto di Rinaldo Küfferle, contiene una “moralità pseudo-classica” condensando tutta la forza di un dramma della gelosia e dell’incomprensione tra i due amanti narrati da Ovidio né “Le Metamorfosi”. La musica di Krenek si rifà al suo periodo storico di composizione e contiene atonalità, alcuni riferimenti neoclassici, spunti wagneriani e tipici stili dell’opera italiana (lo stesso libretto è in lingua italiana). Dopo l’ascolto non c’è euforia come non vi fu neppure alla prima assoluta, la quale fu notevolmente stroncata dalla critica.
Valentino Villa firma, in quest’occasione la sua prima regia d’opera. Il regista ha affermato: “In Krenek la morte di Procri a opera di Cefalo è stata cancellata. Procri sopravvive grazie all’intervento della dea Diana. Al contrario Eccessivo è il dolor di Colasanti si nutre di questa morte il cui lascito è, nella mia visione, tristemente raccontato in Ciò che resta”. Abbiamo quindi una doppia immagine del mito e di conseguenza una doppia immagine di Procri.
Questa linea drammaturgica ha portato Villa a privare la vicenda di Cefalo e Procri dell’aurea mitologica, gli dei sono umani. L’Olimpo è una comoda dimora nella quale gli dei rivaleggiano tra loro e i protagonisti si muovono in una sorta di divertissement, che racchiude un frammento del mondo classico. È magistrale il lavoro di “collage” dei due spartiti, attraverso una funzionale narrazione drammaturgica. I quadri visivi, che si rifanno agli storici già riferiti divertissement, la visione umana dei personaggi, cui si aggiungono, come in difformità, i paesaggi alpestri che creano una forte emozione in una lettura molto originale e pertinente. La scenografia di Massimo Checchetto aiuta in modo efficace questo intento, i costumi di Carlos Tieppo sono molto belli e molto azzeccato è il disegno luci di Vilmo Furian.
Sul podio c’era Tito Ceccherini, un direttore che è un indiscusso riferimento in questo repertorio. Egli è capace di districarsi con assoluta brillantezza tra lo stile di Krenek e quella della Colasanti, assai differenti tra loro. Se del compositore austriaco coglie appieno ogni tipica sfaccettatura, soprattutto dodecafonica e il ritmo, dell’italiana focalizza una lettura di grande respiro con ricercate armonie e uno sviluppo narrativo-sinfonico di ottima fattura.
Silvia Frigato, Procri in entrambi i lavori, è molto valida come interprete nella scrittura barocca della Colasanti, dove sfodera fraseggio e colori davvero ragguardevoli. Altrettanto valida nell’opera di Krenek, nella quale tuttavia non ha modo di esprimere altrettanto talento causa la scrittura stessa dello spartito.
Leonardo Cortellazzi, Cefalo, è artista poliedrico capace di districarsi con molta bravura in un repertorio vastissimo. E anche in quest’occasione “moderna” abbiamo apprezzato vocalità, stile e precisione davvero ragguardevoli.
Professionali le prove di Cristina Baggio, Aurora, e Francesca Ascioti, Diana, e un cammeo illustrissimo è stato quello di William Corrò nel ruolo di Crono.
Teatro che registrava purtroppo parecchi vuoti, ma in parte era prevedibile, successo convinto a termine per tutta la compagnia, staff tecnico e per la compositrice Silvia Colasanti, presente in sala.
FALSTAFF [Lukas Franceschini] Parma, 5 ottobre 2017.
Falstaff è un capolavoro assoluto e a sé stante nel teatro d’opera italiano agli sgoccioli del XIX secolo. Ancor più sorprendente è che un simile spartito sia uscito dall’inventiva musicale di un grande compositore ottantenne, ancora capace di produrre un lavoro così complesso e originale. L’opera tuttavia pur non raggiungendo i favori e forse i vertici di altri melodrammi verdiani resta un punto di riferimento nel teatro lirico. Le ragioni del mancato riscontro di massa sono riassumibili in pochi concetti. Falstaff richiede una preparazione molto accurata di squadra e tranne il protagonista non ha parti così rilevanti per gli altri personaggi. Il linguaggio musicale è frazionato in numerosi e continui stimoli acustici, sia dall’orchestra sia dai pezzi d’insieme e anche dall’intrecciato chiacchiericcio degli interventi solistici. Il libretto, un gioiello di Arrigo Boito, è farcito di espressioni auliche, sottintesi, allusioni, che è sviluppato e offerto attraverso la bellezza dei recitativi verdiani, con ovvia conseguenza di umorismo e commozione, che culmina nella fuga finale, una morale della commedia.
La produzione di Falstaff a Parma è stata creata da Jacopo Spirei, coadiuvato da Nikolaus Webern per le scene e la Silvia Aymonino quale scenografa. Trattasi di un bellissimo spettacolo di ambientazione moderna con qualche tocco di vintage. Tutta l’opera è contraddistinta da una vivida regia, elegante, ironica, talvolta surreale, di ottimo effetto teatrale e aderente al libretto. Il pregio di Spirei è di raccontare con molta fantasia e garbo senza mai eccedere, anzi ha creato un perfetto equilibrio che va apprezzato e diverte moltissimo. Oltre alla camera del protagonista, ove campeggia il ritratto della regina, abbiamo una visione onirica di un classico paese di campagna inglese, ovviamente Windsor, tutta colorata e ben ordinata ma gli edifici sono sbilenchi, ottima idea per rilevare che si tratta di un racconto di fantasia, quasi una favola. Infatti, la vicenda del panciuto Sir John con le sue avventure galanti non è altro che una commedia allegra, anche se contiene una morale non predominante ma leggiadra, che in parte ognuno può vedere a modo proprio. Ben caratterizzati i personaggi, lo sbruffone ma simpatico protagonista, le quattro comari a cominciare da Mrs. Quickly, con un ton rockettaro, dalle più sofisticate Mrs. Alice e Mrs. Meg, ancora piacenti donne di mezza età, ma con look notevolmente giovanili e con vestitini succinti della domenica. Simpatico il giovane Fenton, in gonnellino di pelle scozzese, più sobri Ford e Cajus in giacca e cravatta attorniati da un coro in bombetta e impermeabile in perfetto stile inglese, anche se ormai sorpassato, ma di facile richiamo nella memoria collettiva. Molto efficace il disegno luci di Fiammetta Baldiserri. Gran bello spettacolo, spassoso che raccoglie un consenso unanime.
Doveroso rilevare che il cast nel suo complesso ha dimostrato un’omogeneità molto apprezzabile e un contributo sia vocale sia teatrale di ottima fattura.
Trionfa nel ruolo del protagonista il baritono Roberto De Candia, il quale forse debuttava il ruolo ma comunque non ha molte recite all’attivo di Falstaff, ma sarà un personaggio che negli anni a venire “dovrà” affrontare spesso. Il physique du role è perfetto e le arti di creare un personaggio credibile sono insite nella personalità del cantante. Inoltre, la tecnica vocale gli permette di sfoggiare un fraseggio d’eccellenza, è capace di trovare colori e sfumature meravigliose, sia patetiche sia brillanti. Un Falstaff ben costruito e delineato in tutte le peculiarità del ruolo.
Altrettanto valido il Ford di Giorgio Caoduro, un cantante che meriterebbe di frequentare con maggior frequenza i palcoscenici italiani. Anche nel suo caso siamo di fronte ad un grande artista che sfodera tutte le sue non comuni frecce interpretative, abbinate a una voce robusta ma valida nell’accento, nell’espressione e con una linea di canto possente e rifinita.
Ben assortito anche il quartetto delle comari nel quale si distinguevano la brillante ed elegante Alice di Amarilli Nizza, precisa in ogni intervento, l’irruente Quickly di Sonia Prina, molto stilizzata vocalmente e spassosa in scena, cui mancava quel tratto vero e proprio della comare dovuto probabilmente dal repertorio solitamente affrontato. Gustosissima e di estrema eleganza la Meg di Jurgita Adamonyte, molto efficace in un canto preciso e raffinato.
Bravissima Damiana Mizzi, Nannetta, la quale pur facendosi annunciare indisposta non ha dato segno di particolari carenze, anzi la sua prova è stata davvero ragguardevole per pulizia e morbidezza. Al suo fianco l’innamorato Fenton, Juan Francisco Gatell, era un personaggio simpatico e molto efficace che trovava un meritato plauso nell’aria del terzo atto, realizzata con molta ispirazione.
I due servitori di Falstaff, Bardolfo e Pistola erano perfettamente caratterizzati rispettivamente da Andrea Giovannini e Federico Benetti, due eclettici cantanti ben assortiti nei ruoli e nella prova musicale.
Infine, ma non per ultimo, l’eccellente Gregory Bonfatti, che donava al personaggio del Dottor Cajus un accento e una resa scenica da manuale.
L’orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” in ottima forma, era diretta con mano sicura da Riccardo Frizza, che ha saputo regalarci una lettura pertinente, mantenendo un buon equilibrio sia con il palcoscenico sia con le diverse sonorità dello spartito. Ragguardevole la scelta dei tempi, ora brillanti e spumeggianti, ora più delicati e aerei. Molto buona la prova del coro del Teatro Regio, istruito da MarTino Faggiani.
Al termine successo trionfale per tutta la compagnia, e aggiungo ben meritato.
FALSTAFF [William Fratti] Parma, 5 ottobre 2017.
L’ultima opera del Cigno di Busseto torna sul palcoscenico del Teatro Regio di Parma con uno spettacolo firmato da Jacopo Spirei – collaboratore di lunga data di Graham Vick – che mantiene sempre una certa attenzione alla parola, con una sana leggerezza che aiuta a percepire i veri messaggi reconditi di questo capolavoro.
L’azione è giustamente trasposta in tempi contemporanei, così da permettere al pubblico di rivedersi e riconoscersi in scena; resta sempre punzecchiante, mai banale, mai ridicola, sempre divertente nella misura dettata dalla compostezza, trascurata solo dal protagonista e dai suoi servitori. Ottimi i costumi di Silvia Aymonino – interessante la scelta dell’animalier – ed efficaci le luci di Fiammetta Baldiserri. Invece le scene di Nikolaus Webern sono un’occasione persa. Validissima la piccola stanza d’osteria costruita quasi in proscenio, che agevola i cambi che si possono fare sul retro; elegantemente squisita la piazza di Windsor che prende il posto del giardino di Ford. Meno intrigante, ma accettabile, la casa di Alice che si apre sulla piazza. Assolutamente mediocre la scena finale, con piccole aiuole vistosamente finte, la casa dei Ford ancora aperta, la quercia idealizzata in un disegno luci sul lampadario della sala.
Ottima la lettura musicale di Riccardo Frizza sul podio di una Filarmonica Arturo Toscanini finalmente compatta e omogenea. Frizza guida con mano salda la matematica millimetrica di questa immensa partitura senza mai lasciare nulla al caso e il risultato lo si percepisce in crescendo fino all’apoteosi finale, quando dirige una fuga così precisa da potersi sentire ogni singola parte e ogni singola parola.
Roberto De Candia dimostra di avere fatto suo questo ruolo, pur con la certezza che crescerà ulteriormente nel corso degli anni. Il suono è ampio, corposo e luminoso al tempo stesso, perfetto per la parte, con una certa musicalità e precisione che gli derivano dal repertorio mozartiano e rossiniano. Il personaggio è centratissimo, intriso di bon ton britannico, irriverente ma garbato, insolente ma composto.
Amarilli Nizza debutta nella parte di Alice – ennesimo ruolo verdiano del suo catalogo – e finalmente la riconduce nell’ambito delle vocalità piene e robuste. Alice non possiede pezzi solistici o duetti, se non qualche frase in terzo atto, ma è l’artefice di tutta la commedia, pertanto il peso del suo canto deve rappresentare ciò che compie in scena. Nizza, in questo senso, interpreta una “Signora” Alice sotto ogni punto di vista, facendosi sempre sentire dalle note più basse, saldamente ancorate, fino agli acuti.
Giorgio Caoduro è un Ford brillante, dotato di smalto e ampiezza nella voce, rigore e compostezza nell’interpretazione scenica.
Damiana Mizzi è annunciata indisposta – la Signora Meo potrebbe adottare il cortese modello Pereira effettuando direttamente le comunicazioni in palcoscenico – ma la sua performance non sembra particolarmente menomata. Anzi si presenta lucente e in grado di affrontare i filati con un buon uso del fiato, anche se il legato è da migliorare.
Juan Francisco Gatell è un buon Fenton, innamorato, gentile, romantico, elegante e raffinato anche nel canto elegiaco che contraddistingue questo personaggio.
Sonia Prina interpreta una Quickly squisita, anche se nella vocalità si riscontra uno stile non propriamente morbido e fluido che appare un poco strano, presumibilmente derivante dal suo repertorio d’elezione. Ma ciò non è un grande problema, poiché le note ci sono e il personaggio è davvero accattivante.
Meg è la brava Jurgita Adamonyte, Cajus l’efficacie Gregory Bonfatti, Bardolfo l’istrione Andrea Giovannini, Pistola il valido e ben preparato Federico Benetti. Buona la prova del Coro del Teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani.
STIFFELIO [Lukas Franceschini] Parma, 6 ottobre 2017.
Strepitoso allestimento di Stiffelio al Verdi Festival ideato da Graham Vick nell’insolita cornice del Teatro Farnese, insito nel complesso della Pilotta.
Il secondo titolo del Festival è da sempre considerata opera minore del compositore di Busseto, anche se negli ultimi anni vanta una discreta riproposta a livello internazionale.
Stiffelio è un’opera lirica in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, rappresentata in prima assoluta il 16 novembre 1850 al Teatro Grande di Trieste. Il soggetto è basato sulla commedia francese di Émile Souvestre ed Eugène Bourgeois, Le Pasteur, ou L’Évangile et le Foyer del 1848.
L’opera affronta il tema, per l’epoca assai spinoso, dell’adulterio, per di più ai danni di un pastore protestante, e termina con un singolare lieto fine. Lo scarso successo e le modifiche a cui le censure locali sottoponevano l’opera (nel 1851 l’opera fu rappresentata a Firenze con il titolo Guglielmo Wellingrode e il protagonista trasformato in un primo ministro tedesco) indussero Verdi a modificare radicalmente l’opera, aggiungendo il quarto atto e retrodatando l’azione al medioevo.
Oggigiorno Stiffelio è considerata un punto di svolta nella lunga traiettoria artistica di Verdi. Tanto l’ambientazione quasi contemporanea quanto il rapporto complesso e doloroso tra la protagonista femminile e l’autorità paterna preannunciano soggetti futuri. Inoltre, la lucida e asciutta essenzialità del disegno drammaturgico e della sua delineazione musicale, intensa ma povera di sottolineature patetiche, potrebbe essere considerata scarsa di melodrammaticità. Lo scarso successo probabilmente è da attribuire a due elementi principali: il difficile soggetto, sovente non del tutto compreso, e la clamorosa affermazione dell’opera successiva il ben più osannato e conosciuto Rigoletto. Tuttavia, Verdi scriveva a Cesare De Sanctis: “Fra le mie opere che non girano, alcune le abbandono perché i soggetti sono sbagliati, ma ve ne sono due che vorrei non dimenticare, sono Stiffelio e La battaglia di Legnano”. La lettera proseguiva informando il mittente che aveva già scritto a Piave in merito ad un rifacimento dell’opera, che sarà Aroldo andato in scena a Rimini nel 1857.
Si parlava già da qualche tempo di questo nuovo spettacolo di Graham Vick denominato lo “Stiffelio in piedi”, poiché la realizzazione nello storico Teatro Farnese non avrebbe previsto nessuna sedia per il pubblico. Lo stesso sarebbe stato partecipe dello spettacolo, con un cartellino con codice a barre da indossare a collare, libero di muoversi e seguire le vicende dell’opera, che si svolgeva su dei praticabili mobili. Mai si sarebbe potuto pensare che la genialità del regista ci avrebbe inserito in una drammaturgia così moderna e credibile prendendo spunto da un simile soggetto. Si salgono le scale del palazzo e tutto il pubblico aspetta l’apertura delle porte del Farnese, questo avviene appena l’orchestra inizia la sinfonia. Immediatamente ci troviamo di fronte le tanto “assurde” sentinelle in piedi, che in questi anni hanno folklorizzato le piazze italiane. Sono gli adepti di della setta pseudo-religiosa cui fa capo il protagonista, Stiffelio, un pastore assasveriano. Le comparse, talune in abito ecclesiastico, ci salutano e ci danno il benvenuto. Già quest’impatto è raggelante e impressionante. I cantanti sono già disposti sui loro palchi mobili, la musica di Verdi c’invade e inizia la storia, una vicenda cui noi pubblico siamo non spettatori, ma partecipi, quasi coprotagonisti, ascoltiamo, vediamo, scrutiamo anche nelle stanze più intime. È una chiara e ferma condanna all’integralismo religioso, il quale vuole e pretende una facciata mentre nelle zone d’ombra si annidano i tentacoli della vita. Ecco dunque la giovane sposa, trascurata (anche fisicamente) da un marito più dedito alle sue prediche, conferenze religiose televisive e presentazione dei libri (con tanto di autografi), cede alle lusinghe del bel giovane di turno. La lettura di Vick non vuole fare la morale ma scolpisce solo fatti di cronaca che sono conosciuti e riportati dai media. Assistiamo a una sorta di fiction-reality, dove si riscontrano le usuali debolezze umane. Non è vincolante il perdono finale del marito all’adultera, quando lui stesso è colpevole, ma impressionano il coro e i figuranti che attorniano il loro mentore, predicando temi come “la vera famiglia” tra uomo e donna, vituperando la teoria gender, tanto confusamente esposta. Nella setta ci sono persone che cadono in trance, altre che facendosi scudo del loro ruolo si dedicano alla lussuria, anche omosessuale, che nella scena del cimitero sarà condannata dalla violenza da altri più integerrimi. Non da meno è il ritratto che il regista fa del padre dell’adultera, uomo di antichi valori, il quale vuole e pretende che gli scandali restino in famiglia e tutto si accomodi per il bene e la salvaguardia del matrimonio e la facciata che la società deve vedere. Tuttavia, è il finale che ci lascia ancora più entusiasti, quando sulle note del perdono tutti i componenti dello spettacolo si abbracciano in una riappacificazione unitaria, tra coppie di diverso genere, attuando di colpo il senso di una società che è cambiata, anche se taluni non vogliono rendersene conto. Una lettura forte, unica, incredibilmente attuale quanto perfettamente incastonata in un libretto di un secolo e mezzo addietro, cui non è secondario l’apporto musicale della mano verdiana, il quale si adatta perfettamente. Noi spettatori siamo attoniti nel girare attorno alle scene che sviluppano in ogni angolo della platea del teatro, il coro è o sulle grandinate o al nostro fianco e siamo coinvolti come mai c’era capitato di essere in uno spettacolo che resterà indimenticabile e di difficile riproduzione. Brillantissimi e di grande fascino teatrale i movimenti coreografici di Ron Howell, bellissimi e non banali i costumi moderni di Mauro Tinti, il quale è anche scenografo e rende alla perfezione l’idea registica con una struttura snella ma di forte impatto visivo. Le luci di Giuseppe Di Iorio contribuiscono con efficacia elettrizzante a questa lettura così particolare.
L’orchestra del Teatro Comunale di Bologna (per la prima volta al Verdi Festival) è collocata nel fondo, e a una prima visione parrebbe come distaccata dai solisti. Non è così per l’ausilio di monitor e per la grande prova offerta dal direttore Guillermo Garcia Calvo che offre non solo un supporto rilevante ai solisti, ma ci regala una lettura viva, molto intensa, ricca di colori e di grande affresco drammatico. Meravigliosa la prova dell’organico strumentale, sempre calibrato e in grande serata, come altrettanto si può affermare del Coro bolognese, diretto da Andrea Faidutti, che imprime la consueta elevata professionalità.
Il cast era di altissimo livello in tutte le sue parti. Luciano Ganci, il protagonista, è tenore sicuro e dotato di voce limpida e seducente. Molto raffinato nel fraseggio e nella ricerca di variegati colori, trova un terreno particolarmente idoneo in questo Verdi così attento al verso con un’interpretazione maiuscola.
Maria Katzarava, Lina, è un soprano con grandi mezzi che utilizza in maniera molto appropriata in tutte le sfaccettature del personaggio. Da buon soprano drammatico è attenta ai segni musicali della disperazione, dell’inquietudine senza mai eccedere, attraverso un canto nitido, forte e ben calibrato nei cromatismi.
Altrettanto valido lo Stankar di Francesco Landolfi, un baritono con accento nobile, morbido nel canto che rende variegato e sfumato in tutta la parte, inoltre interpreta un personaggio ragguardevole per elegante peso drammatico.
Bravissimo il giovane Giovanni Sala, Raffaele, svettante nel registro acuto e dotato di voce molto bella e ben calibrata. Emanuele Cordaro, Jorg, è un ministro dotato di voce forte e misurata che si ritaglia uno spazio importante in un ruolo secondario. Non sono da meno il bravissimo Blagoj Nacoski, preciso e musicale Federico, e Cecilia Bernini, una freschissima e svettante Dorotea.
Spettacolo di non facile realizzazione, ma le dure prove durate quasi due mesi hanno prodotto frutti eccezionali.
Al termine successo trionfale per tutta la compagnia, e mai tale aggettivo è così appropriato.
FRA DIAVOLO [Simone Ricci] Roma, 8 ottobre 2017.
A distanza di quasi un secolo e mezzo è tornato nella Capitale il celebre lavoro di Auber, all’insegna degli anni Cinquanta e della tecnologia moderna.
Se in un celebre best-seller, diventato poi film, aveva vestito Prada, al Teatro dell’Opera di Roma si è puntato su un elegante completo degli anni Cinquanta per l’abbigliamento del Diavolo. Al Costanzi è andata in scena la prima recita di “Fra Diavolo”, l’opera del compositore francese Daniel Auber che mancava nella Capitale da ben 133 anni. L’ultimo e unico precedente di questi tre atti risaliva al 22 maggio 1884 e c’era dunque una certa curiosità nello scoprire il nuovo allestimento, curato in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo. Il libretto originale in francese e il debutto all’Opera di Roma per il direttore d’orchestra Rory Macdonald erano altri due spunti per assistere con interesse allo spettacolo.
Questa recensione si riferisce alla prima rappresentazione dell’opera, quella di domenica 8 ottobre 2017. La regia di Giorgio Barberio Corsetti, il quale ha curato le scene insieme a Massimo Troncanetti, ha fatto leva su un’ambientazione più moderna dell’opéra-comique di Auber. Gli sfondi e i costumi (curati da Francesco Esposito) facevano pensare a una località italiana di mare degli anni Cinquanta o Sessanta: era chiaro il riferimento al cinema nostrano di quel periodo, in cui la presenza dei Carabinieri era frequente (basti pensare a “Pane, amore e fantasia” di Comencini). Le scenografie, inoltre, sono state realizzate con stampanti 3D, una tecnologia moderna che ha una spiegazione ben precisa.
Sarà un caso ma la sigla 3D fa pensare all’aria più celebre di quest’opera (Voyez sur cette roche) e al nome di Fra Diavolo pronunciato tre volte (le tre D di Diavolo dunque) per incutere più timore: la locanda e gli altri ambienti sono stati realizzati appunto con queste stampanti e l’effetto ottenuto è stato deformante, visto che gli edifici hanno fatto pensare alle creazioni di Salvador Dalì. Le video-proiezioni hanno arricchito il racconto, nonostante qualche dettaglio superfluo, in particolare la mongolfiera e l’aereo che sembravano trasportare Lord Rocburg e Lady Pamela mentre si affacciavano dalle finestre della locanda.
I già citati Carabinieri non stonavano affatto in un contesto di questo tipo: a dire la verità, le marce a ritmo di musica erano forse eccessivamente buffe, ma non hanno di certo rovinato il risultato finale. Curiosa, poi, è stata la scelta di accompagnare alcuni momenti musicali con dei balletti sincopati e che il pubblico romano ha mostrato di gradire. Passando a parlare del cast vocale, non si può non cominciare con John Osborn: il tenore americano ha calzato senza problemi i panni di Fra Diavolo, mostrando grande sicurezza nei fiati e un volume cospicuo, garantendo allo stesso tempo una presenza scenica sfrontata e coinvolgente. Gli spettatori del Costanzi hanno applaudito soprattutto la grande performance di J’ai revu nos amis.
Anna Maria Sarra ha tratteggiato una interessante Zerlina per intenzioni interpretative e qualità vocali: è stata seducente al punto giusto nel secondo atto, senza mai trascurare la tecnica raffinata. Il Lorenzo di Giorgio Misseri, poi, si è caratterizzato per la voce compatta e senza squilibri, mentre è apparsa affiatata come non mai la coppia di turisti presa di mira da Fra Diavolo: Roberto De Candia ha convinto con il suo Lord Rocburg, una figura al limite dell’aristocratico e quasi impettita, senza che la sua vocalità abbia mai dato segni di cedimento, mentre Sonia Ganassi era una Lady Pamela divertente e comicamente seduttiva, oltre che sicura e spigliata, mai sopra le righe e sempre musicale.
Il cast era completato da Alessio Verna, un Matteo preciso e corretto (anche se si faceva fatica a credere che fosse il padre di Zerlina), oltre a Jean Luc Ballestra e Nicola Pamio, rispettivamente Giacomo e Beppo, degni compari di Fra Diavolo e protagonisti di una buona presenza scenica e di una discreta resa vocale. Si è parlato all’inizio del debutto al Costanzi di Rory Macdonald: il direttore scozzese ha analizzato con cura lo spartito, guidando con convinzione l’orchestra e puntando sempre a un buon rapporto con il palcoscenico. L’esecuzione del coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto come sempre da Roberto Gabbiani, è stata pregevole e appropriata.
Di sicuro bisogna dare il merito al Costanzi di aver riproposto un titolo non semplice e frequente, soprattutto a distanza di quasi un secolo e mezzo: personalmente ritengo il libretto italiano più appropriato per la resa musicale dell’opera di Auber, ma bisogna anche tenere conto della lingua originale ed è quello che ha deciso di fare l’Opera di Roma. Dopo questa prima rappresentazione, “Fra Diavolo” tornerà a spaventare e divertire il pubblico capitolino con altre cinque repliche, per la precisione il 13, 15, 17, 19 e 21 ottobre prossimi.
JÉRUSALEM [Lukas Franceschini] Parma, 12 ottobre 2017.
L’edizione critica di Jérusalem, rifacimento francese de I Lombardi alla prima crociata, a cura di Jürgen Selk, inaugura il Festival Verdi 2017. L’inaugurazione del Verdi Festival è stata con la peculiare proposta di Jérusalem, per la prima volta al Festival e in seconda edizione al Teatro Regio nel corso della sua storia.
Jérusalem è un grand-opéra in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Alphonse Royer e Gustave Vaez, da Temistocle Solera. La prima rappresentazione fu all’Opéra de Paris il 26 novembre 1847 e tra gli interpreti vi era Gilbert Luis Duprez. Dopo il successo de I Masnadieri a Londra, Verdi fu contattato dalla direzione dei teatri parigini per comporre un’opera da rappresentarsi nella capitale francese. Considerato il poco tempo a disposizione, egli non si voleva sottomettere a situazioni lavorative asfissianti, pertanto propose un adattamento alle esigenze francesi, con relativo libretto in lingua, de I Lombardi alla prima crociata, andata in scena alla Scala nel 1843. Non fu secondario anche il fattore economico, infatti, Parigi richiedeva la presenza del compositore, e l’opera fu pagata come nuova sia dal teatro sia dall’editore Ricordi. Inoltre, Parigi era una piazza molto l’importante, più di Londra, e Verdi, che vi debuttava, sperava ottenere un successo rilevante cimentandosi per la prima volta con un grand opéra, che in Francia si era imposto negli ultimi decenni.
Caso unico nella storia dei rifacimenti verdiani, la prima stesura, cioè I Lombardi, rimase pressoché in repertorio e impedì la circolazione della seconda, la quale fu riportata in teatro nella celebre edizione veneziana, in italiano, con la direzione di Gianandrea Gavazzeni nel 1963. Nonostante sia il rifacimento dei Lombardi, la trama è completamente diversa, e il dramma storico è ambientato a Tolosa e in Palestina negli anni 1095-1099.
Il festival di Parma, che da alcuni anni si svolge nel mese di ottobre, sta risalendo la china, la quale fino a poco tempo addietro lo aveva confinato a mero teatro di provincia. Fanno testo i tre allestimenti di quest’anno, tutti realizzati con l’utilizzo di una versione critica, indispensabile strumento per una rassegna monografica che vuole essere, e deve, non tanto punto di riferimento ma almeno fedele della realizzazione delle partiture di Verdi.
Hugo De Ana firma uno spettacolo molto bello, in piena linea con la sua mano creativa, spettacolare e grandioso, e aggiungo tradizionale, poiché abbiamo scampato il pericolo dell’attualizzazione, che tuttavia era abbastanza esclusa nella prassi dal regista argentino. La narrazione è fluida e lineare, l’aderenza al libretto perfetta, anche con l’ausilio di proiezioni, talvolta con elementi di difficile comprensione, ma è stato emblematico leggere, dopo un gioco di lettere che s’incastrano, la parte finale della bolla papale, “Deus vult” che esortava alle crociate per riconquistare i luoghi santi. La grande scenografia è rappresentata da citazioni di luoghi, oggi resti archeologici, d’indubbio fascino, ma anche vetrate e tempeste di sabbia. I costumi sono realizzati con arte, sorprendete la fattura e il gioco di colori. De Hana racconta un grand opéra con stile, le grandi scene di massa sono momenti di grande concitazione in palcoscenico ma controllate e di grande effetto teatrale. Manca in parte lo scavo psicologico dei singoli protagonisti, egli si limita a raccontare in maniera epica ed elegante la vicenda. Il balletto eseguito integralmente, trova nella coreografa Leda Lojodice una creatività efficace e fantasiosa, e un plauso va ai solisti, oltre per la bravura tecnica, anche per aver danzato su un palcoscenico inclinato e ricoperto di sabbia. Altamente affascinanti le luci di Sergio Vitali.
Sul podio dell’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, il bravo Daniele Callegari sostiene con vigore tutta la partitura, in un clima che non potremo mai affermare francese, poiché Verdi scrive all’italiana e adatta una partitura a un più ampio respiro e usanze d’oltralpe. Callegari conosce bene l’Ottocento musicale e la sua lettura, oltre ad essere rigorosa nel dettato, è viva nei segmenti ove è percepibile l’impeto militare, ma non manca una valida guida a pagine più intime nelle quali colpisce la scansione dei colori e l’ampio respiro orchestrale nei preludi. Inoltre, non secondario, l’efficace rapporto con il palcoscenico, del quel tiene le redini in maniera ferma e con grande resa sonora. L’orchestra “Toscanini” era in grande serata per compattezza e uniformità sonora, come altrettanto valido l’apporto dell’autorevole Coro del Teatro Regio, diretto da Martino Faggiani, che offre una prova superba.
Il miglior solista era Michele Pertusi, Roger, che coglie un successo personale in un ruolo a lui particolarmente congeniale. Oltre alla fascinosa voce, uno stile impeccabile gli permettono di realizzare un personaggio diversificato nel corso dell’opera, attraverso l’utilizzo di un incisivo fraseggio e una duttile gamma di colori vocali, i quali corrispondono con precisione ai dettami della partitura. Memorabile l’aria “O jour fata” all’inizio del II atto.
L’Hélène di Annick Massis risente ormai di una freschezza vocale non più fervida e di una voce che non si adatterebbe per spessore al ruolo. Tuttavia, non manca di professionalità e anche un certo accento, ma i mezzi sono limitati, si può apprezzare un ricercato fraseggio ma i da capo sono omessi, e non tutta la parte sembra eseguita. La vocalista e l’artista suppliscono in parte alle carenze di fondo, e se nella preghiera del primo atto è molto manierata ma povera di colori, la successiva invettiva è accomodata per quanto le è concesso.
Ben diverso il discorso per Ramon Vargas, Gaston, che vanta ancor oggi una voce bella e uniforme, un accento pertinente accomunato a un fraseggio e una dizione veramente encomiabile. Il suo tallone d’Achille resta il registro acuto, soprattutto oggi dopo oltre trent’anni di carriera, e pertanto il do nella celebre aria “Je veux encore entedre” è omesso, come tutte le altre puntature scritte. Il tipo di tenore per Jérusalem sarebbe ben diverso, e la scelta pur del valido artista è piuttosto opinabile.
Il resto del cast è notevolmente professionale, in cui il Comete do Toulose di Pablo Galvez è un fiero nobile, Valentina Boi un’Isaure puntuale, Deyan Vatchov un Adhémar possente. Completano con lode la locandina: il Raymond di Paolo Antognetti, l’Emiro di Massimiliano Cattellanii, l’Officeir di Matteo Roma e Francesco Salvadori nel doppio ruolo di araldo e soldato.
Successo molto convinto al termine, con particolari ovazioni per Michele Pertusi.
TRISTAN UND ISOLDE [Margherita Panarelli] Torino, 15 Ottobre 2017.
Il capolavoro di Richard Wagner Tristano e Isotta inaugura la nuova Stagione del Teatro Regio di Torino con la prima italiana della celebrata regia di Claus Guth, un cast di specialisti e Gianandrea Noseda sul podio.
Non è un segreto che Wagner compose Tristano e Isotta sotto l’influenza del grande trasporto provato per Mathilde Wesendonck durante il periodo che trascorse a Zurigo.
Claus Guth sceglie di ambientare la vicenda di Tristano e Isotta in una casa alto-borghese, come si immagina fosse proprio Villa Wesendonck che ne fu la cuna, trasportando la dimensione etica dell’opera all’epoca di Wagner, rendendo le vicende dei due amanti una variazione sul tema, molto in voga nella seconda metà dell’800, della consorte infelice e del fallimento del matrimonio borghese che quasi trascina al tradimento la malcapitata sposa, costretta dalle convenzioni sociali a sposare un uomo che non ama, Basti pensare alle varie Effie Briest, Madame Bovary e Anna Karenina che costellano il panorama letterario europeo dell’epoca.
Il paragone è sicuramente efficace e avvicina allo spettatore moderno una Handlung che è solo apparentemente distante dimostrando che tutti possono comprendere una donna combattuta tra un amore totalizzante e il dovere verso la famiglia, e in questo caso addirittura la propria patria, sentimento con il quale è forse meno possibile empatizzare, poiché è argomento ancora moderno e attuale.
Le scenografie di Christian Schmidt sono sontuose ed è encomiabile il rispetto delle situazioni del libretto nonostante lo spostamento della vicenda. Sono particolarmente efficaci i momenti nel giardino d’inverno interno all’immaginaria villa nella quale si svolge l’azione e la proiezione durante la seconda scena del secondo atto di ombre che suggeriscono senza dubbio la presenza di alberi e della luna. Meno riuscito l’inizio dello stesso secondo atto dove Tristano e Isotta si cercano in mezzo alla folla presente al ricevimento seguente il matrimonio senza trovarsi, chiara metafora delle convenzioni sociali ”diurne” che tengono separati i due amanti ma durante il quale si perde il pathos del ricongiungimento dei due. Poco credibile è anche il duello tra Tristano e Melot con coltelli da tavolo dalla punta palesemente smussata e l’idea di rendere Brangäne doppio di Isotta non è sviluppata a dovere, rimanendo un mero spunto.
L’intero palcoscenico è occupato da una piattaforma rotante grazie alla quale si sostituiscono velocemente i vari ambienti della villa, interni (la camera di Isotta, l’anticamera, il giardino interno, un corridoio ed il salone) ed esterni ad essa (Un muro piuttosto fatiscente a simboleggiare Kareol) ma con il progredire della trama la rotazione si velocizza sempre di più e durante il monologo di Tristano del terzo atto finisce per diventare un confuso sfoggio di bravura nonostante l’intenzione iniziale di sottolineare, a guisa di leitmotiv, le parole dell’eroe.
Il comparto musicale non delude. La direzione è affidata a Gianandrea Noseda il quale mette in risalto il versante mistico ed estatico del capolavoro Wagneriano affidandosi a tinte soffuse unite a colori quasi mediterranei, mai violenti, come un alone caldo che circonda l’intera vicenda, privilegiando cantabilità e melodia, in una lettura di grande fascino, assistito in questo egregiamente dall’Orchestra del Teatro Regio.
La prova di Peter Seiffert nel ruolo di Tristan è innegabilmente maestosa come lo è il ruolo che gli è affidato, nonostante la stanchezza si faccia sentire nel terzo atto in alcuni momenti dalla linea di canto meno sicura. Il risultato raggiunto è comunque una prova maiuscola da esperto quale è di questo personaggio.
Se nulla si può obiettare alla resa attoriale di Ricarda Merbeth, qui impegnata nel ruolo di Isolde, bisogna invece constatare come la limpidezza del suo registro acuto non corrisponda ad un registro grave corposo e pienamente utilizzato al quale l’indubbio temperamento ed il fraseggio appassionato, sopperiscono solo in parte. Di grande effetto è il suo Liebestod, degna conclusione di una prova che risulta, al netto delle difficoltà che il ruolo pone, esauriente e competente.
Giovanile e dal fraseggio posato ed elegante il Re Marke di Steven Humes cui latita un pizzico di gravitas ma che si adatta egregiamente all’allestimento di Guth.
Eccellente Martin Gantner nei panni di Kurwenal, mentre non convince appieno invece la Brangäne piuttosto routinière di Michelle Breedt il cui fraseggio manca di mordente e la cui voce dal timbro acidulo risulta a tratti veramente poco attraente. Corretti nei ruoli brevi a loro affidati Jan Vacík come Melot, Joshua Sanders, un pastore, Franco Rizzo nei panni del timoniere e Patrick Reiter in quelli di giovane marinaio. Il successo per tutti è caloroso e meritato.
DON GIOVANNI [Lukas Franceschini] Venezia, 19 ottobre 2017.
L’opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, nella produzione curata da Damiano Michieletto (2010), è riproposta al Teatro La Fenice per una dozzina di repliche quale ultimo titolo della Stagione 2016-2017.
Spettacolo molto accattivante, ne abbiamo già parlato, e probabilmente uno dei migliori del regista veneziano (sicuramente molto superiore agli altri due della trilogia dapontiana, sempre allestiti alla Fenice). La visione di Michieletto prevede un protagonista quasi demoniaco, crudele che tiene avvinghiate tutte le sue vittime e loro affini, in un gioco spietato per lui molto appagante tanto quanto l’irrinunciabile sesso, poiché in questo spettacolo la seduzione, il corteggiamento e la galanteria sono del tutto assenti. Prevale invece l’irruenza, l’egocentrismo e la foga dominante del protagonista, come fosse un manipolatore di esseri umani e un divoratore di donne. In questo caso, molto efficace l’ultima scena nella quale il banchetto di Don Giovanni, un’orgia elettrizzante e molto ben allestita drammaturgicamente, il cibo è rappresentato dalle donne. Idee forti, Michieletto ci ha ormai abituato, ma pertinenti, e in linea con sfaccettatura del seduttore incallito che forse non avevamo considerato. Oltre alla mano abbastanza felice del regista, il vero illuminato creatore è lo scenografo Paolo Fantin, che ricostruisce tutta una serie di ambienti (settecenteschi) in continuo movimento che s’intersecano e ricostruiscono tra loro in speculare perfezione armonica, una visione elettrizzante e magnifica. Altrettanto belli i costumi di Carla Teti, la quale con gusto stilizzato ricerca un ‘700 armonico ed elegante nelle vesti dei personaggi.
Non convince nel suo insieme la direzione di Stefano Montanari, che pur avendo a disposizione un’orchestra attenta e in ottima forma, sceglie un ritmo narrativo e drammaturgico altalenante e incomprensibile. Colpisce in un primo momento il tempo veloce e incalzante, il quale poi scivola come un’onda in dinamiche molto più lente. Non abbiamo riscontrato una linea omogenea dello spartito, e anche se tale ritmo poteva destare qualche interesse e una certa vitalità all’azione teatrale, alla lunga diventava anche stantio e inespressivo. Inoltre, in molti passi era assai difficoltoso per i solisti seguire il maestro in questa vorticosa lettura, tanto che in alcuni concertati il risultato non era soddisfacente. Per contro non è possibile staccare un tempo così largo all’esecuzione di “Dalla sua pace” quando si ha a disposizione un tenore limitato, povero d’accento e corto di fiato, tal esecuzione avrebbero faticato a seguirla anche illustri e di riferimento nomi del passato, ormai defunti.
Adrian Sapetrean, il protagonista, ha una voce robusta e armonica, timbro ragguardevole, ma la tecnica precaria non gli ha consentito dii controllare e adeguare le rilevanti doti in un canto più forbito, seducente, con mezzevoci, fraseggi e colori più raffinati. Invece, pur nella solidità vocale, abbiamo avuto un personaggio a tratti violento, poco cavalleresco e nobile, nel quale in taluni momenti si riscontravano emissioni rauche e poco nitide. Inaccettabile l’esecuzione della serenata senza sensualità e armonici.
Più composto il Leporello di Andrea Vincenzo Bonsignore, molto valido scenicamente quale succube del padrone, vocalmente ben impostato e molto valido nel fraseggio, peccato che la regia preveda sia balbuziente e questo in parte penalizza quanto c’è di buono in questo cantante che conferma anche ottime caratteristiche attoriali.
Valentina Mastrangelo, Donna Anna, è una cantante musicale e dotata di voce molto bella anche se il peso specifico non è efficacemente drammatico, il canto d’agilità non del tutto preciso e il recitativo talvolta debole. Tuttavia, l’artista sfodera una buona scansione di colori e accenti e nel complesso la prova è superata, con l’auspicio di future prestazioni più calibrate.
Paola Gardina, Donna Elvira (al debutto nel ruolo), è senza dubbio la migliore interprete del cast. Cantante raffinata, precisa, dotata di una musicalità eccelsa, conferisce al personaggio un giusto equilibrio tra l’irruenza e il patetico, complice anche una voce brunita ma omogenea in tutti i registri. Ragguardevole la sua esibizione sia nei momenti di forza sia nei passi elegiaci, a tal proposito indicativo l’attacco di “Ah taci ingiusto core” nel II atto, ma tutto il ruolo è stato studiato con perizia sia musicalmente sia teatralmente e la prova è certamente di alto livello.
Molto discutibile la prova di Patrick Grahl, Don Ottavio, cantante con pessima dizione, voce metallica e non calibrata tecnicamente poiché erano evidenti sia acuti forzati sia intonazione precaria.
Pregevole la Zerlina della giovane Irene Celle, ruolo che potrebbe riservale in futuro approdi più lusinghieri giacché il materiale vocale c’è ed è anche ragguardevole, ma alcune lacune tecniche rendono disomogenea la sua prova. È penalizzata nell’aria “Batti, batti” da tempi troppo vorticosi ma considerata la giovane età aspettiamo fiduciosi.
Molto simpatico il Masetto di Davide Giangregorio, abbastanza rifinito vocalmente e con un buon tratto teatrale.
Censurabile il Commendatore di Attila Jun, cantante con voce stentorea e ingolata.
Buona la prova del Coro diretto da Claudio Marino Moretti.
Teatro completamente esaurito in ogni di posto, con un pubblico stranamente distratto durante l’esecuzione ma che al termine ha tributato un caloroso successo a tutta la compagnia.
JÉRUSALEM [William Fratti] Parma, 20 ottobre 2017.
In questi mesi chi si è avvicinato allo spartito per la prima volta ha spesso commentato che si trattasse di un’opera nuova e non di una versione francese. Nulla di nuovo, il fatto era già certo e assodato: il libretto italiano de I Lombardi non è tradotto, ma è fonte di una nuova trama, la traduzione avviene solo quando Jérusalem è portata sui palcoscenici italiani col titolo di Gerusalemme; la musica è pressoché la stessa, ma ricostruita sul nuovo testo e le nuove voci, con piccoli tagli e moltissima musica nuova dove già si intravede il genio di Don Carlo – soprattutto nella marcia dei crociati – e di Aida – nella scena del giudizio di Gaston.
Lo spettacolo interamente ideato da Hugo De Ana porta indiscutibilmente la sua cifra stilistica, accomunandosi ad altri preziosi allestimenti ideati sui palcoscenici più importanti di tutto il mondo, ma in questo viene a mancare le coup de théâtre, pertanto ci si aspetta sempre di assistere a qualcosa di eclatante che invece mai accade. L’impressione è che abbia voluto essere troppo cauto. Addirittura lo spazio creato per la marcia, che avrebbe potuto essere un momento di grandeur nello stile del terzo atto di Don Carlo, appare registicamente troppo vuota. Indubbiamente si accontenta il loggione, storicamente allergico alle novità eccessive e alle rivisitazioni, ma in questo modo si porta la cultura verso il banale, il già visto e l’ombra della noia è sempre dietro l’angolo. Il tedio colpisce soprattutto durante il lungo divertissement, dove Leda Lojodice, contagiata da estrema cautela, crea una modesta coreografia decisamente didascalica, quando invece avrebbe potuto usare questo lungo tempo per raccontare una storia. Gli spettatori estremamente conservatori felicemente applaudono.
Daniele Callegari, sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini, riesce a creare un buon amalgama, ma si fa prendere troppo la mano dal maestoso francese, talvolta dimenticando il nervo verdiano e i pezzi d’assieme dei primi due atti risultano monotoni durante la prova generale. Invece l’ultima recita risulta più che convincente, smaltata e brillante. Ottimo è tutto il quarto atto, soprattutto il coro d’apertura, complice la bravura indiscussa del Coro del Teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani.
La Hélène della prova generale – pertanto non criticabile – era Annick Massis, che si è cimentata in una parte infarcita di troppe variazioni verso l’acuto. Diversamente Silvia Dalla Benetta porta in palcoscenico tutte le note della partitura, tutte appoggiate e intonatissime, facendosi ascoltare anche in basso, con un’ottima emissione mista. La sua è una voce propriamente adatta al repertorio del primo Verdi e più in generale del drammatico di agilità, sia per il timbro particolare contraddistinto da slanci vigorosi e messe di voce elegantissime, sia per la tecnica perfettamente impostata e arricchita di un ottimo uso dei fiati e del legato. In questa lunga opera mette così in mostra le sue agilità nella polacca di secondo atto e nella cabaletta di terzo, così come un canto morbido e raffinato nel duetto con Gaston e nella grande aria dopo i ballabili.
Ramon Vargas è un Gaston piuttosto efficacie e buon fraseggiatore, ma poco luminoso, presumibilmente perfetto per ripercorrere la prima parigina del 1847 quando Gilbert Duprez, proveniente da un repertorio dolce ed elegiaco, si presentava con una voce talvolta elettrizzante e talvolta indurita. Purtroppo mancano irrimediabilmente i due do presenti sullo spartito.
Il Roger della prova generale era Michele Pertusi – già Pagano nelle due edizioni precedenti de I Lombardi parmigiani – che si è prodigato nella consueta lezione di belcanto. Alla recita del 20 ottobre è Mirco Palazzi, dotato di voce più scura e con una buona linea di canto, ma calante negli acuti della prima cabaletta. Molto buona è invece la resa del terzetto e del finale ultimo.
Più che efficaci le parti di contorno, a partire dal brillante Raymond di Paolo Antognetti e la salda Isaure di Valentina Boi. Massimiliano Catellani è un buon emiro, mentre ci si aspettava più corpo dal legato pontificio di Deyan Vatchkov durante la sortita e la scena del giudizio di Gaston, quando invece risulta ben centrato in tutte le altre parti dell’opera. Concludono gli adeguati Pablo Galvez, Matteo Roma e Francesco Salvadori.
JÉRUSALEM [Margherita Panarelli] Parma, 20 ottobre 2017.
Produzione di grande prestigio quella concepita da Hugo De Hana, maestosi scene e costumi, dai grigi delle sale gotiche di Tolosa alle dorate sabbie del deserto in Palestina, invero notevoli, ma un uso esagerato e a tratti persino immotivato delle proiezioni toglie fascino all’insieme. Emblema di ciò gli spostamenti dei crociati resi in tal modo quando a disposizione vi era un palco completamente vuoto. Di grande effetto invece le scenografie e le piogge di sabbia, così come ottimo è lo scorrere dell’azione e l’aderenza al libretto, sempre encomiabile nel lavoro del regista argentino. Ancora a proposito delle numerose proiezioni: è stato interessante leggere durante l’Introduzione il Discorso di Urbano II al Concilio di Clermont-Ferrand del 1095, il quale di fatto diede inizio alla Prima Crociata.
Daniele Callegari dirige in una lettura di grande vigore la Filarmonica Arturo Toscanini. Il dialogo buca-palcoscenico è curatissimo e i risultati sono eccellenti, è solo da annotare in alcuni momenti, come nel coro dei crociati del secondo atto “Le Seigneur nous promet la victoire”, l’apprezzabile vigore dimostrato che sfocia in eccessiva verve, ma non vengono mai a mancare coesione e brillantezza da parte dell’intera compagine orchestrale.
Di grande pregio il lavoro del Coro del Teatro Regio di Parma, preparato in maniera eccellente da Martino Faggiani, impeccabile vocalmente e scenicamente.
Doveroso menzionare le coreografie dei quattro ballabili che aprono il terzo atto, a cura di Leda Lojodice, che risultano affascinanti di per sé ma poco coese al tono del resto della vicenda. Il cast vocale è di altissimo livello : Rámon Vàrgas, qui alle prese con il ruolo di Gaston, possiede voce di gran fascino per timbro e per pulizia di emissione. La apparente cautela con cui affronta la parte è delicatezza e non timore, nonostante i tagli di alcune puntature che ha scelto di non affrontare, poiché risulta chiaro nei momenti più concitati, come la scena del giudizio, dove si spende generosamente anche in frasi declamate e interventi più incisivi, che il suo è un approccio belcantistico al ruolo. Il fraseggio è puntuale e la dizione eccellente e la mancanza di alcune note, che si sarebbe probabilmente notata di più in caso di esecuzione scadente delle stesse, non inficia un’ottima resa del personaggio. L’approccio al ruolo è una scelta pienamente giustificata dalla posizione di questo titolo nel catalogo verdiano, con la quale si potrà concordare o meno, ma che sortisce sicuramente in questa edizione critica un effetto forse ancora poco esplorato per questo repertorio e sicuramente encomiabile.
Silvia dalla Benetta affronta il ruolo di Hélène da vero soprano drammatico di agilità; la tessitura del ruolo è adatta alla voce piena e elastica dell’interprete, il cui timbro non perde di rotondità e omogeneità nel registro grave o in quello acuto, entrambi esatti dalla partitura. Particolarmente bella è la Polacca del secondo atto “Quelle ivresse! bonheur suprême!”ma l’intero ruolo è affrontato con gusto, sicurezza e splendido controllo di fiati e proiezione del suono che consentono al soprano di tratteggiare il personaggio con una variegata tavolozza di emozioni grazie alle messe di voce perfette, ai filati e al volume notevole del suo strumento.
I due interpreti risultano pienamente convincenti anche sul lato scenico come anche il basso Mirco Palazzi il quale riesce a rendere piena giustizia al personaggio di Roger, dalle molte sfaccettature, nonostante il ruolo gli fosse stato affidato solo per questa recita, così come quello di Hélène a Silvia dalla Benetta. La sua aria del primo atto “Oh! dans l’ombre, dans le mystère” è cantata con sicurezza e fiero vigore, per poi passare ad accenti più eterei e sublimi, ma non meno incisivi, dal secondo atto con “O jour fatal! ô crime!”.
Non manca certo di squillo e prestanza lo scudiero di Gaston, Raymond, interpretato da Paolo Antognetti, ci si augura di sentirlo in futuro in ruoli più corposi.
Eccellente sostegno viene anche da Valentina Boi nel ruolo di Isaure, la confidente di Hélène, voce sicura dagli acuti saettanti. Buone prove anche dagli interpreti degli altri ruoli di contorno a partire dal solido Comte de Toulouse di Pablo Gálvez ed il tonante Adhémar de Monteil, legato papale, di Deyan Vatchkov. Adeguate le prove di Massimiliano Catellani nel ruolo dell’Emiro di Ramla, Matteo Roma come suo Ufficiale e Francesco Salvadori nel doppio ruolo di Araldo e Soldato.
Il successo al termine è caloroso per tutti e ben meritato.
DER FREISCHÜTZ [Lukas Franceschini] Milano, 20 ottobre 2017.
Dopo quasi vent’anni torna nella sala del Piermarini Der Freischütz di Carl Maria von Weber, emblema dell’opera romantica tedesca, rappresentato in prima assoluta alla Konzerhaus di Berlino il 18 giugno 1821.
Il trionfo che l’opera ebbe alla prima determinò in breve tempo una rapida diffusione, l’accoglienza parigina del 1841, altrettanto trionfale, decretò il definitivo successo europeo. La trama dell’opera è tratta da leggende popolari tedesche e molte delle sue arie furono ispirate dalla musica popolare tedesca, pertanto la sua identità nazionale e l’aspro temperamento emotivo sono fattori che hanno determinato il concetto di opera nazionale tedesca, che al tempo voleva contrastare il modello del melodramma italiano, il quale aveva solide radici in area germanica. Nel Freischütz accanto al Lied vocale e al valzer lento, Landler, entrambi originari del folklore d’oltralpe, coesiste pure una forma della tradizione italiana. L’aspetto naturale dei boschi, delle montagne s’interseca con la fiaba (anche truce) per esaltare un amore dolce che diventa simbolo di serenità e intimità anche se nato nella fosca e infernale valle del Lupo, la quale esprime una dimensione sovrannaturale e misteriosa tipica del primo romanticismo. L’opera è modellata sul principio non nuovo del Singspiel con dialoghi parlati, ma emerge in primo luogo un’overture di espressiva unità tematica con tutti motivi che ricompaiono in seguito nella partitura. Non secondaria è la magia sensoria ed evocativa del suono strumentale che è ripetuto con una frammentazione geniale durante gli esorcismi di Kaspar.
La nuova produzione presentata al Teatro alla Scala, regia di Matthias Hartmann, scene di Raimund Orfeo Voigt, costumi di Susanna Bisovsky e Josef Gerger, si lascia guardare ma non entusiasma, anzi fa rimpiangere la precedente creata da Pier’Alli. Seducono i grandi tronchi d’albero che creano una scena boschiva anche affascinante, si apprezzano i costumi ispirati alla più tradizionale Boemia, il fuoco vero che illumina la gola del Lupo durante l’esorcismo è sinistro come tutta la scena, tuttavia questo spettacolo offre un’idea del già visto e di uno sviluppo poco profondo. Pur essendo sfarzosamente realizzato, è disarmante nella realizzazione degli interni con dei tubolari illuminati più idonei a un mondo moderno ed elettrico che al romantico ambiente della foresta e delle montagne. Dal punto di vista drammaturgico il regista Hartmann si limita ad abbozzare ma non trova una lettura personale per identificare i personaggi, spesso lasciati a se stessi, ad eccezione del demoniaco Kaspar, che regge la grande scena della gola boscosa in maniera straordinaria.
La direzione di Myung-Whun Chung è caratterizzata da un estremo lirismo, però ispirato più al patetico che al fantasioso affresco di colori e d’indicative pagine descrittive della vita di paese, al sovrannaturale e all’invenzione melodica solista, nella quale il direttore trova terreno più consono. Tuttavia la direzione di Chung è ottimamente cesellata, in ogni angolo, ma mai veramente emozionante. L’orchestra della Scala è in grande serata per coesione di suono e timbro, segue il concertatore alla perfezione in una lettura che ha anche dell’incantevole, ad esempio il leitmotiv di Agathe, ma che non esprime vigore e sovente con tempi molto allargati, che a mio avviso propende per una solennità opinabile.
Stupefacente la prova del Coro, diretto da Bruno Casoni, sia nella bella caratterizzazione del canto popolare sia nelle grandi scene d’assieme in particolare il finale.
Il protagonista Max di Michael Konig, ha voce poco squillante, molto ridimensionata ed è piuttosto ruvido nell’emissione. Meglio l’Agathe di Julia Kleiter, soprano di ottime proprietà, la quale è particolarmente emozionante per spessore lirico-intimistico nella seconda aria, mentre nella cavatina, seppur cantata con solida linea, trova qualche difficoltà espressiva per mancanza di spessore.
Eva Libeau è una frizzante Annchen scenicamente ma la voce è molto limitata e talvolta debole, tuttavia è accettabile.
Gunther Groissbock, Kaspar, è un attore impressionante, mefistofelico e insinuante, vocalmente avrebbe anche i requisiti per rendere il ruolo in maniera rilevante ma lacune tecniche denotano a tratti un’emissione grossolana e un registro acuto sfibrato.
Bravo Stephen Milling, l’Eremita, voce possente e ben calibrata, preciso e brillante il Killian di Till von Orlowsly, professionale il Kuno di Frank van Hove, sommario l’Ottokar di Michael Kraus.
Molto bravo il gruppo delle quattro damigelle della sposa, composto da Céline Mellon, Sara Rossini, Anna-Doris Capitelli, Mereike Jankowski.
Pubblico piuttosto pacato durante l’esecuzione ma prontamente solerte al termine nel decretare un buon successo a tutta la compagnia.
LA RONDINE [Lukas Franceschini] Firenze, 22 ottobre 2017.
Per la prima volta a Firenze è andata in scena l’opera La Rondine di Giacomo Puccini, nel centesimo anniversario dalla prima assoluta che fu al Grand Théâtre di Montecarlo il 27 marzo 1917, allora con protagonisti Gilda Dalla Rizza e Tito Schipa.
Un ritardo strano ma casuale, Firenze ha allestito molte esecuzioni in prima assoluta e italiana soprattutto nel corso delle magnifiche stagioni del Maggio Musicale. Il ritardo ha però avuto una risposta sorprendente da parte del pubblico, la recita domenicale ha registrato il tutto esaurito, e anche le altre recite non erano meno affollate. Trattasi di un risultato eccezionale e stupefacente poiché il titolo non è dei più appetibili dal grande pubblico, e pur restando sempre in repertorio non ha un’assidua frequenza di rappresentazione.
La Rondine è un’opera in tre atti su libretto di Giuseppe Adami. Originariamente concepita come operetta, in base a un contratto con l’impresario del Carltheater di Vienna, ma Puccini era insoddisfatto dalla drammaturgia creata dai librettisti Heinz Reichert ed Alfred Willner. Trasformò il soggetto in un’opera vera e propria affidandosi al commediografo italiano Giuseppe Adami. Tuttavia la convinzione del compositore sul progetto era esile cui si sommò una certa stanchezza d’ispirazione, aspetti che compromisero in misura determinante la gestazione del lavoro, che si trascinò per tre anni tra continui ripensamenti. Una volta finita composizione, nel 1916, era impensabile poterla rappresentare a Vienna, sia per la guerra in corso sia perché era la capitale del paese nemico. La scelta cadde sul piccolo stato di Monaco perché neutrale anche se ovviamente simpatizzava per la Francia e sosteneva forze in combattimento, ma restava un’isola “felice” in quella Costa Azzurra che viveva ancora il fascino delle belle époque. L’accoglienza fu festosa ma non trionfalistica, e Puccini non era del tutto soddisfatto del suo lavoro. Pur proseguendo alcune rappresentazioni all’estero e in Italia (a Bologna la prima nazionale) il compositore fece delle modifiche che possono essere inserite nella versione del 1920 (Palermo) nella quale la parte di Prunier è trasportata in chiave di baritono, l’inserimento nel I atto dell’aria di Ruggero “Parigi! È la città dei desideri” e decisivi cambiamenti nel finale. Esiste una terza versione del 1921 mai rappresentata perché sopravvissuta solo in uno spartito per canto e pianoforte, che elimina l’aria di Ruggero, riporta Prunier a tenore e modifica ulteriormente il finale, nel quale Ruggero è informato da un biglietto anonimo del passato di Magda. Questa versione si è potuta ascoltare a Torino nel 1994 con la revisione e orchestrazione delle parti mancanti a cura di Lorenzo Ferrero. E’ corretto puntualizzare che solitamente si usa eseguire la prima versione com’è stato anche all’Opera di Firenze in quest’occasione.
Lo spettacolo, funzionale e ben strutturato era creato interamente, regia, scene, costumi e luci, da Denis Krief, il quale trasporta la vicenda ai giorni nostri. Identifica i personaggi con una luce molto realistica, un gruppo di persone oziose che vive alla giornata e nella spensieratezza economica. Un ricco che mantiene la sua amante (che trova un leggero parallelismo con Violetta), un poeta in erba innamorato della giovane cameriera di Magda, e un folto stuolo di amici goliardici di vita spensierata, che non guarda certo agli eventi della loro epoca, o non la vuole vedere. Un perfetto equilibrio tra sentimentalismo, che è alla base dell’opera pucciniana, e un’atmosfera spensierata ma con grandi affreschi di verità, una società borghese. Sarà questa verità la chiave di tutto lo spettacolo, l’accettazione del proprio ruolo e del proprio carattere, visto soprattutto al femminile. Magda ritorna alla sua vita poiché capisce che non può essere la sposa del giovane per bene, Lisette ritorna al ruolo di cameriera, anche per lei come per Magda c’è stata una parentesi, un diversivo, nel quale hanno potuto prima sognare ma poi rendersi conto del proprio destino. Una realtà forse triste ma inesorabile. In questa chiave di lettura Krief punta il dito più sul tema sociale che sulla frivolezza, lo fa in maniera elegante, sobria ma non ambigua. Eccellenti i costumi, variopinti e di taglio prêt-à-porter, originalissime le scene, contraddistinte dal colore bianco, definite in ambienti sghembi ma in grande di design.
Altra colonna portante di questa produzione è stato il direttore Valerio Galli, concertatore di rango che riesce a scavare nella complessa partitura sia gli aspetti intimistici, sia il gioviale utilizzo di ballabili e feste. Orchestra mai forzata e sempre controllata, ottima la perizia con cui segue i solisti, e la lucentezza nelle pagine sentimentali è davvero encomiabile. Complice anche un’orchestra del Maggio Musicale in ottima forma e particolarmente sostenuta, e un Coro di grande qualità diretto da Lorenzo Fratini.
Molto efficace nel suo insieme il cast scritturato per l’occasione. La Magda di Ekaterina Bakanova è brillante e rifinita in un canto morbido con ottimi accenti. Ben realizzato il personaggio di Ruggero da parte del tenore Matteo Desole, dotato di voce calda e precisa. Brillantissima la prova di Matteo Mezzaro, Prunier, un giovane sempre in crescendo per una prova disinvolta e di raffinata esecuzione vocale. Altrettanto si può dire della frizzante Lisette di Hasmik Torosyan, soave e precisa. L’esperienza scenica caratterizza la figura ambigua ma elegante che Stefano Antonucci fa di Rambaldo.
Di alto livello le parti secondarie, puntuali e molto musicali, Dario Shikhmiri (Périchaud), Rim Park (Gobin), Adriano Gramigni (Crébillon), Francesca Longari (Yvette), Marta Pluda (Bianca), Gida Frasconi (Suzy), Giovanni Mazzei (maggiordomo), Antonio Corbisiero (Rabonner), Elena Bazzo (Georgette), Tiziana Bellavista (Gabriella), Thalida Marina Fogarasi (Lolette).
Del teatro esaurito in ogni ordine di posto si è detto, il successo finale è stato caloroso e giustamente meritato.
IL TROVATORE [Lukas Franceschini] Padova, 27 ottobre 2017.
Inaugurata la Stagione Lirica al Teatro Comunale “G. Verdi” con una produzione de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, proveniente dal Teatro Nazionale Sloveno di Maribor, in coproduzione con il Bassano Opera Festival.
L’esito generale della serata non è stato del tutto positivo e l’elemento più discutibile è stata la presenza sul podio del maestro Alberto Veronesi, il quale ha compromesso in maniera decisiva lo svolgersi dell’esecuzione.
Veronesi si è prodigato in una direzione del tutto incomprensibile musicalmente con tempi personali altalenanti, senza alcun criterio di concertazione con il palcoscenico come i cantanti e l’orchestra non dovesse essere un tutt’uno ma due enti se stanti e paralleli. Ne consegue un’assenza totale di colori, dinamiche imbarazzanti e un linguaggio interpretativo verdiano notevolmente fuori dall’ordinaria esecuzione. Nella mano del direttore pare mancasse il senso teatrale che un’opera così affasciante e ricca di atmosfera come Trovatore offre su un piatto d’argento, sempre ammesso che si voglia servire come il compositore suggerisce, e di daccapo e gusto “verdiano” non è nemmeno il caso di parlarne. In più occasioni ho avuto la percezione che i cantanti andassero per conto proprio e il direttore si adeguava a seguirli, poiché se fosse avvenuto il contrario, il risultato sarebbe stato ancor più disastroso.
In tale situazione anche la prova dell’Orchestra di Padova e del Veneto, solitamente molto più apprezzabile, è penalizzata e si potrebbe supporre che non ci sia stato quel feeling necessario, di dialogo e comunicazione, tra i professori e il podio.
Più positiva la prova del Coro Lirico Veneto, istruito da Stefano Lovato, che conferma una solida professionalità.
Nel cast, in generale sommario, un solo elemento brilla di luce propria, ed è il baritono Enkhbat Amartuvshin. Il cantante debuttò trionfalmente in un concerto la scorsa primavera a Verona, cui seguirono alcune recite di Rigoletto, in estate, all’Arena, accolte con grandi favori da parte di pubblico e critica. A Padova ha riconfermato le caratteristiche di baritono nobile, voce ampia e ben amministrata in tutta la gamma, capace di canto elegante e sfumato, ricco di accenti e con un fraseggio molto accurato. Una prova davvero positiva come da qualche tempo non ascoltavamo in teatro, con la speranza che in futuro migliori l’arte attoriale, ancora un po’ grezza, e non si riveli la consueta meteora nel panorama lirico.
Walter Fraccaro, Manrico, è il solito cantante abbastanza sicuro che esegue il tutto con un’impostazione senza rilevanti espressioni. Il timbro è ancora solido, ma l’intonazione precaria, il fraseggio a sprazzi eloquente, sfumature e accenti sommari, impegnandosi in una recita senza infamia né lode.
Precaria anche la Leonora di Maria Katzarava, al debutto nel ruolo ma affrontato con troppa disinvoltura e forse poco tempo di studio. Del tutto diversa dalla Lina nello Stiffelio al Verdi Festival di Parma il mese scorso, la cantante sfodera anche in quest’occasione una voce importante e una discreta musicalità, ma in una parte “cantata” a tutto tondo come in Trovatore non si può barare. Ecco che una tecnica non precisa denota un registro acuto forzato e limitato, mezzevoci e fraseggio sono approssimativi e la pesantezza del ruolo rende una decrescente resa vocale nel corso della recita. Considerate le caratteristiche vocali sarebbe auspicabile una maggior preparazione dei ruoli, anche in questo caso per non perdere una cantante che avrebbe, probabilmente, qualcosa da dire nel prossimo futuro. Forse l’emozione, forse la poca sintonia con il direttore, o la memoria non perfetta, nel primo atto la cantante ha pasticciato il recitativo e cadenza tra aria e cabaletta.
Judit Kutasi, Azucena, conferma la regola odierna di molti soprani drammatici impegnati in ruoli da mezzosoprani. La cantante, che possiede un timbro rilevante e una buona arte attoriale, è costretta ad abusare di suoni forzati nel grave, sovente sfogati, tuttavia pur possedendo facilità in acuto si guarda bene dall’eseguire il do nella stretta del duetto con Manrico.
Il Ferrando di Simon Lim, anch’egli in possesso di voce profonda e non comune, si colloca nella classica routine quanto a interpretazione e metodo di canto.
Piuttosto anonimi i ruoli secondari, che svolgono il loro compito con sufficienza risicata: Carlotta Bellotto (Ines), Orfeo Zanetti (Ruiz), Luca Bauce (vecchio zingaro), Luca Favaron (un messo).
Resta infine lo spettacolo, creato interamente da Filippo Tonon, coadiuvato da Cristina Aceti quale costumista. Allestimento molto scarno scenograficamente, ma godibile sotto l’aspetto visivo per un gusto romantico che si rifà più all’epoca della composizione verdiana che alla reale collocazione storica della vicenda. Molto efficaci i cambi scena, veloci e costituiti da pochi elementi portati in scena da figuranti e coro corrispondono all’azione. I costumi sono di grande fattura e illuminano il palcoscenico, in particolare quelli di Leonora. Non mancano nella visione del regista alcuni riferimenti pittorici ben inseriti nell’ambiente, tuttavia mi è parso del tutto fuori stile il campo di papaveri illuminato a giorno nel I atto quando invece dovevamo trovarci in una buia notte. Non del tutto plausibile la pantomima delle ancelle quale preludio al corteo che avrebbe dovuto portare Leonora al convento. La scena migliore è quella del carcere, delimitata da una grata e un’efficace illuminazione. Non sempre il disegno luci seguiva di pari passo l’azione e lo sviluppo sui singoli personaggi non sempre messo a fuoco, ma è uno spettacolo “essenziale”, tradizionale ed estetico, credo come nelle intenzioni del regista, che regge la scena.
Al termine, come spesso accade nei teatri di provincia, successo incontrastato ed entusiasmante per tutti, anche se l’ovazione l’ha ricevuta il solo Enkhbat Amartuvshin.
IL BARBIERE DI SIVIGLIA [Lukas Franceschini] Rovigo, 5 novembre 2017.
La 202ª Stagione Lirica al Teatro Sociale è stata inaugurata con l’esecuzione dell’opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in un nuovo allestimento coproduzione del teatro rodigino e la Fondazione Rovigo Cultura in collaborazione con Opera Academy Verona.
Il Teatro Sociale di Rovigo vanta una tradizione lirica di grande risonanza, è rilevante che un teatro di provincia abbia una storia che sorpassa i due secoli di attività, oltre ad essere stato luogo del debutto di due grandi del ‘900: Beniamino Gigli e Renata Tebaldi. Nel corso della sua lunga storia tanti altri celebri cantanti hanno calcato le scene del Teatro Sociale, e anche in epoche più recenti non sono mancati momenti di grandi serate d’opera. Tuttavia negli ultimi anni anche di fronte a spettacoli interessanti con cast ragguardevoli, per diversi e intrecciati fattori, l’affluenza del pubblico si era affievolita notevolmente, che non si può tradurre solo come uno scarso interesse nei confronti dell’opera. Quest’andamento ha preso una piega letteralmente opposta con l’inizio della stagione odierna, infatti, le quattro recite (due riservate alla rassegna “Teatroragazzi”) erano completamente esaurite, pare anche che qualcuno giunto all’ultimo non abbia trovato posto. Non possiamo che esserne felici, un teatro vuoto non è solo indice di scarsa cultura ma anche di una società che non trova e non cerca sbocchi di convivenza, come paralizzata in un mondo se stante.
Passando alla locandina dell’opera, il cast scritturato a Rovigo nel suo complesso era soddisfacente e di buona qualità.
Alessandro Luongo, Figaro, ha confermato le sue ottime capacità canore, voce di bel timbro omogeneo, eccellente nell’uso dei colori e del fraseggio, accomunato da doti attoriali non comuni contraddistinte da eleganza e brillantezza.
Marina De Liso, salvo errori di nascita rodigina, affronta il ruolo di Rosina con sicurezza e disinvoltura molto pertinente, ed è maliziosa nella caratterizzazione del personaggio. La cantante è dotata di voce mezzosopranile chiara che ben si adatta alla partitura rossiniana, ben realizzata la coloratura e l’encomiabile spavalderia nella varietà degli accenti. Le variazioni non erano del tutto convincenti solamente sotto l’aspetto del gusto, che per opinione personale erano un po’ troppo artefatte, ma l’esecuzione generale della cantante è senza dubbio di ottima fattura.
Matteo Macchioni, Conte d‘Almaviva, che rispetto al don Giovanni vicentino di qualche anno fa abbiamo trovato meno efficace per una voce meno armonica e una scarsa propensione al canto d’agilità. Inoltre, è stato penalizzato dall’esecuzione del rondò finale, solitamente omesso se non alla presenza di un autentico fuoriclasse, che ha messo ancor più in evidenza non solo mancanze tecniche e un registro acuto limitato ma in particolare una scelta di repertorio azzardata. Meritevole, nel complesso, la volontà dell’artista che esegue tutta l’opera, nella quale è protagonista a dispetto del titolo, con onore ma nulla più.
Christian Starnieri, dottor Bartolo, è validissimo come attore ma il cantante manca di quella grana vocale del buffo soprattutto nel sillabato e nei colori.
Enrico Rinaldo, Don Basilio, è cantante con un materiale molto importante e profondo ma sovente ruvido e poco armonico.
Mirabile la Berta di Giovanna Donadini, che nel piccolo ruolo ha ancora una volta sorpreso per spigliatezza teatrale e buona resa vocale.
Piuttosto discontinuo ma accettabile il Fiorello di Claudio Mannino, bravi sia Francesco Toso, un ufficiale, sia Elia Zanon, Ambrogio.
Sul podio il maestro Alessandro Cedrone, ha offerto una lettura piacevole abbastanza equilibrata nelle sonorità e impronta con fatica un’omogeneità tra buca e palcoscenico. L’orchestra Filarmonica Veneta non era particolarmente brillante, evidenziando sovente sfasature tra le parti, tuttavia ha mantenuto una sobria e accettabile esecuzione, ma richiede più attenzione in fase preparatoria. Positiva la prova del maestro al fortepiano Riccardo Favero, che suonava uno strumento ottocentesco, scelta insolita ma apprezzabile.
Molto buona la prova del Coro Lirico Veneto, istruito da Flavia Bernardi.
Lo spettacolo era interamente realizzato da Massimo Pizzi Gasparon Contarini, il quale è coadiuvato dall’opera Academy di Verona nella realizzazione dei costumi. La concezione del regista è prevalentemente concentrata sull’estetica, cifra stilistica cui spesso si è ispirato seguendo le indicazioni del suo maestro (Pier Luigi Pizzi). In parte ci riesce come scenografo, l’ambientazione è molto elegante con una Siviglia in bozzetto sullo sfondo, davanti alla vicenda della commedia di Beaumarchais, realizzata con pochi oggetti, tutti in bianco, un piccolo balcone sulla destra, tavoli, sedie, sgabelli, e un grande letto che determina la prima scena di Rosina, ma che stranamente resterà in scena fino alla fine dell’atto I. I costumi, seppur di grande fattura, e l’apprezzato coinvolgimento dei giovani dell’Accademia con docente bar 5Lorena Marin, sarebbero stati maggiormente efficaci se più cromatici, e non identificati nel bianco assoluto, colore, voluto dal regista, che ha impresso a questo Barbiere un’aurea quasi da commedia dell’arte (il coro maschile indossava la celebre maschera di Pulcinella), che francamente non del tutto ci azzecca sia con Rossini sia con la commedia del francese. Tuttavia, la visione è piacevole e scorre con buona sequenzialità come la narrazione registica, la quale pur seguendo una traccia teatrale efficace sfortunatamente cade spesso in macchiette e cliché di vecchio spettacolo che ha compromesso in parte uno spettacolo che altrimenti sarebbe stato più efficace ed elegante. In tal senso, un grave errore registico è stato quello di creare scenette a margine durante la non corta esecuzione del rondò “Cessa di più restare”, l’assolo più importante di tutta l’opera che andrebbe ascoltato senza ingerenze poiché trattasi di un vero e proprio pezzo di bravura. Comunque il lavoro di Gasparon, nel suo insieme, è abbastanza valido e godibile.
Grande successo per tutti al termine.
DIE ZAUBERFLÖTE [Emiliano Mazza] Brescia, 12 novembre 2017.
Seconda replica di Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart, targato Opera Lombardia. Lo spettacolo, ripresa di un allestimento dell’Opéra Royal de Wallonie di Liegi (Belgio), è una coproduzione dei principali teatri di tradizione lombardi e approda al Teatro Grande dopo aver toccato Bergamo e Como nelle scorse settimane.
La concezione originale si deve al duo di registi francesi Cécile Roussat e Julien Lubek, entrambi diplomati presso la scuola parigina di mimo intitolata a Marcel Marceau. Proprio la presenza di mimi, fin da prima dell’attacco dell’Ouvertüre, è sicuramente uno dei caratteri più originali della messinscena. Questi personaggi, dalle affascinanti virtù acrobatiche ed espressive, ricorrono in vari momenti dell’opera in un muto dialogo con i personaggi, talvolta distraendo un po’ dalla componente canora. La base dell’idea di regia, ripresa in questo caso efficacemente da Giorgia Guerra, va ricondotta ai continui riferimenti alla notte ed in particolare al momento in cui Tamino pronuncia la domanda “O ewige Nacht, wann wirst du schwinden?”-“O notte eterna, quando svanirai?”. Ecco dunque che il principe viene presentato all’inizio come un giovane in preda a terribili incubi (il serpente) mentre dorme nel proprio letto. L’interno dell’abitazione, di aspetto borghese ottocentesco, non è esente da richiami a “La Bella e la Bestia” disneyana e costituisce in buona sostanza la scenografia del Primo Atto. Di contro il Secondo Atto, regno di Sarastro, è una sorta di mondo onirico popolato di enormi libri. All’ascoltatore l’immaginazione necessaria per rendere plausibili con tale allestimento i molteplici salti narrativi di una vicenda che notoriamente non eccelle per coerenza. Di certo, dovendo sbilanciarsi su quale delle possibili interpretazioni del libretto i registi propendano, la risposta è probabilmente quella leggera e fiabesca. I riferimenti alla simbologia massonica, pur presenti in alcuni costumi egizianeggianti e nella libreria come simbolo della sapienza, passano comunque in secondo piano in un’ambientazione irragionevole come solo i sogni sanno essere. Venendo alla parte musicale, direttore d’orchestra era Federico Maria Sardelli, che si è contraddistinto per il consueto rigore filologico nelle sonorità (anche attraverso l’uso di tromboni antichi e la moderazione del vibrato negli archi) ed una serie di accortezze quali la trasformazione delle figurazioni puntate in doppi punti. La direzione di buca e palcoscenico è risultata tecnicamente molto efficace ma non particolarmente espressiva e a tratti affrettata. L’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, per conto suo, non ha brillato per precisione, esibendo anzi un suono piuttosto scarno nei pochi archi schierati. Notevole invece per compattezza la prova del Coro Opera Lombardia, preparato da Diego Maccagnola. Sul versante vocale, Tamino era Klodjan Koçani. Il giovane cantante albanese ha mostrato un timbro piacevole ed un buon gusto nel fraseggio. Purtroppo le note acute risultano spesso spinte. Bravissima Enkeleda Kamani nei panni di Pamina, sostenuta da una tecnica di canto pregevole: la voce è sempre ben proiettata sia nei gravi che negli acuti. L’aria Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden ha rappresentato, secondo l’opinione di chi scrive, il momento migliore della rappresentazione. Ottima anche la prova di Daniele Terenzi, Papageno dal canto sonoro e sicuro su tutta la linea. Le tre arie sono risolte con facilità e con un divertente gusto attoriale, piacevolmente mostrato anche durante le parti recitate. Corretta la Papagena di Raffaella Palumbo nella sua breve parte. Sarastro era invece il basso Abramo Rosalen, dal grande volume vocale, non sempre a fuoco nelle note più gravi. Venendo ai personaggi negativi, la terribile Regina della Notte era interpretata da Maria Sardaryan. Durante l’aria del Primo Atto O Zittre nicht la voce non è praticamente pervenuta, principalmente a causa della scomoda posizione in cui si trovava a cantare (a diversi metri di altezza e con uno spesso tendaggio sopra la testa). Nella famosa Der Hölle Rache, cantata stavolta in una posizione più favorevole, è risultata invece abbastanza precisa nelle agilità e nei picchettati acuti. Emissione comunque decisamente migliorabile a cominciare dal vibrato troppo stretto. Marcello Nardis, nelle vesti di Monostatos, ha delineato un personaggio nervoso, certamente convincente da un punto di vista scenico ma eccessivo nel canto poco fraseggiato. Bene le tre dame, nell’ordine Maria Sole Mainini, Francesca Pierpaoli e Alessandra Andreetti: da segnalare in particolare la prima. Eugenio di Lieto ha cantato piuttosto ingolato la parte del Primo sacerdote, meglio nel Secondo Atto come Secondo armigero a fianco del sonoro tenore Marco Miglietta (Primo armigero e Secondo sacerdote). Abbastanza affiatati infine i Drei knaben del Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala. Nel complesso uno spettacolo piacevole, anche se con un cast perfettibile. La giovane età dei protagonisti, selezionati in gran parte attraverso il concorso Aslico, fa comunque ben sperare nella sistemazione delle mende tecniche esibite da alcuni. Successo pieno in un Teatro Grande praticamente esaurito.
AIDA [Lukas Franceschini] Bologna, 12 novembre 2017.
Penultimo appuntamento operistico della Stagione Lirica 2017 al Teatro Comunale con Aida di Giuseppe Verdi, in un allestimento curato da Francesco Micheli per l’Arena Sferisterio di Macerata ora riadattato per un teatro tradizionale.
Aida mancava dal teatro bolognese dal 2001, quando la diresse Daniele Gatti, allora direttore principale dell’Orchestra del Comunale, protagonista era la compianta Daniela Dessì.
Al termine della rappresentazione lo spettacolo ci lascia molti dubbi e più ombre rispetto le luci. Probabilmente il riadattamento in teatro non ha giovato e forse non è stato curato come avrebbe necessitato giacché alla prima il regista non era presente. Commenti a tergo sostenevano che ormai un’opera come Aida non è più rappresentabile in uno stile tradizionale perché logore e abusate. Francamente non mi convince il concetto, Aida è un’opera che volutamente è ambientata in Egitto, i motivi sono ben noti, al tempo dei faraoni, allora costumi, usanze e modi di vivere erano diversi da oggi. Pertanto portare Aida nella modernità è un azzardo che potrebbe materializzarsi in una lettura ancor più dozzinale della classica proposta.
Micheli sceglie la strada del minimalismo con scene spoglie, che in certi momenti rimandano ad altro regista che ha abusato in tali concetti. La scenografia di Edoardo Sanchi è costituita da due pannelli, uno inclinato sul palcoscenico l’altro che funge da fondale. Sulle prime abbastanza incomprensibile, ma nel corso dell’opera si evince che trattasi di un computer portatile aperto. La vicenda è narrata come fosse un film da vedere sul mezzo più rappresentativo della comunicazione odierna. Infatti, leggendo le note di regia, dopo la recita, è lo stesso regista che conferma tale impressione: il Canale di Suez fu allora un’opera innovativa e altamente tecnologica, pertanto la trasposizione non poteva avvenire oggi che tramite il computer. Idea opinabile ma anche forse logica, tuttavia oltre alla collocazione storica sarebbe servita maggior focalizzazione sui personaggi, i quali si muovono e recitano, per usare un eufemismo, come robot fine se stessi quasi senza anima. Non ci sono soluzioni peculiari né nelle scene intimistiche né nei grandi momenti corali, il tutto, seppur con pulizia, scorre attraverso una freddezza imbarazzante. Durante il preludio sono proiettate alcune immagini storiche, papiri tratti dalla storiografia egizia, ma nel corso della rappresentazione si sfiora il ridicolo poiché a ogni ingresso si legge a caratteri cubitali il nome del personaggio, o in seguito brevi frasi del libretto. Inoltre, è ormai insopportabile il continuo utilizzo della platea come fosse un palcoscenico, il regista lo fa durante il trionfo, scena decisamente non riuscita, sia nel finale facendo entrare Aida dal fondo. Le grandi botole da cui “sorgono” i cantanti potrebbero trovare un utilizzo anche apprezzabile, ma quando si riduce nel corso di tutta la rappresentazione all’unica via d’entrata, scade nel noioso. Ci sono invenzioni discutibili o indecifrabili, una su tutte l’ingresso di Radames al III atto al fianco di Amneris prima del celere duetto con la protagonista. In generale è una regia che annoia e non trova una lettura che entusiasmi, ed è un peccato perché Micheli ci aveva abituato ad altri tipi di spettacoli. Originale che tutta la vicenda prenda spunto da un racconto, o guidato politicamente (difficile capirlo), dal sommo sacerdote Ramfis, ma quando questo è realizzato con l’utilizzo di tablet e si scade nel deprimente. Gli stessi strumenti tecnologici sono in mano al coro in alcuni momenti epici come la scena 2a del I atto, la quale purtroppo non trova una cifra sacrale idonea.
I costumi di Silvia Aymonimo, pur nella loro asciuttezza, sono molto belli soprattutto quelli riservati ai reali, ma colpisce anche il nero e lungo abito di Aida. Azzeccate in questa situazione le coreografie di Monica Casadei, ruvide e stilizzate, ottimamente eseguite dalla Compagnia di Ballo Artemis Danza e dalle Allieve di Arabesque, che vorremo vedere anche in altre occasioni. Luci ben assortite e funzionali di Fabio Barettin, che attraverso cromatismi diversi focalizzano una certa drammaturgia con suggestione.
Non convince del tutto la concertazione di Frédéric Chaslin, poiché segue una strada propria di grande rispondenza sinfonica, ma non trova una corrispondenza dinamica nelle scene portanti, come l’intero atto III, e nelle parti solistiche spesso poco curate con colori e teatralità rilevanti. E’ un peccato perché il direttore è un bravo professionista, che in altre occasioni aveva dimostrato ben diverso impeto. Inoltre è stato poco attento alle esigenze dei singoli, e pretendere da un tenore sostituito all’ultimo di eseguire il Si bem smorzato di Celeste Aida era impresa presa in partenza. L’Orchestra e il Coro del Teatro comunale erano in gran serata, orchestra lucida e precisa, suono compatto e ben amministrato in tutte le sezioni, Coro, istruito da Andrea Faidutti era perfettamente calibrato e di grande professionalità, però penalizzato dovendo cantando anche in platea.
Compagnia di canto nel complesso piuttosto disomogenea, la quale ha avuto grandi difficoltà nel seguire una lettura così asettica e poco rifinita, quando invece gli stessi interpreti avrebbero avuto bisogno di cure più amorevoli.
Monica Zanettin, Aida, è interprete efficace nella drammaticità, capace di utilizzare con proprietà accenti diversi e fraseggiatrice accurata. Non sempre ci sono stati abbandoni lirici emozionanti ma questo è da ascrivere a una direzione disattenta, poiché il soprano sappiamo, da altre recite ascoltate, che è capace di altro. Nell’insieme una bella prova la più rilevante dell’intero cast.
Da Antonello Palombi, Radames, che passava all’ultimo momento dalla seconda compagnia alla prima sostituendo Carlo Ventre, non si può pretendere granché. È un cantante di sommaria correttezza, voce abbastanza robusta nell’acuto, ma con tecnica precaria che non gli permette non solo di modulare i diversi registri, ma anche di trovare fraseggio e accento di sostanza. Il ruolo è realizzato a senso unico con l’utilizzo di un canto sempre sul forte o mezzo forte, e nient’altro.
Nino Surguladze, Amneris, è stata una carta non del tutto azzeccata per questo ruolo. La cantante è sempre corretta e mai in nessun momento accenna ad appariscenti mancanze, ma di suo non possiede il volume vocale per il ruolo, e l’accento è limitato per l’altera principessa egizia, anche se la regia vorrebbe ridurla a bambina spaventata, ma lo spartito dice ben altro. Tuttavia, la cantante trova in un fraseggio eloquente e un senso teatrale forbito, un punto di forza.
Dario Solari, Amonasro, è baritono di buone qualità vocali rifinite e robuste ma non sempre utilizzate al meglio quanto ad accento e morbidezza.
Notevolmente sotto tono la prova di Enrico Iori, un Ramfis molto usurato che non possiede più uno spessore vocale idoneo. Superiore e ben definito Il Re di Luca Dall’Amico, autorevole interprete e preciso nei suoi interventi.
Nelle parti minori Cristiano Olivieri era un bravo messaggero, e Beth Hagermannn una corretta la sacerdotessa.
Poco efficace la sperimentazione dei sopra titoli utilizzando lo smartphone, notevolmente preferibile la soluzione della proiezione. Durante l’esecuzione applausi scarsi e poco convinti, ma al termine prolungati e di vivo consenso.
NABUCCO [Lukas Franceschini] Milano 16 novembre 2017.
Nabucco di Giuseppe Verdi è stato il penultimo titolo operistico della stagione scaligera 2016-2017, proposto nell’allestimento ideato da Daniele Abbado nel 2013 in coproduzione con Londra, Chicago e Barcellona.
Spettacolo non indimenticabile quello di Abbado ma nel complesso apprezzabile nella sua asciuttezza e stilizzazione. Il regista sceglie un’ambientazione moderna, senza nessun connotato con la storica vicenda del re babilonese. Prendendo spunto dal conflitto violento tra i popoli, attualizza una vicenda che parrebbe, seppur con molte eccezioni, essere dei giorni nostri. Infatti, il primo atto potrebbe essere ambientato nello spazio dedicato al Museo dell’olocausto di Berlino, una sorta di cimitero celebrativo degli eventi tragici di cui sappiamo. La violenza perpetuata sul popolo ebraico è così ancora più incisiva. Nelle altre scene l’elemento principale è la sabbia, potremo trovarci in un deserto, comunque in un luogo isolato, nel quale un popolo cerca con viva speranza una terra di pace, di convivenza di serenità. Dalla sabbia, che può nascondere molte cose, sorgono simboli e armi, strumenti di difesa contro il malvagio. La regia tende a comprendere e sviluppare i personaggi attraverso una drammaturgia espressiva, fatta di sguardi, intenzioni, rapporto psicologico. Ci riesce con garbo e la preziosità di non cercare percorsi troppo psicoanalitici. La scena, di Allison Chitty, scarna ma molto simmetrica favorisce l’intento registico. I costumi sempre della Chitty nella loro modernità passano inosservati, molto apprezzabili invece i video di Luca Scarzella e le luci di Alessandro Carletti, che con grande professionalità contribuisce a una visione emozionante, come ad esempio l’occhio di bue puntato dall’alto sul coro durante l’esecuzione del celebre coro al III atto.
Sul podio abbiamo ritrovato Nello Santi, un direttore che tardivamente, e forse fuori tempo, la Scala riscopre dalla Traviata della scorsa primavera e anche per la prossima Aida nel 2018. Il direttore si adopera in lettura molto tradizionale, prevalentemente nervosa ma talvolta con tempi lentissimi che in parte potrebbero compromettere l’esecuzione se il maestro non fosse anche un esperto accompagnatore di voci. Infatti, mai si è perso il controllo tra buca e palcoscenico in un buon lavoro d’insieme che solo una lunga e professionale carriera è capace di supportate. Di daccapo non è neppure il caso di parlare, ma nel complesso lo stile è sufficientemente appropriato anche se non folgorante del Verdi prima maniera.
L’orchestra della Scala era in splendida forma per coesione di suono, precisione nei singoli momenti e garanzia di altissima professionalità. Altrettanto si deve affermare del Coro, istruito da Bruno Casoni, il quale ovviamente non manca l’appuntamento con il celeberrimo “Va pensiero”, e nel corso di tutta l’opera è coprotagonista a tutti gli effetti con risultati mirabili.
Leo Nucci è ancora una volta Nabucco. Giunto alla sua età e con tanti anni di carriera è lecito osservare che la freschezza vocale è andata, eppure il baritono è ancora capace di serate memorabili come questa del 16 novembre. La voce era molto più omogenea di recite recenti, meno nasale, morbida e molto sonora in tutta la gamma, elementi che accumunati alla grande bravura scenico-interpretativa del cantante fanno dedurre che eravamo di fronte una gran bella esecuzione.
Anna Pirozzi, Abigaille, è probabilmente una delle migliori interpreti del ruolo oggigiorno. La cantante, che ha più volte cantato il ruolo, anche in quest’occasione conferma le sue doti, che si distinguono in un canto forbito nel colore e nel fraseggio. E’ capace di forgiare la voce sia nelle morbidezze sia nelle parti drammatiche, che sviluppa con buona tecnica e impeto ragguardevole.
Non convince lo Zaccaria di Mikhail Petrenko, il quale non possiede una tecnica rifinita poiché la voce, seppur rilevante, e limitata nel volume e nella proiezione, spesso non proiettata e negli assiemi quasi non udibile.
Stefano La Colla, Ismaele, esegue il proprio compito con proprietà ma senza particolari finezze, spesso usando un canto spinto e stentoreo.
Positiva la prova di Annalisa Stroppa, Fenena, interprete precisa e cantante molto raffinata.
Completavano il cast con buona professionalità Giovanni Furlanetto, un Gran Sacerdote di forte personalità, Ewa Tracz, Anna, e Oreste Cosimo, Abdallo.
Al termine un successo pieno e convito, con particolari ovazioni per Nucci e il maestro Santi.
TI VEDO, TI SENTO, MI PERDO (IN ATTESA DI STRADELLA), [Lukas Franceschini] Milano, 21 novembre 2017.
L’ultimo titolo della stagione d’opera 2016-2017 è una nuova commissione al compositore Salvatore Sciarrino da parte del Teatro alla Scala e della Staatsoper unter der Linden di Berlino: “Ti vedo, ti sento, mi perdo” (in attesa di Stradella) in prima esecuzione assoluta su libretto dello stesso compositore.
Il compositore si confronta ancora una volta con il mondo musicale barocco, ispirandosi per questa sua nuova opera, la sedicesima, alla figura di Alessandro Stradella, grande artista del ‘600 dalla vita avventurosa, la quale si potrebbe sintetizzare in “genio e sregolatezza, avventurosa, in parte criminale e con tragico epilogo”.
Sciarrino, per l’intricato libretto, ha tratto ispirazione da molteplici fonti letterarie e poetiche (Apollonio, Ovidio, Stramboli, Rilke e altri) e documenti storici. L’opera si suddivide in due atti e il soggetto si sviluppa sulla vana attesa di Stradella, compositore, (non presente scenicamente), durante le prove di una sua cantata. Drammaturgicamente l’opera è caratterizzata da un’instabilità temporale e di spazio dell’azione. La scena è articolata in tre settori diversi ma paralleli: oltre l’orchestra nella classica posizione in buca, vi è la presenza di un “concertino” in scena composto di archi e ottoni (qui posti a destra e sinistra del primo palco di proscenio). Al centro del palcoscenico una sorta di teatro in allestimento, è qui che si prova la citata cantata, che è il denominatore della vicenda, con i suoi protagonisti: la cantatrice, il coro, il musico, il letterato, e i servi. Tuttavia l’opera si svolge su tre differenti piani ma nello stesso tempo intersecati: la prova musicale, le scene comiche dei servi che commentano e beffeggiano la situazione e i costumi dei loro padroni (chiaro riferimento alla commedia dell’arte), e il tragico racconto delle vicende di Stradella, non fisicamente in scena. I riferimenti all’opera barocca sono palesi, il tragicomico, ma anche a opere più recenti, come la straussiana Ariadne auf Naxos nella vicenda dei servi e delle persone che gravitano attorno al teatro.
Come riportato nel programma di sala, in un saggio di Cesare Fertonani e Gianluigi Mattietti, Sciarrino condensa l’opera in due temi portanti: il distacco prima di perdersi (con riferimento alla cantata nella quale ci sono riferimenti a Ulisse e Orfeo); la centralità vista come presenza fisica del corpo, di senso e di passione.
L’orchestrazione è ricca e diversificata, che è da supporto indissolubile con il dialogo, e la ricaricata vocalità degli interpreti. Non mancano citazioni dello stesso Stradella, ma anche di Fryderyk Chopin e Claude Debussy. Non meno rilevante è che le voci cantano e recitano con l’orchestra, uno stile tipico del compositore siciliano. Uno stile quasi di concezione e fattura di delicate sonorità e di suoni strumentali che rievocano il passato nello stile di Sciarrino. Il quale scrive anche un libretto di non facile comprensione, ma ciò che rallenta l’esecuzione è la pratica della ripetizione, troppo abusata.
Lo spettacolo di Jurgen Flimm, regista, George Tsypin, scenografo, Ursula Kudrna, costumista, Olaf Freese, disegno luci, e Tiziana Colombo, coreografa, affascina e conquista per una rievocazione barocca che è ben calibrata tra il passato e il rifacimento presente di un’epoca mitizzata. Rilevante il tratto gestuale sui singoli, i quali sono accomunati da un senso di commedia, divertente e di grande impatto teatrale. Magnifici i costumi creati dalla Kurdna, ben calibrate le luci, fantastica e molto peculiare la scena che usa anche la struttura stessa del teatro, che solitamente non si vede. Ultima, ma non secondaria, la coreografia che evoca sempre il passato ma con chiari riferimenti e soluzioni dell’oggi.
Sul podio il giovane direttore francese Maxim Pascal, il quale ha dimostrato uno straordinario talento di concertazione, poiché era assai difficile tenere tutti sulla retta via avendoli posti in situazione diversa. Senza bacchetta ha impresso un ritmo è uno stile che vanno oltre la classica lettura, ma sfociano nella precisione musicale accomunata da una delicatezza e un trasporto artistico di altissimo livello.
Non meno efficace la prova dell’intera compagnia di canto, nella quale prevalgono in primis Laura Aikin, la Cantatrice, di straordinario fraseggio e precisione vocale, e subito dopo Charles Workman, il Musico, cantante raffinato e di grande espressione timbrica. Ma tutti sono da lodare senza riserve: Otto Katzameier (il Letterato), Sonia Grané (Pasquozza), Lena Haselmann (Chiappina), i divertentissimi e inappuntabili servi Thomas Lichtenecker (Solfetto), Christian Oldenburg (Finocchio), Emanuele Cordaro, Minchiello e Ramiro Maturana, giovane Cantore.
Il coro era composto dai solisti dell’Accademia della Scala e un Allievo del Conservatorio G. Verdi di Milano: anche per loro un plauso convinto: Hun Kim, Massimiliano Mandozzi, Chen Lingjie, Oreste Cosimo, Sara Rossini e Francesca Manzo.
Buon successo al termine, l’opera è stata molto apprezzata dal pubblico, anche se bisogna rilevare le molte assenze dopo la pausa tra primo e secondo atto.
LA CIOCIARA [Lukas Franceschini] Cagliari, 24 novembre 2017.
Il Teatro Lirico, nelle figure del Sovrintendente Claudio Orazio e del Direttore Artistico Mauro Meli, realizza un “colpo” perfetto allestendo nel capoluogo sardo l’opera La Ciociara di Marco Tutino, prima esecuzione europea dopo il debutto alla War Memorial Opera House di San Francisco nel giugno 2015.
Marco Tutino, compositore di lungo corso nel panorama internazionale con innumerevoli successi, ha avuto l’onore di ricevere la commissione per un’opera in America, primo italiano dai tempi di Giacomo Puccini. Il soggetto, noto a tutti, è tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia, dal quale lo sceneggiatore Cesare Zavattini e il regista Vittorio De Sica idearono il film, uscito nel 1960, con protagonista Sofia Loren che per quell’interpretazione vinse il premio Oscar come miglior attrice. Con tali precedenti, un romanzo famoso anche se non trai i più apprezzati di Moravia, e un film di portata e conoscenza internazionale, la scelta di Tutino, di Fabio Ceresa librettista, e Luca Rossi sceneggiatore, sembrava quasi una sfida impossibile, oppure troppo azzardata invece il risultato è stato trionfale e pienamente azzeccato. Il team non ha voluto escludere quello che esisteva, hanno capito in anticipo che nell’immaginario collettivo era imprescindibile, ma il loro talento, perché di questo si tratta, è stato quello di condensare la vicenda letteraria in una trama che unisse gli eventi, sviluppando una drammaturgia efficace che mettesse in luce configurata tutti i personaggi. E come afferma l’autore “…i sentimenti sono chiari senza ambiguità”. La musica e la parola non occultano i sentimenti, li rendono espliciti attraverso una melodia efficace e immediata che conquista e piace. Non mancano intermezzi solo strumentali, che potremo chiamare forse interludi, di forte impatto drammatico, e sarebbe superfluo trovare un raccordo con compositori precedenti, Tutino esprime a tutto tondo la sua arte attraverso una scrittura musicale di alto livello. L’orchestra è di grandi dimensioni e questo rende evidente che non si tratta di puro accompagnamento ma svolge un compito ben più importante, quello di definire la drammaturgia attigua. Tutino ha avuto il pregio di non cercare una scrittura moderna, sovente sperimentale, ma di ricercare volutamente un linguaggio di racconto lineare ed emozionante. Potremo azzardare il termine “nuovo verismo” del XXI secolo. Una delle più belle e riuscite opere contemporanee degli ultimi anni.
Lo spettacolo realizzato in coproduzione con la San Francisco Opera, lo stesso della prima assoluta, era curato da Francesca Zambello, regia, Peter J. Davinson, scenografo, Jess Goldstein, costumista, Mark McCullough, disegno luci. La regista imposta la sua lettura come un romanzo d’appendice, ispirandosi molto al mondo del cinema, però prudentemente senza copiare dal film omonimo. Abbiamo avuto una lettura drammaturgica di grande effetto, peculiare l’identificazione di tutti i personaggi in maniera pertinente e di grande lettura classica, con particolare attenzione al rapporto tra madre e figlia che trova particolare efficacia in moltissime scene, in un contenitore chiaro e lineare. D’altronde come da lei stessa affermato, il racconto ambientato durante il secondo conflitto mondiale è così coinvolgente che non può lasciare indifferenti. Contribuiscono in questo intento le funzionali scene, con leggero impatto di teatro di prosa, costumi azzeccati e storicamente precisi, luci d’effetto, e le proiezioni video d’archivio, curate da S. Katy Tucker, di grande supporto narrativo.
Sul podio un bravo concertatore come Giuseppe Finzi, che scolpisce una lettura musicale di grande effetto sonoro, rilevando non solo una direzione a disposizione del canto, spesso declamato, ma anche tavolozze sinfoniche che rimandano a concezioni del primo ‘900 di straordinaria espressione e colore.
Una partecipe, puntuale e nitida Orchestra, quella del Lirico di Cagliari, gli permette di esprimere al meglio lo spartito, cui va aggiunto il non secondario apporto del Coro, istruito da Donato Sivo, al quale sono riservate pagine di grande impegno, come ad esempio il concertato della scena 2a del I atto, nella quale ha manifestato tutta la sua professionalità e partecipazione.
Quest’opera è stata composta espressamente per le qualità artistiche e vocali, eccelse e molto espressive, di Anna Caterina Antonacci, la quale interpreta una Cesira di straordinaria resa teatrale e drammaticamente elettrizzante. La cantante bolognese trova una linea vocale, soprattutto nel declamato, di alta espressione realizzata con accenti e colori di forte impatto. Non manca una peculiare impostazione canora che nell’assolo del terzo atto coglie un apice davvero commuovente. Inoltre, crea un personaggio singolare e tutto giocato attraverso una recitazione da manuale, senza imitare nessuno. Una grande prova di teatro musicale realizzata da una grande artista!
Bravissimi anche tutti gli altri interpreti che trovano una via canora e teatrale molto rilevante. Lavinia Bini è una delicata Rosetta che impressiona nella trasformazione finale dopo la violenza subita. Aquiles Machado, Michele, è cantante rifinito e intellettualmente espressivo. Dirompente il cattivo Giovanni di Sebastian Catana, un baritono vilain di buone qualità. Straordinario Roberto Scandiuzzi, Fedor von Bock, che nella breve scena della cena all’inizio del II atto realizza un personaggio impressionante per forza drammatica e incisiva precisione vocale. Molto bravo Nicola Ebau, il pilota americano, e rilevante nel canto e nell’interpretazione Gregory Bonfatti, il viscido avvocato Sciortino. Non meno efficaci la svanita Maria Sciortino di Lara Rotili, e Martina Serra, nel drammatico ruolo di Lena.
Completavano il cast con alta professionalità i tre soldati marocchini, il citato Ebau assieme a Francesco Leone e Michelangelo Romero, ed Enrico Zara, un uomo fuori scena, al quale è riservata la citazione della famosa canzone “Una strada nel bosco”.
Teatro gremito in ogni ordine di posto e molto curioso, che al termine ha decretato un successo eclatante a tutta la compagnia, giustamente meritato!
L’augurio è che quest’opera cosi bella, piacevole, e di forte impatto teatrale, sia presto ripresa in altri teatri perché merita una maggiore diffusione e conoscenza.
IL BORGOMASTRO DI SAARDAM [Lukas Franceschini] Bergamo, 24 novembre 2017.
Il Donizetti Festival 2017 è stato inaugurato dal melodramma giocoso Il Borgomastro di Saardam nella revisione critica sull’autografo a cura di Alberto Sonzogni.
Per la prima volta il Donizetti Festival si è svolto interamente al Teatro Sociale, sito nella cosiddetta Bergamo Alta, poiché il teatro principale sarà chiuso nei prossimi due anni per un completo restauro con una spesa preventiva di diciotto milioni di euro, un impegno che l’Amministrazione Comunale si è assunta con onore.
In tale situazione dovendo utilizzare un teatro, bellissimo gioiello d’edificio all’italiana, ma di dimensioni molto ridotte il programma è dovuto convergere su titoli con organico adatto al luogo. Non tradendo lo spirito monografico del Festival, il direttore Francesco Micheli ha scelto l’opera menzionata e un dittico che vede accoppiato il maestro, Giovanni Mayr, e l’allievo, Gaetano Donizetti, di cui daremo conto in seguito.
Il Borgomastro di Saardam fu rappresentato a Napoli al Teatro del Fondo il 19 agosto 1827. L’opera si colloca in quel ristretto gruppo di spartiti che Donizetti compose al suo rientro a Napoli dopo il soggiorno palermitano come direttore del Teatro Carolino. Il libretto fu ideato da Domenico Gilardoni, il quale aveva previsto che l’intera parte del protagonista fosse recitata in dialetto napoletano, usanza molto diffusa al tempo nelle opere comiche e buffe. La partitura autografa, conservata presso l’Archivio Ricordi, evidenzia la fretta con la quale fu creata, numerose sono le abbreviazioni e la calligrafia non è rifinita, ma le indicazioni d’espressione sono precise. La musica esprime una sommaria regolarità e anche una prevedibile inventiva, ma le melodie sono sempre raffinate e pur apprezzando l’abilità e anche l’inventiva del compositore non possiamo ravvedere qualcosa di particolarmente innovativo. Non è una critica definire l’opera un lavoro minore ma è piacevole che si ascolta con interesse.
Nella stagione di Carnevale del 1828 Il Borgomastro di Saardam fu ripreso alla Scala di Milano e per l’occasione compositore e librettista dovettero approntare delle modifiche. Scontato che la lingua napoletana fu “tradotta” in italiano, furono tagliati alcuni numeri, e spostate delle scene del II atto. Inoltre, fu invariato il grado di parentela tra la primadonna, Marietta, e il Borgomastro, da figlia a pupilla. Questa variazione fu plausibilmente “dovuta” per rafforzare la parte di Carolina Ungher, unica interprete presente sia a Napoli sia a Milano, che poté così vantare un bellissimo duetto a scapito del ridimensionamento del ruolo della seconda donna. Se a Napoli l’opera ebbe un discreto successo, a Milano cadde dopo un’unica recita. Pur rivelando una certa routine e un’affiliazione con opere di stampo rossiniano, esaminando a fondo lo spartito si evincono le capacità di Donizetti, anzi, si potrebbe affermare che trattasi di opera di svolta nella crescente maturazione che a breve porterà alla completa emancipazione con numerosi capolavori. In seguito vi furono diverse riprese, ancora a Napoli, a Roma e in Europa, per poi cadere nell’oblio. L’unica ripresa del ‘900 fu nel 1973 in Olanda con protagonista Renato Capecchi. La produzione fu ideata dal direttore Jan Schaap, il quale trascrisse l’opera dal manoscritto quasi interamente autografo conservato nell’Archivio Storico Ricordi di Milano.
Anche questa nuova edizione del Festival 2017 si rifà alla versione di Milano (1828), poiché la versione napoletana, fino ad ora, non può essere integralmente ricostruita con fonti certe. Il riallestimento dell’opera operato da Donizetti per Milano fu eseguito sul precedente manoscritto (di Napoli), ma riordinando la successione dei numeri, delle arie e inserendo nuovi recitativi, pertanto risultano perduti i precedenti recitativi e parti dei numeri, originariamente in lingua napoletana.
Lo spettacolo ideato da Davide Ferrario, al debutto nella regia d’opera, è molto apprezzabile. Egli ambienta l’opera ai primi del ‘900, rispettando il libretto, in un cantiere navale. Molto peculiare il lavoro svolto sulla drammaturgia dei singoli protagonisti e molto chiara la chiave di lettura, brillante, di facile comprensione e azzeccata teatralmente. Unica licenza è stata quella di utilizzare dei video e fotogrammi in bianco e nero, trasformando la città di Saardam in Bergamo. Operazione opinabile ma non disturbante e se l’intento era quello di rendere omaggio la città natale del compositore non disturba per nulla.
Molto belle e lineari le scene di Francesca Bocca, di gran classe i costumi di Giada Masi, efficaci in ogni momento le luci curate da Alessandro Andreoli.
La brava e precisa Orchestra del Donizetti Opera era diretta da Roberto Rizzi Brignoli, il quale si adopera con grande efficacia in tempi sciolti e molto sostenuti imprimendo alla vicenda un ritmo narrativo ben rifinito. Non manca di trovare un giusto rapporto tra buca, palcoscenico e sala teatrale, rendendo il tutto attraverso una sonorità controllata e un apprezzabile bilanciamento di dinamiche e colori.
Il Borgomastro Wambett era interpretato da Andrea Concetti, il quale conferma l’ottima predisposizione vocale in questi ruoli, perfetta dizione, fraseggio curato e puntale nel canto, anche se rispetto al solito era molto contenuto nella recitazione.
Giorgio Caoduro, lo Czar, è cantante molto rifinito nel gusto, timbro vellutato e brillantezza vocale, qualità che gli permettono di mettere a segno un altro rilevante ruolo.
Irina Dubrovskaya, Marietta, è cantante molto diligente e preparata ma costretta in un ruolo che non le offre possibilità di dimostrare peculiarità virtuosa, tuttavia la prova è degna di lode.
Meritevole di plauso il Pietro di Juan Francisco Gatell, che in una parte non particolarmente acuta ma più impostata sul versante lirico, realizza il meglio in canto forbito, morbido e cesellato e la presenza scenica è ammirevole.
Un lusso nella parte secondaria di Carlotta avere Aya Wakizono, puntuale e molto espressiva, bravissimo il Leforte di Pietro Di Bianco e molto professionali l’Ali di Pasquale Scircoli e l’Uffiziale di Alessandro Ravasio.
Molto positiva e di grande fattura la prova del coro diretto da Fabio Tartari.
Il pubblico che affollava il piccolo Teatro Sociale ha decretato al termine un autentico e meritato successo a tutta la compagnia. Una bella serata che ci ha fatto conoscere un Donizetti minore ma realizzato con molta cura.
FALSTAFF [Margherita Panarelli] Torino, 26 Novembre 2017.
Secondo titolo della stagione operistica 2017/2018 del Teatro Regio di Torino è l’ultimo capolavoro verdiano.
La regia è a cura di Daniele Abbado e la direzione musicale di Donato Renzetti che guida con navigata esperienza e ironia le maestranze artistiche del Teatro Regio e i solisti nella partitura Verdiana. Grande attenzione è posta al dialogo tra buca e palcoscenico e ai ritmi scenici in un calibrato gioco teatrale di sicura efficacia.
Gradevole e ben strutturato l’impianto scenico di Graziano Gregori che pur nella sua semplicità, con forme che richiamano i teatri dell’epoca di Shakespeare, restituisce con efficacia gli ambienti dell’azione.
Nel ruolo del protagonista Carlo Lepore sostituisce Carlos Alvarez impossibilitato a sostenere la recita da problemi di salute. Il Falstaff di Lepore e robusto e solido come la voce del suo interprete lo è in tutte i registri e completa la splendida interpretazione vocale con una somma attenzione al fraseggio e alla parola scenica fondamentali per la riuscita di questo personaggio anche più che in tanti altri, come è noto.
La voce di Tommi Hakala qui nei panni del sospettoso Ford risulta di colore un poco chiaro per il personaggio a lui affidato ma la tecnica del baritono è solida e la regia, che gli richiede di interpretare un lezioso damerino, ben si sposa al timbro del cantante.
Convince appieno Francesco Marsiglia, Fenton dall’emissione limpida e dal timbro cristallino, perfettamente adatta al giovane personaggio.
Erika Grimaldi è una Mrs.Ford di grande fascino e carisma in un ruolo che le calza a pennello vocalmente e scenicamente.
Giovane, graziosissima e di tecnica molto solida Valentina Farcas conquista nel ruolo di Nannetta. i suoi interventi risaltano all’interno di una recita riuscitissima e musicalmente eccellente. Eccellenti risultano anche le altre due “comari di Windsor”, Sonia Prina e Monica Bacelli professioniste solide e dalla grande comunicativa. Molto bene anche i ruoli secondari dove convincono il Dottor Cajus di Andrea Giovannini, il Bardolfo di Patrizio Saudelli, pur se un po’ ingessato, e lo spassoso pistola di Deyan Vatchkov.
L’accoglienza del pubblico è entusiasta per questa ultima recita che ha visto la sala riempirsi quasi completamente.
UN BALLO IN MASCHERA [Lukas Franceschini] Venezia, 29 novembre 2017.
Il Teatro La Fenice ha inaugurato la Stagione Lirica e di Balletto 2017-2018 con l’opera Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, sul podio il maestro Myung-Whun Chung, nuovo allestimento di Gianmaria Aliverta, protagonista il tenore Francesco Meli.
Lo spettacolo ideato da Aliverta è ambientato in un’America ottocentesca in piena evoluzione sociale con l’abolizione della schiavitù. Non possiamo dire che ci troviamo a Boston poiché nella scena finale appare la Statua della Libertà. Questa trasposizione non avrebbe effetti particolari se non vi fosse un errore di fondo nella concezione del regista: quello di anteporre la questione politica alla passione. Sarebbe prolisso fare qui una genesi dell’opera e della lunga e complicata vicenda delle trasformazioni cui Verdi e Antonio Somma dovettero adattarsi sui dettami della censura, ma il nucleo della drammaturgia dell’opera è e resta la passione amorosa tra Riccardo e Amelia. Tutto si sviluppa attorno a questo sentimento “impossibile”, gli altri personaggi, con sfaccettature diverse, ruotano attorno i protagonisti. La questione politica è marginale e appena pennellata da Verdi, ad eccezione dalla scena della congiura, che fu voluta dal compositore per il grande effetto teatrale. Dovremo trovarci a Boston, dove il Governatore Riccardo è a capo della colonia inglese. Tutto eliminato, e la trasposizione non trova riferimento e connessione con la guerra civile e le discriminazioni razziali che ebbero un peso diverso e maggiore nell’Ottocento americano. Non è il caso di parlare degli incappucciati, chiaro riferimento al Ku Klux Klan, che con Ballo in maschera non ci azzecca per nulla. Leggendo le note di regia capiamo che il conflitto di razza ha un peso molto importante per il regista, ma poi aggiunge che Kristin Lewis, Amelia, cantante di colore, ha sposato Renato e pertanto si è elevata socialmente. Opinione legittima, ma cosa centra con la vicenda? Quando la parte la cantava Leontyne Price o Antonietta Stella, non ci poneva tale quesito. Troppe idee in questa lettura, che per la loro complessità scivolano di mano nella realizzazione, con la considerazione primaria che a mio parere poco è stato concepito in funzioni delle idee originali, pur reggendosi su una lettura anche plausibile ma per nulla affasciante.
La scenografia, ideata da Massimo Checchetto, è ben realizzata nella prima scena dell’atto I, un tribunale con grande scalone cui accedervi, ma fallisce clamorosamente la scena finale, senza un vero colpo di teatro e catapultandoci, con il calare di una grande bandiera americana, dentro un ambiente poco identificato ove troneggia la testa della statua della Libertà, citata prima, e dunque non più Boston ma New York? Inoltre la rupe girevole del II atto non entusiasma quale ambiente sinistro come avrebbe dovuto essere.
I costumi di Carlos Tieppo sono molto eleganti ma lascia perplessi il primo abito di Riccardo, più idoneo a dei romanzi d’appendice. Luci molto rifinite quelle realizzate da Fabio Barettin.
L’Orchestra della Feniceera in ottima forma e si adegua alle istruzioni di Myung-Whun Chung, maestro direttore e concertatore, che nel Ballo evidenzia soprattutto il dramma, non mancando una ricercata inversione di ritmo nei brani brillanti. Chung spesso abusa di tempi lenti, troppo, ma non perde mai la linea parallela tra buca e palcoscenico, inoltre non avendo a disposizione un cast eccellente, accomoda e accompagna tutti secondo le loro possibilità. Doveroso rilevare il grande intento riuscito nella ricerca di colori e l’ampio respiro sinfonico dei preludi. Una prova positiva ma non elettrizzante poiché talvolta mancava di tensione a scapito della narrazione.
Eccellente la prova del coro diretto da Claudio Marino Moretti, preciso, duttile e raffinato in ogni intervento, e non meno convincente la prova dei Piccoli Cantori Veneziani preparati da Diana D’Alessio.
Nel cast primeggia Francesco Meli, un Riccardo dotato di splendida voce, cosa risaputa, ottimo fraseggio, perfetta dizione. Ci saremmo aspettati una maggiore varietà d’accento, ora che il ruolo è stato più volte affrontato, invece, la strada intrapresa dal cantante, sembra quella dello sfoggio di proprietà vocali dolci e molto armoniose, a discapito di tensione (nel II atto) e peculiari mezzevoci, che in un paio di occasioni non erano del tutto precise. Tuttavia, è oggigiorno una delle migliori carte spendibili nel ruolo, se non la più azzeccata, e nel complesso la sua performance è stata rilevante.
All’opposto l’Amelia di Kristin Lewis, purtroppo cantante in piena discesa. Di là di un timbro che sarebbe idoneo, si riscontrano grandi lacune sia in acuto, limitato e stridulo, sia nel registro grave, forzato e artificioso, cui si devono sommare soventi momenti d’intonazione precaria.
Bravo Vladimir Stoyanov, il quale disegna un Renato compito e abbastanza controllato, con un fraseggio controllato, non particolarmente rifinito, ma per questo mai sopra le righe.
Poco in parte Silvia Beltrami nel ruolo di Ulrica, la quale deve scendere a compromessi con una scrittura troppo grave per le sue corde, pertanto sovente con note aperte nel basso. Ciononostante il personaggio era realizzato al meglio, e un certo fraseggio ricercato valorizzava l’esibizione.
Molto brava Serena Gamberoni, un Oscar molto rifinito e vocalmente preciso, cui si somma una presenza scenica di ottima soluzione.
Molto convincenti le parti secondarie, a cominciare dai bravissimi e insinuanti Samuel e Tom, rispettivamente Simon Lim e Mattia Denti, e dall’ottimo Silvano di William Corrò, il quale nel breve intervento ha messo in evidenza una voce bellissima e omogenea, pastosa e di ampio volume (possibile che questo cantante, di casa a Venezia, debba essere sempre relegato a ruoli di carattere?).
Professionali Emanuele Giannino, un Giudice, e Roberto Menegazzo, servo d’Amelia.
Durante l’esecuzione pochi applausi, o contenuti, ma al termine il pubblico che gremiva La Fenice ha tributato un caloroso consenso a tutta la compagnia, con particolari ovazioni per il direttore, Meli e la Gamberoni.
PIGMALIONE – CHE ORIGINALI! [Lukas Franceschini] Bergamo, 1 dicembre 2017.
Al Festival Donizetti è stato allestito un dittico davvero peculiare: il primo spartito di Gaetano Donizetti Pigmalione, che non possiamo chiamare opera bensì scena drammatica, e un omaggio al maestro del bergamasco, Giovanni Simone Mayr, con la farsa Che originali!
La serata si apre con la farsa di Mayr che fu rappresentata per la prima volta al Teatro di San Benedetto di Venezia il 18 ottobre 1798. Il librettista Gaetano Rossi trasse il soggetto da La Musicomania (1796) di Placido Bordoni, traduzione italiana della commedia francese La musicomanie di Audinot. Della fonte letteraria conservò la struttura generale ma con l’aggiunta del personaggio di Aristea, figlia di Don Febeo, modificando il carattere con inclinazione “metastasiana”, unificò nel personaggio dell’innamorato Carolino le varie peripezie di più personaggi. Mayr con la sua musica accentuò il carattere “meta-teatrale” dell’opera. Lo spartito e la drammaturgia cono incentrate sulla vita musicale e teatrale del tempo, aspetto risolto con ironia e sagacia, attraverso le quali si evince una rilevante scioltezza della melodia. Non secondario è l’aspetto del genere teatrale, la farsa, che non solo a Venezia ma in tutta Europa prosperava con successo. Il consenso fu immediato e continuato per quasi un trentennio. L’edizione della Fondazione Donizetti 2017, curata da Maria Chiara Bartieri evidenzia la presenza di un’aria di Carluccio, la quale può essere inserita secondo l’uso “dell’aria di baule”, prassi molto usata nel ‘700 e primo ‘800, consuetudine molto gradita sia dai cantanti sia dal pubblico. Il direttore Gianluca Capuano, per l’odierna edizione, ha scelto e riadattato l’aria di Figaro “Se vuol ballare signor contino” presa dalle Nozze di Figaro mozartiane.
La scena lirica, come la definì Gaetano Donizetti, Pigmalione è l’unico approccio del compositore a un soggetto mitologico, che narra la nota vicenda di uno scultore il cui lavoro diventa essere vivente. Lo spartito fu composto nel 1816 durante il soggiorno bolognese per gli studi con padre Mattei, e con tutta probabilità trattasi di lavoro sperimentale. Il libretto di autore ignoto è basato sull’opera omonima di Giambattista Cimador con versi di Antonio Simone Sografi, che a sua volta è una traduzione di Pygmalion di Jean-Jacques Rosseau, quest’ultimo derivato dal Libro X delle Metamorfosi di Ovidio. Donizetti poteva studiare a Bologna soltanto grazie ai contributi che giungevano da Bergamo, non sarebbe stato in grado di commissionare un nuovo libretto, quello di Sografi, opera molto rappresentata nell’Italia settentrionale, era invece alla sua portata. Pigmalione è un lavoro modesto per tuti i significati che il termine può rappresentare, due i personaggi (il protagonista, tenore, e Galatea, soprano), la cui scrittura vocale ha un’estensione limitata e gli abbellimenti sono misurati. È l’unica opera di Donizetti il cui autografo, conservato alla Bibliothèque Nationale di Parigi, non contenga la divisione in numeri separati, questa peculiarità identifica che fu composta come esercitazione e non ai fini dell’esecuzione o della pubblicazione. Poiché la statua Galatea prende vita nella parte finale dell’opera, il peso di questa ricade quasi esclusivamente sul personaggio maschile, il quale può rivolgere la parola solo agli dei o a se stesso, con il risultato che l’azione manca di tensione drammatica. I momenti migliori sono un ritornello che accompagna la contemplazione della statua e il recitativo quando questi si accorge del misterioso potere che la statua ha acquisito. Le arie sono brevi e simmetriche, i recitativi tutti accompagnati e il duetto finale non ben risolto, ma abbozzato. L’influsso di Mayr è evidente in molte parti, la sapiente mano inventiva di Donizetti sarà di venire. Altra particolarità è quella che la scena drammatica in musica non fu mai rappresentata Donizetti vivente, la prima rappresentazione moderna ebbe luogo a Bergamo, Teatro Donizetti, nel 1960 con protagonisti Antonio Annaloro e Oraniana Santunione.
Il dittico presentato al Festival era curato nella regia da Roberto Catalano, il quale a mio avviso ha voluto trovare un collegamento che non era necessario. Tuttavia non si può affermare che la realizzazione non sia stata efficace, anzi abbiamo assistito a due spettacoli ben congeniati e molto attenti alla drammaturgia. Nella farsa di Mayr c’è un’ambientazione quasi surreale con le bellissime le scene di Emanuele Sinisi, che ben si adattano alla bizzarra vicenda di Febeo, ossessionato dalla musica, tutti devono conoscerla e amarla, costringendo figlie, servitori e il pretendente di Aristea, in tale ottica. La regia è comica e trasborda spesso nel grottesco, lineare con lo stile della farsa comica, ma sempre sul filo dell’eleganza e dell’ottima impostazione drammaturgica. Sul fondo del palcoscenico si ravvisa una riproduzione di un celebre quadro di Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese, dietro il quale si nasconde una stanza delimitata da uno specchio: è abitata da Pigmalione, che osserva gli stravaganti personaggi dell’opera, e magari tenta di trovare qualche ispirazione. Nella seconda parte la stanza di Pigmalione è proprio uno studio, con esempi di lavori incompiuti, ma la sua attenzione è rivolta a Galatea, posta nel fondo che poi prende anima, e come in un ricongiungimento l’artista abbraccia la sua creatura.
I costumi di Ilaria Ariemme erano bellissimi, e s’ispiravano al mondo Wes Andrenon, e alle creazioni di Elsa Schiapparelli. Cromatici e accecanti nella farsa di Mayr, sobri in bianco e nero nella scena di Donizetti. Uno spettacolo piacevole e molto rifinito nei dettagli, anche se senza le note di regia, stampate nel libretto di sala, era difficile cogliere tutte le intenzioni del regista.
Di gran pregio le luci di Alessandro Andreoli.
Molto buona la prova dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, diretta da Gianluca Capuano, un ottimo musicista che trova un perfetto equilibrio tra voci e parte strumentale, i tempi sono sostenuti e la sonorità è azzeccata, dove vitalità e freschezza hanno avuto un forte impatto teatrale.
In Che originali! la parte del leone era di Bruno De Simone, Febeo, un istrione scenico dotato sempre di ottima vocalità, schietta, precisa e gran maestro nei passi sia sillabati sia concitati. Non meno valida la prova di Leonardo Cortellazzi, Carolino, un tenore sempre in ascesa che in un certo Donizetti potrà trovare un fertile terreno per il futuro. Il timbro è molto ragguardevole e armonioso, la gamma dei colori e il fraseggio perfetti, cui si somma una spiccata sensibilità interpretativa.
Molto brava Chiara Amarù, Aristea, la quale dimostrava una vocalità omogenea e ben rifinita nell’accento, che le consentono un canto prezioso e piacevole.
Pregevole anche la prova di Omar Montanari, Biscoroma, una parte di carattere ben interpretata dal baritono senza cadere nel gusto della vecchia macchietta, il quale ha dimostrato ottima tecnica e un canto forbito.
Angela Nisi, Donna Rosina, era ben calata nel personaggio, tuttavia il canto molto educato evidenziava un registro acuto talvolta stridulo. Ben rifinita la Celestina di Gioia Crepaldi, e molto convincente sia scenicamente sia vocalmente il Carluccio di Pietro Di Bianco.
In Pigmalione, il protagonista “unico” era Antonino Siragusa, il quale ha dimostrato un ottimo risultato interpretativo, soprattutto nei lunghi e rilevanti recitativi, e un canto forbito nell’accento e nel colore anche se in qualche occasione l’intonazione non era precisa. Molto brava Aya Wakizono, Galatea, attraverso una vocalità seducente nel suo breve intervento.
Al termine successo meritato contraddistinto da lunghi e convinti applausi a tutta la compagnia.
DIE ANTILOPE [Lukas Franceschini] Bolzano, 2 dicembre 2017.
Inaugurata al Teatro Comunale di Bolzano la Stagione lirica Opera 20.21 della Fondazione Haydn con Die Antilope del compositore austriaco Johannes Maria Staud, la cui prima esecuzione fu al Teatro di Lucerna nel 2014.
Il direttore artistico Matthias Losek, nelle note scritte per il programma, precisa che l’odierna stagione, denominata “Escape from reality”, chiude il ciclo sulla trilogia della vita, giunta alla terza parte. Lo stesso aggiunge che la questione centrale è: Che cosa ci fa battere il cuore? Il fenomeno dell’uomo le ragioni per cui fa ciò che fa, se sia consapevole di ciò che sta facendo e come faccia ciò che fa. Questi sono i quesiti intrinsechi sollevati dall’arte che volutamente il direttore vuole porre al pubblico nella rassegna 2017/2018. Aspetti che illustrano perfettamente Die Antilope, in prima italiana, del compositore Staud, primo artista residente alla Fondazione Haydn, e su libretto di Durs Grunbein. Il tema centrale è lo sfasamento dei mondi, la linea sottile tra ragione e follia, tra la ricerca della felicità e lo scontro con la realtà. La vicenda è sviluppata sul personaggio di Victor, un giovane impiegato, che alla festa aziendale denota il suo disagio per l’ambiente claustrofobico e assordante, caratterizzato da futili chiacchere e pettegolezzi. Decide di buttarsi dalla finestra del tredicesimo piano, iniziando così un viaggio surreale attraverso le vie della città come se il protagonista si fosse catapultato in un universo parallelo, trovandosi di fronte a situazioni buffe, minacciose, a strani personaggi. È il caso della signora seduta ai tavolini di un caffè che commenta la notizia di un uomo gettatosi dalla finestra, il severo guardiano dello zoo, i dottori che diagnosticano tremende malattie ai passanti e che colpiti dalla lingua indecifrabile di Victor gli diagnosticano una “depressione africana”. Al termine del viaggio il protagonista si ritrova nuovamente al party aziendale, la festa sembra essere rimata congelata durante la sua assenza, e tutto riprende come nulla fosse accaduto.
Il libretto non si basa su un testo letterario preesistente ma dalla stretta collaborazione tra compositore e il poeta. Essi hanno voluto raccontare un‘atmosfera vaga, la quale prende una definizione più precisa nel corso dello sviluppo. Neppure era loro intenzione creare un testo cui accomunare una musica, bensì un netto parallelo di lingua (anche incomprensibile come quella di Victor) e musica, elaborando, come loro stessi affermano, “un qualcosa a metà, sospeso tra narrazione ed esagerazione, tra realismo e assurdità”.
Il compositore rielabora un numero molto limitato di materiali, ma questi sono variati in ogni scena. Il risultato è un delicato gioco di contrasti, nei quali è sfruttato con ingegnosità l’intervento corale. L’alternanza di squarci sinfonici, con sezioni percussive, intensi momenti armonici e timbri peculiari, sono un’altra caratteristica dello spartito. Staud si avvale anche di un “live electronics” al campionamento di un clavicembalo e un pianoforte dall’intonazione microtonale, all’inserimento di frammenti di conversazione (registrati e manipolati). Non mancano frammenti di musica pop, appositamente composte e molto efficaci. Il musicista afferma che non è un approccio post moderno, ma delle finestre che apre e chiude su un mondo musicale “come nei film di Fellini”. La struttura vocale dei personaggi è connotato su ogni singolo interprete, evitando ogni forma di recitativo o parlato, si denota invece una linea vocale sagomata secondo i principi opposti dell’enfasi tardoromantica. Le emissioni baritonali anticonvenzionali di Victor assumono efficace estraneità sia nel contesto drammaturgico sia musicale. Potremo affermare che la musica di Staud, che per molti versi è inesplicabile, si sviluppa in temi improvvisi e sorprendenti, che possono forse sedurre, forse ammaliare, forse stupire.
Perché il titolo “Die Antilope” (l’antilope)? La domanda è forse scontata, meglio chiarire con le idee del compositore. Poiché l’opera nasce dalla necessità di contrapporsi al nonsense delle chiacchiere, da un desiderio di espressione pura, si è voluto contrappore l’antilope, un animale che vive in grandi gruppi, ma è anche molto individualista e può scappare velocemente. Il protagonista s’identifica in quest’animale e parla un linguaggio di un’umanità dimenticata, spezza i legami con un grande atto di liberazione dadaista che deve rimanere ed è incomprensibile a quelli intorno a lui. Victor è come l’animale, tenace, eccentrico, che spesso corre temendo per la sua vita. Gli altri personaggi sono semplici, esagerati, caricaturali, ma restano figure accessorie ed emblematiche.
Convincente proposta, che imprime nei settanta minuti di durata un’esagerata trasformazione musicale e molti riferimenti odierni, ma forse è il finale, non indicato, che porta il pubblico alla riflessione.
Il regista Dominique Mentha realizza uno spettacolo che di primo impatto appare onirico, stilizzato, e lieve, anche con l’ausilio delle scene essenziali e ben realizzate da Ingrid Erb e Werner Hutterli. Ma durante la corta esecuzione ci si accorge della sottile e cruda chiave di lettura, che volutamente va in crescendo, e fa notare la violenza della società sul singolo, il distaccato. La collettività ha sempre la meglio, e soprattutto più potere.
Ingrid Erb è anche autrice di bellissimi costumi moderni, e in particolare non si possono non menzionare le maschere a forma di animale, dal titolo dell’opera. Efficaci e variegate le luci di Norbert Chmel.
Splendida la prova dell’orchestra Haydn, ormai specializzata in musica contemporanea, e non meno efficace, anzi punto di riferimento, la direzione di Walter Kobéra, un concertatore che con sapiente professionalità scava in ogni singola peculiarità tematica della partitura, producendo una valida coesione sonora, ritmo e acceso stile sinfonico, non tralasciando un’efficace drammaturgia musicale di grande effetto narrativo.
Di grande pregio e di perfetta uniformità la prova del Wiener Kammerchor, istruito da Michael Grohotolsky.
Il protagonista assoluto, Victor, era il bravissimo baritono Wolfgang Resch, il quale riesce a essere interprete strabiliante e rifinito cantante nella difficile parte che impone stili diversi e tecnica rifinita.
Non meno validi gli altri interpreti, ai quali è richiesta una professionalità e una rilevante preparazione vocale: Elisabeth Breuer (Collega/donna/scultura), Maida Karisik (Collega/donna/donna anziana), Bibiana Nwobilio (Segretaria/giovane donna/passante) Gernot Heinrich (Collega/giovane uomo/dottore), Christian Kotsis (Capo/capocameriere/collega/passante/dottore), Ardalan Jabbari (Dottore/vigile), Catrina Poor (Madre), Leonhard Felix Mahlknecht (Giovane Victor).
Al termine il pubblico che gremiva nella quasi totalità il teatro ha tributato a tutta la compagnia, un successo molto caloroso, con particolare entusiastica accoglienza per il compositore.
DON PASQUALE [Natalia Di Bartolo] Vienna, 2 dicembre 2017.
Saldamente in mano al M° Evelino Pidò, che ne ha salvaguardato l’italianità, il Don Pasquale di Donizetti, in scena a Vienna il 2 dicembre 2017 godeva di un cast di prim’ordine, opportunamente guidato anch’esso dal noto Maestro, che ha impresso la propria iperattività direttoriale anche a questa partitura, ma una volta tanto con la brillantezza richiesta, senza eccedere nei tempi e godendo delle mirabili capacità della fantastica orchestra del Wiener Staatsoper, che gli ha consentito di cesellare, sia pure a quei ritmi indiavolati, dinamiche di variegato colore e di grande spessore sonoro.
Sul palcoscenico, il suddetto cast autorevole vedeva come Don Pasquale l’esperiente Alessandro Corbelli, protagonista ben caratterizzato e vocalmente pregevole.
Altrettanto il personaggio del Dottor Malatesta di Pietro Spagnoli, che si è prodotto anche in una imitazione della dizione gassmaniana alla lettura della lettera al primo atto e che ha retto la parte con garbo e spirito. E’ in duetto, però, che i due artisti si sono dimostrati particolarmente spumeggianti e la sinergia delle loro voci è stata esempio di gran scuola italiana ed ha suscitato l’entusiasmo del pubblico, anche per via di un bis programmato ma d’effetto.
Però a brillare singolarmente dal punto di vista vocale sono stati due protagonisti innamorati, la Norina di Andrea Carroll e l’Ernesto di Maxim Mironov.
Andrea Carroll, soprano statunitense piccola e graziosa, ha un’agilità vocale di tutto rispetto e contemporaneamente una completa padronanza del palcoscenico. Guidata attimo per attimo dalla regia attentissima di Irina Brooks ha reso una Norina vivace e brillante, pur risentendo di un problema di pronuncia delle consonanti doppie che le starebbe a pennello correggere. Per il resto, un vero grillo sulla scena, espressiva e coinvolgente.
Altrettanto coinvolgente, soprattutto dal punto di vista vocale, Maxim Mironov, dalla straordinaria vocalità tenorile “di grazia”, governata con capacità anche nel tenere a freno un vibrato stretto che è caratteristica e non difetto della sua voce. Questa caratteristica gli rende particolarmente congeniali le agilità rossiniane in cui si è espresso recentemente ne L’Italiana in Algeri, vista e recensita sempre a Vienna, nella quale si è dimostrato uno strabiliante Lindoro.
Geniale dal punto di vista registico il suo duetto con la cornetta all’inizio del secondo atto, dove la Brooks gli ha affiancato lo strumentista solista in palcoscenico. Un momento struggente di altissima qualità sonora e teatrale, con un sentore un po’ circense, nel senso più nobile del termine.
Del resto tutta l’ormai collaudata produzione della Brooks era permeata da tale sentore ed a tale scopo si è anche servita opportunamente dell’ottimo coro del Wiener Staatsoper, diretto da Martin Schebesta e di un buon numero di mimi, irrefrenabili sulle coreografie di Martin Buczko.
Non tutte le soluzioni sceniche, come quella del trasformare in un locale notturno la magione di Don Pasquale si sono rivelate vincenti, ma la caratteristica verve un po’ tra il visionario ed il folk-kitsch della regista ha preso il sopravvento per l’intero spettacolo, senza tuttavia, bisogna riconoscerlo, snaturare il capolavoro donizettiano.
Forse un po’ troppa carne al fuoco per movimentare le scene, qualche tendenza in eccesso nel far muovere i protagonisti al ritmo della musica brillante dell’opera, qualche soluzione azzardata come quella di trasformare il dottor Malatesta in un fisioterapista, ma in fondo, tutto al proprio posto, con un occhio alle avanguardie ed al teatro americano di ambientazione country in cui la Brooks si è già ampiamente distinta.
Prova ne siano anche i costumi di Sylvie Martin-Hyszka volutamente confusionari e di stile apparentemente discutibile, in una complessiva trasposizione moderna dei tempi dell’azione, ma in realtà anch’essi ricchi e curatissimi, così come le scene di Noëlle Ginefri-Corbel, illuminate da Arnaud Jung…Il tutto al servizio dello stile di Irina Brooks.
Il pubblico viennese, incurante del freddo, numeroso e come sempre variegato, ha seguito con interesse e divertimento anche l’intreccio ed ha applaudito con entusiasmo, richiamando al proscenio più volte gli interpreti e decretando il grande successo dell’intera rappresentazione.
LA CENERENTOLA [Emiliano Mazza] Bergamo, 9 dicembre 2017.
La stagione lirica di Bergamo e il contestuale Festival Donizetti quest’anno si svolgono quasi interamente nel piccolo Teatro Sociale di Città Alta, stante il Teatro Donizetti in restauro.
Si tratta di una buona occasione per far conoscere un teatro che per decenni è stato lasciato in abbandono a sé stesso e solo nel 2009 restituito fruibile alla città. Lo spazio piuttosto raccolto (550 posti), ultimato nel 1809, risulta ideale per molte opere italiane coeve che non richiedono grandi orchestre né vasti spazi scenici per funzionare a dovere. È senz’altro il caso de La Cenerentola di Rossini, eseguita per la prima volta il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma, proposta a Bergamo nell’allestimento itinerante Opera Lombardia preparato a Brescia nei mesi scorsi.
Il ruolo della protagonista Angelina era sostenuto dalla bravissima Cecilia Molinari, giovane mezzosoprano trentino, che ha risolto senza sforzo le agilità del rondò Nacqui all’affanno e nel duetto con Don Ramiro. La voce è omogenea in tutti i registri e il legato perfetto. Molto bene anche nel canto steso della canzone Una volta c’era un re, dove si è messa in luce come sensibile interprete. Il principe di Ruzil Gatin esibiva un bellissimo timbro di tenore di grazia e un buon gusto nel fraseggio, con alcune difficoltà nel controllare le dinamiche del registro acuto. Non impeccabile la resa della difficile aria Sì, ritrovarla io giuro, dove ha screziato alcuni acuti. A fianco del prence, il Dandini di Clemente Antonio Daliotti ha offerto una prova non indimenticabile a cominciare dall’emissione talvolta ingolata. Non pienamente a suo agio anche nelle agilità. Meglio l’Alidoro di Alessandro Spina, dal grande volume vocale e di bel timbro. Molto ricercata l’esecuzione dell’aria Là del ciel nell’arcano profondo: vanno segnalati solo alcune difficoltà nelle note acute. Eleonora Bellocci impersonava la sorellastra Clorinda: in questo caso la voce non è molto ampia e non sempre omogenea nei vari registri, ma l’interpretazione del personaggio risultava piuttosto convincente. Bene anche nell’aria Sventurata! mi credea, scritta in realtà da Luca Agolini e frequentemente tagliata. A bistrattare Angelina c’era pure la Tisbe di Elena Serra, dal vibrato un po’ eccessivo. Il baritono Vincenzo Taormina completava la compagnia di canto nei panni di Don Magnifico, esibendo una tecnica vocale eccellente sia nei gravi che negli acuti in maschera. L’interpretazione di questo ruolo di basso buffo risulta un filo caricaturale, forse su indicazione del regista, ma convince.
Lo spettacolo di Arturo Cirillo in effetti ha tentato di cogliere la verve comica di Rossini con una recitazione molto estroversa. Egli si avvale anche della presenza di quattro bravi figuranti in alcuni momenti dell’opera: superflui quando compartecipano discretamente all’azione, si stenta a trovare senso compiuto per il resto, a cominciare dalla scenetta durante l’ouverture in cui i quattro tentano vicendevolmente di mettersi abiti e scarpe femminili. Al regista andrebbe ricordato che i luoghi per sdoganare al meglio la fluidità sessuale sono altri. Piacevoli e divertenti invece i colorati costumi di Vanessa Sannino. Nella scena d’entrata di Dandini (Come un’ape nei giorni d’aprile), il baritono indossa infatti un costume che ricorda vagamente un’ape mentre le due sorellastre dei cappelli floreali.
La direzione d’orchestra era affidata a Yi-Chen Lin, giovane direttrice cinese classe 1985. Apprezzabile nell’aver accompagnato con sicurezza il palco, scollandosi comunque in un paio di momenti dei concertati, non ha purtroppo trasmesso particolari emozioni nella meravigliosa Sinfonia. Meglio la scena del temporale. Il risultato non può certo prescindere dall’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, il cui suono poco coeso degli archi è facilmente spiegato osservando sul libretto di sala che nemmeno un professore stabile della formazione milanese era in buca per Cenerentola. I Pomeriggi Musicali, sabato dunque interamente freelance, godeva fra l’altro del dono dell’ubiquità, suonando anche Zauberflöte a Pavia. A parte maggiore varietà e chiarezza nella denominazione, nulla da imputare alle direzioni artistiche: si fa quel che si può con i budget a disposizione. Spiace però constatare ancora che nel nostro Paese il livello delle compagini, sebbene di solito composte da eccellenti singoli, sia così inficiato da programmazioni a breve termine. Migliore il risultato conseguito dal Coro Opera Lombardia diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, purtroppo relegato in uno spazio di contorno dell’essenziale scenografia di Dario Gessati. Si segnala infine il prezioso contributo di Alessandro Trebeschi al fortepiano nei recitativi secchi.
ANDREA CHÉNIER [Lukas Franceschini] Milano, 13 dicembre 2017.
La stagione d’opera 2017-2018 del Teatro alla Scala è stata inaugurata con l’opera Andrea Chénier di Umberto Giordano, scelta voluta da direttore musicale Riccardo Chailly, il quale oltre ad aver diretto la precedente edizione nel 1985 vuole proporre il repertorio italiano cosiddetto verista, negli ultimi anni in po’ trascurato.
Andrea Chénier, dramma storico in quattro quadri su libretto di Luigi Illica, fu rappresentato in prima assoluta proprio alla Scala il 28 marzo 1896 e fu un trionfo, anche se a priori erano molte le perplessità se mettere in cartellone lo spartito. Protagonisti furono Giuseppe Borgatti, allora non conosciuto ma poi divenuto celeberrimo soprattutto nel repertorio wagneriano, Evelina Carrera e Mario Sammarco, uno dei migliori baritoni a cavallo del secolo.
L’opera è un dramma di ambiente storico, ispirato alla vita del poeta francese André Chénier, all’epoca della rivoluzione francese, mentre il personaggio di Carlo Gérard ricalca la figura del rivoluzionario Jean-Lambert Tallien. Sebbene l’opera porti la matrice di “opera verista”, come tutta la produzione di fine ottocento, caratterizzati in drammi a tinte forte, soggetti ambientati in sfere popolari della società e la predisposizione al canto e alla strumentazione orchestrale “urlata”, Andrea Chénier ne condivide solo alcuni tratti, in particolare la violenta passione, forti aspetti drammatici e un’insistente violenza, ma l’aggettivo verista non è del tutto esatto. Innanzitutto è presente una diligente ricostruzione storica e ambientale, un peculiare colore, e tanti particolari che ricreano un’atmosfera passata. Il protagonista è un personaggio realmente vissuto, martire a poco più di trent’anni, che a suo tempo il romanticismo aveva trasformato in eroe e alfiere degli ideali della rivoluzione. Inoltre, se il librettista Illica aveva creato dettagliate didascalie che rendono molto fedele in tutti i particolari il quadro storico, introducendo anche personaggi come Robespierre, il compositore congloba peculiarità sonore che ricordano gli anni della Rivoluzione francese: danze e minuetti aristocratici, rulli di tamburo, canti patriottici, temi come quello della Carmagnola o l’accenno alla Marsigliese. Tutti questi ingredienti, l’ambiente storico e il motivo sociale-politico, per Giordano sono un cavillo atto a mettere in scena una grande storia d’amore. Tutti gli elementi, anche importanti, contenuti nell’opera, i valori morali e rivoluzionari, la giustizia sociale sono di contorno alla forza dell’amore, che porterà i giovani amanti al tragico destino ma con un lieto fine forse ultraterreno.
La ricercata composizione di Giordano punta a un discorso narrativo continuato, rilevante è che il recitativo si fonde spesso con immense espansioni liriche, il tutto denota una flessibilità dell’insieme. Tuttavia non mancano momenti d’intenso canto spiegato, che si rifanno al classico pezzo chiuso, cioè la cosiddetta aria. Il compositore ha riservato questo modo ai tre personaggi maggiori, gli altri si esprimono attraverso un declamato ricercato, mentre l’orchestra può essere definita come un tessuto sinfonico di coesione. A tal proposito è molto interessante l’intervista di Franco Pulcini a Riccardo Chailly, pubblicata nel programma di sala, nella quale il maestro evidenzia “… la parte strumentale rappresenta la base, il nucleo portante di tutta l’opera. In questo senso è anche una partitura sinfonica davvero sorprendente e il peso specifico dell’orchestrazione è rilevante sia per la modernità sia per gli anni in cui fu scritta…. Il mondo armonico è di un’originalità e una ricchezza musicale sbalorditiva. La melodia non sarebbe così affasciante e unica se non fosse sorretta da una personale impalcatura di accordi originali sorprendenti. Si distingue da altri titoli del tempo anche per questo motivo.”.
In queste parole si coglie il pieno significato di quest’opera, unica ed esemplare nel contesto musicale storico, ma anche della produzione stessa di Giordano, e il successo incontrastato sia di pubblico sia dei grandi interpreti, che vollero, eseguirla è indicativo.
Bellissimo lo spettacolo creato dal regista Mario Martone, che volutamente, e aggiungo fortunatamente, è fedele alla collocazione storica. Partendo dal concetto che il mondo merlettato e incipriato della nobiltà francese sta per concludersi, ha voluto realizzare una visione che sovente s’ispirava al tableau vivant. Scelta molto condivisibile e di forte impatto scenico, cui si aggiunge la genialità della scenografa Margherita Palli che s’ingegna nella costruzione di scene collocate su una pedana rotante, chiaro riferimento a un carillon antico, che crea continuità nell’azione drammaturgica. Scene scomponibili in breve tempo dove s’impongono i grandi specchi a parete nella dimora nobile, che girati diventano pareti di grande fascino per l’esterno del II atto. E ancora, le tribune del tribunale che diventano le scale per l’ascesa alla ghigliottina. Martone è maestro nel muovere le masse, le quali hanno una funzione rilevante nel corso della narrazione, rappresentativa la scena dei popolani che guardano i nobili, che danzano la gavotta, attraverso un vetro nel finale I, e anche il pubblico veemente nella grande scena del tribunale. I singoli, anche le parti minori, sono caratterizzati per una recitazione sobria ed elegante, mai enfatica ma molto espressiva.
I costumi, di grande fattura e pregevole aderenza storica, di Ursula Patzak, che conferma una creatività davvero rilevante.
Le luci di Pasquale Mari contribuiscono con determinazione efficace e professionale alla lettura voluta dal regista, di grande effetto le scene d’ombra poi improvvisamente illuminate a giorno con il cambio della scena. Mirabile la coreografia di Daniela Schiavone che ci riporta al perduto mondo settecentesco di danze stilizzate e manierati minuetti.
Il direttore Riccardo Chailly è il sommo musicista che conosciamo, e la lunghissima carriera a livelli alti lo dimostra. Tuttavia in quest’occasione ha dimostrato qualità, non indifferenti, che hanno determinato la sua concertazione. Innanzitutto Chailly ama profondamente questo repertorio, e l’ha dimostrato nell’intenso lavoro con l’Orchestra della Scala, la quale in forma smagliante ha seguito le direttive in maniera perfetta, producendosi in un suono uniforme, compatto, molto sonoro, ricchissimo di colori. Non sono mancati una tensione drammaturgica e un gioco di scansioni ora liriche ora drammatiche di assoluto pregio e raro ascolto. Secondo aspetto rilevante è stata la maniaca preparazione e cura nell’accompagnamento dei solisti, ai quali ha permesso una disinvoltura canora di pregio senza mai perdere lo spirito e l’enfasi dello sparito. A tutto questo bisogna aggiungere un’appassionata conduzione, in molte occasioni di stampo sinfonico con uno slancio impressionante, sempre in perfetto equilibrio con la partitura. Una grande prova che va doverosamente lodata.
Ottima la prova del Coro diretto da Bruno Casoni, che trova nella compagine scaligera una delle migliori formazioni, duttile, omogenea e di grande professionalità.
Non meno valida l’esibizione del Corpo di Ballo, sotto la guida di Frédéric Olivieri, che nei brevi interventi dimostra tutta la grande classe e perizia tecnica che da sempre lo distinguono.
Il protagonista era Yusif Eyvazov, al centro di troppe polemiche alla vigilia. Alla fine è uscito vincitore dall’infernale sfida, merito anche dell’accurata preparazione con il direttore. La voce non è particolarmente seducente, ma questo si sapeva, tuttavia il cantante ha dimostrato un’ottima linea di canto, sempre controllata e con buoni colori e prezioso fraseggio. Il registro acuto è sfavillante e all’occorrenza sfoggiato con gusto e facilità. Di contro ci sono ancora una zona centrale e l’emissione a mezzavoce da rifinire, oltre ad una recitazione più incisiva, ma al termine della recita non si poteva che attribuirgli un plauso incondizionato e anche la considerazione che probabilmente non c’era possibilità migliore.
Anna Netrebko, debuttante nel ruolo di Maddalena, e nella vita reale moglie di Eyvazov, ha interpretato e cantato un personaggio rifinito in ogni punto. La voce sempre bella e piena è voluminosamente ovattata con suoni seducenti, e il fraseggio dimostra le ottime capacità esecutive della cantante. A suo discapito un’innaturale forzatura nel registro grave, la partitura lo prevede, ma senza accusare gravi danni, trova maggiore terreno fertile nella celebre aria, eseguita con straordinaria passione, e nella parte finale dove sfodera un’avvincente vocalità, drammatica, quasi trasognante, impetuosa e con sfumature ricercate da grande artista. La dizione però a tratti è incomprensibile. Scenicamente un po’ impacciata nel primo atto, è a mio avvio una Maddalena completa con grande carisma nel III e IV.
Il Gérard di Luca Salsi è improntato su un’interpretazione e un canto tipicamente verista, nel senso buono del termine. La voce è tanta e anche di pregio ma l’emissione non è morbida e la linea di canto sempre impostata con forza che alla fine rendono la sua esibizione monocorde e stentorea. Tuttavia quando riesce a modulare le sue qualità vocali, come in alcuni passi di “Nemico della patria”, i risultati sono completamente diversi e più apprezzabili.
In Andrea Chénier è compreso un folto numero di parti secondarie, le quali hanno un’importanza maggiore che in altre opere, perché hanno piccoli ma rilevanti spazi personali e nell’insieme costituiscono una colonna portante dell’opera. Il Teatro alla Scala ha trovato l’eccellenza nella scelta di tali ruoli, e sarebbe riduttivo fare una classifica, ma doverosamente l’elenco non è in ordine decrescente bensì tutto di altro livello.
Eccellente la prova di Carlo Bosi, l’Incredibile, che ha eseguito la sua parte con una squisita brillantezza vocale. Non da meno il Roucher di Gabriele Sagona, cantante dotato di un’ottima vocalità, pastosa e molto sonora. Emozionante Judit Kutasi, vecchia Madelon, dotata di bella voce da contralto, e frizzante la Bersi di Annalisa Stroppa sempre precisa e puntuale.
Classe e signorilità contraddistinguevano la prova di Mariana Pentcheva, contessa di Coigny, stilizzato e puntuale l’abate di Manuel Pierattelli.
Non meno efficaci e di grande fattura vocale le interpretazioni di Costantino Finucci, Fléville, Gianluca Breda, un Fouquier sprezzante, Francesco Verna, un Mathieu non caricaturale, l’imponente e fiero carceriere Schmidt di Romano Dal Zovo, e il bravo Riccardo Fassi nel doppio ruolo del Maestro di casa e Dumas.
Il pubblico esauriva il teatro esaurito in ogni ordine di posto, particolarmente attento e osservante alla volontà del direttore di non applaudire dopo gli assoli per non interrompere l’azione drammatica (scelta anche logica, ma poco teatrale), che al termine ha decretato un autentico trionfo, meritatissimo, a tutta la compagnia.
La produzione era dedicata a Victor De Sabata nel cinquantenario della scomparsa, il quale aveva diretto alla Scala l’opera nel 1932 e 1949.
TOSCA [Lukas Franceschini] Rovigo, 15 dicembre 2017.
Al Teatro Sociale un nuovo allestimento dell’opera Tosca di Giacomo Puccini ideato da Artemio Cabassi per 202ª Stagione Lirica.
Spettacolo quello di Cabassi, autore anche di scene e costumi, all’insegna della tradizione, con una scenografia magra ma efficace. Considerato lo spazio esiguo del palcoscenico ai lati s’intravedono delle bianche colonne che fanno da contorno per tutti i tre atti e le relative scene, sul fondo tre diversi giganteschi fotogrammi della città eterna che “allargano” la scena. Sul palco pochi elementi ma efficienti per l’azione. Bellissimi i costumi, cromati e grande fattura, i quali come rilevato dall’autore non sono in stile impero ma di foggia settecentesca poiché l’azione si svolge esattamente tra il 14 e il 15 giungo 1800 (battaglia di Marengo) e pertanto la “moda” napoleonica era ancora da venire a Roma. Colpisce ed è encomiabile il lavoro svolto dal regista sulla recitazione dei singoli interpreti, rendendo credibile e viva l’azione senza oltrepassare il limite della drammaticità e cadere nel facile cliché teatrale. Abbiamo avuto un sagrestano fortunatamente non balbuziente ma semplice prelato e un barone Scarpia di spiccata nobile eleganza, che non scende dal piedistallo del potere. Tosca era un’appassionata donna e Cavaradossi un artista idealista e irruente. Peculiarità che hanno valorizzato sia l’allestimento sia alcune scene non del tutto riuscite, come il Te Deum un po’ troppo “raccolto”, e un drappo di troppo (che ricordava quello del primo atto) dietro la tavola della cena di Scarpia. Poco efficaci le luci di Marco Ogliosi che tenevano a rendere sempre buia la scena, e in molte occasioni a non individuare chiaramente i personaggi. Tuttavia è uno spettacolo tradizione, ben impostato e che si vede con piacere.
In quest’occasione è stata scritturata l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, forse per la prima volta a Rovigo, e l’esibizione è stata molto apprezzabile per compattezza di sonorità e ottimo insieme strumentale. Merito anche, o forse soprattutto, della concertazione di Simon Krecic, che ha saputo cogliere e realizzare tutte le insidie della partitura con ottima professionalità, tenendo sempre costante il ritmo drammatico ma allentare all’occorrenza per slanci romantici. Mirabile l’attenzione riservata al buon equilibrio tra buca e palcoscenico.
Di buon livello la prova del Coro Lirico Veneto, istruito da Flavia Bernardi, preciso e puntuale nel grande finale atto I. Una menzione di plauso va anche al Coro di Voci Bianche Leopold Mozart di Rovigo, diretto da Francesco Toso, che ha assolto il suo compito con bravura e ottima coesione.
Protagonista era Lilla Lee, chiamata all’ultimo a sostituire la titolare indisposta. La cantante americana è dotata di tanta e robusta voce, che sarebbe anche ideale per il ruolo, ma la tecnica non raffinatissima non le consente di tosca 6risolvere le parti più liriche con un fraseggio e un utilizzo di colori in maniera efficace, tuttavia l’ottimo registro acuto colma tale lacuna e nell’insieme la prova è positiva.
Molto valida la prova del tenore Cristian Ricci, Cavaradossi, il quale non avrebbe una voce idonea per qualità timbrica al ruolo, ma l’accurato fraseggio, il sapiente uso degli accenti e una peculiare ricerca di colori gli hanno permesso di realizzare un personaggio molto credibile e adeguato vocalmente non mancando in particolare un’appassionata esecuzione di “E lucevan le stelle”.
L’elemento meno efficace del cast era Mauro Bonfanti, Barone Scarpia, che purtroppo aveva una linea di canto troppo enfatica e per nulla raffinata, sempre utilizzata con voce forte e in parte triviale, essendo sempre eccessivo.
Blagoj Nacoski era uno Spoletta di lusso, interprete viscido e perfido con una luminosa vocalità. Molto apprezzabile il sagrestano di Angelo Nardinocchi, elegante e mai eccessivo in macchiette sovente abusate, e imponente il Cesare Angelotti di Italo Proferisce, cantante dotato di voce corposa e ben amministrata.
Completavano la locandina degli interpreti, il professionale Claudio Mannino, Sciarrone, e l’incisivo e severo carceriere di Francesco Toso.
Al termine applauso generale per tutti gli artefici dello spettacolo, particolare molte ovazioni per Ricci, ma qualche segno di dissenso per Bonfanti.
LA DAMNATION DE FAUST [Simone Ricci] Roma, 17 dicembre 2017.
La regia di Damiano Michieletto ha attirato reazioni contrastanti per quello che è il primo titolo della stagione 2017-2018.
La dannazione di un adolescente: si potrebbe riassumere con queste cinque parole “La damnation de Faust” messa in scena al Teatro dell’Opera di Roma, un nuovo allestimento in coproduzione con il Regio di Parma e il Palau de Les Arts “Reina Sofia” di Valencia che ha provocato reazioni contrastanti tra il pubblico. Si tratta del titolo con cui il Costanzi ha deciso di aprire la stagione 2017-2018, una scelta curiosa se si pensa alle particolarità di questo lavoro musicale. Il compositore Hector Berlioz parlò sempre della sua “creatura” come di una leggenda drammatica: la prima rappresentazione avvenne in forma di concerto nel 1846, mentre per la prima esecuzione in forma scenica si attese fino al 1893, ben 24 anni dopo la morte del musicista francese.
Questa recensione si riferisce alla recita di domenica 17 dicembre 2017, la terza in programma. La regia di Damiano Michieletto ha spiazzato il pubblico romano: la scena unica, bianca e simbolica (curata da Paolo Fantin) ha fatto da sfondo al viaggio a episodi di Faust e Mefistofele. Il primo è stato rappresentato appunto come un adolescente con felpa e jeans, mentre il demone indossava un doppiopetto, entrambi seguiti senza sosta da un operatore che riprendeva ogni momento e ogni dettaglio con una steadycam. Michieletto ha avuto molte idee, ma secondo un famoso proverbio “il troppo stroppia”: ci sono state soluzioni interessanti e altre che potevano essere evitate senza problemi.
La scelta di Faust bullizzato sui banchi di scuola dai compagni di classe durante la famosa “marcia ungherese” è stata accolta dalla disapprovazione del loggione, anche se è sembrata più che altro una voce solitaria, presto zittita dal resto del teatro. Lo stesso Faust è stato fatto morire su un letto di ospedale, quasi come se il suo sogno fosse avvenuto durante il coma. Il regista ha suddiviso la partitura in quindici episodi, tutti contraddistinti da un titolo, una sorta di mini-serie in stile “The Truman Show”. Non sono mancati neanche Faust e Margherita bambini che cercano di avvicinarsi su una trave da ginnastica artistica e le ragazze mascherate che tentano Faust con lo stesso vestito di Margherita, prontamente denudate da Mefistofele.
Gli spettatori romani si sono trovati di fronte anche un gigante topo che si muoveva ritmicamente durante la canzone del ratto, un giardino dell’Eden con insegne al neon e un Mefistofele trasformato in serpente. Le perplessità tra il pubblico non sono mancate, in particolare non tutti sono riusciti a seguire il filo del discorso, cercando di intuire le intenzioni del regista. A parte i fischi e le proteste dopo la marcia ungherese, però, non ci sono state altre interruzioni, segno che tutto il teatro ha voluto seguire con attenzione ogni scena prima di giudicare (si è sentito chiaramente anche un “Bravo Damiano” per incoraggiare Michieletto).
Il cast vocale è stato applaudito con convinzione. Sui social si sono lette in questi giorni critiche molto feroci all’indirizzo dei cantanti: di sicuro una regia tanto impegnativa non li ha premiati, ma hanno mostrato di essere consapevoli dei loro mezzi. Il tenore ceco Pavel Cernoch ha affrontato con coraggio un ruolo non semplice come quello di Faust. La sua performance può essere paragonata a un motore diesel: dopo un inizio leggermente titubante, si è immedesimato bene nel personaggio, con una estensione costante e qualche limite per quel che riguarda gli acuti. Il maggiore trasporto è stato ottenuto in occasione di Merci doux crepuscul.
Alex Esposito ha “rubato” senza dubbio la scena ai colleghi con una prestazione convincente, sia dal punto di vista visivo che canoro. Il suo Mefistofele era grottesco al punto giusto, accattivante e sfrontato (il bacio appassionato alla truccatrice e i continui palpeggiamenti ne sono un chiaro esempio), oltre che molto sicuro di fronte alla steadycam. Il basso-baritono bergamasco è noto per il repertorio mozartiano, ma non ha sfigurato neanche con Berlioz: la ballata della pulce è stata corretta, ma in generale sono state colte tutte le sfumature di un personaggio in continuo travestimento. Il “triangolo” era completato da Veronica Simeoni nel ruolo di Margherita.
Il suo stile è stato raffinato, anche se spesso troppo attento nel cercare di cogliere le caratteristiche più nascoste della giovane amata da Faust. Dignitoso, poi, è stato il Brander di Goran Juric. Daniele Gatti ha diretto con piglio l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, riuscendo a sprigionare le potenzialità di una partitura complicata. Calibrato, sicuro e accolto da una lunga ovazione è stato il coro del Costanzi, diretto da Roberto Gabbiani, nonostante un posizionamento poco felice nella parte più alta della scena, senza la possibilità di interagire con gli altri personaggi. Buono, infine, il contributo degli allievi della Scuola di Canto Corale. Alla fine gli applausi sono stati scroscianti per tutti, senza altri riferimenti al lavoro di Michieletto.
LA VEDOVA ALLEGERA [Lukas Franceschini] Verona, 19 dicembre 2017.
Dopo la forzata pausa autunnale, la Fondazione Arena riprende l’attività al Teatro Filarmonico con l’operetta Die Lustige Witwe di Franz Lehar, nella versione italiana, titolo che chiude la stagione 2017, in attesa della vera inaugurazione 2018 che sarà a febbraio con Otello di Giuseppe Verdi.
Lo spettacolo è quello celeberrimo di Gino Landi, autore anche delle coreografie, che fu presentato decenni addietro al Festival dell’Operetta a Triste, e già proposto a Verona in altre occasioni.
Allestimento classico, anche se ormai denota i suoi anni, lucente e ben realizzato nella fantasiosa Parigi d’inizio secolo XX. La regia di Landi trova un giusto equilibrio in una narrazione spigliata e scorrevolissima, sovente interpolata di gags gustose e mai eccessive che si vede con piacere. Buono l’utilizzo del corpo di ballo, anche se in taluni momenti troppo presente senza senso appropriato. A mio avviso l’unico momento mancato è l’entrata di Hanna Glawari, la quale avendo a disposizione una grande scala non fa una sortita da vera primadonna, creando fascino e meraviglia.
Molto belle le scene di Ivan Stefanutti che s’ispira all’austero elegante per l’ambasciata nel primo atto, con cambi scena efficaci attraverso pannelli scorrevoli, che non fermano l’azione. Meno felice la festa in giardino nella casa della protagonista, dove il folklore, un po’ troppo paesano, la fa da padrone. Il terzo atto che dovrebbe essere il più folgorante poiché ambientato nel celebre locale della Belle Époque Chez Maxim è leggermente ridimensionato e poco fantasioso, con tutto il coro collocato in fondo per dare spazio al balletto, si poteva pensare una soluzione più efficace.
Molto belli i costumi di William Orlandi, che impone uno stile elegante nelle divise e nei brillanti costumi femminili, e molto colore per “les grisettes”, come da copione. Le luci sarebbero dovute essere più calibrate secondo l’azione drammaturgica, invece erano spesso in posizione unica.
Il primo soggetto che dovrebbe essere preso in considerazione per allestire un’operetta classica come La Vedova Allegra, dovrebbe essere il direttore d’orchestra, il quale deve avere un chiaro e preciso stile, che oltre alla professionalità dovrebbe contribuire al brio, alla brillantezza delle pagine meravigliose di Lehar e mantenere un costante nella concertazione composta di grandi colori e dinamiche peculiari. L’operetta è un mondo di fantasia, di sogno, di evasione. Tutte queste caratteristiche non erano presenti in Sergio Alapont, il quale segue un ritmo lento, sonorità pesanti, e poca attenzione alle voci con il risultato di un rilevante sfasamento tra buca e palcoscenico. Il maestro spagnolo ha anche una buona preparazione ma alla fine pare che questo repertorio non sia molto nelle sue corde, poiché sia la concertazione sia l’insieme sono stati nel complesso noioso.
L’orchestra dell’Arena di Verona era molto precisa e preparata, ma piuttosto spenta per l’impostazione del direttore, sappiamo che avrebbe potuto essere molto differente e più rigorosa. Buona la prova del Coro diretto da Vito Lombardi.
Elisa Balbo era una Hanna Glawari molto educata musicalmente e riesce a interpretare un personaggio credibile e piacevole. La voce è molto contenuta, e qui il direttore avrebbe dovuto avere più accortezza, ma è molto bella e il canto lirico è ben sviluppato e d’effetto. Il ruolo probabilmente dovrebbe essere più rodato per fornire accenti più maliosi e ricercati, in future occasioni sicuramente il personaggio sarà più focalizzato, poiché il materiale c’è e la cantata è molto raffinata.
Enrico Maria Marabelli interpreta un Conte Danilo convincente, elegante, sornione, e dotato di una voce bella molto duttile e brillante nel canto.
Molto bravo Francesco Marsiglia, Camille, che attraverso una voce morbida e pulita assicura un’interpretazione appassionata e molto musicale.
Lucrezia Drei, Valencienne, è una brillante interprete, sicura e molto rifinita vocalmente, anche in questo caso il direttore avrebbe dovuto avere più accortezza per un volume non particolarmente robusto, ma di grande fascino e brillante nell’accento e nel fraseggio.
Strepitoso il Barone Zeta di Giovanni Romeo, che accomuna solida vocalità, pastosa e forbita, a una recitazione davvero ragguardevole e divertente, senza mai eccedere. Un personaggio riuscitissimo sotto tutti gli aspetti.
Francesco Paolo Vultaggio era un intrigante e bravo Cascada, Stefano Consolini un brillante e perfetto St. Brioche, Andrea Cortese un Kromow divertentissimo e Nicola Ebau un Pritschitsch efficace.
Ben assortite e divertenti le tre donne dell’ambasciata: Olga, Sylvaine e Praskovia, rispettivamente Lara Rotili, Serena Muscarello e Francesca Paola Geretto.
Come nell’edizione precedente il ruolo di Njegus era interpretato da Marisa Laurito. L’attrice napoletana ha sfoderato tutto il suo brillante talento in una spassosa interpretazione, sia scenica sia cabarettistica, arrivando nel terzo atto anche a realizzare una spaccata! Tuttavia al personaggio è stata fornita troppa importanza con macchiette superflue, al limite dello scurrile o troppo scontate e poco divertenti, e un assolo nel III atto del tutto superfluo. Peccato che la signora Laurito abbia esagerato, perché il talento era divertente e di classe anche senza aggiunte. Il pubblico però ha apprezzato moltissimo.
Molto bravo il Corpo di Ballo assemblato per l’occasione, il quale si è esibito anche in un’aggiunta, Gaité Parisienne di Offenbach, che esce dai confini di Lehar, ma tutto sommato ci può stare.
Al termine applausi fragorosi che hanno determinato un successo pieno all’esecuzione.
TOSCA [Lukas Franceschini] Bologna, 21 dicembre 2017.
La stagione d’opera 2017 del Teatro Comunale si è terminata con l’opera Tosca di Giacomo Puccini nell’allestimento di Daniele Abbado che debuttò al regio di Torino nel 2016.
L’allestimento di Abbado caratterizzato dal colore, bianco e nero, è sviluppato in uno spazio unico adatto per rappresentare le tre diverse situazioni che compongono l’opera, ovviamente con qualche piccolo cambiamento. La concezione del regista è sviluppata nel concetto che lo svolgersi degli avvenimenti, degli stati d’animo, sono collocati su un altare (stilizzato), espressioni che sorgono dalla femminilità di Tosca, come le diverse stazioni di un’ipotetica “via Crucis”, che ci accompagnano in episodi mentali e simbolici. Detto così potrebbe essere riduttivo per un dramma verista, di Sardou, che fin dagli esordi teatrali ebbe grandissimo successo soprattutto oltralpe poiché fu interpretato da Sarah Bernhardt. Le bianche colonne ai lati fissano in maniera inequivocabile l’ambiente, chiesa, palazzo e spalti del castello, la grande pedana centrale (talvolta rotante), potrebbe rappresentare il vortice nel quale cade la protagonista e non riesce a uscirne. Vari e diversi sono gli elementi esterni che conducono Tosca al suicidio finale, un amante rivoluzionario del quale non condivide del tutto gli ideali, un viscido e potente funzionario dello stato pontificio che la ricatta, l’inganno della finta fucilazione cui segue l’atto estremo quando si rende conto di aver perso tutto.
Monumentale ed efficace la scena creata da Luigi Perego, autore anche di bellissimi costumi in stile belle époque, poiché come nelle intenzioni del regista, l’opera e il libretto si prestano anche a un linguaggio cinematografico. Gli abiti hanno uno stile che potremo ravvisare in celebri pellicole sia del muto sia del primo sonoro, lineari ma eleganti per gli uomini, di forte cromatismo quelli di Tosca, unica donna presente nel cast.
La regia di Abbado è molto pulita e focalizza i personaggi in maniera molto teatrale senza sfociare nell’enfasi caricaturale, anzi comune denominatore è l’eleganza, realizzata attraverso sguardi e piccole movenze, come stessimo assistendo a un thriller sempre in equilibrio tra speranza e delusione.
Uno spettacolo molto curato e ben realizzato, forse rivisitato in chiave psicoanalitica, ma di forte impatto e bella visione.
Sovente sono proiettati sullo sfondo dei video di Luca Sarzella, non invasivi, che contribuiscono a determinare la scena, che in Tosca è molto precisa e scandita nei tempi.
Sul podio abbiamo trovato Valerio Galli, che ritroviamo dopo la bella prova fiorentina de La Rondine. Il giovane maestro ha un’ottima concezione dello spartito, dal quale riesce a far emergere colori, sfumature, tensione, senza mai abusare nella tonalità ma tenendo una conduzione molto equilibrata e di preciso senso drammaturgico. Inoltre la bacchetta è molto attenta alle voci, non se sovrasta mai, e la tenuta dello spettacolo è assicurata anche con la buona prova dell’Orchestra, attenta e precisa.
Ottima la prova del Coro del Comunale diretto da Andrea Faidutti, e molto preziosa la presenza del Coro di Voci Bianche istruito da Alhambra Superchi.
Omogeno il cast alla recita cui abbiamo assistito. Elena Rossi è una Floria Tosca molto avvincente scenicamente, mentre la parte vocale seppur apprezzabile per un fraseggio variegato e accenti pertinenti è inficiata talvolta da un vibrato in zona acuta Se riuscisse a rimediare questa particolarità, la sua interpretazione sarebbe di gran pregio, poiché la cantante è molto musicale e ha tutte le carte in regola per il ruolo.
Bella prova quella del tenore Diego Torre, Cavaradossi, che possiede nella zona acuta una sicurezza invidiabile, meno rifinito il centro, ma il cantante è capace di utilizzare bene sia la mezzavoce sia il fraseggio producendosi in un ruolo ben delineato. Particolarmente apprezzata “E lucevan le stelle” per una linea di canto molto ispirata.
Il migliore era il baritono Gevorg Hakobyan, Barone Scarpia, perfetto interprete del sadico poliziotto ma sempre elegante e mai forzato. La voce è molto bella, anche se non eccessivamente tonante ma utilizzata senza forzature plateali e rispettoso del dettato musicale cui si aggiunge una spiccata recitazione che fa della sua interpretazione un momento molto ragguardevole.
Bravo Nicolò Ceriani, un sagrestano misurato e credibile, perfetto Nicola Pamio nel realizzare un viscido e odioso Spoletta, superbo e preciso l’Angelotti di Luca Gallo.
Completavano il cast il tenebroso Sciarrone di Tommaso Caramia, Raffaele Costantini era un professionale carceriere e la brava Annalisa Taffetani, puntuale nello stornello del III atto.
Pubblico molto partecipe che gremiva il teatro in ogni ordine di posto. Successo convito al termine con molte chiamate al proscenio e appuntamento a gennaio con un altro Puccini, La Bohème, che inaugurerà la Stagione Lirica 2018.